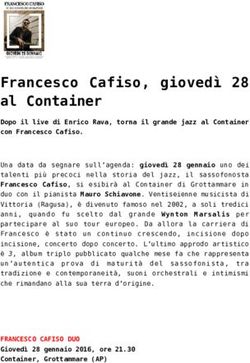CON IL VANGELO NELLE PERIFERIE ESISTENZIALI SEGUENDO L'INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CON IL VANGELO NELLE PERIFERIE ESISTENZIALI
SEGUENDO L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO
Convegno Caritas Catania 22 marzo 2014
1. Una Chiesa in uscita
Già il 18 maggio dell’anno scorso parlando ai movimenti e alle comunità
ecclesiali in piazza San Pietro Papa Francesco aveva lanciato il suo appello
accorato ad andare incontro agli altri, soprattutto ai più poveri:
In questo momento di crisi non possiamo preoccuparci soltanto di noi stessi,
chiuderci nella solitudine, nello scoraggiamento, nel senso di impotenza di fronte ai
problemi. Non chiudersi, per favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo nella
parrocchia, con gli amici, nel movimento, con coloro con i quali pensiamo le stesse
cose… ma sapete che cosa succede? Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si
ammala. Pensate ad una stanza chiusa per un anno; quando tu vai, c’è odore di umidità,
ci sono tante cose che non vanno. Una Chiesa chiusa è la stessa cosa: è una Chiesa
ammalata. La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali,
qualsiasi esse siano, ma uscire. Gesù ci dice: “Andate per tutto il mondo! Andate!
Predicate! Date testimonianza del Vangelo!” (cfr Mc 16,15). Ma che cosa succede se
uno esce da se stesso? Può succedere quello che può capitare a tutti quelli che escono di
casa e vanno per la strada: un incidente. Ma io vi dico: preferisco mille volte una
Chiesa incidentata, incorsa in un incidente, che una Chiesa ammalata per chiusura!
Uscite fuori, uscite!
Ma è nella Esortazione Apostolica Evangelii gaudium che il Papa formula la
definizione completa di una “Chiesa in uscita”.
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa,
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. “Primerear –
prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità
evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta
nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere
l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle
strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia,
frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva.
(n. 24).
Il motore di questa uscita fuori da se stessa della comunità cristiana è, dunque,
la misericordia che essa ha sperimentato, l’infinita misericordia le Padre. Lo
scopo, dunque, è la missione, perché il bisogno più grande che c’è nel mondo è
conoscere la verità su Dio rivelata a noi in Gesù Cristo. Quell’impensabile verità
da parte dell’uomo che si riassume nella parola misericordia. Questo è il cuore
dell’annuncio cristiano, l’essenziale che deve oggi più che mai essere detto e
ridetto al mondo. Non c’è nulla di volontaristico nella missione: essa è la forza
diffusiva della misericordia di Dio. È solo questa che commuove i cuori e non i
ragionamenti astratti, anche se logicamente perfetti. Il papa di questo è
profondamente convinto.2
La preoccupazione è, dunque, squisitamente missionaria e la ragione di
questa uscita verso le periferie esistenziali non è culturale, sociologica o politica;
essa è squisitamente teologica, più propriamente cristologica:
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale,
sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa
preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad
avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una
opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della
carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa». Questa
opzione – insegnava Benedetto XVI– «è implicita nella fede cristologica in quel Dio
che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà». Per questo
desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a
partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È
necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un
invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del
cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la
nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro (n. 198).
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di
promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di
attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo come
un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera
preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il
suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di
essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è
sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma
perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra
persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente». Il povero, quando è amato,
«è considerato di grande valore», e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da
qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi
personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo
accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà
possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come “a casa loro”. Non
sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novella del
Regno?». Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che
pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a
cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone» (199).
Forse tutto questo può essere esemplificato da una esperienza recente che ho
fatto nel carcere di Piazza Lanza in cui esercito il mio ministero sacerdotale, di
cui ho parlato anche su “L’Osservatore Romano”. Un detenuto, dopo ventisette
anni di fedele convivenza, dalla quale sono nati figli e nipoti, ha espresso il
desiderio di sposarsi. Lo doveva alla sua donna – mi ha detto – per darle la
dignità di sposa; lo doveva ai suoi figli per dar loro la coscienza di appartenere
ad una vera famiglia; lo doveva a se stesso e alla sua coscienza di cristiano Non
aveva però la possibilità di comprarsi neanche la cravatta, figuriamoci poi gli
anelli nuziali e tutto il resto. Attorno a questa richiesta si è creata tra gli altri3
detenuti una grande attesa della risposta che avrebbe dato la Chiesa. Nei
quartieri poveri, infatti, della nostra città è invalsa l’opinione che si sposano in
chiesa soltanto coloro che se lo possono permettere, perché per sposarsi bisogna
affrontare una spesa considerevole. Ebbene le amicizie che ho avuto
l’opportunità di crearmi nei miei lunghi anni di ministero sacerdotale mi hanno
messo in grado di provvedere nel miglior modo possibile a tutto l’occorrente.
Uno degli orafi più noti della città ha regalato le fedi nuziali ed ha aggiunto
anche una somma in denaro per i bisogni degli sposi; un notaio mi ha dato uno
dei suoi migliori vestiti da cerimonia; altre persone hanno pensato alla sposa, ai
dolci e ai confetti e perfino ai fiori con i quali addobbare l’altare, costruito
all’interno di una splendida sala del carcere destinata ai colloqui dei detenuti con
i familiari. Ogni volta che veniva fuori un bisogno leggevo negli occhi del futuro
sposo come una sfida alla carità della Chiesa. Il rito del matrimonio si è svolto
alla presenza dei familiari, dei testimoni, della direzione della casa circondariale,
del comandante e di tanti agenti della polizia carceraria ed è stato anche allietato
da un coro improvvisato dai volontari impegnati in collaborazione col
cappellano Al momento delle promesse coniugali gli sposi sono stati afferrati da
una commozione grande e a stento sono riusciti a pronunziare le parole della
formula; come raramente oggi accade anche tra i giovani che iniziano la loro
convivenza coniugale. Avevano compreso che con il sacramento il loro amore si
inseriva in quello di Cristo per la sua Chiesa e richiedeva, pertanto, altrettanta
fedeltà e gratuità, una donazione assoluta, fino alla morte. Il contesto creato
dalla carità ecclesiale rendeva loro più credibile quello che professavano con le
loro parole. Quel matrimonio ha reso più glorioso il volto di Cristo in
quell’ambiente; quel volto di misericordia che papa Francesco non smette mai di
suggerirci e che rende più umana la vita in qualunque situazione. È la ricchezza
più grande che è stata donata agli sposi e ai carcerati tutti. Adesso le domande di
matrimonio religioso si sono moltiplicate.
Ecco, la carità e la misericordia rendono credibile l’annuncio cristiano che i
poveri spesso hanno la capacità di accogliere più degli altri, mostrando a noi e a
tutto il mondo quanto sia efficace nei loro cuori l’azione della grazia e
l’esperienza dell’amore di Cristo.
2. Le periferie esistenziali
a) I poveri e le nuove forme di povertà e di fragilità
È da dire che
la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione
spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede;
hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua
benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino
di crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve
tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (n. 200).4
Viene riaffermato qui che il bisogno più grande dell’uomo è Dio, la sua verità
e la sua grazia. Da qui segue l’impegno per una più grande giustizia sociale
ineludibile da parte della comunità cristiana:
Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla
senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con
dignità e per l’inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché
parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla
mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con
discorsi vuoti (n. 207).
Particolare attenzione meritano le nuove forme di povertà: i senza tetto, i
tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e
abbandonati, la tratta delle persone specialmente delle donne e dei bambini.
Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono
anche i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si
vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro
la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo.
Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei
nascituri, si fa in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico,
oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente è intimamente
legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere
umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo
sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade
questa convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei
diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di
turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita
umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla fede, « ogni violazione della dignità
personale dell’essere umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa
al Creatore dell’uomo» (n. 213).
b). I giovani
La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto
dei cambiamenti sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte
alle loro inquietudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con
pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a parlare con
loro nel linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte
educative non producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e
movimenti prevalentemente giovanili si possono interpretare come un’azione dello
Spirito che apre strade nuove in sintonia con le loro aspettative e con la ricerca di
spiritualità profonda e di un senso di appartenenza più concreto. È necessario, tuttavia,
rendere più stabile la partecipazione di queste aggregazioni all’interno della pastorale
d’insieme della Chiesa (105).
c). Le famiglie
La famiglia attraversa una crisi culturale profonda:
Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva
che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno (66).5
L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita che
indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli
familiari (67).
Da qui segue imperioso “il bisogno di evangelizzare le culture per
inculturare il Vangelo” (69).
Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con
Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È necessario
arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la Parola di
Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città (74).
Ma va riaffermato il modo di affrontare queste grandi questioni. È quanto
Papa Francesco ha detto lo scorso 20 febbraio, aprendo i lavori del Concistoro
straordinario sulla famiglia:
La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere
quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è
indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità. Ci viene chiesto
di mettere in evidenza il luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a
viverlo con gioia nella loro esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà, con una
pastorale intelligente, coraggiosa e piena d’amore.
La sfida, dunque, è sulla bellezza: aiutare l’uomo di oggi a riconoscere
“quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi” e il
metodo è quello di offrirgli una compagnia misericordiosa, cioè “intelligente,
coraggiosa e piena d’amore”.
Credo che l’intenzione che ha mosso il nuovo Papa fin dall’inizio del suo
ministero petrino, dichiarata poi nell’intervista rilasciata al direttore della Civiltà
Cattolica, padre Antonio Spadaro, è stata quella di mostrare una Chiesa capace
di “riscaldare il cuore” della gente con la sua misericordia. Nella misericordia
splende, infatti, in modo particolare l’amore di Dio: è quella bellezza che
commuove e convince, che ha la capacità di attrarci attraverso il visibile
all’invisibile. E’ il misterioso scopo e metodo dell’Incarnazione. La bellezza –
denunciava von Balthasar – «non è più amata e custodita nemmeno dalla
religione. Se essa viene strappata come una maschera al suo volto, mette allo
scoperto dei tratti che minacciano di riuscire incomprensibili agli uomini».
Il papa vuol farci capire a quali condizioni certe riaffermazioni dottrinali
possono essere efficaci, cioè risultino comprensibili e accettabili, oggi. Infatti, se
è vero che certi valori cristiani per la loro ragionevolezza sarebbero riconoscibili
anche da una intelligenza non credente, purché sia lealmente aperta a quelle
evidenze originarie che la propria coscienza può suggerire a ogni uomo, è
altrettanto vero che essi, pur avendo una loro intrinseca ‘naturalezza’, sono
divenuti visibili allo sguardo dell’uomo così come storicamente è fatto e
accettabili dalla sua volontà solo nel contesto culturale aperto dal cristianesimo e
rivitalizzato continuamente dalla presenza della Chiesa. Quando questa viene
meno o si affievolisce, come sta accadendo soprattutto nella nostra vecchia
Europa, si esaurisce quell’alimento essenziale del quale i valori umanistici si6 sono nutriti. Papa Francesco dimostra di aver compreso profondamente questa verità e questo nesso essenziale tra fede e ragione e, a partire da tale presupposto, imposta le sue priorità nella evangelizzazione. «La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. – diceva Papa Francesco nell’intervista rilasciata al direttore de “La Civiltà Cattolica” lo scorso 19 agosto – La cosa più importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di misericordia». E ancora: «Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Questo non è possibile. Io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi è stato rimproverato. Ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Il parere della Chiesa, del resto, lo si conosce, e io sono figlio della Chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione». «Gli insegnamenti, tanto dogmatici quanto morali, non sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra sull’essenziale, sul necessario, che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò che fa ardere il cuore, come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trovare un nuovo equilibrio, altrimenti anche l’edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La proposta evangelica deve essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa proposta che poi vengono le conseguenze morali». 3. Il linguaggio dei gesti o della fisicità “Come ha detto papa Francesco...” è un ritornello che accompagna spesso le confessioni dei penitenti del Duomo di Catania, dove trascorro parecchie ore settimanali ad esercitare il ministero della riconciliazione, e i miei colloqui con i detenuti. Anzi devo dire che l’avere lo stesso nome del Santo Padre, cioè Francesco, mi ha dato una carta di credito in più presso di loro, quasi che l’omonimia garantisca anche una somiglianza spirituale. Sono fenomeni questi che raramente mi erano stati offerti prima, sebbene io abbia circa sessant’anni di sacerdozio. Quest’uomo è riuscito ad avvicinarsi alla loro vita e alla loro umanità in modo talmente significativo e determinante che, per esprimere se stessi, essi usano le sue parole nelle quali si sentono perfettamente compresi” Mi sono chiesto a che siano dovuti e ritengo di avere individuato nei contenuti del magistero e nella modalità di comunicazione dell’attuale pontefice la loro spiegazione. Il contenuto, come abbiamo visto, è semplice, direi elementare: i cristiani sono chiamati a far fare agli uomini del nostro tempo l’esperienza della misericordia del Signore. La misericordia, infatti, è ciò di cui l’uomo ha più bisogno per riconciliarsi con se stesso e con Dio.
7
Quando ho letto ai miei detenuti le parole che il papa aveva loro inviato
attraverso i cappellani delle carceri, con le quali si ricorda che «nessuna cella è
così isolata da escludere il Signore, nessuna; Lui è lì, piange con loro, lavora con
loro, spera con loro; il suo amore paterno e materno arriva dappertutto» e che
finiscono con quell’interrogativo audace ed inquietante che ha confidato
sopraggiungere nel suo cuore sempre dopo le telefonate che fa ancora ai
carcerati di Buenos Aires: «perché lui è lì e non io che ho tanti e più motivi per
stare lì […] poiché le debolezze che abbiamo sono le stesse, perché lui è caduto
e non sono caduto io?», ho visto prima i loro occhi segnarsi di lacrime e alla fine
sono stato coinvolto nel loro applauso caloroso e grato. Quegli uomini in quel
momento hanno ritrovato il senso vero della loro dignità, quella che nessuna
colpa potrà mai cancellare.
C’è anche una elementarità ed efficacia particolare nel modo di comunicare
di papa Francesco. Parole chiave che sintetizzano dottrina e conseguenze etiche,
immagini che si imprimono nella mente e aiutano la memoria e soprattutto gesti.
È quella “fisicità” di cui ha bisogno l’uomo e che egli concede attraverso la sua
persona a tutti. Vale più un suo bacio dato ad un bambino che un lungo e
articolato discorso sul valore della vita umana. Tommaso d’Aquino ha affermato
che «al loro destino di felicità gli uomini sono ricondotti attraverso l’umanità di
Cristo» (Summa theologiae, III, 9, 2, c.) e per questo «la grazia prima ha
colmato la sua umanità e da lì è derivata a noi» (Ibid., I-II, 108, 1, c.). «Non è il
ragionamento astratto che convince l’uomo, – ha scritto il mio grande amico don
Luigi Giussani verso la fine della sua vita, quasi per svelare il segreto della sua
fecondità sacerdotale – ma il trovare nell’umanità un momento di verità
raggiunta e detta» (Il senso religioso, Rizzoli, Milano 2001, p. VI).
I miei detenuti mi hanno fatto scoprire il valore di questo suggerimento.
Prima di qualunque iniziativa nei loro confronti è stata la mia presenza nei
bracci e nelle celle. Essi sono molto sensibili alla fedeltà con cui vado a trovarli,
all’affetto con cui li abbraccio. Si può dire che attraverso questa fisicità loro
percepiscono il senso che tu hai della loro dignità e quando la sentono
riconosciuta si arrendono nel rapporto con te e a tutto ciò che tu loro proponi.
Ciò mi ha fatto ricordare quanto ha detto ancora Papa Francesco il 18 maggio
scorso ai movimenti e alle comunità ecclesiali durante la veglia di Pentecoste:
Quando io andavo a confessare nella diocesi precedente, venivano alcuni e sempre
facevo questa domanda: “Ma, lei dà l’elemosina?” – “Sì, padre!”. “Ah, bene, bene”. E
gliene facevo due in più: “Mi dica, quando lei dà l’elemosina, guarda negli occhi quello
o quella a cui dà l’elemosina?” – “Ah, non so, non me ne sono accorto”. Seconda
domanda: “E quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di quello al quale dà l’elemosina,
o gli getta la moneta?”. Questo è il problema: la carne di Cristo, toccare la carne di
Cristo, prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà, per noi cristiani, non è
una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale. Direi,
forse la prima categoria, perché quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto
povero per camminare con noi sulla strada. E questa è la nostra povertà: la povertà della
carne di Cristo, la povertà che ci ha portato il Figlio di Dio con la sua Incarnazione. Una8
Chiesa povera per i poveri incomincia con l’andare verso la carne di Cristo. Se noi
andiamo verso la carne di Cristo, incominciamo a capire qualcosa, a capire che cosa sia
questa povertà, la povertà del Signore. E questo non è facile.
Per Natale un amico mi ha regalato cento panettoni per i miei detenuti. Ho
chiesto alla direzione del carcere di poterne portare uno per ogni cella. Ho
preteso, però, che mi si aprissero le celle in modo da poterli consegnare
personalmente entrando quasi a casa loro. È stato più questo gesto di contatto
fisico amicale che il panettone portato a commuoverli. Non vi dico poi dei
mussulmani: non finivano mai di baciarmi.
Questo episodio mi ha fatto pensare. Io ero piuttosto abituato ad avere
prevalentemente un rapporto concettuale e verbale con gli altri. Il discorso e la
parola erano il mezzo privilegiato di comunicazione. Il povero, colui che è
povero in ogni senso, capisce solo attraverso la fisicità dei gesti. Il Signore ha
lasciato i sacramenti come strumenti di santificazione: essi sono dei gesti fisici
carichi di un effetto spirituale.
Allora ho cominciato a mettermi alla fine della Messa in fondo alla chiesa per
salutarli e abbracciarli uno per uno. Sapeste quanta intensità di rapporto si
esprime in quel momento e quanta maturità affettiva richiede questo esprimersi
attraverso la carne! Essa è pari a quella che si richiede nella vita coniugale, che
poi è il sacramento del rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, come dice Paolo agli
Efesini.
Conclusione
La gioia dell’incontro con Gesù è la genesi dell’evangelizzazione. Gioia che
si rinnova e si comunica quando, superando la tristezza individualistica, ci si
apre verso gli altri. L’evangelizzazione non è un programma o un progetto, ma
è l’inevitabile comunicarsi della bellezza della vita cristiana vissuta.
Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza
cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene
attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi desidera vivere con dignità e pienezza non ha
altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. […] Quando la Chiesa chiama
all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo
della realizzazione personale: «Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la
vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione,
alla fin fine, è questo». Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere
costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la dolce e
confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime […]
Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza –
ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e
ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi
ricevuto in loro la gioia del Cristo» (Evangelii gaudium, 9-10).Puoi anche leggere