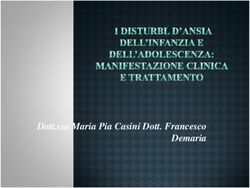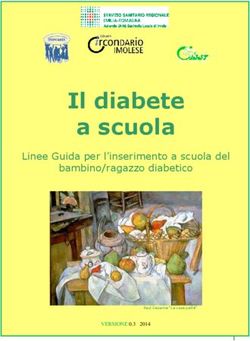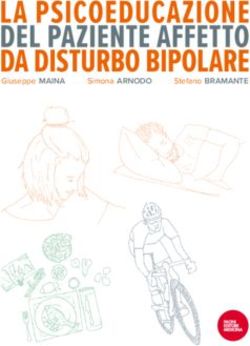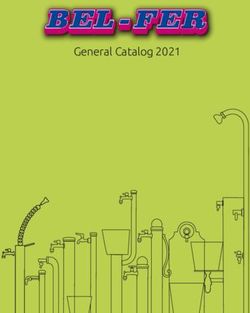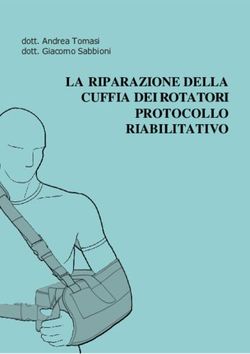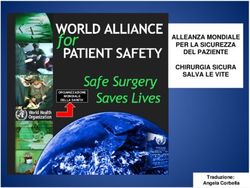Attacchi di Panico e Fobie - Associazione INSIEME Onlus
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
UNIVERSITÀ DI MESSINA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della
Formazione
Sede di Noto (SR)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Attacchi di Panico e Fobie
Tesi di Laurea di:
Corradina Triberio
Relatore:
Chiar.mo Preside. Prof. Antonino Pennisi
ANNO ACCADEMICO 2010-2011
IINTRODUZIONE
Inizio la mia Tesi di Laurea dal titolo: “ATTACCHI DI PANICO E FOBIE” raccontandovi il
motivo della mia scelta per questo argomento: Io soffro di DAP.
DAP,cosa significano questa tre lettere ?
Significano: DISTURBO DA ATTACCO DI PANICO.
Era una calda mattina afosa dell’estate dell’anno 2001 quando ad un tratto scendendo le scale di
casa mia che dalla mia stanza portano in cucina chiamavo disperatamente mia madre in preda ad
un malore improvviso e sconosciuto la cui vertigine, il senso di svenimento e la tachicardia mi
stavano inghiottendo in un vortice immaginario con tanta paura di morire che si era impadronita
di tutta me stessa. Per fortuna bastò la presenza amorevole di mia madre ed il susseguirsi di
qualche interminabile minuto per ritornare alla realtà ed al benessere. Sì, proprio alla realtà;
perché quando si ha un attacco di panico la realtà è soffocata dalla paura che si impadronisce di
tutto te stesso: mente e corpo.
Da quell’attacco di panico improvviso la mia vita cambiò.
Ma cosa mi portò a stare così male ? Una notizia per me scioccante il cui protagonista era il
cuore malato di una persona a cui volevo molto bene. Trasferì in modo psicosomatico la
malattia cardiaca in me stessa fino a soffrire di DAP.
Dopo quel primo attacco di panico ce ne furono tanti altri per un intero anno sedando il malore
sporadicamente con un ansiolitico quando era necessario.
Dopo quel periodo la mia vita ricominciò ad essere “normale” in quanto gli attacchi di panico si
erano allontanati, ma gestivo la mia vita non facendo attività in cui sapevo che il mio cuore
avrebbe accelerato il suo battito quindi non facendo più sport e spostandomi solamente con
mezzi di trasporto a motore anche per brevi tratti di distanza.
Vivevo la vita condizionata dal pensiero del cuore .
I miei genitori erano ignari di tutto ed io ne ero poco consapevole per me la cosa principale ed
più importante era non affaticare il mio cuore. Ero diventata cardiopatica nella mia mente
benché il mio organo cardiaco fosse in perfetta salute.
Passarono gli anni vivendo in questo modo.
IIIUna sera dei Mondiali di Calcio dell’anno 2006 ero in casa da sola ed avrei dovuto raggiungere
i mie genitori a casa di amici. Mi stavo preparando quando sentì il mio cuore battere più
velocemente, il respiro affannato, il tutto sfociando in tachicardia ed in un attacco di panico
improvviso. Riuscì a telefonare a mia madre che mi raggiunse in fretta e con amorevoli cure e
l’intervento tempestivo del mio medico di famiglia riuscì a stare bene.
La mia vita subì una trasformazione.
Per tre lunghi mesi mi vennero attacchi di panico ogni giorno e spesso mi costringevano a
recarmi al pronto soccorso.
Sono arrivata quasi ad uno stato vegetativo: avevo paura a camminare, mangiavo solo
imboccata da mia madre riuscendo ad inghiottire pochi bocconi di cibo, avevo paura ad uscire,
avevo paura a lavarmi, avevo paura degli specchi, avevo paura a ridere, avevo paura quasi a
parlare lo facevo sottovoce per non sforzarmi; la mia vita si svolgeva coricata a letto e dicendo
in continuo solo una cosa : HO PAURA.
I miei genitori erano disperati, ma nel frattempo non accettavano di portarmi da uno psichiatra
perché i disturbi mentali sono visti come un qualcosa di cui ci si deve vergognare e di cui si ha
paura ad affrontarli, ma poi vista la grave situazione l’hanno affrontata portandomi in ospedale
da uno bravo psichiatra.
Ero arrivata ad avere ventuno attacchi di panico nelle ore solari e durante le ore notturne era un
susseguirsi di attacchi di panico anche mentre dormivo ed ero dimagrita più di dieci Kg,
destando preoccupazione e molto timore ai miei genitori
Nel novembre dell’anno 2006 i miei genitori mi hanno messa in macchina e portata in ospedale
dal mio psichiatra di fiducia e dopo un colloquio e la visione di analisi cliniche e visite
cardiologiche perfette ha diagnosticato il: DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO.
Ho iniziato la cura farmacologica l’indomani del colloquio con lo psichiatra e da quel momento
la mia vita è stata in ascesa perché il mio corpo ha avuto una riposta positiva farmacoterapia,
invece alla psicoterapia non rispondevo in modo positivo ed ho dovuto abbandonare perché mi
sentivo nervosa ed angosciata dopo il colloquio con lo psicoterapeuta.
La mia cura risolutiva è stato l’amore di mia madre che mi ha strappata con forza e volontà alle
mie fobie, la farmacoterapia che mi ha aiutata a non avere il malore degli attacchi di panico, la
mia voglia di vivere che non mi è mai mancata.
IVAdesso dopo molti anni sono qui a scrivere la mia testimonianza di vita, sto bene, ho ripreso la
mia vita e mi metto in gioco anche se ancora continuo a curarmi con la farmacoterapia con dosi
di mantenimento. Voglio puntualizzare per esperienza personale che per uscire dall’incubo del
DAP non bastano le terapie ma si deve volere, si devono accettare le cure, si deve accettare di
essere aiutati perché se non si è affiancati da tutto ciò è molto difficile uscirne si avranno
sempre delle ricadute come l’ho avuta nel 2006. Consiglio a tutti coloro che ne soffrono di farsi
aiutare da specialisti ed accettare le cure perché senza una cura è solo un cammino in discesa.
La mia tesi si apre con una piccola dedica, seguono il frontespizio, l’introduzione, una poesia
scritta da me dal titolo: “Attacco di Panico”, quindi i capitoli della tesi. I capitoli sono cinque,
all’interno di ciascuno di esso ci sono i vari paragrafi che sviluppano l’argomento trattato in
cadauno. Alla fine della tesi abbiamo la conclusione, l’indice e la bibliografia.
Dedico la mia tesi principalmente a San Giuseppe Moscati il Medico Santo di cui sono diventata
devota non appena l’ho incontrato nella cappella dell’ospedale dove lavora il mio psichiatra di
fiducia ed ai miei meravigliosi genitori che mi hanno dato la vita e sostenuta sempre e che mi
hanno dato la possibilità di studiare. Inoltre al mio amico che non c’è più di nome Davide ed al
mio carissimo psichiatra il Dott.Orazio Antonuccio primario del reparto di Psichiatria
all’Ospedale di Avola (SR). Ancora dedico la mia tesi in modo particolare alla Santissima
Trinità, la Madonna, San Pio da Pietrelcina,San Giovanni Bosco, San Corrado, Santa Lucia,
Santa Rosalia e Sant’Agata che ho pregato tanto ed invocato per aiutarmi negli studi
universitari.
Ringrazio tutti i miei professori del mio corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione e
Formazione”, i segretari e tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso di studi.
Ringrazio per ultimo, ma non per importanza, il mio relatore il Preside Professore Antonino
Pennisi che mi ha dato la possibilità di scrivere la tesi sull’argomento che io desideravo.
Concludo l’introduzione alla mia tesi con una poesia che ho scritto in cui descrivo uno dei mie
tanti attacchi di panico improvvisi augurandovi una buona lettura.
Corradina Triberio
VPoesia: ATTACCO DI PANICO
Inaspettatamente I secondi sembrano lunghi anni
sono dentro un vortice
mi gira la testa mi sento svenire
sono fuori dalla realtà
sento solo vertigini nel mio corpo
la strada succhia mi agito
tutta me stessa. non riesco a prendere le medicine
sono lì dentro la borsa che ho tra le mani
Il mio sguardo è alienato non riesco ad aprirla
il sudore aumenta sempre più
il mio corpo non risponde AIUTO
il mio cuore è impazzito.
nessuno mi aiuta mi sento svenire
AIUTO cerco di camminare
mi tremano le mani il mio respiro è sempre più affannato
mi tremano le braccia il mio cuore è troppo agitato
mi tremano le gambe sto perdendo i sensi
non riesco a reggermi in piedi
AIUTO lo grido forte ci sono riuscita
la mia voce è inesistente
ma,
mi manca l'aria
tutti si allontanano
AIUTO hanno paura del mostro che si è impossessato di me
sto impazzendo a stenti riesco a camminare
mi trascino a passi lenti
AIUTO ed arrivo alla soglia della porta amica
che mi salva per l'ennesima volta
sto morendo. dal pazzesco vortice
che mi stava inghiottendo
Corradina Triberio
VICAPITOLO 1
Premessa
La salute della psiche è meno nota alle persone in quanto i mass media dedicano soprattutto rubriche di
medicina informando quasi unicamente sulla salute del corpo e quindi le persone quasi ignorando l’universo
dei disturbi mentali non comprendono l’importanza della salute mentale.
I disturbi mentali evocano ancora tutt’oggi un senso di imbarazzo e di vergogna sia in chi ne soffre, sia nei
familiari che nel contesto sociale in genere.
La medicina si occupa del visibile e dell’oggettivo in quanto cura il corpo, ma l’invisibile cioè la psiche la
cui parola deriva dal greco Psiche che significa “anima” viene curata dalla psicologia.
Diceva Aristole: “ L’anima è ciò che un corpo può fare di un corpo naturale dotato di organi, essa costituisce
l’attività primaria ed intenzionale”.
La nozione di anima però non coincide con quella di mente. La mente è paragonata al software del
computer cioè il programma ossia le giuste informazioni formate da una lista di istruzioni emanate dalla
nostra rete neurale ed è stato scoperto che il corpo umano trasmette in codice binario; il cervello invece è
paragonato all’hardware del computer cioè la parte organica del nostro corpo.
La psicologia sfocia nella psicologia contemporanea o delle scienze cognitive in generale agli odierni
orientamenti di studio e di comprensione delle malattie mentali cioè alla psicopatologia ed alla psichiatria.
La psicopatologia si apre essenzialmente alla filosofia esistenziale di dare una interpretazione del malato e
della malattia mentale quindi della comprensione e descrizione fenomenologica della modalità di esistenza e
dei vissuti dei soggetti malati a svelarne le strutture ontologiche legate all’impossibilità di essere o sentirsi
diversi. La psichiatria indaga i disturbi mentali seguendo un approccio clinico-nosologico con l’obiettivo
della diagnosi e quindi l’attuazione dei protocolli per il trattamento.
Il funzionamento mentale (la memoria, l’intelligenza, il linguaggio, il pensiero, la ragione, la creatività) si
spiega facendo riferimento all’attività dei sistemi di connessione cioè le reti neurali ovvero all’attività del
sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP) . Il cervello ed il midollo spinale
costituiscono il sistema nervoso centrale, dai gangli del midollo spinale si originano le fibre nervose che
innervano tutti i tessuti degli organi e degli apparati. Questa fitta rete di nervi costituisce il sistema nervoso
periferico (SNP) . Quindi abbiamo due porzioni si sistema nervoso quello centrale e quello periferico.
7Gli orientamenti della psicologia contemporanea o delle scienze cognitive in generale agli odierni
orientamenti di studio e di comprensione delle malattie mentali cioè alla psicopatologia e alla psichiatria
troviamo indizi interessanti a carico dei comportamenti.
Si notano che nelle malattie mentali soprattutto quelle più gravi abbiamo evidenti riferimenti ai processi
informazionali che riflettono nell’anomalia comunicativa dei fenomeni psicopatologici.
Le psicopatologie sembrano oltre che disturbi delle comunicazioni anche disturbi delle relazioni intesi in
duplice dimensione di personale ed interpersonale.
L’aspetto personale è testimoniato dalla difficoltà dei soggetti ad individuarsi ed a riconoscersi come persone
dotate di prerogative personali proprie oppure dall’eccessiva considerazione e focalizzazione su di sé.
L’aspetto interpersonale si riflette nell’autoisolamento dei malati di mente e nella conseguente chiusura in sé
ed all’alterità.
Quindi le psicopatologie si caratterizzano come disturbi delle comunicazioni e delle relazioni .
Nella neurobiologia del cervello il rapporto causale tra gli stati cerebrali e gli stati mentali e tra gli stati
cerebrali e i disturbi mentali basta una minima perturbazione come stress,traumi, lesioni ecc… per
determinare un cambiamento sia degli stati mentali che della personalità nel suo complesso.
Negli ultimi 30 anni è stata apprezzata anche l’attività delle cellule della glia la cosiddetta materia bianca
ritenuta per lungo tempo un tessuto di supporto alla materia grigia, ma adesso se ne apprezza la loro funzione
di ausilio negli scambi sinaptici.
Tutti gli eventi patologici che interessano il sistema nervoso prendono il nome di neuropatie e fondano
l’oggetto della neurologia. Codeste come tutte le altre patologie organiche sono caratterizzate dalla presenza
di una lesione accertata ed accertabile. Le neuropatie sono patologie del cervello.
Abbiamo tesi innatiste sull’eziologia delle malattie mentali per quanto riguarda l’ereditarietà genotipica che
l’ereditarietà ambientale, ma queste indagini al massimo possono dimostrare la familiarità o predisposizione
allo sviluppo in determinate circostanze della malattia mentale.
Le teorie organicistiche sull’eziologia delle malattie mentali più accreditate in ambito clinico individuano il
danno nelle alterazioni biochimiche a carico di alcune proteine e aminoacidi nei neurotrasmettitori quali
dopamina,serotonina,acido glutammico, gaba e negli altri di cui non sono ancora noti gli effetti, oltre che nei
recettori sinaptici. I neurotrasmettitori e i recettori consentono il passaggio degli impulsi nervosi
elettrochimici nel SNC con la funzione di eccitare o di inibire l’ attività dei neuroni , la presunta sede della
8lesione si configurerebbe nel difetto della modulazione biochimica dei neurotrasmettitori e dunque nella
costituzione di nuove connessioni sinaptiche neurali da cui deriverebbero i disturbi psicopatologici.
Le psicopatologie non rispondono a tutt’oggi a una eziopatogenesi palese e condivisa cioè manca la presenza
di una lesione accertata ed accertabile.
Gran parte delle malattie sono diagnosticabili con l’ausilio di indagini strumentali che mettono in evidenza la
localizzazione precisa e l’entità del danno come negli organi, negli apparati e nelle neuropatie.
Le lesioni del cervello sono riscontrabili attraverso una serie di tecniche che prevedono le misurazioni
elettriche o le misurazioni elettromagnetiche.
Le misurazioni elettriche sono quelle ottenute attraverso esami come l’ElettroMioGrafia (EMG) o
l’ElettroEncefaloGramma (EEG) ; esse rilevano e registrano la differenza di potenziale muscolo-tendineo o
delle aree cerebrali e consentono di valutare l’attività elettrica di base ossia quella degli impulsi nervosi
espressa in millivolt (mV) per millisecondi (ms).
Le misure elettromagnetiche forniscono immagini elettroniche e digitali delle strutture anatomiche
superficiali e profonde del cervello e sono la MagnetoEncefaloGrafia (MEG), la
TomoGrafiaAssialeComputerizzata (TAC) , la Risonanza Magnetica Nucleare (MRI), Risonanza Magnetica
Nucleare Funzionale (fMRI).
I disturbi della mente in assenza di lesioni certe ed accertabili rendono vano l’ausilio di stumenti diagnostici
l’unica soluzione è la metodica diagnostica del colloquio clinico strutturato con il DSM-IV.
Il DSM è il Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM), cioè il manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali che viene prodotto dall’APA (Associazione degli Psichiatri Americani) dal
1952 è attualmente alla sua sesta versione. Il DSM è quindi il manuale ufficiale che viene usato negli Stati
Uniti dagli psichiatri e da più di 400 mila operatori della salute mentale per effettuare diagnosi psichiatriche,
ma che è largamente in uso anche altrove, Italia compresa. Il suo sistema di classificazione fornisce la
tassonomia psichiatrica standard sulla base della quale possono essere diagnosticati, e di conseguenza curati,
i disordini mentali. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali è stato più volte modificato,
includendo ed eliminando malattie. Consiste in una classificazione "nosografica ateorica assiale" dei
disturbi mentali. I disturbi mentali vengono definiti in base a quadri sintomatologici e questi
ultimi sono raggruppati su basi statistiche.[1]
Il DSM-IV è la quarta revisione di un lavoro di ricerca di mezzo secolo da parte dell'American Psychiatric
Association. Parte della popolarità del DSM-IV è dovuta al fatto che esso si basa su una vasta base empirica
ed è ateoretico cioè si è limitato a identificare le tipologie più frequenti di disturbo psichico e a fotografarne
9gli elementi associati.
Il manuale, secondo gli intendimenti degli autori e dell'APA, dovrebbe essere:
nosografico: i quadri sintomatologici sono descritti a prescindere dal vissuto del singolo, e sono
valutati in base a casistiche frequenziali.
ateorico: non si basa su nessun tipo di approccio teorico, né comportamentista, né cognitivista,
né psicoanalitico, né gestaltico, etc.
assiale: raggruppa i disturbi su 5 assi, al fine di semplificare e indicare una diagnosi standardizzata.
su basi statistiche: si rivolge ad esse in quanto il sintomo acquista valore come dato frequenziale; i concetti
statistici di media, frequenza, moda, mediana, varianza, correlazione, ecc. giungono ad essere essi stessi il
"solco" mediante il quale si valuta la presenza o meno di un disturbo mentale.
Si tratta di un manuale che raccoglie attualmente più di 370 disturbi mentali, descrivendoli in base alla
prevalenza di determinati sintomi.
Il problema della malattia mentale non è un problema esclusivamente biologico o organicista come si
credeva in passato, l'approccio attuale è necessariamente un approccio “multidisciplinare”: la malattia
mentale è in sé stessa multifattoriale e ciò comporta che si tenga conto di tutti i diversi paradigmi di
spiegazione. Il disturbo mentale è il risultato di una “condizione sistemica” in cui, rientrano: il patrimonio
genetico, la costituzione, le vicende di vita, le esperienze maturate, gli stress, il tipo di ambiente, la qualità
delle comunicazioni intra ed extra-familiari, l'individuale diversa plasticità dell'encefalo, i meccanismi
psicodinamici, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi.
La struttura del DSM-IV segue un sistema multiassiale: divide i disturbi in cinque Assi, così ripartiti
ASSE I: disturbi clinici, caratterizzati dalla proprietà di essere temporanei o
comunque non "strutturali" e altre alterazioni che possono essere oggetto di
attenzione clinica: lo psichiatra cerca la presenza di disturbi clinici che possono
essere riconducibili non solo al cervello e al sistema nervoso, ma anche a qualsiasi
condizione clinica significativa che il soggetto può avere (per esempio valuterà se il
10soggetto è
sieropositivo, malato cronico, etc.)
ASSE II: disturbi di personalità e ritardo mentale. Disturbi stabili, strutturali e
difficilmente restituibili ad una condizione "pre-morbosa"; generalmente, ma non
necessariamente, si accompagnano a un disturbo di Asse I, cui fanno da contesto.
Questo asse è divisa in sottoparagrafi
corrispondenti ai diversi disturbi di personalità.
ASSE III: condizioni mediche acute e disordini fisici
ASSE IV: condizioni psicosociali e ambientali che contribuiscono al disordine
ASSE V: valutazioni globali del funzionamento
Generalmente il DSM richiede un cut-off cioè un numero minimo di sintomi raccolti per poter effettuare una
corretta diagnosi.
Di solito il DSM richiede un periodo minimo di presenza dei sintomi per poter effettuare una diagnosi. Altri
criteri di esclusione sono l'età di insorgenza del disturbo ed una diagnosi differenziale rispetto a disturbi che
potrebbero essere accomunati dagli stessi sintomi.
Il DSM è al centro di numerose critiche, dal momento che non a tutti sembra uno strumento adeguato per
valutare la situazione clinica di una persona. Opinioni difformi da quella dell'APA criticano la sua struttura
rigidamente statistica, in particolar modo la scelta dei cut-off che porterebbero a diagnosticare un disturbo
mentale ad una persona con tre delle caratteristiche richieste, allo stesso modo di una persona con sette di
quelle caratteristiche e a scapito di chi ne raccoglie solo due.
Inoltre l'approccio descrittivo del DSM impedisce di individuare qualche riferimento alle caratteristiche
soggettive del paziente, agli effetti della sua esperienza e la sua storia personale.[2]
1.1 L’encefalo
L’encefalo è contenuto all’interno di una solida struttura ossea, la scatola cranica, che lo protegge dagli
agenti esterni e da eventuali traumi. Il suo peso totale è di circa 1350 grammi nel maschio e 1200 grammi
nella femmina, ovviamente ciò non deve far pensare che vi sia una differenza di capacità intellettiva fra i due
sessi, si tratta solamente di uno sviluppo quantitativo diverso in rapporto a una diversa massa corporea totale.
Quest’organo è responsabile del controllo e della regolazione di tutte le attività e funzioni del nostro corpo;
11ad esso giungono gli stimoli (sensazioni e percezioni) raccolti dalla periferia dell’organismo e da esso
partono tutte le risposte motorie trasmesse alla muscolatura. L’encefalo è il centro delle funzioni mentali
superiori, come la memoria ed i processi di ragionamento.
L’encefalo è diviso in tre parti connesse tra loro:
- Cervello;
- Cervelletto;
- Tronco Encefalico;
Il cervello non è una struttura tutta uniforme, ma è diviso in due parti simmetriche gli emisferi destro e
sinistro la cui superficie è ricca di solchi e scissure disposti nell’uomo secondo un piano uniforme, malgrado
una grande variabilità individuale, e sono connessi da una lamina di fibre nervose chiamata corpo calloso. La
forma del cervello è grossolanamente simile a quella di un ovoide, più espanso posteriormente, convesso
nella parte superiore e con la superficie inferiore appiattita. I due emisferi sono entrambi suddivisi in sotto-
parti, denominate lobi: il lobo frontale, il lobo occipitale, il lobo temporale e il lobo parietale. La corteccia
cerebrale è costituita da materia grigia, quella bianca centralmente, costituita da fasce di fibre nervose,
presenta nuclei di altra sostanza grigia che sono importanti centri nervosi. Il mantello cerebrale è
suddivisibile dalle scissure, le più importanti sono: la scissura laterale o del Silvio, il solco centrale del
Roland, la Scissura parieto-occipitale, il solco del cingolo e la scissura collaterale in otto lobi, cinque sulla
superficie esterna degli emisferi, uno sulla superficie mediale, e due su quella inferiore.
Nel cervello abbiamo pure i ventricoli cerebrali che sono quattro cavità comunicanti fra loro, i due laterali
comunicano con il terzo attraverso i forami interventricolari di Monro. Il quarto ventricolo comunica con il
terzo attraverso il l'acquedotto mesencefalico del Silvio. In essi viene prodotto e circola il liquido cerebro-
spinale questo viene prodotto per secrezione dai plessi corioidei. Il liquido dal quarto ventricolo si riversa
nello spazio subaracnoideo attraverso fori: foro di Magendie e forami di Luschka.
12Fig.1 L’encefalo
Le informazioni al cervello e dal cervello vengono trasportate da strutture cellulari il cui prolungamento
assonico entra nella costituzione del midollo spinale.
Il midollo spinale è parte del sistema nervoso, è situato all'interno della colonna vertebrale ed è responsabile
della trasmissione degli impulsi nervosi dal centro alla periferia e viceversa.
Il talamo è il principale centro di comunicazione fra il midollo spinale e gli emisferi cerebrali.
Al di sopra del tronco cerebrale si trova una struttura implicata nel coordinamento motorio, che si chiama
cervelletto.
Il cervelletto rappresenta, dopo gli emisferi cerebrali, la parte dell'encefalo più sviluppata. Al pari degli
emisferi cerebrali esso appare grigio in superficie dove si trova uno spesso strato corticale reso irregolare da
una serie di scissure che lo suddividono in diverse porzioni. L'insieme dei risultati sperimentali ottenuti
nell'animale e nell'uomo sembra giustificare la tendenza attuale a non considerare più il cervelletto come
organo esclusivamente dedicato al controllo dell'equilibrio o dei movimenti volontari. In base all'esistenza di
cospicue connessioni anatomiche con le aree associative e paralimbiche della corteccia cerebrale, entrambe
coinvolte nella organizzazione di funzioni nervose superiori, si è progressivamente consolidata l'ipotesi che il
cervelletto rappresenti una parte importante del sistema distribuito di circuiti neurali dedicati alle funzioni
cognitive.
Il tronco encefalico di forma approssimativamente cilindrica, racchiuso in un canale contenuto all’interno
della colonna vertebrale, contiene numerose strutture e vie nervose molto importanti e connette il cervello al
midollo spinale. Lungo circa 45 cm, ha un diametro di un centimetro circa; è costituito da sostanza grigia
(neuroni) all’interno e da fasci di sostanza bianca situati sulla superficie. La sua funzione principale è quella
13di provvedere all’innervazione del tronco e degli arti; a tale scopo è collegato alla periferia mediante 33 paia
di nervi, detti appunto nervi spinali. Sia l’encefalo sia il midollo spinale sono rivestiti e protetti da membrane
connettivali: le meningi, che possiedono una propria rete di vasi, in cui circola un liquido detto liquor (o
liquido cerebrospinale),che ha la funzione di sostenere e proteggere le strutture nervose; normalmente, il
volume del liquor è di circa 150 cm3.
Fig.2 Midollo spinale
1.2 Le funzioni fisiologiche dell’encefalo
I due emisferi cerebrali non svolgono le stesse funzioni fisiologiche; quello di sinistra è coinvolto nel
linguaggio articolato, nella scrittura, nella memoria delle parole note, nell’associazione tra l’espressione
verbale e le immagini o le idee, quello di destra invece è coinvolto in attività non linguistiche e ha soprattutto
la capacità di cogliere i messaggi visivi nel loro insieme tenendo conto delle valenze emotive. Un ponte di
fibre nervose, che connettono le due metà del cervello, consente lo scambio di informazioni. Per quanto
riguarda ciò che concerne l’attività intellettiva, allo stato attuale delle conoscenze, si ritiene che non esista
un’aria specifica dove insorgano le idee o dove trovi localizzazione la memoria: tali capacità sono piuttosto
ritenute diffuse a tutta la corteccia cerebrale e realizzate attraverso l’associazione tra i diversi centri nervosi
superiori.
14Per comprendere che le nostre facoltà sono localizzate in certe regioni specifiche del cervello ci sono voluti
molti anni di studio.
La prima persona a tentare ciò fu lo scienziato viennese Franz Joseph Gall. All'inizio del XIX secolo, attorno
al 1800, egli fu il primo a cercare di descrivere nei dettagli le suddivisioni del cervello, basandosi su un
approccio sperimentale che oggi si chiama frenologia.
Gall era rimasto colpito dal fatto che i tratti intellettuali di certe persone sembrassero trovare una
corrispondenza nella forma del loro cranio. Ad esempio, alcuni tra i più intelligenti dei suoi amici avevano
una fronte particolarmente prominente. Gall aveva allora immaginato che tale prominenza fosse dovuta al
fatto che l'intelligenza nel cervello fosse localizzata nella regione frontale, e che l'intensa attività intellettuale
dei suoi amici avesse causato il maggiore sviluppo di questa regione del cervello, deformando così il cranio e
rendendo la regione frontale più prominente.
In secondo luogo Gall ha introdotto l'idea che le funzioni sono localizzate. Egli ha proposto localizzazioni di
funzioni cerebrali in modo molto preciso, sostenendo che regioni specifiche controllassero funzioni molto
elaborate, come la riservatezza, l'amore romantico, l'altruismo, la generosità eccetera, essendo ciascuna di
esse associata a una parte diversa del cervello. Aveva costruito una cartografia del cervello nella quale le
tendenze al possesso, a essere parsimoniosi o risparmiatori, tutte questi attributi collegati all'accaparrare,
fossero raggruppati insieme, e che l'idealismo, l'esuberanza, la raffinatezza e il perfezionismo, tutti questi
tratti di ordine superiore, fossero anch'essi localizzati nel cervello.
Così fino a circa il 1860, quando un grande neurologo francese, Paul Broca, riaprì la questione della
localizzazione nel contesto della neurologia del linguaggio.
Broca si imbatté in un paziente con un insolito difetto di linguaggio. Questi problemi del linguaggio sono
chiamati afasie. Sono delle malattie neurologiche che riguardano l'articolazione o l'espressione del
linguaggio, generalmente dovute a incidenti di tipo vascolare. Questo paziente comprendeva perfettamente il
linguaggio, ma era incapace di articolarlo, non riusciva a utilizzare il linguaggio per esprimersi. Aveva
completamente perso la facoltà di esprimersi con il linguaggio, nonostante fosse rimasto capace di
comprenderlo.
Quando questo paziente morì e fu sottoposto ad autopsia, Broca scoprì che questo paziente aveva una lesione
nel lobo frontale. In seguito Broca scoprì altri sette pazienti con un difetto simile: tutti avevano difficoltà a
esprimersi con il linguaggio, ma tutti lo comprendevano perfettamente. Al loro decesso, l'autopsia dimostrò
che ciascuno di essi presentava la stessa identica lesione e che in ciascuno di essi la lesione era localizzata
nell'emisfero sinistro del cervello. Egli annunciò allora uno dei principi fondamentali delle neuroscienze e
cioè che noi parliamo con il nostro emisfero sinistro. La nostra capacità di esprimerci in modo preciso con il
15linguaggio è localizzata nel cervello sinistro. Broca denominò quest'area "area di Broca ", nome col quale
viene tuttora chiamata.
Qualche anno più tardi un neurologo tedesco, Karl Wernicke, compì una seconda scoperta. Scoprì un
paziente che presentava una lesione dell'area parieto-temporale, proprio dove il lobo parietale incontra quello
temporale. Questo paziente aveva un difetto di linguaggio diverso da quello di Broca: i pazienti di Broca
capivano, ma non riuscivano a esprimersi. Questo paziente, invece, era in grado di esprimersi, ma non capiva
niente; quindi quello che diceva aveva ben poco senso.
Al momento dell'autopsia, Wernicke vide che la lesione si trovava ancora una volta nell'emisfero sinistro a
livello del lobo parieto-temporale. Egli chiamò questa zona "area di Wernicke".
Il merito più grande di Wernicke, tuttavia, non si limita a questa scoperta, ma al fatto di aver combinato le
scoperte proprie e quelle di Broca nello sviluppo di una teoria del linguaggio.
La corteccia occipitale è il luogo in cui l'informazione visiva entra nel cervello, mentre l'area temporale è il
luogo d'entrata dell'informazione uditiva. Quando si sente qualcuno parlare, o quando si legge qualcosa, le
informazioni entrano all'interno di sistemi sensoriali specifici e quindi vengono portate nell'area di Wernicke,
dove sono tradotte in una sorta di codice neurale del linguaggio. Questo codice viene poi inviato all'area di
Broca, attraverso una via nervosa nota come fascicolo arcuato. Successivamente, nell'area di Broca, le
informazioni vengono tradotte in linguaggio, che può poi essere articolato e pronunciato.
Wernicke ha dunque ripreso l'idea della localizzazione delle funzioni ed elaborandola sostenne che una
funzione complessa come il linguaggio non è controllata da una sola regione, ma dalla combinazione di più
regioni.
Del cervello abbiamo una buona conoscenza dello sviluppo, abbiamo una buona conoscenza del modo in cui
funzionano le cellule e dei sistemi di cellule, ma quello che ancora non si è riusciti a capire sono i processi
della mente; le neuroscienze cognitive si domandano infatti quale sia la struttura della mente.
Fig.3 Area di Broca e di Wernicke
1.3 Il sistema nervoso
16Il sistema nervoso è costituito da un insieme complesso di organi centrali racchiusi all’interno della cavità
cranica e del canale vertebrale e da organi periferici predisposti alla funzione di raccogliere gli stimoli interni
ed esterni e di inviare gli impulsi alle cellule effettrici.
Le attività degli organi del corpo umano sono regolate da un sistema di cellule dette neuroni. Il sistema
nervoso è suddiviso in sistema nervoso centrale costituito dall’encefalo e dal midollo spinale e in sistema
nervoso periferico che è costituito dai nervi cranici dai nervi spinali e dai gangli.
Fig.4 Il sistema nervoso
Il neurone è l’unità fondamentale del sistema nervoso, il più piccolo elemento capace di generare impulsi
nervosi. Esso è costituito da un corpo centrale dalla cui superficie si dipartono i dendriti e l’assone. Dal
punto di vista fisiologico, invece, rappresenta una cellula in grado di generare e trasmettere un impulso
elettrico. Come tutte le cellule dell’organismo, il neurone, possiede un nucleo ed un citoplasma che gli
permettono di svolgere la sua attività. Il sistema nervoso è formato da circa diecimila milioni di neuroni.
17Fig.5 Il neurone
I neuroni sono cellule specializzate che hanno come proprietà: l’eccitabilità e la conducibilità
eccitabilità: è la capacità in seguito ad uno stimolo di modificare la differenza di potenziale
transmembrana.
conducibilità: è la capacità di condurre gli impulsi elettrici lungo le fibre nervose.
I neuroni hanno forme e dimensioni diverse ma si possono classificare in 3 tipi principali:
neuroni motore: trasmettono gli impulsi dal sistema nervoso agli organi periferici (effettrici)
neuroni associativi: servono a collegare tra loro altri neuroni.
neuroni sensoriali (o cellule bipolari o cellule T): hanno due prolungamenti rivestiti di mielina, uno
dei quali conduce l’impulso verso il corpo cellulare (cioè verso l’interno) e l’altro dal corpo cellulare
verso l’esterno( afferenti).
Lo spazio di comunicazione fra neuroni e fra questi e le cellule effettrici è chiamato sinapsi.
L’impulso per poter essere trasmesso ha bisogno di particolari sostanze chiamate: neurotrasmettitori.
Vi sono diversi tipi di neurotrasmettitori: l’acetilcolina, l’adrenalina, la noradrenalina, ecc…
18Fig.6 La sinapsi
Il sistema nervoso è bipartito in sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico.
Il sistema nervoso centrale è costituito dall’ encefalo e dal midollo spinale.
Il sistema nervoso periferico comprende i nervi cranici che derivano dal cervello e i nervi spinali emergenti
dal midollo spinale con i gangli.
I nervi, cranici o spinali, svolgono una funzione di collegamento trasportano dal centro alla periferia gli
stimoli originati dal sistema nervoso centrale necessari alla contrazione muscolare; in direzione opposta,
ovvero dalla periferia al centro, portano avanti gli stimoli sensoriali raccolti dai recettori, e riguardanti, per
esempio, la posizione del corpo nello spazio, il dolore, la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto.
Il Sistema Nervoso Periferico si suddivide in due parti principali:
Sistema Nervoso Somatico, responsabile delle risposte volontarie;
Sistema Nervoso Autonomo, o Vegetativo, responsabile delle risposte involontarie.
Il Sistema Nervoso Somatico è costituito da fibre nervose periferiche che inviano informazioni sensitive al
Sistema Nervoso Centrale e fibre nervose motorie che si portano ai muscoli scheletrici.
19Il Sistema Nervoso Autonomo e' suddiviso in due parti ad azione antagonista:
Simpatico (toracico - lombare);
Parasimpatico (craniosacrale).
Il Sistema Nervoso Autonomo è costituito dal sistema nervoso simpatico e dal sistema nervoso
parasimpatico.
Il Simpatico nasce nel midollo spinale. Stimola il cuore, dilata i bronchi, contrae le arterie e inibisce
l'apparato digerente, prepara l'organismo all'attività fisica.
Il Parasimpatico è antagonista al sistema simpatico ed è un sistema che promuove la digestione, la peristalsi,
al sonno e al riposo. sono molto. Nel cuore, il Parasimpatico ha il compito di diminuire i battiti cardiaci, la
pressione, e provocare una vasocostrizione delle coronarie.[3]
20CAPITOLO 2
Premessa: che cosa è l’ ATTACCO DI PANICO
L’ attacco di panico è un episodio di improvvisa ed intensa paura provocato da una forte ansia
accompagnato da sintomi somatici e cognitivi come palpitazioni, tremore, sensazione di soffocamento,
vertigini, dolore al petto, nausea, paura di morire, paura di impazzire, brividi, vampate di calore e nei casi più
estremi svenimento. La durata dell’attacco di panico è di circa trenta minuti.
Chiunque abbia provato un attacco di panico lo definisce come un’esperienza terribile, improvvisa,
indescrivibile che lascia dentro di sè la paura di un nuovo episodio.
L’episodio dell’attacco di panico può rimanere isolato o ripetersi nel tempo, nel secondo caso, possiamo
parlare di disturbo di panico ( DAP ) .[4]
2.1 Il termine “panico”
Il temine panico deriva dal Dio Pan, una divinità ellenica parte uomo e parte capra, che il mito lo vuole
figlio di Zeus e della ninfa Callisto, mentre un’altra versione lo vuole figlio di Penelope e di tutti i suoi
pretendenti, con cui avrebbe avuto rapporti durante l’attesa del marito.
Pan era un Dio solitario non risiedeva sull’Olimpo, ma viveva specialmente nei boschi e con la sua voce
spaventosa incuteva in chi la udiva una grande paura, infatti panico da Pan per questo motivo.
Secondo Omero la versione più accreditata di Pan era che egli nacque dall’unione di Hermes e della ninfa
Driope, ninfa della quercia; la madre lo abbandonò subito dopo la nascita poiché il suo aspetto era talmente
brutto che ne rimase terrorizzata; Hermes allora lo raccolse e dopo averlo avvolto in una pelle di lepre, lo
portò sull’Olimpo per far divertire gli dei, causando così l’ilarità di Dionisio, che lo accolse nel suo seguito.
È raffigurato con gambe e corna caprine, con zampe irsute e zoccoli, mentre il busto è umano, con due corna
in fronte, il naso schiacciato, il volto ornato da una barba caprina e dotato di un’espressione terribile, a
dispetto della quale Pan è un dio gioviale e generoso, sempre pronto ad aiutare quanti chiedono il suo aiuto.
21Fig.7 Dio Pan
Racconta Plutarco che sotto il regno di Tiberio, un vascello romano si trovò a passare nei paraggi di un’isola
del mar Egeo, quando il vento cessò improvvisamente e nel silenzio si udì una voce gridare: "Il Grande Pan è
morto". A quella notizia da ogni parte dell’isola scoppiarono pianti, gemiti e singhiozzi di cui non si seppe
mai la provenienza.[5]
2.2 Che cosa è il disturbo di panico
Il disturbo di panico è incluso nel gruppo dei disturbi d’ansia, la caratteristica principale è la presenza di
attacchi di panico ricorrenti ed inaspettati seguiti dalla preoccupazione persistente di avere un altro attacco di
panico. In genere prima di rivolgersi ad uno psichiatra ci si rivolge a vari medici in primis al cardiologo per
scongiurare problemi cardiaci, quindi al pneumologo e così via finché si arriva come ultima spiaggia allo
specialista. Lo psichiatra dopo un colloquio ed una diagnosi differenziale diagnostica il tipo di problematica
del paziente nel nostro caso si tratta del: disturbo di panico (DAP).
Il soggetto affetto da DAP entra pian piano in un circolo vizioso perché ha sempre paura dell’arrivo di un
nuovo attacco di panico, le relazioni sociali risultano compromesse,è incapace di uscire da solo, incapace di
stare in casa da solo, incapaci di dormire da solo,diventa dipendente dagli altri. A stare male non è soltanto
chi ha il disturbo di panico, ma anche i familiari del soggetto affetto da DAP perché non riescono in un
primo momento a capirlo ed aiutarlo e successivamente devono modificare la loro vita di per aiutare la
22persona che sta male. Il termine specifico della paura perenne di rimanere da soli, di spostarsi, cioè di tutti gli
evitamenti è: agorafobia.
È inevitabile il senso di frustrazione per il soggetto affetto da DAP e ciò deriva dal fatto di dipendere dagli
altri, egli si sente depresso, scoraggiato, sfiduciato, apatico, pessimista, con sensi di colpa, infelice. Questi
stati d’animo vengono definiti demoralizzazione secondaria perché non sono dovuti ad una depressione vera
e propria, ma sono soltanto la conseguenza del fatto che il soggetto che soffre di attacchi di panico ha come
conseguenza una limitazione del suo benessere psico-fisico e nelle relazioni sociali e con l’ambiente. Tutto
ciò scompare quando si guarisce dal DAP ritornando ad essere di buon umore, attivi, fiduciosi, autonomi.
C’è da precisare il significato di due termini cioè guarire ed eliminare. Guarire non significa eliminare del
tutto un problema, ma riuscire a stare bene anche avendolo, convivere con esso, questa fase negli attacchi di
panico è quando si sta bene ma si è ancora in terapia. Eliminare significa proprio il non avere più quel
determinato problema in questo caso degli attacchi di panico quando non si è più in terapia di nessun tipo e
non si hanno ricadute
Esiste anche il DAP che sfocia in vera e propria depressione ed in questi casi la sofferenza e le difficoltà per
chi ne è affetto sono maggiori, ma le terapie usate per il DAP aiutano anche per la depressione.
2.3 Differenza tra paura,ansia e panico
La paura è uno stato d’animo giustificato da situazioni reali che costituiscono un pericolo, essa dipende da
un fattore esterno che se non c’è questo elemento reale non c’è nemmeno essa. Se questa sensazione di paura
si prova quando non c’è un elemento reale o il pericolo è inferiore a ciò che percepisce il soggetto si parla di
ansia. L’ansia invece dipende da un fattore interno ed è molto difficile evitarla, essa è un’esperienza molto
diffusa, ma non sempre patologica. Non tutte le persone che provano ansia si ammalano di questo disturbo o
devono fare una terapia per eliminarla. In alcune situazioni l’ansia può essere utile per migliorare le proprie
prestazioni, se invece essa è troppo bassa si può anche avere una prestazione inferiore alle proprie effettive
capacità. Quando l’ansia invece è eccessiva siamo di fronte alla vera e propria patologia che compromette la
propria vita provocando un forte disagio. Il soggetto ansioso si sente sempre in pericolo: è una percezione
difficile da poter descrivere. Gli stati d’ansia comprendono anche gli attacchi di panico. Una crisi di ansia ha
caratteristiche comuni in varie situazioni quali irrequietezza, indecisione, gesticolazione, tachicardia,
aumento della pressione arteriosa, sudorazione eccessiva, tremore, apprensione, attesa di eventi spiacevoli. Il
soggetto ansioso è sempre angosciato ed ha molta immaginazione e rimugina sempre sulle cose che gli
accadono trasformando un evento reale in immaginario fonte di interrogativi e preoccupazioni. La persona
ansiosa è pessimista e tutto ciò si ripercuote sulla sua visione del mondo e nel suo comportamento sfociando
in ipervigilanza, sfiducia in sé e preoccupazione eccessiva ed ella è consapevole di tutto ciò. Tutto questo si
23manifesta con un comportamento previdente, adotta precauzioni eccessive per tutto ciò che deve fare. La
mente dell’ansioso è in continua “ebollizione” fin dal risveglio pensa agli eventi della giornata, se avrà
abbastanza tempo, se avrà degli imprevisti, se avrà dimenticato a fare qualcosa. Egli per tranquillizzarsi in
genere usa dei mezzi come amuleti, ricordi dell’infanzia, medaglioni o altri oggetti che gli trasmettono
sicurezza e/o conforto. È fondamentalmente superstizioso, si affida a scongiuri, formule magiche, ogni cosa
acquista un significato o diventa un segno.
In famiglia l’ansioso si preoccupa eccessivamente per la salute ed il benessere di tutti.
La persona con ansia patologica si abbandona spesso all’uso di alcool e/o stupefacenti perché egli si sente
inadeguato alla realtà che lo circonda. Infatti sono persone facilmente suggestionabili, vulnerabili e
dipendenti dagli altri. L’ansia è comune alla maggior parte degli uomini e delle donne in egual modo nel
mondo, si manifesta nelle classiche forme di timore ed inquietudine ed è presente a tutte le età dai bambini,
agli adolescenti, agli adulti. Così anche l’attacco di panico è in egual modo distribuito come patologia e ne
soffre una buona percentuale della popolazione mondiale. L’età di insorgenza è in genere intorno ai 25 anni
con casi di deviazioni intorno ai 6-9 anni. La persona colpita da un attacco di panico ne sa riferire l’inizio e
la fine in modo facilmente individuabile, mentre l’ansia ha un inizio ed una fine non precisabili.
Riconosciamo tre tipi di attacchi di panico caratteristici con differenti relazioni tra l’esordio dell’attacco di
panico e la presenza o assenza di fattori scatenanti situazionali:
Attacchi di panico inaspettati (non provocati) nei quali l’esordio non è associato con un fattore
scatenante situazionale cioè si manifesta spontaneamente a “ciel sereno”.
Attacchi di panico causati dalla situazione (provocati) nei quali l’esordio non è associato ad un
fattore scatenante situazionale ma si manifesta subito durante l’esposizione o nell’attesa dello
stimolo o del fattore scatenante situazionale.
Attacchi di panico sensibili alla situazione che hanno più probabilità di manifestarsi in seguito
all’esposizione allo stimolo o al fattore scatenante situazionale, ma non sono invariabilmente
associati con lo stimolo e non si manifestano necessariamente subito dopo l’esposizione.
24L’attacco di panico può anche manifestarsi con modalità atipiche: l’attacco abortivo è caratterizzato da tutti i
sintomi iniziali dell’attacco di panico tipico, la sintomatologia insorge e progredisce con la stessa modalità,
ma si arresta poi in fase precoce, senza raggiungere il picco estremo di gravità che è un genere caratterizzato
dalla paura di morire o di impazzire o di perdere il controllo.
2.4 Definizione dell’attacco di panico
Nella quarta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) l’attacco di panico
viene definito come un periodo preciso di intensa paura o disagio durante il quale quattro o più dei seguenti
sintomi si sono sviluppati improvvisamente ed hanno raggiunto il picco nell’arco di 10 minuti :
1. Palpitazioni, cardiopalmo o tachicardia: le palpitazioni fanno temere al paziente di poter avere un
infarto e questo aumenta la paura ed il bisogno di cercare un medico; in realtà il rischio di un infarto
durante una crisi di panico è molto scarso. La tachicardia è provocata da una scarica di adrenalina
che fa aumentare la quantità di sangue che arriva al cuore.
2. Sudorazione: la sudorazione, tipico sintomo ansioso, è abbondante soprattutto al palmo delle mani,
ma anche in altre zone del corpo.
3. Tremori: fini o grandi scosse
4. Dispnea o sensazione di soffocamento: in forma più lieve questo sintomo si può manifestare come
intolleranza per gli ambienti chiusi (claustrofobia), per le finestre chiuse, si ha sempre il bisogno di
tenere un po’ la porta aperta, la finestra o il finestrino della macchina aperti. Anche l’intolleranza ai
vestiti stretti ed attillati può essere interpretata come sintomo agorafobico.
5. Sensazione di asfissia o mancanza d’aria: la sensazione è quella di non riuscire a respirare
profondamente, si tende perciò ad aumentare la frequenza del respiro (polipnea).
6. Dolore o fastidio al petto o sensazione di oppressione toracica: non è causato da un imminente
infarto, ma dalla contrazione dolorosa dei muscoli intercostali.
7. Nausea o disturbi addominali.
8. Sensazione di vertigini, di instabilità, di testa vuota o di svenimento: sono sintomi legati alla
polipnea .
9. Derealizzazione (sensazione di irrealtà) o depersonalizzazione (essere distaccati da sé stessi).
10. Paura di perdere il controllo delle proprie azioni o di impazzire.
11. Paura di morire.
2512. Parestesie (sensazione di torpore o di formicolio): le parestesie soprattutto intorno alle labbra ed alle
mani, sono provocate dall’aumento della frequenza respiratoria la cosiddetta “sindrome di
iperventilazione”. Questo aggrava ancora di più l’ansia poiché si teme di poter avere una paralisi. E’
sufficiente respirare più lentamente e più profondamente o respirare per qualche secondo in un
sacchetto di carta per far sparire il formicolio.
L’ordine sopra seguito nel riportare i sintomi riflette la frequenza con cui vengono solitamente riferiti.
L’attacco di panico è un sintomo aspecifico cioè può far parte di diversi disturbi. È il sintomo principale del
DAP, ma non è esclusivo di questo.
Dinanzi ad un paziente con un attacco di panico prima di concludere che soffre di DAP è bene fare una
diagnosi, la cosiddetta diagnosi differenziale.
Indipendentemente dall’età del soggetto o dai fattori di rischio deve essere raccolta una storia medica e
devono essere eseguiti degli esami quali ECG ed esami di laboratorio di routine (esami delle urine,
emocromo, glicemia, calcemia, ormoni tiroidei ecc..) per accertarsi dello stato di salute. Nell’esame delle
urine è importante effettuare l’esame della presenza di sostanze psicoattive.
Un disturbo d’ansia con attacco di panico legato ad una condizione medica generale comprende l’attacco di
panico dovuto all’azione di una malattia medica. Esistono numerose malattie mediche che possono
provocare un attacco di panico e questo non significa essere affetti da DAP. Infatti la diagnosi di DAP
richiede che le crisi non siano provocate da una malattia fisica. Le malattie fisiche che possono scatenare un
attacco di panico sono:
L’epilessia temporale che provoca crisi improvvise di attacchi di panico, ma qui l’ECG è
chiaramente alterato, invece nel DAP è normale.
Malattie della tiroide tutte le malattie che provocano ipertiroidismo o ipotiroidismo.
Feocromocitoma è un tumore caratterizzato da crisi improvvise di iperproduzione di adrenalina e
quindi si avverte un sintomo simile ad un attacco di panico.
Altri disturbi endocrinologici, come ad esempio l’ipoglicemia. Queste malattie fisiche vengono
facilmente diagnosticate con gli esami di laboratorio.
Un attacco di panico può essere provocato anche dall’assunzione di sostanze, ma queste non causano il DAP.
Ciò significa che l’attacco di panico è correlato all’uso di una determinata sostanza. Il disturbo è dovuto
all’assunzione o all’astinenza, ma scompare quando termina l’effetto della sostanza. Quindi si prende in
causa l’assunzione e l’astinenza di sostanze.
26Per quanto riguarda l’assunzione possono provocare un attacco di panico sostanze farmacologiche
(cortisonici, tiroxina, insulina in dosi eccessive, broncodilatatori, pillole dietetiche ecc..), sostanze psicoattive
(caffeina, bevande alcoliche, anfetamina e simili, cocaina, cannabis, allucinogeni, inalanti ecc…), sostanze
tossiche (sostanze volatili come vernici, benzina ecc.., anidride carbonica, gas nervini, insetticidi organo
fosforici che si usano in agricoltura).
Invece, per quanto riguarda l’astinenza da quelle sostanze che provocano un attacco di panico si deve
ricordare l’astinenza da sostanze farmacologiche ( sedativi, ipnotici e ansiolitiche) oppure dalle sostanze
psicoattive (bevande alcoliche, cocaina ecc…).
C’è da precisare che le sostanze farmacologiche provocano l’attacco di panico se sono assunte in dosi
eccessive o errate, invece le sostanze psicoattive, il gruppo della caffeina e delle bevande alcoliche, possono
provocare un attacco di panico, ma devono essere assunte a dosi eccessive. Le droghe possono provocare un
attacco di panico anche a dosi non eccessive. Le sostanze tossiche raramente provocano un attacco di panico.
2.5 Fattori di rischio
Un fattore di rischio importante nel DAP è rappresentato dai disturbi del sonno. Di per sé un disturbo di
sonno non può causare il DAP, ma molte persone durante il sonno hanno attacchi di panico della stessa
intensità di quelli diurni. La conseguenza è la difficoltà ad addormentarsi per la paura di avere degli attacchi
di panico. L’insonnia e la deprivazione di sonno, indipendentemente dalla causa, possono provocare nei
giorni successivi un aumento della frequenza e della gravità degli attacchi di panico.
Un altro fattore di rischio per il DAP sono gli eventi stressanti. Essi non causano direttamente il DAP ma
possono facilitarne l’esordio: in modo particolare i gravi eventi drammatici come la morte di una persona
cara, oppure una grave malattia, un grave incidente ecc…
Se questi eventi si verificano quando il soggetto è affetto da DAP la sintomatologia nella maggior parte dei
casi aggrava, ma in molti casi pazienti affetti da DAP riescono a gestire meglio una situazione di un evento
drammatico che quelle obiettivamente non pericolose, ma che essi vivono come tali.
Gli eventi traumatici sono un altro fattore di rischio, come la perdita di un rapporto affettivo o di
separazione. L’evento di separazione o perdita nei pazienti con il DAP non và inteso come evento
traumatico, ma piuttosto come un evento significativo di insicurezza.
I fattori ambientali climatici non causano in sé il DAP, ma può avvenire un attacco di panico in coincidenza
con una determinata condizione climatica. Le possibilità dell’attacco di panico possono essere in coincidenza
casuale o l’evento meteorologico viene vissuto in modo angosciante, capita che in base alla temperatura si
verificano degli eventi corporei come ad esempio l’ipotensione se c’è troppo caldo. La persona accusando
27Puoi anche leggere