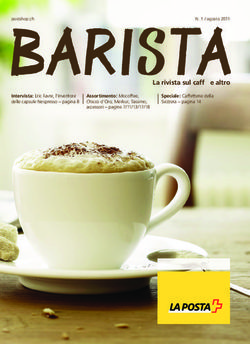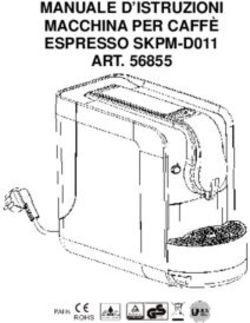Alzheimer Caffè: la ricchezza di una esperienza
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Alzheimer Caffè:
la ricchezza
di una 2012
esperienzaIl volume è stato redatto da Marco Trabucchi Professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università Tor Vergata. Direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia. I capitoli 2 e 3 sono stati curati da Stefania Amico Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia Il Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG) è una libera associazione con personalità giuridica senza fini di lucro costituitasi il 27 luglio 1988. Nasce dall’intenzione di alcuni laureati, operanti da tempo nell’area della gerontologia e della geriatria, di dare impulso a studi, ricerche ed attività rivolte ai problemi epidemiologici, clinici e socio- assistenziali nella terza età.
Sommario
Introduzione
La demenza:
un futuro di speranza? pag. 07
Capitolo 1
L’organizzazione dei servizi per le
persone affette da deficit cognitivo pag. 19
Capitolo 2
L’Alzheimer Caffè
Prospettive di lavoro: dimensioni,
organizzazione, operatori,
programmi e costi pag. 39
Capitolo 3
L’Alzheimer Caffè
Benefici per la persona affetta da
demenza e la sua famiglia pag. 57
Capitolo 4
Un modello di servizio a basso
costo e ad elevata utilità sociale pag. 67
Conclusioni 6
Per una sussidiarietà
frugale pag. 83
pagine 2_3introduzione
Maurizio
Carrara
Presidente
UniCredit
Foundation
N ello scenario attuale la fragilità sociale si fa più vicina, le problematiche
legate all’inclusione e alla partecipazione nel territorio non sono più
esclusive delle aree in via di sviluppo, ma toccano direttamente le nostre
comunità. A causa del disgregarsi dei vecchi modelli assistenziali, infatti,
emergono nuovi gruppi a rischio di esclusione, fra i quali gli anziani.
Coniugando le esigenze reali a modelli teorici di successo, UniCredit
Foundation ha promosso varie formule di intervento, al fine di accompagnare
la persona anziana nella quotidianità e creare le premesse per una migliore
qualità di vita. Per questo motivo, l’impegno della Fondazione pone al centro
i bisogni concreti della Terza Età, quali la disponibilità di cure adeguate per
le cosiddette malattie della longevità e la creazione di reti di servizio per
l’anziano e la sua famiglia.
La pubblicazione “Alzheimer Caffè: la ricchezza di una esperienza” è l’esito
di un percorso biennale, dedicato allo sviluppo e alla diffusione di spazi
terapeutici innovativi – gli Alzheimer Caffè - basati sull’incontro e lo scambio
di esperienze tra le persone affette dalla patologia, familiari ed esperti.Oltre a garantire un sostegno socio-economico ad alcuni dei centri già
operativi, il progetto ha supportato l’attività del Gruppo di Ricerca Geriatrica
di Brescia, coordinato dal professor Marco Trabucchi, nella definizione delle
linee-guida per la costituzione di Alzheimer Caffè. Oggi, questo modello è
disponibile per gli enti locali e le associazioni di volontariato che intendono
replicare le best-practice a livello locale.
La lettura di questo testo, che raccoglie esperienze dirette tratte dal
territorio, offre spunti concreti su come attivare forme di auto-aiuto efficaci a
partire da un impegno generoso e volontario.
Buona lettura,
Maurizio Carrara
Presidente UniCredit FoundationLa demenza: Introduzione
un futuro di speranza?
Lo scenario 10
Le ricerche e il futuro 14
Lo studio sugli Alzheimer Caffè 15
pagine 7_7alzheimer caffÈ:
la ricchezza di una esperienza
INTRODUZIONE
La demenza:
un futuro di speranza?
ALZHEIMER
“È dolcissima” dicevi
Sfidando la nostra incredulità
Della compagna di una vita
Che supina nel suo giaciglio
Volgeva lenta alla meta
Del suo impenetrabile esilio.
Poi, lei avviata all’eternità,
Al sommesso: “È la fine di un calvario”
Rispondevi: “Non è che l’inizio”.
Anche tu, ora,
Condividi quell’amaro destino
Ricurvo su una sedia addossata al muro,
Come a proteggere il tuo scrigno
Di glorie esibite e ripudiate miserie
Affondate nell’insondabile mistero
Di un incessante presente
Di cui non conservi memorie
Né più coltivi progetti.
Eppure ...
Ancora un profilo amico
T’illumina di un disarmante sorriso
E la carezza di amorevoli parole
Intessute del pane dei ricordi
Risveglia l’eco di perdute emozioni
A inumidirti l’occhio e farti dire,
Scompaginando le nostre certezze,
“Grazie per una giornata diversa”.
Amaro destino
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?Abbiamo scelto di iniziare questa pubblicazione su nuove modalità per aiutare
la vita delle persone affette da demenza e delle loro famiglie con la poesia di
Alceo Gianani, perché nella parte conclusiva del testo la persona ammalata
inaspettatamente esprime un sentimento di riconoscenza verso chi gli è vicino
(“grazie per una giornata diversa”). Potremmo affermare - senza timore di
retorica - che i versi sono la più bella, implicita conferma del ruolo degli Alzhei-
mer Caffè. Questi infatti fanno crescere momenti di “amorevoli parole”, che
“possono far risuonare una risposta anche dalla voragine misteriosa della mente
di chi è chiuso nel proprio enigma e che non ha più la capacità o la speranza di
poter realizzare una relazione”. Queste ultime sono considerazioni prese dal
commento di Franca Grisoni alla poesia di Gianani e pubblicate sul n.1 del 2011
di Psicogeriatria. Infatti ogni fascicolo della rivista dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria si conclude con una pagina poetica, per riaffermare che talvolta
(spesso) la realtà della sofferenza può essere meglio compresa se vicino alla
scienza e alle sue certezze si colloca anche una visione del mondo che tende
ad unificare la realtà e a mostrarne nel profondo tutte le diverse dimensioni. In
quest’ottica si colloca il volume che analizza le attività degli Alzheimer Caffè;
la loro utilità non può infatti essere dimostrata solo con i numeri, ma anche - e
soprattutto - attraverso l’esperienza che diviene impegno realizzato.
“A massive amount of personalized care”. Questa dichiarazione - che tradotta
in italiano perde un po’ della sua incisività (“una grande quantità di cure per-
sonalizzate”) - è stata lanciata da un famoso medico al fine di spiegare l’at-
mosfera generale nella quale si dovrà svolgere nei prossimi anni la cura delle
persone anziane, in particolare quelle affette da alterazioni della cognitività.
L’affermazione vuole essere allo stesso tempo un atto di realismo (le persone
da assistere saranno sempre di più, come indicato dalla demografia e dall’epi-
demiologia) ed un impegno a favore degli anziani fragili. Nonostante tutte le
oggettive difficoltà culturali, organizzative, economiche, sono la medicina e i
sistemi assistenziali ad assumersi la responsabilità di fornire un servizio adegua-
to agli specifici bisogni della singola persona.
Assumiamo questa frase, assieme alla poesia di Gianani, come leitmotiv del
libro, perché l’accostamento tra realismo, impegno e valutazione complessiva
della persona umana che soffre è un aspetto centrale per il futuro dell’assisten-
za a chi invecchia. Infatti risponde ad un preciso invito che è stato fatto tante
volte da più parti e recentemente confermato sulla prima pagina della rivista
medica Lancet (“sarebbe un grave errore continuare ad interpretare il prolun-
gamento della vita umana avvenuto in questi anni come un evento negativo,
mentre deve essere vissuto positivamente, anche perché è la dimostrazione
significativa delle potenzialità della natura”). Sarà un preciso dovere di chi ha
responsabilità di leadership culturale far comprendere diffusamente la portata
di queste affermazioni e le loro ricadute sui comportamenti individuali e col-
pagine 8_9lettivi; non è operazione facile, perché in questo campo la retorica negativa è
sempre viva, ma è irrinunciabile. Però la tendenza dei nostri giorni a rispettare
l’autonomia di chi riceve le cure è irreversibile (nel caso delle demenze l’auto-
nomia è esercitata prevalentemente dal caregiver, a nome della diade curata);
quindi i servizi devono porre l’ammalato nel ruolo di attore primario, come
avviene negli Alzheimer Caffè.
Sulla stessa lunghezza d’onda, quando ci si avvicina alle demenze è necessario
abbandonare le espressioni negative che solitamente accompagnano la descri-
zione della malattia; è invece importante riaffermare che l’identità umana
dell’ammalato non si perde fino alla morte e che il lavoro di cura è importante
perché impedisce che alla fine muoia un fantasma. L’assistenza capace e amo-
revole dà senso alla vita dell’altro, attraverso una sorta di trasferimento di
umanità tra chi dona tempo e cure e chi è curato. Ma anche i primi in questo
modo realizzano la propria vita e le danno senso. L’atto di donazione non è mai
a senso unico.
Lo scenario
Un’analisi realistica dello scenario che accompagna la vita delle persone affet-
te da demenza si deve fondare anche su considerazioni rispetto al momento at-
tuale, caratterizzato da una forte crisi economica, che si riflette soprattutto sui
servizi alle persone fragili. Nei prossimi anni avverranno dei cambiamenti che
oggi non riusciamo nemmeno a prevedere nelle loro dimensioni e che pongono
continue domande senza risposta. La crisi del welfare fino a dove colpirà? Vi
saranno alcuni settori privilegiati, perché caratterizzati da una maggiore quan-
tità di sofferenza e di difficoltà, che saranno almeno in parte risparmiati dai
tagli? Come potrebbero essere organizzati servizi low cost, senza rinunciare alla
qualità assistenziale? Quali alternative vi saranno alla copertura dei servizi da
parte della collettività come avviene oggi? Si ritornerà ad istituzioni finanziate
dalla generosità collettiva come nell’Ottocento? I cambiamenti negli stili di vita
degli ultimi decenni, che valorizzano l’individualismo e riducono l’importanza
della pietas sociale, saranno compatibili con una ripresa delle responsabilità
verso le persone meno fortunate? La tematica è seria e ampia, perché coinvolge
dinamiche che interagiscono tra di loro in maniera più complessa rispetto ad
un passato che sarebbe banale cercare di far rivivere; è indispensabile quindi
affrontarla in una prospettiva radicalmente diversa da quella abituale.
È, però, anche necessario pensare anche a soluzioni nell’immediato, perché
la crisi non permette tempi lunghi; ipotizzare percorsi che da una parte diano
la possibilità di risparmiare e dall’altra di organizzare servizi a basso costo è
quindi un dovere per evitare che proposte di valore siano prive di fondamento
concreto a causa della mancanza di adeguati finanziamenti e che quindi appa-
iano irrilevanti. La significativa riduzione avvenuta nel 2011 delle prestazioni
ambulatoriali e diagnostiche dopo l’introduzione di nuovi ticket può essere let-
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?ta sia come campanello d’allarme rispetto al dubbio che il cittadino rinunci per
ragioni economiche a curarsi, sia come una riduzione di prestazioni inutili. In
ogni modo, qualsiasi sia l’interpretazione del fenomeno è in sintonia con il sem-
pre maggiore ricorso a soluzioni a basso costo e ad alto valore aggiunto come
quelle offerte dagli Alzheimer Caffè. Ad esempio, è doveroso in questa prospet-
tiva compiere un’analisi critica dei costi che oggi sono generati dall’assistenza
ospedaliera, per identificare possibili aree di risparmio da indirizzare verso l’as-
sistenza continuativa alle persone anziane colpite da malattie croniche come la
demenza. Una seria spending review in questo ambito potrebbe permettere di
risparmiare in tempi relativamente brevi almeno il 10% della spesa totale, per
un ammontare a circa 5-6 miliardi di euro. Fino ad ora in questo campo non è
stato fatto nulla di realmente incisivo; anche dove si è decisa la chiusura dei
piccoli ospedali non si è avuto il coraggio di compiere atti di vero cambiamento,
per cui sono rimasti in vita servizi di scarsa qualificazione, senza un reale van-
taggio per l’assistenza nel territorio. Ma non è solo la problematica dei piccoli
nosocomi che va considerata; infatti nell’organizzazione complessiva dell’assi-
stenza ospedaliera sarebbe necessario intervenire per ridurre doppioni, proli-
ferazioni di centri di costo, in particolare rispetto alle tecnologie più moderne,
veri e propri sprechi indotti spesso da esigenze clientelari. Qualcuno sostiene
che la pressione sociale sui grandi ospedali e sulle tecnologie - spesso pubbli-
cizzate come miracolose - impedirebbe una diversa distribuzione della spesa.
A questo riguardo è importante ricordare il ruolo della politica, che non deve
essere trainata da scelte più o meno irrazionali, ma dovrebbe assumere la guida
dei cambiamenti per indirizzarli e raccogliere attorno ad essi il consenso de-
mocratico. Un esempio emblematico a questo proposito è costituito dalla spesa
per farmaci ospedalieri che è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni; attorno
a questa tematica si sviluppano motivazioni di carattere scientifico, clinico,
economico, organizzativo, etico. Solo una guida politica forte sarebbe in grado
di indicare un percorso, che sia allo stesso tempo rispettoso delle esigenze
del singolo e della collettività, senza piegarsi a pressioni non sempre limpide.
Per fare un esempio - che mi auguro sia interpretato correttamente dal let-
tore - alcuni trattamenti antitumorali condotti in ambito ospedaliero costano
30-40.000 € all’anno e inducono un incremento della sopravvivenza di qualche
mese; la permanenza di un anziano non autosufficiente in una residenza per
un anno costa una cifra simile (ed è frequentemente l’unica risposta valida per
garantire una sopravvivenza dignitosa, spesso la sopravvivenza stessa). Ripetia-
mo: potrebbe sembrare disumano porre queste alternative, però è opportuno
che la problematica venga affrontata con lucidità senza preconcetti da una
politica in grado di interpretare i veri bisogni della collettività, piuttosto che
venga “slabbrata” da interessi difficilmente conciliabili. Neppure è opportuno
creare antagonismi tra la spesa per i giovani o adulti e quella per i vecchi, ma
è necessario seguire con attenzione l’evoluzione dei fenomeni per fare scelte
pagine 10_11razionali. D’altra parte, sempre più frequentemente compaiono in letteratura
modelli di organizzazione ospedaliera low cost, che si sono dimostrati capaci
di produrre risultati a livello degli ospedali tradizionali. Ovviamente si tratta di
“rivoluzioni” che richiederanno tempo per svilupparsi (ma meno di quanto pen-
siamo), ma non vi è dubbio che è l’unica vera e realistica risposta all’attuale
continuo ed insostenibile aumento dei costi sanitari. Ciò sarà raggiunto con un
forte investimento nell’ICT (ad esempio, il pre-ricovero si attua a distanza at-
traverso Skype), con una riorganizzazione fordista del lavoro che permetta una
forte specializzazione dell’équipe con riduzione dei tempi di lavoro in ambito
sia diagnostico che chirurgico e un controllo rigido dell’evoluzione clinica, il
tutto in ambienti architettonicamente adeguati per il massimo risparmio ener-
getico e nei movimenti.
Quanto sopra riportato potrebbe sembrare argomento troppo specifico rispetto
alla tematica del volume; è stato invece sottoposto all’attenzione del lettore
perché indica come nella società complessa vi sono moltissime interazioni an-
che tra argomenti apparentemente lontani. È però necessaria una guida strate-
gica delle dinamiche sociali, in particolare per proteggere la condizione di chi
è più debole. Ovviamente la guida non deve essere oppressiva, ma rispettare e
valorizzare quanto di ricco e spontaneo vive nella collettività (il modello degli
Alzheimer Caffè ne è un esempio significativo). E nell’attesa che il program-
matore si accorga delle vivacità spontanee di una società non ancora del tutto
assopita su motivazioni deboli della stessa convivenza, il lavoro presentato in
questo volume rappresenta un contributo per valorizzare un ambito specifico
della ricchezza di modelli e di lavoro costruttivo che è presente nelle nostre
città. L’insieme rappresenta un esempio di come la ricerca di nuove possibilità
per inserire progetti utili all’interno del sistema delle cure rifletta l’impegno
più grande che accompagna chi lavora in questi ambiti e che potrebbe essere
riassunto nella famosa frase del presidente Clinton: “Non lasciate che l’econo-
mia spenga i vostri sogni!”
Come si può capire da queste poche righe, la tematica del “massive amount of
care” è molto seria ed ancora in continua evoluzione, ma proprio per questo
motivo diventa importantissima la seconda parte della frase: l’anziano bisogno-
so non deve avere timore per il suo futuro, perché i medici, gli altri componenti
delle équipe di assistenza, i volontari si impegnano per una cura individualiz-
zata. Insistiamo sull’aspetto delle paure per il futuro, perché sono sempre più
frequenti nella mente delle persone anziane. Si incominciano a vedere i primi
segni, ad esempio, nel fatto che alcune famiglie ritirano i propri congiunti dalla
residenza per risparmiare sulle rette. La vistosa riduzione di alcune pensioni
indotta dai recenti provvedimenti governativi potrebbe rendere più difficile per
le famiglie, peraltro spesso gravate da componenti che hanno perso il lavoro,
mantenere il proprio caro in una residenza. È certamente vero che la disponi-
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?bilità del singolo operatore ed il suo impegno non possono incidere su queste
dinamiche spesso drammatiche; rappresentano però un aspetto positivo in uno
scenario per molti versi oscuro. Una luce sempre utile, anche se da sola non
sufficiente a rischiarare l’intero percorso.
Ma cosa vuol dire una cura individualizzata? Il significato della parola è dupli-
ce: da una parte indica un rapporto intenso tra chi presta un servizio e chi lo
riceve, rapporto che deve essere improntato alla gentilezza, all’ascolto at-
tento, alla risposta adeguata a richieste anche quando possano sembrare non
opportune. Ma il termine indica soprattutto che l’impostazione tecnico-clinica
della cura è fatta analizzando la situazione del singolo individuo, qualsiasi sia
la gravità della sua condizione di malattia, di compromissione dell’autonomia
funzionale e cognitiva. Questa è la garanzia più forte per l’efficacia delle cure
e per il raggiungimento di un risultato; l’età non è un indicatore del bisogno né
lo è l’ambito di vita. Infatti a 80-90 anni vi possono essere profili di malattia
e di salute completamente diversi l’uno dall’altro, che richiedono un’analisi
della storia, un esame accurato della condizione attuale, il ricorso ad indagini
strumentali per arrivare a conclusioni che permettano terapie adeguate. Lo
stesso dicasi per il luogo di residenza: il vivere in una casa di riposo (o altra
istituzione permanente) non significa nulla sul piano della condizione indivi-
duale di salute e non può essere aprioristicamente assunto come indicatore
per le decisioni terapeutiche (anzi, spesso, deve rappresentare per il medico
un campanello d’allarme per il rischio di trattamenti inadeguati nella storia
precedente dell’ospite).
Attorno al binomio massa-individuo del quale si è discusso precedentemente
si svilupperanno le dinamiche più importanti per il futuro dell’assistenza alle
persone anziane non autosufficienti. Il fatto che la tematica sia stata aperta-
mente dichiarata in ambito medico può essere allo stesso tempo un vantaggio
(per l’impegno preso da chi ha responsabilità dirette) e un limite (perché i
bisogni della persona non autosufficiente non sono solo clinici); però è il segno
di un percorso che deve essere accompagnato con attenzione da chi sente il
peso della responsabilità verso l’evento più rilevante della nostra epoca, cioè
l’invecchiamento della popolazione e la vecchiaia della persona.
La personalizzazione dell’assistenza è la modalità di lavoro che caratterizza
servizi innovativi come gli Alzheimer Caffè. Il confine tra essere “contenitori
di sofferenza” o “ambiti di cura” è molto sottile; il contenitore può essere
chiuso, la cura invece richiede apertura, rispetto, relazione. In questo modo
si garantisce al fruitore una prospettiva normale, nel cui ambito si cerca di
leggere il bisogno per darvi risposte adeguate. Talvolta la costruzione di servizi
chiusi è un riflesso di difesa in mancanza della capacità di capire le reali esi-
genze dell’anziano, che, per quanto fragile e limitato nelle proprie espressioni
psicofisiche, è sempre portatore di una domanda di senso. Anche la persona
con compromissione delle funzioni cognitive pone a chi lo assiste continue do-
pagine 12_13mande - implicite o verbalizzate - su dove si vuole arrivare con gli atti di cura.
Talvolta una risposta complessiva è difficile, anche perché di fatto la cura è un
continuo rinnovarsi di atti che assumono di volta in volta significato. Solo un
forte collegamento con l’esterno rispetto al luogo delle cure (qualsiasi esso sia,
la casa, un ospedale, un’istituzione) permette di costruire progetti realmente
significativi.
Le ricerche e il futuro
Recentemente Obama ha deciso di destinare un forte investimento economico
e organizzativo all’area della demenza di Alzheimer, ipotizzando di costruire
una serie di progetti il cui risultato finale sia prevenire e curare efficacemente
questa malattia entro il 2025. Nel mondo della scienza e della ricerca qualcuno
ha accusato di pessimismo il Presidente degli Stati Uniti, altri invece sono stati
più prudenti e non si sono esposti in rischiose previsioni. Chi scrive queste note
è impegnato negli studi sulle malattie neurodegenerative da almeno 30 anni e
non ritiene di poter fare ipotesi sui tempi.
In questo scenario di incertezza oggi sono prevalenti due posizioni allo scopo di
dare una speranza per l’umanità che vive con angoscia i timori di una vecchiaia
accompagnata dalla demenza.
La prima è caratterizzata da attenzione e impegno perché la ricerca possa pro-
seguire con finanziamenti adeguati, ma anche con un largo consenso sociale.
Infatti il pessimismo è sempre negativo, sia perché rischia di influenzare le de-
cisioni di chi alloca fondi pubblici e privati, sia perché fa sentire soli gli studiosi.
Fortunatamente negli ultimi mesi si è riacceso in tutto il mondo l’interesse
sull’Alzheimer: alcune ricerche incominciano a dare risultati promettenti e -
come sempre avviene in questi casi - i dati positivi suscitano un giusto entusia-
smo, che si riflette sull’intero ambito di studio. Vi è la speranza che bloccando
la diffusione di una sostanza tossica nel cervello sia possibile controllare il dan-
no neuronale e quindi evitare la comparsa di demenza. Questi risultati si collo-
cano bene nel quadro dei progressi fino ad ora compiuti, che hanno dimostrato
una lenta evoluzione della malattia, che può durare diversi anni, ed i cui segni
sono identificabili nel cervello attraverso le moderne tecnologie di imaging o
nel liquor anche molto tempo prima che compaiano i segni clinici, cioè sintomi
come la perdita di memoria o alterazioni del comportamento. Il futuro è quindi
connotato da dati positivi dal punto di vista scientifico-biologico.
La seconda posizione - altrettanto importante sul piano della ricerca del benes-
sere - mira a garantire le migliori condizioni di vita per le persone che sono già
colpite dalle varie forme di demenza. Infatti, anche se ancora non sono stati
identificati gli strumenti per una cura definitiva, è possibile mettere in atto
interventi per difendere spazi di qualità, pur nel corso di una vita molto diffici-
le. Questa difesa - che si fonda prima di tutto sul riconoscimento della dignità
della persona, indipendentemente dalle condizioni di salute fisica o psichica - si
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?attua in vari modi sul piano clinico e dell’organizzazione dei servizi. In ambito
clinico il compito principale delle cure è garantire che la persona non soffra di
un eccesso di disabilità, oltre a quella indotta dalla malattia (quindi conservare
il massimo possibile di relazioni, non relegare, attivare, non sostituire impro-
priamente nelle attività di base), e allo stesso tempo curare sintomi disturbanti
(ad esempio, nonostante le difficoltà, capire il dolore fisico in una persona che
ha perso la memoria e che non sa riferirne la collocazione e le caratteristiche).
Anche sul piano dei servizi è possibile fare molto per accompagnare l’ammalato
e la sua famiglia nei lunghi anni di storia naturale della demenza. Infatti nelle
malattie croniche, delle quali la demenza è prototipale, i servizi svolgono una
funzione plurima sempre indispensabile, dal tempo della diagnosi, allo staging
ripetuto, all’impostazione e all’adeguamento delle terapie, all’impegno riabi-
litativo. Gli attori dei servizi sono molti e differenziati, ciascuno con un pro-
prio ruolo, ma anche una propria specificità pratica e culturale. Così le Unità
di Valutazione Alzheimer svolgono un ruolo diverso da quello dell’assistenza
domiciliare, dall’ospedale, dai centri fondati sul volontariato. Quest’ultimo è
l’ambito nel quale si è fortemente impegnata negli ultimi tempi la UniCredit
Foundation: dare attenzione a iniziative che sorgono dalla società civile ed in
particolare dal volontariato vuol dire sostenere chi si impegna a rendere meno
difficile la vita degli ammalati, in attesa - come sopra indicato - che si possano
identificare cure specifiche e risolutive per prevenire e curare. Ma anche signi-
fica assistere sul piano tecnico le generosità diffuse perché possano costruire
servizi qualificati, a costi ridotti e spesso con un plus di relazione e vicinanza
particolarmente significativo.
Lo studio sugli Alzheimer Caffè
La ricerca dedicata all’Alzheimer Caffè presentata in questo volume si inserisce
nella logica di favorire la crescita di servizi innovativi ed ha lo scopo di suggerire
modalità per migliorare le prestazioni fornite in Italia da gruppi di volontariato
o di auto-aiuto, in modo che le energie dedicate con generosità e intelligenza
ad accompagnare la vita delle persone affette da demenza, e quella delle loro
famiglie, possano ottenere il massimo risultato possibile.
L’impegno di UniCredit Foundation e del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Bre-
scia ha permesso di analizzare criticamente alcune esperienze e di estrarre
da queste gli aspetti più efficaci per definire una sorta di “buona pratica”, a
disposizione dei gruppi che nei prossimi mesi vorranno impegnarsi in questo la-
voro assistenziale di grande significato. Ovviamente il numero delle esperienze
esaminate è limitato a causa delle condizioni economico-organizzative dello
studio, che hanno impedito l’allargamento del campione alle molte decine di
realtà attive in questo campo in Italia. La scelta è stata dettata anche dall’esi-
genza di presentare in tempi brevi un’analisi qualitativa che potesse indurre il
lettore ad entrare nel campo, più che un’analisi statistica, peraltro difficile da
pagine 14_15sviluppare vista la disomogeneità del campione.
Nel momento di crisi come quello che stiamo vivendo affrontare tale tematica
è allo stesso tempo un segnale di ottimismo, perché crediamo nelle potenzia-
lità della generosità collettiva, ed un atto di realismo, perché sono sempre più
frequenti le richieste di supporti qualificati alle persone che soffrono. D’altra
parte, sempre sul piano di andare alla ricerca di modi innovativi per intervenire
a favore di chi è fragile, è significativo quanto scritto recentemente dal socio-
logo Ilvo Diamanti a proposito della capacità che dovremmo avere -noi addetti
alla messa a punto di cure efficaci- di indagare anche in circuiti fuori di quelli
alti (accademici e di potere), per identificare nelle prassi minime indicazioni
importanti per il lavoro di cura. Scrive Diamanti: “Il buon senso ci spingereb-
be a interrogarci maggiormente su quel che avviene a livello locale e micro-
sociale, nella sfera personale e interpersonale. A esplorare altre teorie e altri
orientamenti metodologici. Ma il senso comune degli specialisti (…) ci induce a
far finta di nulla. A negare la realtà per non cambiare gli occhiali con cui la os-
serviamo. Dall’alto e di lontano”. Questo approccio al quale ci ispiriamo porta
a valorizzare il mondo di tante persone che si curano delle demenze, che pen-
sano, progettano e sperimentano; non abbiamo idea di quanta ricchezza si può
trovare in questi mondi, apparentemente periferici, ricchezze che facilmente
potrebbero essere valutate e messe alla prova, purché conosciute e analizzate
con attenzione. Questo volume è un segno seppur piccolo in questa direzione,
perché esamina modelli cresciuti spontaneamente, guidati da intuizioni origi-
nali collocate a livello locale, per trarne indicazioni di carattere generale. È
una modalità innovativa non banale, che si va sempre più diffondendo come
strumento per analizzare criticamente alcune realtà e proporle come modelli
replicabili.
Nel campo dell’innovazione originale fuori dai circuiti “alti” (come indicato da
Diamanti), e come tale di grande interesse, un esempio significativo tra i molti
che si potrebbero fare, oltre a quello dei Caffè, è rappresentato dal proget-
to di un imprenditore francese di creare una cittadina adatta ad ospitare le
persone affette da demenza, costruendo ambienti di vita individuali e comuni
che si rifanno agli anni Cinquanta, cioè quelli che sono nella memoria delle
persone anziane ammalate. L’idea è stata criticata da molti, ma attendiamo
la realizzazione del progetto per esprimere un giudizio. Però, al di là di alcune
pur interessanti battute su questa “Dementiaville”, resta l’incertezza di come
meglio proteggere le persone più fragili (per vari motivi, cognitivi o non), cioè
se adottare o meno modelli come quello predisposto in Francia. D’altra parte
anche il termine “caffè” per indicare i luoghi di ritrovo delle persone affette da
demenza e delle loro famiglie ha un certo livello di intelligente originalità, che
qualcuno potrebbe non capire. Recentemente Zygmunt Bauman, lo studioso più
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?acuto della modernità, ha scritto: “Il mondo abitato viene strutturato in modo
da essere ospitale - conveniente e confortevole - per i suoi abitanti normali, le
persone che costituiscono la maggioranza. Le automobili devono essere equi-
paggiate con luci e trombe che avvisano del loro arrivo, strumenti di nessuna
utilità per i ciechi e i sordi. Le scale non sono di alcun aiuto per le persone re-
legate su sedie a rotelle. Io stesso, nella mia età avanzata, avendo ormai perso
la maggior parte del mio udito, non posso più essere allertato dai telefoni o dal
campanello di chi suoni alla mia porta”. Non voglio costruire un’antitesi tra chi
critica Dementiaville e le affermazioni di Bauman, ma anche su queste anti-
nomie (protezione in ambienti dedicati o mantenimento nei luoghi naturali di
vita) si deve sviluppare un dibattito sereno, ma serio. Aperto a tutti quelli che
sentono la responsabilità di costruire un mondo allargato di cure sempre più
adatte al bisogno, ma anche sempre più compiutamente accettate dalla società
che vive attorno alle persone fragili. Gli Alzheimer Caffè vivono all’interno di
queste dialettiche; chi vi opera è mediamente coscio di conflitti, inadeguatez-
za, difficoltà. Però l’esperienza del lavoro compiuto e l’interpretazione del suo
significato è motivo per andare avanti, senza eccessi autoreferenziali, ma con
la tranquilla coscienza che sono stati compiuti atti importanti per un relativo
benessere di chi è assistito.
L’insieme delle osservazioni fino ad ora riportate delinea una condizione della
cura delle demenze in forte evoluzione, dalla quale possono comparire i segni
di una speranza possibile. Non si tratta di garantire la guarigione, ma certamen-
te oggi un insieme di fattori ha radicalmente modificato la prospettiva delle
persone affette da demenza. Purtroppo gli angoli bui esistono ancora e sono
caratterizzati da stigma, timori, dolore non espresso, o, ancor più non ascolta-
to e lenito; però lo scenario è cambiato da alcuni anni. Il contenuto di questo
volumetto ne è una testimonianza concreta e viva: lo scopo dei curatori è ap-
punto quello di facilitare, soprattutto tra le persone che non sono strettamen-
te addette ai lavori, come in particolare i volontari impegnati nell’assistenza
all’anziano, la crescita di un sentire positivo. Occuparsi della “situazione dram-
matica” delle persone colpite da demenza non è un “dramma senza futuro”,
perché si possono trovare mille spazi che rendono importante e significativo un
intervento di cura e di accompagnamento. Cioè un futuro per chi è curato, ma
anche per l’impegno generoso di chi si prende cura delle persone affette da de-
menza. Il tutto in una logica di ricerca della normalità. Benché difficile, questo
stile di cura previene comportamenti non corretti; infatti la tecnica clinico-
assistenziale deve realizzarsi in un ambiente che mira a creare condizioni di
vita che sono di tutti, malati e sani.
Si potrebbe concludere che nell’Alzheimer Caffè si realizza una sintesi tra l’im-
pegno personale generoso e volontario e il desiderio di migliorare attraverso
questo lavoro la nostra società. È la visione personalistica per la quale coloro
pagine 16_17che compiono e che ricevono un atto di cura sono strettamente legati, non
solo sul piano della relazione, ma soprattutto del reciproco miglioramento, che
progressivamente assume dimensioni comunitarie.
Un particolare ringraziamento ai colleghi Giuseppe Bellelli, Nicola Berruti, An-
gelo Bianchetti, Stefano Boffelli, Renzo Rozzini, Sara Tironi del Gruppo di Ri-
cerca Geriatrica di Brescia che hanno rivisto parti del manoscritto suggerendo
spunti significativi.
La dottoressa Enrica Cerantola di UniCredit Foundation ha curato i contatti con
le varie realtà che hanno partecipato allo studio, tenendo con mano ferma un
coordinamento non sempre facile. Infine un vivissimo ringraziamento agli attori
primari dello studio, cioè ai coordinatori e ai collaboratori degli Alzheimer Caf-
fè. Hanno capito rapidamente gli scopi della nostra indagine ed hanno fornito
dati e indicazioni sempre adeguati allo scopo; se il libro servirà a riprodurre le
esperienze più significative e quindi a costruire nuovi servizi utili per le persone
affette da demenza è merito soprattutto di questa disponibilità intelligente.
Abbiamo iniziato questa introduzione con un poeta contemporaneo, che ringra-
ziava per “una giornata diversa”, un momento lieve, che passa; la concludiamo
con i versi eterni di Virgilio che canta il rapporto filiale, che attraversa tutti i
tempi, tra Enea e Anchise:
“Su dunque, diletto padre, salimi sul collo;
ti sosterrò con le spalle, e il peso non mi sarà grave;
dovunque cadranno le sorti, uno e comune sarà
il pericolo, una per ambedue la salvezza”.
Le poesie, così diverse, si adattano bene all’ispirazione che sottende il lavoro
generoso svolto da molti negli Alzheimer Caffè; in particolare sottolineano che
nelle difficoltà l’aiuto dato a chi è debole porta alla salvezza comune.
INTRODUZIONE LA DEMENZA: UN FUTURO DI SPERANZA?L’organizzazione Capitolo 1
dei servizi per
le persone affette
da deficit cognitivo
1.A La rete 20
1.B I servizi 26
1.C I supporti informali 33
1.D Un futuro possibile e sostenibile 36
pagine 19_19alzheimer caffÈ:
la ricchezza di una esperienza
CAPITOLO 1
L’organizzazione dei servizi
per le persone affette da deficit cognitivo
1.a La rete
In poche aree dell’organizzazione sanitaria si sono consumate parole così
numerose come in quella della continuità terapeutica da costruire attorno
al paziente anziano ammalato e non più autosufficiente anche a causa di
una compromissione delle funzioni cognitive. Sono molti gli aspetti critici
che interferiscono con la possibile costruzione di un sistema di supporto che
si adatti alle dinamiche complesse prodotte dall’intrecciarsi della crisi dei
rapporti familiari, dal rarefarsi delle dinamiche di vicinato, dalle difficoltà
economiche, dal processo stesso di invecchiamento che avviene in modo as-
solutamente individuale, accompagnato da attese e speranze che non sono
racchiudibili in schemi precostituiti.
Nel passato anche recente si sono utilizzati modelli organizzativi rigidi, fun-
zionalistici, con sistemi di governo dei servizi pianificati in modo schematico,
all’interno dei quali la persona affetta da malattie croniche invalidanti come
la demenza doveva muoversi. Si potrebbe dire che nessuno di questi sistemi
ha avuto successo, e ancor meno ha avuto la possibilità di evolversi a fronte
delle dinamiche demografiche ed epidemiologiche. Non si può escludere da
questa visione l’insieme degli interventi che vengono messi in atto dalla so-
cietà per rispondere ai bisogni degli ammalati; i servizi di cura e assistenza
devono quindi essere caratterizzati da un alto livello di integrazione tra di
loro e con il resto dei servizi alla persona di un determinato territorio, evitan-
do semplificazioni e schematizzazioni funzionalistiche. La loro organizzazione
secondo questi principi è difficile e - di conseguenza - sono pochi gli esempi
che possono essere portati di servizi adeguati ad un bisogno crescente, sia sul
piano quantitativo che qualitativo. Infatti, come già ampiamente riportato in
questo volume, l’aumento del numero delle persone anziane trascina con se
automaticamente anche l’aumento del numero di quelle affette da demenza.
Inoltre, il progresso sociale e culturale ha accresciuto la coscienza sul diritto
del cittadino ad avere risposte adeguate nel momento delle difficoltà, anzi a
vedere riconosciuti proprio gli aspetti più critici come quelli che maggiormen-
te meritano interventi di alto livello.
Le problematiche presentate dalla demenza richiedono una visione comples-
siva dei problemi, anche perché l’evoluzione è così rapida, con un continuo
cambiamento dei quadri clinici, che il paziente (e chi lo assiste) deve disporre
di interventi a suo favore in grado di adeguarsi continuamente, evitando sfa-
samenti, ritardi o addirittura l’assenza di risposte. In un arco temporale rela-
tivamente breve (la malattia di Alzheimer ha infatti una durata media di 5-10
anni) il paziente sperimenta il passaggio da una condizione caratterizzata da
lievi deficit mnesici e difficoltà nello svolgimento delle attività più complesse,
al progressivo sgretolarsi delle competenze cognitive, alla modificazione radi-
cale della personalità (quasi invariabilmente accompagnata da modificazioni
del comportamento), con un deterioramento via via sempre più marcato dello
CAPITOLO 1 L’organizzazione dei servizi per le persone affette da deficit cognitivostato funzionale, fino alla disabilità completa e alla comparsa di gravi com-
plicanze neurologiche e somatiche. In questo percorso vi è il coinvolgimento
profondo e spesso drammatico della famiglia, che vive dapprima l’angoscia
della diagnosi e della prospettiva di un’evoluzione inarrestabile della malat-
tia, poi la difficoltà della gestione dei problemi comportamentali e cognitivi,
nonché del carico derivante dalle necessità assistenziali sempre in aumento.
Alla luce di quanto sopra affermato, l’organizzazione dei servizi, così come
la cura della singola persona, dovrà compiere nei prossimi anni un notevole
passo avanti sul piano culturale, rispetto alle tematiche di oggi, per uscire
dalle logiche di modelli che prevedono una organizzazione rigida, dove tutto
si muove in modo consequenziale, come se ogni evento umano fosse sem-
pre predicibile e rispondente alla logica causa-effetto. È necessario invece
accogliere un approccio dinamico della vita, aperto all’inatteso, capace di
comprendere le relazioni che si sviluppano tra le persone in modo talvolta non
tradizionale. Alla base di questa visione vi è una lettura degli eventi biologici
(e quindi clinici) aperta alla realtà del vivente al di fuori delle schematiz-
zazioni rigide, per cui un evento può derivare dall’interazione di molti altri
e dare a sua volta origine a nuovi equilibri. Non è una strada facile, perché
il percorrere itinerari prevedibili è certamente più rassicurante; però, nel
prossimo futuro potremo sperare di superare le difficoltà economiche, orga-
nizzative e umane solo accettando un modello che rispecchi nel profondo le
caratteristiche della vita, ponendo il progresso tecnologico al servizio di una
visione dinamica, secondo la quale vi sono ricchezze e variabilità nel mondo
che non possono essere racchiuse all’interno dei meccanismi delle macchine.
Chi vuole semplificare, imponendo tappe schematiche alla varietà e alla li-
bertà dei comportamenti individuali può sembrare di possedere la risposta e
forse verrà approvato da qualche osservatore miope, ma alla fine non ottiene
risultati utili, perché l’incontro tra la rigidità di un sistema di risposta e un
bisogno per definizione articolato, che varia nel tempo, ed è influenzato da
condizioni psicosociali, oltre che somatiche, non è mai efficace.
La tematica è di interesse generale e riguarda molti ambiti della vita orga-
nizzata oltre a quelli della medicina e dell’assistenza; si pensi alla diffusione
della medicina basata sull’evidenza come strumento operativo fondato su li-
nee guida e protocolli e allo scontro con la realtà clinica della persona affetta
da demenza, difficilmente schematizzabile entro confini rigidi. Questa situa-
zione richiede equilibrio e apertura, alla ricerca di un punto mediano che si
deve identificare nelle varie realtà di intervento. Parimenti, anche la ricerca
di una modalità per far incontrare la variabilità individuale con l’esigenza di
organizzare servizi che devono seguire standard e comportamenti prefissati
non è facile; è infatti una delle scommesse più rilevanti che la post-modernità
deve affrontare. Tra rigidità e anarchia dove si colloca l’organizzazione dei
pagine 20_21servizi? Non dobbiamo forse accettare un certo livello di conflitto, caratte-
ristica irrinunciabile del tempo di oggi e del progresso che viviamo e che ci
auguriamo? Il conflitto impedisce il ripiegamento della collettività su se stessa
e la scomparsa delle ricchezze che nella diversità abitano la nostra epoca. La
storia - anche le piccole storie costruite dalle persone fragili - non è finita,
ma aperta alla nostra capacità di innovare, partendo dal riconoscimento del
binomio complessità-conflitto e delle dinamiche che ne conseguono.
Oggi viviamo un momento di crisi perché intuiamo che il modello tradizionale
dei servizi per le persone fragili è in difficoltà, ma non disponiamo di modelli
alternativi e maturi. Questa situazione, se da un lato è motivo di preoccupa-
zione, dall’altro stimola e impegna ogni persona di buona volontà (operatore,
cittadino, decisore) a trovare strade nuove e più adeguate. Molti sono inco-
raggiati dal profondo senso etico che è indicato come “senso di responsabilità
verso il fratello”, una regola umana che da sempre ha caratterizzato la cresci-
ta civile. Se l’atteggiamento di conservazione è praticamente e moralmente
negativo, anche l’innovazione deve seguire regole precise, non può essere il
prodotto di idee particolari e non verificate. Soprattutto è importante che si
ponga sempre l’obiettivo di misurare i risultati; sebbene sia impresa difficile,
soprattutto quando sono in gioco diverse dinamiche, non ha rilievo l’innova-
zione che non porti a risultati in termini di salute somatica, di qualità della
vita psichica o pratica, di miglioramento delle relazioni comunitarie, ecc. Su
queste tematiche nel nostro Paese bisogna procedere con grande prudenza,
perché è troppo facile distruggere servizi magari parziali, ma che hanno un
certo ruolo, mentre è difficilissimo costruire alternative realmente operanti
in modo efficace.
I bisogni del paziente e della famiglia
Il primo elemento necessario per una razionale organizzazione delle risposte
ai bisogni del paziente è il riconoscimento della malattia e della sua natura.
Soltanto in un terzo dei casi le persone colpite dalla malattia ricevono una
diagnosi nelle fasi iniziali, mentre più frequentemente è con la comparsa dei
sintomi più eclatanti o delle complicanze che viene riconosciuta la presen-
za di una sindrome dementigena. Il tardivo riconoscimento della natura dei
sintomi provoca sofferenza nel paziente, disagio nella famiglia, ritarda l’ini-
zio dei trattamenti, impedisce una corretta pianificazione degli interventi di
supporto e di prevenzione dei rischi (gestione delle finanze, guida dell’auto,
ecc.) e differisce l’assunzione di decisioni legali.
Dopo la fase diagnostica, il paziente richiede cure mirate per le diverse ma-
nifestazioni cliniche della malattia di Alzheimer e delle altre demenze. Seb-
bene non vi siano trattamenti farmacologici risolutivi, un insieme integrato
di interventi condotti in modo continuativo può indurre un sostanziale mi-
glioramento della qualità di vita del paziente e dei suoi familiari e, spesso,
CAPITOLO 1 L’organizzazione dei servizi per le persone affette da deficit cognitivopuò rallentare la progressione dei sintomi. È necessario il coinvolgimento di
più figure professionali (medico di medicina generale, specialista, psicolo-
go, assistente sociale, infermiere, terapista della riabilitazione, ecc.) che,
in tempi diversi e luoghi diversi (domicilio, centri di diagnosi specializzati,
centri diurni e day hospital, nuclei specifici in residenze protette, reparti di
riabilitazione, ecc.), collaborano per fornire i trattamenti appropriati. Anche
negli stadi più avanzati della demenza è possibile intervenire sfruttando le
capacità residue del paziente e le risorse della famiglia, nonché limitando gli
effetti di comorbilità, deficit sensoriali, ostacoli e stress ambientali.
I bisogni devono trovare risposta nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari
che comprendono un sistema integrato di centri per la diagnosi e la gestione
della terapia, di servizi per l’assistenza domiciliare (incluse strutture semi-
residenziali quali centri diurni) e per il sostegno ed educazione dei caregiver,
servizi di riabilitazione di varie tipologie e servizi di cura a lungo termine.
L’aspetto centrale è la relazione fra i centri che devono garantire da un lato
la specificità dei servizi e dall’altro il collegamento fra i vari livelli, per per-
mettere al paziente il passaggio da uno all’altro in ragione delle specifiche
necessità.
Un punto cruciale di discussione è se la demenza sia una condizione che ri-
chiede una rete autonoma di servizi oppure le risposte possano essere ri-
cercate nel percorso ordinario dei servizi. Numerose esperienze nazionali ed
internazionali hanno dimostrato che attraverso servizi dedicati e specializzati
è possibile rispondere in modo più puntuale ed appropriato alle complesse
problematiche; nonostante ciò, la realtà italiana si presenta estremamente
variegata, con alcune aree dove non è stato fatto quasi nulla, per colpevoli
assenze della politica e dell’amministrazione e per il prevalere di interessi
che non sono quelli della popolazione, in particolare di quella parte afflitta
da gravi problemi di salute.
Verranno di seguito analizzati alcuni nodi centrali della rete dei servizi. Si
deve però premettere che nessuna organizzazione, nemmeno la più avanzata
e ricca, potrà mai offrire risposte completamente soddisfacenti alla famiglia,
che resta l’interprete principale delle necessità del paziente di fronte alla
progressiva perdita di capacità cognitive. Ad esempio, anche quando il pa-
ziente viene ricoverato in un’istituzione, e quindi la famiglia viene scaricata
dai compiti gestionali, restano drammatici alcuni aspetti psicologici, che i
servizi devono affrontare con attenzione e prudenza. Peraltro, se l’ammalato
resta a casa, vi sono aspetti dell’assistenza, come la sua durata (qualcuno ha
definito l’impegno delle famiglie come parametrabile su “una giornata di 36
ore”), il carico di fatica e organizzativo, il carico psicologico (la solitudine
che accompagna chi dona assistenza), che sono solo parzialmente leniti anche
dalla migliore organizzazione dei servizi.
pagine 22_23Uno degli aspetti cruciali che attraversa tutta la problematica dei servizi è
rappresentato dalla capacità della famiglia di reggere la centralità rispetto
ai diversi interventi, che, anche quando sono coordinatiti in modo adeguato,
hanno pur sempre bisogno del fulcro-famiglia. Vi sono situazioni nelle quali
ciò non si realizza ed è quindi il tempo del ricovero dell’ammalato in un’isti-
tuzione; vi sono però tempi e condizioni nelle quali è possibile aiutare la fa-
miglia a svolgere la propria funzione centrale, permettendo così al complesso
sistema assistenziale di funzionare al meglio. Sulle modalità pratiche per re-
alizzare questo obiettivo si sono aperte molte discussioni, senza però arrivare
a conclusioni significative. In particolare, si è molto dibattuto sul ruolo dei
supporti economici dati direttamente alla famiglia come strumento per faci-
litarne l’autonomia e la capacità di affrontare le difficoltà, anche attraverso
una diretta capacità contrattuale nei riguardi di chi presta un servizio, con
un più elevato e non burocratico controllo sulla qualità e la quantità. Non è
questa la sede per esprimere un giudizio definitivo su queste tematiche; è
però importante riaffermare la necessità di trovare strumenti operativi che
permettano di sconfiggere i rischi purtroppo sempre diffusi di autorefenzialità
dei servizi. Ma ancor più importante è creare le condizioni per cui l’assistenza
alla persona colpita da malattia di lunga durata, che quindi interagiscono
con le dinamiche vitali di uomini e donne che convivono con questi proble-
mi, divenga un motivo di attenzione da parte della comunità, stimolando le
energie naturali che essa conserva al proprio interno. Per troppo tempo, in-
fatti, la delega acritica ai servizi, anche quando non erano di elevata qualità,
ha impedito la crescita di generosità diffuse, che difficilmente riuscivano ad
esprimersi in contesti burocratizzati, incapaci di ascolto. Ora il mutare delle
sensibilità ha aperto nuove prospettive; è però necessaria molta elasticità
per integrare nel sistema delle cure - a parità di dignità - la famiglia, il vici-
nato, il volontariato e i servizi prestati da attori che accettano la logica della
centralità di chi viene servito. L’esperienza degli Alzheimer Caffè si colloca
pienamente in questo contesto. Senza retorica, è doveroso riaffermare che
in situazioni particolari come le malattie croniche, che sconvolgono la vita
dell’ammalato e della sua famiglia, l’intervento di cura deve avere la conno-
tazione dell’ascolto e della compassione, non come aggiunte al lavoro tecnico
di cura, ma come componente irrinunciabile di questo.
Per dare significato ai vari spunti sopraindicati, è necessario che il sistema sia
in grado di costruire una forte cultura innovativa degli operatori. Infatti le
nuove aree di impegno rischiano di produrre frustrazione in chi vi lavora, con
conseguente pessimismo e cinismo, se non viene messa in atto una formazio-
ne incisiva, che trasmette le motivazioni del servizio e allo stesso tempo aiuta
a capire l’efficacia degli interventi ed i mezzi più appropriati a questo scopo.
L’impresa formativa tuttavia non è semplice: l’attuale sistema vigente in Ita-
CAPITOLO 1 L’organizzazione dei servizi per le persone affette da deficit cognitivolia è poco più di una bardatura economico-burocratica per quanto riguarda
la formazione continua, mentre l’università non è sempre stata in grado di
formare una classe adeguata di formatori, capaci di coniugare le informa-
zioni tecniche con indicazioni sulla processualità del lavoro, sull’esigenza di
collaborazione tra culture e sensibilità diverse, sulla necessità di misurare i
risultati ottenuti parametrandoli con quelli attesi. Spetta quindi alla ricchez-
za delle individualità che naturalmente si collocano nel territorio trovare so-
luzioni adeguate, che non devono essere considerate attività di lusso (e quindi
espletate solo quando si hanno grandi disponibilità economiche), ma momenti
strutturali alla vita dei servizi. Una formazione adeguata è anche indispen-
sabile per permettere un efficace lavoro di équipe. Deve essere compreso
dagli addetti che questa modalità non è una condizione accessoria, legata a
peculiari sensibilità, ma l’unica condizione per ottenere risultati in situazioni
complesse. La realtà invece dimostra quanto sia difficile indurre alla collabo-
razione professionalità diverse attorno ad un problema clinico-assistenziale,
sia all’interno dello stesso servizio, sia nei punti di contatto e di integrazione.
Per affrontare concretamente il problema della gestione della rete di servizi
per le persone affette da demenza si deve rilevare che in tutto il mondo, ma
soprattutto in Italia, vi sono pochissime ricerche in grado di guidare le scelte
programmatorie. Ci si deve quindi affidare ad osservazioni soggettive o ad
analisi di gruppi che però non hanno realizzato studi controllati in grado di of-
frire risposte definitive. Ci si può però domandare a questo proposito: è dav-
vero realistica la possibilità di impostare queste ricerche in una condizione di
complessità come quella che caratterizza la condizione clinica, psicologica,
relazionale e sociale nell’anziano ammalato abitante in una società avanzata?
La prima modalità - e spesso purtroppo la più frequente - per affrontare la ge-
stione dei servizi per la persona anziana affetta da demenza è quella rinuncia-
taria; il sistema deve aggiustarsi da solo, i cittadini affluiscono direttamente
ai vari segmenti della rete senza essere filtrati se non da condizioni quali la
vicinanza, la disponibilità di posti, l’adeguatezza dei finanziamenti, la volon-
tà di un coinvolgimento personale sul piano economico e organizzativo, ecc.
Questa soluzione non sarà mai apertamente accettata da nessuno, ma nella
realtà è la più diffusa. Il limite più grave è esporre le persone più fragili e le
loro famiglie alla ricerca di soluzioni che esse non sono in grado di identificare
e di raggiungere a causa delle circostanze poste dalle povertà economiche,
culturali, di relazioni, ecc.
La seconda possibile risposta si colloca all’estremo opposto, ed è quella del
funzionalismo assoluto, secondo un modello a rete dove tutto si muove sotto
controllo, ogni spostamento è precostituito, accompagnato e vagliato nella
sua efficacia. Qualche anno fa questo modello era molto diffuso sul piano
teorico e molti ricordano le interminabili lezioni di chi si riteneva portatore di
pagine 24_25Puoi anche leggere