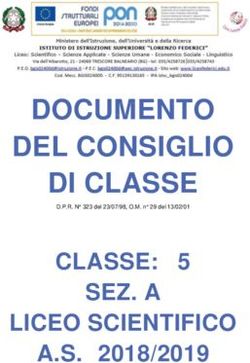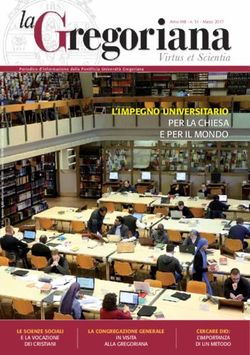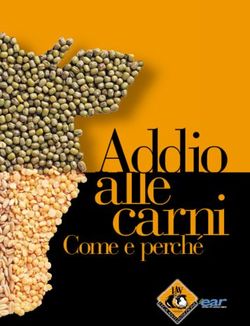All'ombra dei grandi De Vecchi e altri pionieri dell'automobile a Milano - AISA Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile - Associazione ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
All’ombra dei grandi
De Vecchi e altri pionieri
dell’automobile a Milano
AISA
Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
MONOGRAFIA AISA 126
IAll’ombra dei grandi
De Vecchi e altri pionieri
dell’automobile a Milano
AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
2 Prefazione
Lorenzo Boscarelli
3 La Fondazione De Vecchi e la costituzione dell’archivio d’impresa
Alberto De Vecchi
5 La De Vecchi e il contesto milanese
Donatella Biffignandi
15 Ecla, una storia di marca
Donatella Biffignandi
16 Giuseppe Ricordi: fu lui il primo
Gianni Cancellieri
19 Repertorio dei costruttori minori di area milanese dalle origini al 1925
a cura di Donatella Biffignandi e Lorenzo Boscarelli
27 I carrozzieri milanesi, dalle carrozze alle automobili
Alessandro Sannia
MONOGRAFIA AISA 126
1Prefazione
Lorenzo Boscarelli
Negli ultimi decenni dell’Ottocento apparvero tec- manifatturiera, senza confronti rispetto a qualsiasi al-
nologie nuove e dirompenti, come l’energia elettrica, tro distretto italiano, da cui scaturirono innumerevoli
il telefono, il motore a combustione interna, e altre piccole imprese anche nel nuovo settore.
fondamentali per l’igiene personale, che ben presto Se Milano fu il centro iniziale della diffusione dell’au-
avrebbero mutato in modo radicale la vita quotidiana tomobile in Italia, nel volgere di pochi anni Torino la
di un gran numero di persone, appartenenti alle clas- soppiantò, grazie soprattutto alla Fiat che – guidata
si agiate. Inoltre, in Europa, dopo la guerra franco- dalla visione industriale di Giovanni Agnelli e, dob-
prussiana del 1870, si era vissuti sostanzialmente in biamo ritenere, di gran parte del suo gruppo dirigen-
pace, per cui ben si poté definire quel periodo “la belle te – si dotò delle risorse tecniche, organizzative e fi-
époque”. nanziarie adeguate a perseguire una rapida crescita e
Non stupisce quindi che, negli anni e decenni succes- il dominio del mercato nazionale. Questa visione era
sivi all’apparizione delle prime automobili – costruite profondamente diversa da quella che possiamo pen-
intorno al 1890 in Germania e in Francia – si creasse sare caratterizzasse la grande maggioranza dei pionieri
per il nuovo mezzo un interesse molto elevato, tanto della motorizzazione.
da stimolare tanti tecnici, imprenditori e investitori a Scontate queste differenze di approccio e di obiettivi,
dedicare inventiva, passione e risorse finanziarie alla i cui esiti furono ben presto palesi, dobbiamo ricono-
realizzazione del nuovo mezzo. scere che il potenziale dell’automobile – la cui ampiez-
Si avverte, nella gran quantità di iniziative sorte allora, za all’inizio del Novecento fu percepita da pochi, per
rivolte alla costruzione degli autotelai e delle carroz- l’ancora limitata diffusione del mezzo – fu comunque
zerie, un fervore guidato più dall’entusiasmo che da intuito da chi agli albori della motorizzazione vi si de-
una razionale capacità di comprendere le difficoltà da dicò come costruttore, tanto da attirare vaste energie
superare. Cosicché tantissime di quelle imprese ebbe- di lavoro, di dedizione, di creatività.
ro vita molto breve, in alcuni casi effimera. Ma l’esito Alcuni di quei pionieri ebbero la capacità di compren-
non importa, perché nel loro insieme sono la testi- dere l’entità dell’impegno richiesto per lo sviluppo
monianza di quanto l’automobile abbia saputo attirare delle aziende, oltre le prime fasi artigianali. Fu il caso
talenti diversi e stimolarli a dare il meglio di se stessi, della De Vecchi, che da costruttore di veicoli si tra-
perseguendo un disegno o un sogno. sformò in produttore di componenti, raggiungendo
Milano fu la sede ideale per favorire lo sviluppo di un elevato grado di specializzazione che le permise di
quelle aziende artigiane – in pochi casi sostenute da prosperare a lungo e di mantenere un patrimonio di
una visione industriale – per la concentrazione di abi- documenti così ampio da dar vita a una Fondazione.
lità, risorse finanziarie e per il dinamismo che caratte- Così, da un inizio nel mondo della tecnica e dell’im-
rizzava la città, aiutato anche dalla relativa vicinanza presa, si sfocia in un’iniziativa culturale che testimonia
con centri all’avanguardia nelle nuove tecnologie, al di la rilevanza di quelle lontane vicende e ne valorizza il
là delle Alpi. Fu determinante la diffusissima attività ricordo.
Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.
2La Fondazione De Vecchi
e la costituzione dell’archivio d’impresa
Alberto De Vecchi
L a “Fondazione De Vecchi & C. – Milano” è nata
quattro anni fa per iniziativa mia e di Matteo Bra-
vi, cugino di quarta generazione. ‘Fondatore’ con me
sioni dei veicoli pesanti e dei treni. La terza infine,
dagli anni Cinquanta del ‘900 (in parziale sovrappo-
sizione con il mollificio) alla fine degli anni Ottanta,
è stato Marco De Vecchi, il componente più anziano dominata dalla produzione in serie dei ‘cuscini a mol-
della famiglia e protagonista delle fasi più recenti della le’, destinati ai grandi numeri della produzione auto-
vita delle aziende che alla famiglia hanno fatto capo. mobilistica. Un cerchio che si chiude: dall’automobi-
Matteo e io siamo i due anelli della catena che con- le all’automobile passando attraverso la molla, dalle
giungono la terza e la quarta generazione della fami- piccole realizzazioni ‘su misura’ alla grande serie, dal
glia, io sono il più ‘giovane’ dei nipoti di Giuseppe contatto personale con collaboratori e piloti all’inalte-
De Vecchi e Matteo è il più ‘anziano’ dei bisnipoti. rato stile nel rapporto umano con i dipendenti della
Insieme costituiamo l’organo direttivo e ci occupiamo Mollacciaio e con la moltitudine operaia della SICAM
della gestione operativa dell’Ente. e delle sue consociate.
All’inizio di tutto sono stati... un camion e una vali- Partendo da questi presupposti abbiamo dato vita
gia: il mitico Camion del 1914, unico veicolo ancora alla Fondazione e, denominandola “Fondazione De
esistente della produzione De Vecchi, protagonista Vecchi & C. - Milano”, abbiamo voluto richiamare il
di molte vicissitudini (devastazione, restauro, cattive nome e il logo originari della storia delle imprese lega-
conservazioni, nuovo accurato restauro) e una vecchia te alla nostra famiglia.
valigia contenente la primigenia raccolta di documen- Il nostro obbiettivo è stato ed è da un lato realizzare
ti, foto e oggetti da cui partire per una ricerca più am- una ‘casa virtuale’ – un giorno, ce lo auguriamo, potrà
pia e strutturata. anche diventare un luogo fisico – in cui raccogliere
Si poneva l’esigenza di definirne la proprietà e di e valorizzare cose, atti e fatti che rappresentano la
dare al Camion un’adeguata destinazione espositi- memoria storica della nostra famiglia, dall’altro lato
va, unitamente a un bel motore del 1911 anch’esso sviluppare iniziative nuove che quella memoria contri-
unica testimonianza rimasta di una vasta produzio- buiscano a far rivivere e diffondere, radicando e ripro-
ne motoristica. Questo è stato lo spunto, ma si può ponendo nel tempo ciò che riteniamo essere le costanti
dire che la nostra attrazione verso la passata storia caratteriali trasmesse da coloro che ci hanno preceduto
imprenditoriale della famiglia abbia così trovato la con il loro agire: la curiosità, l’apertura alla sperimen-
motivazione decisiva per spingerci ad avviare un tazione, la tensione a ‘fare le cose bene’, la generosità.
progetto che da tempo ‘covava sotto le ceneri’ dei Si tratta di un ‘imprinting’ di valori che vogliamo testi-
ricordi e dei cimeli documentali e materiali sparsi nei moniare e trasmettere attraverso questo ‘contenitore’
cassetti e nei ripostigli delle nostre case. Se volessi- perchè continuino a riprodursi in noi e nelle genera-
mo riassumere in un breve titolo questo progetto si zioni più giovani, qualunque attività e percorso di vita
potrebbe dire: “Una famiglia, tre imprese nel secolo scelgano di intraprendere.
dell’industria”. Lo Statuto rappresenta e traduce formalmente questi
Sono tre infatti le fasi che definiscono l’itinerario in- scopi nel proprio Oggetto:
dustriale della vicenda. La prima, quella della De Vec- “la Fondazione si occuperà di promuovere, salvaguardare, so-
chi ‘automobilistica’, dal 1904 al 1918. La seconda, stenere e diffondere il patrimonio di conoscenze tecniche dell’in-
dal 1919 al 1972, quella della ‘Mollacciaio De Vecchi’, dustria meccanica italiana dal 1900 a oggi... in particolare la
caratterizzata dalla centralità della molla, particolare Fondazione si farà carico della protezione, promozione e dif-
meccanico interpretato al più elevato livello qualitati- fusione del patrimonio storico, culturale e tecnico delle imprese
vo: dalla piccola molla ‘tecnica’, diffusa capillarmen- riconducibili alla famiglia De Vecchi operanti nel medesimo
te nel mondo della meccanica, alle molle degli arredi arco di tempo mediante la valorizzazione dei documenti, dei
(materassi soprattutto), alle grandi molle delle sospen- manufatti e dei materiali nei quali questo patrimonio si manife-
sta, attraverso progetti e iniziative volti a promuovere la ricerca
tecnico scientifica e più in generale la cultura d’impresa come
parte del patrimonio culturale del Paese”.
Alberto De Vecchi, nipote di Giuseppe De Vecchi, Presidente della Fon- Siamo partiti quindi dalla formazione di un archivio,
dazione De Vecchi & C. - Milano. cercando nelle nostre case e effettuando una ricerca
3negli archivi altrui con l’aiuto professionale di un ri- manifestazioni, convegni, incontri; procedendo alla pubblicazio-
cercatore archivista. ne dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee
Di qui è nata la collaborazione con la ‘Fondazione a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori
ISEC - Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea’ e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il
presso cui abbiamo depositato tutto quanto costitui- pubblico, anche con l’istituzione di premi e borse di studio...”.
sce ad oggi il nostro archivio documentale e iconogra- Infine, da ultimo, c’è una piccola componente com-
fico. In quella sede ci troviamo a fianco di numerosi merciale che la più recente normativa sul Terzo Set-
altri archivi di origine aziendale quali Breda, Ercole tore non solo consente ma incoraggia. Ancora dallo
Marelli, Bastogi, Italtel, ecc. Statuto:
La formazione di un archivio è infatti il primo e fon- “...la Fondazione si attiverà per riorganizzare depositare e pro-
damentale passo per la ricostruzione delle memorie teggere Nomi d’Azienda, Marchi, Brevetti, Nomi Commercia-
storiche ma è anche il più difficile perché gli imprendi- li di parti ed accessori per l’eventuale sfruttamento” – anche
tori guardano sempre avanti, mai indietro, non conser- qui ci siamo mossi proteggendo i marchi e i loghi più
vano, buttano via, sono sempre rivolti positivamente significativi – “e per svolgere, in via accessoria e strumentale
al futuro. Il nostro vuole invece essere un tentativo di al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercia-
guardarci indietro ma con l’ambizione di proiettarci lizzazione (per es. in editoria) nei limiti delle leggi vigenti...”.
avanti, facendo uso di quanto andremo via via ritro- Per concludere: il tema dei valori d’impresa e dell’im-
vando. Prima di tutto perché gli archivi raccontano prenditorialità sono il cuore e la cifra che caratteriz-
una storia e qualunque storia contribuisce a costruire zano l’attività della Fondazione De Vecchi & C. in
il presente e il futuro, e poi perché devono essere ‘una quanto dal mondo delle imprese nasciamo e l’impresa
cosa viva’, li dobbiamo per così dire ‘resuscitare’ per- i propri valori li testimonia e li pratica quotidianamen-
ché ci ‘restituiscano’ la vita che contengono. te; l’impresa forma e matura perché organizza le com-
Partendo di qui con l’attività della nostra Fondazione petenze; l’impresa esprime relazioni fra persone ed è
intendiamo fare alcune cose di base: vogliamo essere ancora l’unico ascensore sociale in un paese statico
un organismo ‘aperto’, che opera secondo logiche di come il nostro.
rete (ISEC ne è il primo esempio) e di confronto con In una parola l’impresa fa cultura. Ecco perché dal
tutti gli ‘stakeholders’. Tornando a citare lo Statuto: nostro punto di vista conservare le testimonianze del
“...la Fondazione si propone di individuare e supportare passato, se questo passato è fatto di imprese e di im-
progetti e iniziative culturali di soggetti terzi, che presentino prenditori come nel nostro caso, ben lungi dall’essere
caratteristiche di affinità e coerenza con la cultura d’impresa, polveroso ‘amarcord’ si trasforma in un potente ‘mo-
promuovendo e organizzando seminari, corsi di formazione, tore’ di innovazione.
4La De Vecchi Automobili
e il contesto milanese
Donatella Biffignandi
D ella azienda automobilistica De Vecchi Strada &
C., poi De Vecchi & C., attiva a Milano tra il
1904 e il 1918, si sa poco e si è scritto ancora meno:
si piccoli costruttori-artigiani di area milanese furono
costretti ad uscire dal mercato.
Nel 1913 a Milano erano rimaste in piedi solo 4 im-
qualche cenno fuggevole, ma nulla ancora di organico. prese: la Isotta Fraschini con 533 operai, la Bianchi
Però, se si apre il bellissimo catalogo “L’Automobi- con 443 nel reparto auto (e altrettanti in quello moto
le Produzione e Design a Milano”, realizzato per la e bici, qui non considerati), l’Alfa con 191 e la De
mostra svoltasi nel 1990, con il contributo di alcuni Vecchi con 80. In tutto circa 1250 operai, a cui però
dei più seri storici dell’automobile del Novecento (tra andavano sommati quelli delle carrozzerie, almeno
gli altri, Duccio Bigazzi, Angelo Tito Anselmi, Grif- 750 nelle 13 carrozzerie censite.
fith Borgeson), una foto del salone di vendita della Quattro aziende, rispetto alle decine degli anni prece-
De Vecchi compare a piena pagina all’inizio del saggio denti: la De Vecchi è una di queste, accanto ad altre tre
“Milano e l’automobile: le vicende dell’industria”. È che avrebbero fatto la storia dell’automobile italiana.
un’immagine che rimanda ad una azienda solida e ben Capire perché, passati quattro anni, anche la De Vec-
organizzata, con una struttura non solo produttiva ma chi cessa la produzione automobilistica, nonostante
anche commerciale e con una strategia comunicativa un inizio così promettente, è il motivo che ci spinge
(sulla parete di fondo sono appesi dei manifesti pub- ad andare a ritroso, per cercare di cogliere i lineamen-
blicitari: si indovina una figura femminile, una compo- ti essenziali della storia industriale milanese di quel
sizione grafica che sicuramente sarà stata firmata da periodo in generale, e della storia della De Vecchi in
un buon cartellonista dell’epoca). particolare.
Dunque non stiamo parlando di uno dei tanti tentativi Gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecen-
velleitari che affollarono il comparto automobilistico to avevano visto l’affermarsi di Milano come grande
italiano nei primi anni del Novecento, caratterizzato centro meccanico e metallurgico. Si può tranquilla-
da una crescita che nel breve volgere di anni portò ad mente affermare che nel 1881, quando aprì l’Espo-
un sovradimensionamento impensabile fino a poco sizione Universale, Milano, ormai collegata con i più
tempo prima: le società per azioni, che nel 1904 erano importanti capoluoghi, era il principale centro com-
una decina, con un capitale complessivo inferiore ai merciale e la maggiore città industriale d’Italia. In soli
18 milioni di lire, nel 1907 erano diventate 61 e il loro dieci anni, dal 1881 al 1891, triplicarono i CV vapore
capitale toccava i 100 milioni. Gli autoveicoli prodotti, impiegati nelle attività industriali, da 12.000 a 36.000
che nel 1904 erano 3.080, avrebbero raggiunto l’anno (e nel 1911 i cavalli impiegati erano diventati 73.000,
seguente le 8.870 unità, un aumento del 188% (pur- di cui 50.000 prodotti da motori elettrici); gli abitanti
troppo non esistono dati certi sui volumi produttivi passarono da 242.457 nel 1861 a 602.236 nel 1911.
del periodo 1906-1910). Tantissimi i settori di produzione manifatturiera:
Si trattava di una espansione incontrollata che esaurì quello dei carrozzai (più di 2.000 addetti), bigiotterie,
presto le possibilità di ricezione di un mercato cro- oreficerie, concerie, cappellerie, e poi il mondo delle
nicamente asfittico quale quello italiano, mentre le lavoratrici a domicilio, cucitrici, ricamatrici, sarte, cre-
capacità esportatrici rimanevano ancora in gran parte staie, guantaie… ma il settore in cui i prodromi della
potenziali. Fu così che, al primo manifestarsi della cri- grande industria moderna, incentrata sulla fabbrica
si finanziaria internazionale del 1907, gran parte del capitalistica, si manifestarono con maggior rilievo fu
fragile edificio eretto in gran fretta negli anni prece- quello meccanico. Alcune di queste officine ebbero un
denti crollava, travolgendo anche iniziative dotate di destino duraturo e svolsero un ruolo di primo piano
serie fondamenta. Fu una selezione durissima, e diver- nell’industrializzazione milanese, superando tra l’altro
il difficile ostacolo costituito dalla riluttanza dei capita-
li nei confronti degli investimenti industriali. La spinta
alla modernizzazione si esprimeva nell’ampliamento e
Donatella Biffignandi. Storica di formazione, appassionata per me- nella razionalizzazione degli impianti, e nell’introdu-
stiere, socia Aisa da sempre, ha scritto parecchi articoli e alcuni libri zione di macchinari e macchine utensili moderni. Ma
sulla storia dell’automobile. nonostante la loro rilevanza avevano ancora un carat-
5tere arretrato, ibrido, ravvisabile in parecchi fattori: la che, la Franco Tosi, la AEG-Thomson Houston (poi
presenza preponderante di lavoratori di mestiere; la CGE), la Ercole Marelli e altre.
divisione rudimentale del lavoro, l’arretratezza tecno- Le fabbriche di automobili propriamente dette do-
logica, l’eccessiva diversificazione della produzione. vranno attendere ancora un decennio prima di trovare
Per fare un esempio, la Prinetti & Stucchi nel 1891 spazio nelle statistiche ufficiali e più precisamente nel-
utilizzava i suoi 400 addetti sia per la lavorazione del le rilevazioni effettuate per il censimento dell’industria
sughero sia per la produzione di macchine per cucire. del 1911.
Pur con queste carenze l’industria meccanica di Mi- Uno studio di qualche anno fa (“Nascita e diffusione
lano era pur sempre la “principalissima” della città dell’industria automobilistica milanese e del suo in-
e distaccava gli altri settori per l’ammontare dei ca- dotto”, di Roberto C. Garberi, in “Storia in Lombar-
pitali investiti. Il quadro che emerge è quindi quello dia” anno XXVIII, n. 3, 2008) ha stimato in 277 il nu-
di una città in cui l’avvio dell’industrializzazione era mero di imprese aventi titolo a rientrare, per un arco
contraddistinto non solo dalla proliferazione di fab- temporale che va dalla fine dell’Ottocento agli anni
briche di grandi dimensioni bensì anche dalla diffusio- Trenta, nel comparto automobilistico, ripartendosi
ne di “un’industria di dettaglio”, caratterizzata da un per il 13% in costruttori (37 aziende), 18% fabbricanti
tessuto diffuso di piccoli “lavoreri” e di fabbricazioni di accessori (50 aziende), 45% rivenditori/importatori
a domicilio, che si affiancava alle già esistenti grandi (124), 6% carrozzerie (18 aziende), 17% servizi vari
fabbriche. Una Milano industriale in cui si affollavano (48 aziende). Ma se consideriamo soltanto gli anni
medi e piccoli stabilimenti gestiti da imprenditori che fino alla Grande Guerra, contiamo 21 costruttori, 4
erano a volte ex operai e che svolgevano nelle loro fabbricanti di accessori, 8 rivenditori, 9 carrozzerie, 1
aziende le funzioni di direzione tecnica, attività com- operatore di servizi vari .
merciali e controllo. Alcune iniziative imprenditoriali nel settore automo-
Nel periodo successivo, dagli anni Novanta allo scop- bilistico ebbero origine da tecnologie e, in parte, ca-
pio della Grande Guerra, la situazione egemonica di pitali esteri: la casa anglo-francese Darracq si era pro-
Milano nel panorama economico del paese si andò posta la creazione di una filiale produttiva a Napoli
vieppiù consolidando. Il decollo e l’affermazione di (1906), decidendo nel prosieguo di erigere i propri
Milano quale maggiore centro industriale italiano fu- stabilimenti nell’area milanese del Portello. Fa parte
rono stimolati da un insieme di fattori favorevoli: larga di questo gruppo anche l’inglese Wolseley, che tentava
disponibilità di forza lavoro a basso costo, protezione nel 1907 la penetrazione sul mercato italiano con la
doganale, propensione sempre più manifesta dei ca- marca Wolsit, che però ebbe maggiore successo per
pitali all’investimento nel settore secondario, le nuove le biciclette che per le auto. In altri casi invece sorse-
possibilità di approvvigionamento energetico derivan- ro come ramo parallelo di un’azienda impegnata nel-
ti dalla realizzazione del trasporto dell’energia elettrica la meccanica leggera: per esempio l’Isotta Fraschini
a distanza (vedi la bella figura dell’imprenditore Etto- (1900), in cui i fratelli Fraschini provenivano da un’a-
re Conti, pioniere dell’applicazione dell’energia elettri- zienda produttrice di minuteria metallica; mentre la
ca ad usi industriali). L’assunzione del ruolo strategico Züst (1904) proveniva dalla produzione di macchine
centrale da parte della metalmeccanica andò di pari utensili e la Majocchi (1906), dalla bulloneria.
passo alla crescita del peso specifico dei rami elettrico In quatto casi, invece, l’azienda costruttrice è uno
e chimico. E anche sul piano culturale non si scherza- “spin-off ” dall’industria ciclistica, ramo tra i più mo-
va: nel 1905 si stampavano a Milano 323 periodici di derni del periodo, caratterizzato dalla lavorazione di
cui 13 quotidiani. precisione, dal ruolo preminente dell’assemblaggio
I dati statistici del 1900 per Milano rilevati dalla Dire- e dall’utilizzo di componenti quali i cuscinetti a sfe-
zione generale di statistica del Ministero di Agricoltu- re, le catene di trasmissione, le ruote gommate (tutti
ra, Industria e Commercio parlano genericamente di elementi che la rendono madre naturale del veicolo a
officine metallurgiche e di officine meccaniche, dedite motore), che aveva ugualmente solide radici a Milano.
alla produzione di caldaie a vapore, motori a vapore, Si può parlare di osmosi tra bicicletta e automobile
a gas ed idraulici; di macchine per l’industria; di pro- per la Bianchi, la Frera, la Türkheimer.
duzione del ferro vuoto e sagomato; di locomotive, È questo l’ambiente in cui muove i primi passi il no-
vagoni e carri da ferrovie e da tramvie; di apparecchi stro Giuseppe De Vecchi, fondatore dell’azienda a cui
da illuminazione e da riscaldamento; di macchinario diede il nome. Nato a Milano nel 1878, entra giova-
da illuminazione elettrica, apparati elettrici, strumenti nissimo presso l’armaiolo Legnani, e quindi completa
di ottica, di fisica e di calcolo. D’altronde la naziona- il suo apprendistato alla Prinetti & Stucchi, azienda
lizzazione delle Ferrovie aveva dato notevole impulso che nel 1883 aveva introdotto in Italia la costruzione
al polo del materiale ferroviario, favorendo la trasfor- di macchine per cucire, estendendo in seguito la sua
mazione in grandi industrie di imprese già esistenti da attività anche alle biciclette e alle piccole automobili.
qualche decennio come la Breda, le Officine Meccani- È intraprendente, appassionato di meccanica, affasci-
6nato dalle novità. Nel 1903, venticinquenne, si unisce La partecipazione della De Vecchi alla II Esposizio-
ad un amico di ventitré, Ettore Strada. Insieme, apro- ne Internazionale di Automobili a Torino del 1905 è
no una sorta di garage, che nella “Guida dell’Auto- attestata da un bel diploma di partecipazione, firmato
mobile Club di Milano” del 1904 viene citato come da Goria Gatti, una delle personalità torinesi più di
“De Vecchi e Strada, via Bertani 16”, nella categoria spicco in ambito organizzativo e giornalistico. I Saloni
“Garages e depositi benzina”. L’anno dopo (“Catalo- si susseguono in entrambe le città per alcuni anni, con
go Automobile Club Milano”) compare nuovamente grande confusione sulla numerazione delle diverse
sia nella categoria “Garages e depositi benzina”, sia edizioni: ciò è comunque testimonianza di una note-
in quella titolata “Elettricità”, dove sono elencati la vole vivacità di entrambe le città, ugualmente elettriz-
Achille Fusi, la Ghirardi & Giardini, la Türkheimer zate di fronte a questo nuovo prodotto industriale,
e la Ceirano. E l’Isotta Fraschini; che nasce anch’essa che coinvolgeva così tanti mestieri e competenze, e si
come garage a supporto di una organizzazione com- affacciava su un mercato di cui i più coraggiosi indo-
merciale, e che solo nel 1904 sarà trasformata in ano- vinavano le enormi potenzialità.
nima e dotata di uno degli stabilimenti industriali più In ogni caso la De Vecchi si divide equamente: oltre
moderni del periodo. che a Torino nel 1905, dove occupa lo stand n. 51
Il 1903 è anche l’anno in cui nel capoluogo lombardo esponendo uno châssis e una moto, è presente a Mi-
nasce l’Automobile Club di Milano, e in cui circolano lano nel 1906, stand n. 56, dove presenta lo châssis
più auto che in qualsiasi altra città italiana, compresa “DVS” con motore 4 cilindri 10 CV di cui si dice che
Torino, 194 auto rispetto alle 1440 in tutta Italia (a è “con doppia accensione magneto ed accumulatori”.
Torino sono 178: dati dell’ACM). E non sono poche Una splendida doppia pagina del numero speciale di
le fabbriche: 5, sulle 15 del territorio nazionale (Bian- maggio 1906, dedicato al Salone dalla rivista “L’Au-
chi, Isotta Fraschini, Prinetti & Stucchi, Luigi Figini, e tomobile”, descrive con entusiasmo l’iniziativa De
la Camona Giussani e Turinelli, nata quell’anno dalla Vecchi, equiparandola alle più moderne tendenze
confluenza di due imprese di Sesto San Giovanni e americane. Infatti mentre in Europa si privilegiava la
che costruiva auto elettriche), oltre ad altre due azien- costruzione di vetture veloci e potenti, e di conseguen-
de costruttrici di motori per automobili (la Soc. It. za costose, negli Stati Uniti si badava maggiormente
Motori Daimler e la Alfredo Lazzati). Per quest’ulti- alle esigenze di un pubblico più vasto, più interessato
mo caso occorre ricordare che erano infatti molte le ad una vetturetta leggera, popolare per acquisto e per
fabbriche italiane che non si costruivano in proprio i manutenzione. Il debutto della Ford T, la vettura utili-
propulsori: per esempio i tricicli presentati dalla Pri- taria per eccellenza (1908), non si farà attendere mol-
netti & Stucchi montavano motori De Dion, come to. La 10/12 HP della De Vecchi Strada & C., esposta
anche il quadriciclo a motore della Edoardo Bianchi. al Salone, sembra proprio andare in quella direzione:
È chiaro dunque che nei primi anni, 1903 e 1904, i due più di quanto facessero, ai tempi, la Fiat, o la Itala, o
amici tastano il terreno e le proprie possibilità lavo- l’Aquila Italiana, presente per la prima volta a questo
rando come officina di riparazioni e garage: un’attività Salone. Una osservazione dell’articolista pare interes-
che dà loro occasione di approfondire i segreti della sante, quella relativa allo châssis, “in acciaio stampato
meccanica e mettere a punto le proprie idee personali. ricurvo e ristretto anteriormente, di fabbricazione della stessa
A fine 1905 anche i due amici si decidono: viene co- ditta DVSC che ha assunto la fabbricazione dei châssis... di
stituita la società De Vecchi, Strada & C, con capitale cui si è resa fornitrice già di parecchie fra le migliori fabbriche
di 300.000 lire (96.000 versate), e uno scopo chiaro: la di automobili”. È un Salone, questo a Milano del 1906,
costruzione di automobili. Sede è sempre in via Ber- di particolare rilievo: è organizzato nell’ambito dell’E-
tani 16, indirizzo di casa di De Vecchi; gli altri soci sposizione Internazionale del Sempione, per celebrare
sono Giuseppe Borioli, Alberto Casalbore, Umberto il Traforo Ferroviario inaugurato l’anno precedente,
De Benedetti, Adele Faina ved. Sirtori, Paolo Mezza- che aveva reso possibile la prima linea ferroviaria tra
notte, Carlo Rogorini, Carillo Rovere, Gian Giuseppe Milano e Parigi. La De Vecchi ottiene Diploma e Me-
Taccani, Giovanni Tomasina. La sede, già l’anno suc- daglia di Bronzo. Non male per una quasi esordiente.
cessivo, viene spostata in via Melzi d’Eril 32a e quindi Nel 1907 la De Vecchi è presente sia a Torino sia a
in via Peschiera 2 (una parallela di corso Sempione,
strada storica per l’automobilismo milanese¹).
1. Invece nella zona nord-ovest, chiamata genericamente
Gli anni dei saloni “del Sempione”, si insediano i costruttori di automobili i
quali, negli anni Venti e Trenta, operavano in stabilimenti
La vettura che decidono di mettere sul mercato, appro-
di grandi dimensioni; è il caso dell’Alfa Romeo, dell’Isot-
fittando delle vetrine offerte dai frequenti Saloni che
ta Fraschini (già presenti dagli anni Dieci), della fabbrica
si svolgevano in quegli anni sia a Torino sia a Milano, di carburatori Memini, della carrozzeria Touring e di altre
è una 10/12 HP, a 4 cilindri verticali separati, 3 marce industrie che avevano bisogno per la loro attività di grandi
più retromarcia, trasmissione a catena, valvole bilaterali. aree edificabili, non disponibili in altre zone cittadine.
7Milano. Anche questi Saloni riscuotono un gran suc- duzione la 12 HP, ma è presentata sul mercato anche
cesso: nel 1907 a Torino gli espositori sono addirit- una novità: la 16 HP, sempre a 4 cilindri ma bibloc-
tura 166; a Milano, 197. Ora l’azienda ha anche un co, 4 marce più retromarcia, trasmissione a cardano.
Agente Generale di Vendita: è Federico Momo, con Un modello decisamente più moderno. Entrambi i
sede in Foro Bonaparte. Momo non è un novellino modelli vengono esposti a Torino (80 gli espositori),
in questo ambito: è già esclusivista per Lombardia e insieme anche ai tipi da 14 e da 18 HP, e persino un
Veneto della torinese Junior (sempre un intreccio tra esemplare di camion: così per lo meno recita una pub-
Milano e Torino), azionista minoritario della OTAV di blicità realizzata per il Salone, poco prima del cambio
Max Türkheimer e promotore della fusione tra le due societario (infatti l’azienda è ancora indicata come De
aziende (Otav e Junior). Vecchi Strada & C.). E su un annuncio comparso sulla
Ma non dobbiamo pensare a una crescita del settore Stampa Sportiva pochi giorni dopo, i due modelli, 12
graduale ed inarrestabile, ad anni felici di sperimen- e 16 HP, vengono definiti “la perfezione dell’odierna
tazioni e successi... Furono anni in realtà tormentati, concezione dell’automobile”.
contradditori, dai risvolti drammatici. Come già ac-
cennato, la crescita del comparto automobilistico fu Le prime corse
tumultuosa ed eccessiva. La corsa alla speculazione si A sostenere l’impresa, occorre una buona capacità
fece dilagante e vertiginosa. E come sempre in questi comunicativa: e difatti, poche settimane dopo, la De
casi, il “crack” non si fece attendere: già nella seconda Vecchi decide di iscrivere due sue macchine alle corse
metà dell’anno 1906 si potevano notare i primi segni di velocità in programma sul rettilineo da Padova a
della recessione, che fu totale e disastrosa nel 1907². Bovolenta, il 5 aprile 1908.
Per fare alcuni esempi: le azioni Fiat si svalutarono del Non si tratta dell’esordio assoluto: quello era avvenu-
95% in pochi mesi; del 50% quelle dell’Itala; si ridus- to due anni prima, nell’aprile del 1906, quando il pi-
sero di quattro quinti quelle della Rapid. Entrarono lota Giulio Sirtori guidò una D.V.S.C. (questo il modo
in gioco sia fattori di crisi internazionale (al mercato con cui si iscrisse) nella prima categoria della Milano
americano furono imposte notevoli restrizioni, delete- – San Remo, quella che vedeva gareggiare gli chassis
rie per le nostre esportazioni) ma soprattutto si pagò di costo da 4.000 a 8.000 lire. Non fu evidentemente
dolorosamente lo scotto di questa crescita artificiosa un gran successo, perché Sirtori è citato fra gli iscritti,
ed improvvisata. Il mercato interno non poteva assor- ma non fra i vincenti (una pubblicità della Taurinia,
bire la produzione di così tante aziende, più di quaran- ripetuta su molti fascicoli di Stampa Sportiva, si vanta
ta tra Torino e Milano. Alcune erano addirittura sorte di essersi imposta sulle squadre Otav, Rapid, De Vec-
su basi fittizie, prive cioè di un qualsivoglia impianto chi). La seconda vettura iscritta, guidata da Federico
di produzione; altre si erano rovinate per partecipare Momo, dovette presumibilmente ritirarsi.
alle corse, uno dei sistemi pubblicitari più efficaci ma Da notare che Sirtori non era uno qualunque: nel 1908
anche più costosi ed impegnativi; altre non erano ri- parteciperà su una Züst al raid da New York a Parigi,
uscite a superare la fase pionieristica ed artigianale di attraversando tutto il continente americano fino allo
produzione, finendo perciò schiacciate dalle società in Stretto di Bering, di lì passando in Siberia e quindi in
grado di sviluppare una produzione standardizzata ed Europa. Un’impresa epica.
organizzata, frutto di investimenti anche tecnologici. È plausibile supporre che la signora Faina vedova Sir-
La De Vecchi traballa, ma resiste. E rilancia. Al fine di
estendere il capitale societario, i due soci decidono un 2. Per dare un’idea, Motori Cicli & Sports del 1° maggio
azzardo: trasformare la società da anonima in acco- 1908 scriveva che “a Torino l’Aquila è in liquidazione, a
mandita (una forma di società che prevede due tipi di Napoli Hermes ha convocato i creditori, a Piacenza è chiu-
soci, gli accomandanti, responsabili limitatamente alla sa la Marchand, a Genova in liquidazione la Zena e la Flag,
quota conferita, e gli accomandatari, responsabili in a Milano la Serpollet Italiana è in aspettativa provvisoria,
solido illimitatamente). L’attività è la stessa, ma i mez- la Türkheimer riduce il capitale, e così la Fiat a Torino, la
zi finanziari sono aumentati: 215.000 lire versate, su Florentia a Firenze...”.
225.000. Gli accomandatari sono Giuseppe De Vecchi 3. Come un dirigente sportivo inglese potesse interessarsi
e Umberto De Benedetti. È il 23 febbraio del 1908, e all’industria automobilistica non è un mistero. Ce lo spie-
con un rogito del notaio Ponzani si sancisce la nascita ga indirettamente Ettore Conti nel suo diario (“Dal Tac-
della nuova Società De Vecchi & C. Accomandita per cuino di un borghese”) quando descrive la classe dirigente
Automobili. Escono di scena i soci Carillo Rovere e milanese d’inizio Novecento come un gruppo composito,
Giovanni Tomasina; entrano invece Alessandro Mag- plasmato da forti personalità, coeso e insieme pronto a me-
scolarsi con le altri componenti dell’elite urbana, riferendo
gi, Alfred Ormond Edwards³ (co-fondatore nel 1899
della loro consuetudine di incontrarsi a colazione al Caffè
della Milan Cricket and Football Club) e Luigi Stabbia.
Cova di via Montenapoleone a Milano, che tanto ricorda
Strada rimane, ma solo come socio accomandante (e il caffè Burello di torinese memoria. E quando scopriamo
difatti non c’è più il suo nome nel logo). Resta in pro- che Edwards era grande amico di Pirelli… il gioco è fatto.
8tori, che compare già nel primo Consiglio di Ammini- divulgatore automobilistico, autore di una sorta di Bi-
strazione della De Vecchi, sia sua madre. gnami per meccanici, chauffeurs e proprietari, uscito
Nel 1908 molte cose sono cambiate rispetto a quel in molteplici edizioni (dal 1899 al 1925), a sancire la
primo tentativo sportivo. Entrambe le macchine buona costruzione della De Vecchi. Una analisi così
iscritte dalla De Vecchi rientrano nella I° categoria, approfondita di un modello della Casa permette di
che prevede un peso massimo di 650 kg e un alesag- stilare una dettagliatissima scheda tecnica: eccola.
gio non oltre gli 80 mm (nella VI categoria l’alesaggio “Automobili De Vecchi Strada & C. Questa casa costrui-
massimo era di 130 mm, il peso 1100 kg); una guidata sce specialmente vetture di 12 CV a 4 cilindri. Il Chassis è
da De Vecchi stesso, l’altro da un certo La Manna. Il di acciaio stampato ed atto a ricevere qualunque carrozzeria
rigore dei controlli è tale che i concorrenti devono (tasto già premuto nel catalogo, evidentemente qualità
smontare davanti ai commissari i cilindri del moto- che permetteva la realizzazione “ad personam” della
re, in modo da permetter loro di prenderne visione vettura finita). Le molle sono lunghissime e del miglior acciaio
e misura. La De Vecchi ottiene un risultato più che (una annotazione profetica, visto il successivo svilup-
lusinghiero, perché proprio l’auto guidata dal fonda- po industriale della De Vecchi...), le posteriori collocate
tore vince la sua categoria, alla media di 63,683 km/h, lateralmente e nella parte esterna del chassis. Le ruote sono con
percorrendo il tratto dei 10 km in 9 minuti 25” e 3 mozzi in acciaio montati completamente su cuscinetti a sfere, le
decimi, e meritandosi la Targa d’Argento. misure delle gomme sono mm 810 x 90 anteriori e mm 815
La vettura é presumibilmente una 10/12 HP, motore x 105 posteriori. Il motore è a 4 cilindri separati con valvole
biblocco 4 cilindri, trasmissione a catena: una versio- comandate, con regolatore che permette di variare il numero dei
ne rimaneggiata di quella prima 10/12 HP presente giri da 150 a 1400. Detto regolatore è comandato a mano
in catalogo fin dal 1904/1905. Però ha delle caratte- sul volano di direzione (ossia, il volante) insieme all’anticipo
ristiche su cui vale la pena soffermarsi. Il motore è dell’accensione. L’acceleratore è a pedale, con funzionamento
disassato e ha un volano ventilatore (licenza Daimler regolare dolce e silenzioso il quale prova come la sua costru-
Benz) abbastanza leggero; non ha quindi un ventila- zione sia perfetta sotto ogni rapporto. L’accensione del motore
tore separato con i relativi problemi di trasmissione e è fatta con magnete Bosch ad alta tensione con candele normali
assorbimento di potenza. Le masse alleggerite contri- senza complicazione alcuna di comandi come nell’accensione
buiscono ad un numero di giri di circa 1800 al minuto, per rottura. Il carburatore speciale a livello costante con presa
quando quelli delle altre vetture si aggirano tra i 1200 d’aria supplementare automatica, dà al motore una miscela di
e i 1500 al minuto. Di qui una maggior potenza, pur gas tanto perfetta e costante, che permette di ottenere una mar-
con alesaggio ridotto, e prestazioni brillanti. Il ponte cia regolare e silenziosa con un minimo consumo di benzina
posteriore è un piccolo capolavoro di progettazione (che però non viene quantificato). Il raffreddamento è
ed esecuzione con le fodere dal differenziale alle ruote assicurato da pompa centrifuga, e da radiatore a grande super-
di forma conica, forgiate e forate dal pieno, poi alesate ficie del tipo ad alveare; inoltre il volante del motore disposto
insieme per garantire gli allineamenti, in modo da li- a ventilatore, concorre a migliorare tale raffreddamento. Con
mitare il rischio, frequente di quei tempi, della rottura questa disposizione il motore può funzionare anche adagissimo
dei semiassi. La licenza costruttiva del ponte è ceduta e con vettura ferma senza pericolo di riscaldamento. Il cambio
alla Daimler Benz in cambio di quella del volano ven- di velocità è a train balladeur, tre velocità e contromarcia (ossia
tilatore. retromarcia); con la grande velocità in presa diretta montato
su cuscinetti a sfere; con differenziale accoppiato. Gli ingranaggi
Echi sulla stampa sono fresati e del miglior acciaio al nikel Krupp; lavorano nel
Dunque capitali freschi, buoni risultati sportivi (e per- grasso e sono comandati da una sola leva. I freni danno piena
ciò buona pubblicità) e buona stampa. La De Vecchi garanzia di un funzionamento dolce, pronto e sicuro. Essi sono
decide infatti di stampare un catalogo, di cui dà co- due: uno a ceppo sulla scatola dal differenziale e nell’interno del
scienziosamente conto la rivista Motori Cicli & Sports carter d’alluminio, lavorante costantemente nel grasso e l’altro
del 15 giugno 1908. “Il catalogo porta la qualifica di provvi- a espansione funzionante nell’interno degli ingranaggi applicato
sorio ma contiene tipi ben definiti e definitivi. Vi troviamo l’in- sulle ruote posteriori. Il primo viene comandato da una leva a
tera serie delle vetture con motore a 4 cilindri: 12 HP, 14 HP, pedale, il secondo è manovrato con leva a mano sita a fianco del
16 HP, 18/24 HP e il tipo per omnibus o camion da 28/35 conducente. La trasmissione è a catena; tutti i movimenti di essa
HP. Vi è quindi una estesa scelta specialmente nei modelli sono montati su cuscinetti a sfere.
per città e da medio turismo. Come si vede dai disegni e dalle Lo sterzo è completamente irreversibile a vite senza fine, sul
fotografie gli chassis De Vecchi Strada & C. sono costruiti volante di direzione sonvi due manette: l’una pel gas e l’altra
magistralmente, sono dotati di tutti gli ultimi perfezionamenti, per il comando dell’accensione al motore. La lubrificazione dei
e si prestano ad ogni tipo di carrozzeria per città e da viaggio”. vari organi è accurata in modo particolare, dipendendo in gran
Ma è soprattutto il manuale firmato dal dottor Ga- parte da essa il buon funzionamento e la durata della macchi-
ribaldi Pedretti (“Guida del meccanico chauffeur na. Degna di un cenno speciale è la lubrificazione del motore e
conduttore di automobili”, Hoepli, 1908), notissimo del cambio di velocità che vien fatto a mezzo di un distributore
9automatico semplice e preciso. Tale distributore è applicato sul vapeur surchaffée”), e quindi rilevato da John Henry
parafango anteriore, e funziona per l’azione dello scappamento Exshaw, di Arcachon (F), nel maggio 1911 e registrato
del motore. Automatica e a pressione è pure la distribuzione all’Ufficio Demaniale di Torino, il 21 maggio 1911, al
della benzina”. n. 24739, come rende noto la Gazzetta Ufficiale del
Il 1909 si presenta dunque sotto ottimi auspici, per Regno d’Italia del 18 dicembre 1911.
la casa milanese. Proprio a Milano dal 5 al 15 giugno,
in occasione dell’inaugurazione del nuovo Palazzo Le grandi corse
dell’Automobile Club, si svolge una Esposizione di Quell’anno però diventa cruciale per la storia della
Automobili alla quale la giovane azienda decide di par- De Vecchi con ben altro, anche se lì per lì in azienda
tecipare (stand n. 52, nel quale si reca il corridore Bep- non ve ne è consapevolezza. Nel 1908 era entrato in
pe Tamagni come “testimonial” di eccellenza), tanto officina un giovane veneto, un certo Antonio Ascari,
più che al modello 10/12 HP si è aggiunto il Tipo A arrivato da poco a Milano insieme alla famiglia di pic-
16/20 HP di 2,8 litri, già presentato al Salone di To- coli commercianti. Si era fatto un po’ di esperienza
rino dell’anno precedente e presente sul catalogo. Ne meccanica in un’officina di biciclette di campagna: ma
dà un preciso resoconto Motori Cicli & Sports del 1° alla De Vecchi cresce velocemente. Non rimane molto
giugno. Su entrambi i tipi il telaio è in acciaio stampa- però: su suggerimento di un notabile del suo paese
to, ristretto anteriormente, motore a 4 cilindri verticali di origine emigra in Brasile insieme al fratello Ame-
gemelli a valvole comandate simmetriche, carburatore deo, alla ricerca di maggior fortuna, presumibilmente
automatico, accensione magnete ad alta tensione. La lasciando l’azienda nel 1909. Che l’avesse lasciata o
grande novità è che il 16/20 ha trasmissione a car- che fosse rimasto imparolato in qualche modo, ma-
dano. Nella bella inserzione pubblicitaria riprodotta a gari come rappresentante commerciale non è chiaro,
pag. 17 l’impostazione grafica punta proprio su que- ma non è granché presumibile che potesse pensare
sto dualismo: sotto il bel logo dell’azienda, due mani di vendere solo De Vecchi, nel Nord-Est (Belem) del
sul volante all’interno di un tondo, sono presentati i Brasile. Alla morte nel 1911, per febbre gialla, del fra-
due telai, a cardano e a catena, sempre indicati in base tello decide di rientrare in Italia. Torna ufficialmente
agli HP. Non era marginale questa abitudine di defini- in De Vecchi? Non è certo. Forse è più plausibile che
re i propri modelli citando i “cavalli”, perché da essi stabilisse un commercio generale di automobili a Mi-
dipendeva la tassazione. È sempre la potenza in primo lano (probabilmente con officina) tra cui anche le De
piano, anziché la cilindrata… e il motivo è appunto Vecchi. Comunque all’inizio della guerra fonda un’of-
fiscale. Proprio nel maggio del 1909 la rivista Motori ficina (Falco) che stranamente ha lo stesso indirizzo
Cicli & Sports aveva anticipato i pesanti carichi fiscali di De Vecchi (via Peschiera) per riparare aeroplani
in arrivo sulle vetture: fino a 6 HP prevista un’imposta militari.
di 90 lire, fino a 12 HP 140 lire, fino a 16 HP 180 lire, Ma sta di fatto, e questa tra le tante supposizioni è
fino a 24 HP 220 lire, fino a 40 HP 300 lire, fino a 60 cosa certa, che su una De Vecchi partecipa al Crite-
HP 400 lire, oltre questa potenza 500 lire. Si tratta di rium di regolarità di Modena nel 1911, anche se non
una legge in vigore dal 1° gennaio 1910. con grandi risultati. È il suo esordio nelle corse, la sua
Un nuovo modello, il 20/30 HP, da 4.1 litri, trasmis- prima gara in assoluto, e una foto, sia pure di non ec-
sione cardanica con trasmissione ausiliaria a catena, celsa qualità, lo ritrae a bordo della vettura insieme ai
è presentato al Salone di Torino del 1910, uno dei due Commissari Castoldi e Gioncada. Dunque uno
più importanti del periodo, 10.000 metri quadri co- dei più grandi campioni italiani di automobilismo di
perti e ben 206 espositori. È ancora un biblocco: il questo primo quarto di secolo (morirà nel 1925), pa-
primo motore monoblocco è dell’anno successivo, dre di un pilota a sua volta campione, Alberto Ascari,
ed è montato sulle nuove versioni del 16/20 HP e è transitato dalla De Vecchi, e non in maniera margi-
20/30 HP. Probabilmente è una di queste nuove ver- nale. Il Criterium di Regolarità di Modena (23-29 apri-
sioni a essere esposta all’Esposizione Internazionale le 1911) è una “sei giorni” dal regolamento complica-
delle Industrie e del Lavoro, organizzata a Torino nel tissimo, con varie prove su percorsi differenti per una
1911 per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, e all’in- lunghezza complessiva di 1500 km, da percorrere ad
terno della quale Giuseppe De Vecchi ottiene il di- una velocità mai superiore ai 50 km/h. 5 le tappe, con
ploma di medaglia d’oro “per collaborazione”. De partenza e arrivo a Modena (I, km 339, II km 247, III
Vecchi è premiato nell’ambito del Gruppo XI, Clas- km 280, IV km 404, V km 230).
se 60 (Automobilismo-Motociclismo-Autoscafi), per La seconda vettura iscritta dalla De Vecchi è pilotata
aver esposto lo chassis a benzina 16/20 HP, il carro da Ugo Sivocci, entrato in azienda come chauffeur e
e omnibus a vapore e a combustione di coke licenza meccanico, con compiti di collaudo, e che vi rimarrà
Purrey-Exshaw. Si tratta di un brevetto originariamen- fino al 1920, quando sarà già CMN. I due guidano i
te registrato da un certo Valentin Purrey, di Bordeaux modelli già descritti, il primo una 16/20 HP 4 cilin-
(F), il 10 gennaio 1905 (“Générateur multitubulaire de dri monoblocco 90x110, il secondo una 20/30 HP 4
10cilindri monoblocco 80x130. Ad Ascari assegnano il vettura completa, anche se ci troviamo in un periodo
n. 13... che non gli porta granché fortuna: è squalifi- in cui generalmente la casa costruttrice forniva solo il
cato nella III tappa per “irregolarità di marcia” non telaio, che quindi il cliente provvedeva a carrozzarsi
avendo consentito ad un concorrente di superarlo. Per per conto suo. In ogni modo la gamma dei prezzi dei
dovere di cronaca, ad aggiudicarsi la Coppa Reale è la modelli De Vecchi varia dalle 9.500 (per il Tipo D)
SPA, pilota Augusto Spadoni; la Coppa della Camera alle 13.000 lire chieste per il Tipo C; intermedi sono
di Commercio è del Conte Isolani, su Lancia; Sandon- i Tipi A (10.000 lire), B (12.500 lire), E (11.500). È
nino, su Scat, vince la medaglia d’oro dell’Automobile tanto, o si inserisce in quelle che erano le normali quo-
Club d’Italia; Ernesto Ceirano, ancora su Scat, quella tazioni di mercato? Per fare un confronto, la Bianchi
del Touring. Insomma, tutte marche torinesi. mette in vendita la sua vettura da turismo 25/35 HP
4 cilindri monoblocco, dimensioni 110x140, trasmis-
Nuovi modelli e nuove denominazioni sione cardanica, a 14.000 lire; la Scat il suo 25/35 HP,
Intanto la De Vecchi rinnova la sua linea di produ- 100x150 cc, trasmissione cardanica, a 12.000 lire; la
zione. Alla fine del 1910, come riportano le tabelle di SPA il 25/30 HP 100x140, trasmissione cardanica, a
Motori Cicli & Sports (28.11-4.12 1910), i modelli in 15.000 lire. Si tratta di costi molto simili a quelli del
catalogo sono quattro, tutti a 4 cilindri: il 20/30 HP Tipo C (monoblocco 25/35 HP 110x150). Siamo in
nelle due versioni con trasmissione a catena e motore linea, dunque, con le tendenze di mercato.
biblocco, e con trasmissione cardanica e motore mo- Il 13 giugno di quello stesso anno (1912) Ettore Stra-
noblocco, dimensioni 100x140 mm, una differenza di da, socio accomandante insieme a Giuseppe De Vec-
100 giri al minuto per il monoblocco (da 1200 a 1300). chi, cede la propria quota di 5.500 lire a Umberto De
Gli altri sono le due versioni del 16/20 HP, entrambe Benedetti, in società dal primo giorno. Esce dunque di
con trasmissione cardanica, motore biblocco 90x110, scena il primo compagno di avventura del De Vecchi,
oppure motore monoblocco 80x130, tutti e due 1350 quello dell’officina in via Bertani, della prima moto,
giri/minuto. Li affianca una produzione di veicoli in- della prima vettura leggera; mentre si rafforza la quo-
dustriali: il camion da 30 quintali 20/30 HP 110x140 ta di De Benedetti (ingegnere civile, proprietario di
e il camion da 50 quintali 28/40 HP, 120x140. Infi- terre), già di gran lunga la più corposa: 100.000 lire,
ne è in catalogo anche la Spazzatrice – Raccoglitri- ora 105.500 lire, a fronte delle 8.500 possedute da
ce Stradale, allestita sempre con il motore 20/30HP Giuseppe Borioli, 7.500 dal notaio Casalbore, 11.500
110x140. dallo stesso De Vecchi, 5.000 da Adele Faina ved. Sir-
Questo è un modello su cui punta molto la De Vec- tori, 8.000 da Alessandro Maggi, 20.500 dall’ing. Pao-
chi. Utilizzando i brevetti Guerrini per il sistema di lo Mezzanotte, 10.000 da Alfred Ormond Edwards,
spazzatura (brevetti di proprietà della Società per la 13.000 da Carlo Rogorini, 5.000 da Luigi Stabbia,
manutenzione stradale Gola, Conelli & C.) l’azienda 20.500 da Giovanni Taccani.
mette a punto un veicolo molto particolare, che im- Un anno dopo (MC&S 31.12 1913), risultano in pro-
pressiona favorevolmente (sembra) le autorità milane- duzione solo tre modelli, ciascuno in duplice versio-
si. Lo spazzolone si muove a numero di giri costante, ne normale e allungata. Sono tutti con motore mo-
qualunque sia la velocità della vettura; i suoi organi noblocco, 4 cilindri, trasmissione cardanica, passo di
di movimento girano, nella stessa direzione, anche a 2,95 m, ruote in acciaio. Il Tipo D è un 15/20 HP
vettura ferma, e persino a veicolo in retromarcia. Man 80x130; il Tipo E è un 20/25 HP 90x130; il Tipo F è
mano che viene raccolta, la spazzatura “viene lanciata un 25/30 HP 90x140. Anche in questo caso disponia-
nell’apposito cassone”. L’area spazzata è di un metro mo dei prezzi: vanno dalle 9.500 lire chieste per il tipo
e mezzo, e in un’ora, alla velocità di 12 km/h, l’area D normale alle 12.750 per il Tipo F allungato. Per fare
ripulita è stimata in 18.000 metri quadri. Abbastanza un confronto, il Tipo Unico della Feroldi, un 4 cilindri
da far sognare qualunque amministratore urbano. 90x130, dunque di cilindrata, potenza e ingombro si-
Tra il 1911 e il 1912 esordiscono invece sul mercato mili, è messo in vendita a 9.000 lire; la Bianchi 25/40
le nuove denominazioni dei tipi A, B, C, D ed E. Il HP, 100x140, a 14.000 lire; la Nazzaro 20/30 HP 100
primo non è altro che il solito biblocco 16/20 HP x 140 a 12.000 lire. Ancora una volta la De Vecchi si
90x110; il secondo è il biblocco 20/30 HP 100x130; inserisce in una gamma di prezzi “di mercato”.
gli altri sono il 25/35 HP 4 cilindri monoblocco E a proposito di mercato: “Un nuovo e grandioso locale
110x150 (tipo C4), il 15/20 HP 4 cilindri monoblocco per esposizione delle proprie vetture automobili è stato aperto
a corsa lunga 80x130 (Tipo D) e il 20/25 HP 4 cilindri da poco tempo dalla Ditta De Vecchi & C. in corso Sempione
monoblocco 90x130 (Tipo E). Tutti con trasmissione 8 a Milano. Ivi sono esposti chassis di nuovo modello e vetture
a cardano, 4 marce e retromarcia (così li descrive Mo- complete destinate ai vari rappresentanti d’Italia e dell’estero,
tori Cicli & Sports del 22-30.12 1912). Molto interes- come pure per la consegna immediata ai clienti”. Così scrive
sante leggerne anche i prezzi, su queste stesse tabelle MC&S del 7 maggio 1913. L’anno non è casuale: il
approntate dalla rivista. Si direbbero prezzi riferiti alla “nuovo e grandioso locale” viene individuato, allestito
11Puoi anche leggere