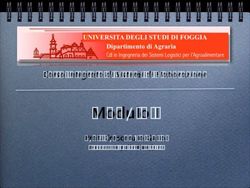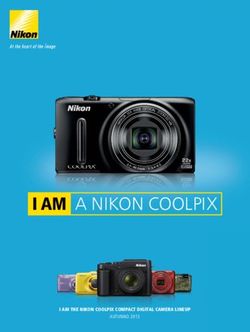Tra visualità e visualizzazione - Ocula
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
www.ocula.it • ISSN 1724-7810 • Vol 21 (November 2020) • DOI: 10.12977/ocula2020-50
Tra visualità e visualizzazione
Ai confini della «scienza dolce delle immagini»
di W.J.T. Mitchell: una lettura*
Valentina Manchia
Politecnico di Milano, Dipartimento di Design; CROSS
valentina.manchia@polimi.it
Abstract
In a semiotic perspective, in dialogue with a science of images, J.W.T. Mitchell’s Ima-
ge Science (2015) appears interesting not only for the theoretical contributions here
collected but for the argumentative structure bringing them together, that the author
himself does not hesitate to propose as a metapicture of his system of thought. This
essay therefore focuses both on the figurative (and figural) modalities of Mitchell’s ar-
gumentative strategies and on the theoretical possibilities that an open reflection on
interdisciplinary boundaries can open in different directions.
Keywords
Visual Culture Studies; Semiotics; Visual Semiotics; Image Theory; Verbo-Visual
Contents
1. Mitchell in forma di figura: una premessa semiotica
2. La chiave inglese come metapicture della scienza delle immagini e figura di confine
3. Tra scienze dure e scienze molli: confini e direzioni di ricerca tra visualità e visua-
lizzazione
Bibliografia
* Questo saggio è la versione rivista, estesa e aggiornata di un primo contributo già
pubblicato su Alfabeta2 il 2 dicembre 2018.
1Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
1. Mitchell in forma di figura. Una premessa semiotica
In un saggio sul frontespizio dei Principi di Scienza Nuova di Giambattista
Vico (1737), Omar Calabrese dipana, con dovizia di dettagli, quella «sorta di
tragitto dello sguardo che mette gli oggetti figurativi in connessione gli uni con
gli altri» (Calabrese 1999: 327) e porta la «dipintura» del frontespizio a far-
si carico dell’ossatura dell’argomentazione dei Principi e a darle corpo, sotto
forma di figura.
L’idea di un frontespizio che, come in Vico e più in generale nella tradizio-
ne dei frontespizi figurati, «serve al leggitore per concepire l’idea di quest’o-
pera avanti di leggere», quindi di una rappresentazione diagrammatica capa-
ce di restituire, sotto spoglie figurative, i rapporti di forza e le relazioni tra i
concetti portanti dell’argomentazione, ci sembra utile anche qui, per leggere
attraverso Mitchell.
La nostra idea, infatti, è che Scienza delle immagini non sia interessante
solo per i contenuti teorici che mette insieme (molti dei quali già editi), ma per
il modo in cui si occupa di tesserli insieme, e dunque per la figura dell’argo-
mentazione che ne risulta. Il libro, infatti, dalla scelta dell’immagine di coper-
tina alla struttura del volume, si occupa di testualizzare un momento teorico
molto specifico: lo sguardo al presente, e allo stesso tempo dal proprio passato
e dagli albori dei visual culture studies fino al presente, di uno degli autori
chiave nell’ambito della visualità contemporanea.
L’esito di questa operazione di testualizzazione del proprio pensiero è la
produzione di una figura al contempo esibita e nascosta, come nella Lettera
rubata di Poe: quella della chiave inglese di Allan Sekula come figura del rac-
cordo, della messa a sistema di prospettive teoriche differenti.
Il tentativo di queste pagine è dunque non solo quello di ripercorrere il
pensiero di Mitchell in Scienza delle immagini ma anche quello di portare alla
luce il pensiero diagrammatico interno ai saggi che lo costituiscono e che la
struttura stessa del libro proietta.
In una prospettiva semiotica – e al contempo di scienza delle immagini – ci
interesseranno dunque tanto le modalità figurative (e figurali) delle strategie
argomentative di Mitchell quanto le possibilità teoriche che una riflessione
aperta sui confini interdisciplinari può aprire in diverse direzioni teoriche.
2. La chiave inglese come metapicture della scienza delle im-
magini e figura di confine
Campeggia sulla copertina di Scienza delle immagini. Iconologia, cultura
visuale ed estetica dei media (Johan & Levi, 2018) di W.J.T. Mitchell la stes-
sa fotografia già scelta per l’edizione americana della University of Chicago
Press: la chiave inglese che è allo stesso tempo chiave di volta del progetto fo-
tografico di cui fa parte (Fish Story, 1995), ed emblema del “realismo sociale”
del suo autore (Allan Sekula, fotografo e teorico della fotografia).
Di certo la chiave abbandonata, ritrovata e immortalata da Sekula due anni
dopo la chiusura per bancarotta di un cantiere navale, è parte di una serie
che è monumentale documentazione, dal 1988 al 1995, del cambiamento del
2Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
lavoro sui mari a seguito degli stravolgimenti della globalizzazione. E a rap-
presentare questo cambiamento – il radicale passaggio da un prima, florido e
attivo, a un dopo, improduttivo e vuoto – è in questo scatto e in altri della serie
la frizione tra l’immagine e quello che all’immagine sta intorno, in tutti i sensi.
Quello che vediamo sembra portarsi sempre dietro la ruggine, o la polvere,
dello sfondo su cui inevitabilmente si staglia.
Qui, sulla copertina di Scienza delle immagini, estrapolata dalla serie di
Sekula e posta in un nuovo contesto a offrirci un emblema del libro ma come
vedremo di Mitchell stesso, tra i padri fondatori di quel campo interdisciplina-
re di studi, sempre più vasto e sempre più sfrangiato, che ha nome di cultura
visuale, quella chiave inglese non può che farci riflettere.
Figura 1. La copertina di Scienza delle immagini con lo scatto di Allan Sekula dalla serie Fish
Story, 1995 (Welder’s booth in bankrupt Todd Shipyard. Two years after closing. Los Angeles
harbor. San Pedro, California)
È una sola immagine, dunque, quella che vediamo, o sono due immagini?
Solo l’immagine, netta e precisa, sbalzata a colori saturi, di un oggetto solido
e ben tangibile, o anche la traccia – fantasmatica – di quello stesso oggetto?
Proprio per questo doppio cortocircuito non poteva esserci copertina mi-
gliore per l’ultima raccolta di saggi di Mitchell, programmaticamente compo-
sta in un dittico, Figure e Sfondi, in cui la prima parte si assegna il compito di
mettere insieme riflessioni che pertengono alla natura di quelle che chiamia-
3Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
mo immagini, per quanto diverse esse siano, e la seconda traccia un quadro
– più quadri – sugli ambienti mediali e sulle condizioni di vita delle immagini.
Sfilano così, nella prima parte, contributi che fanno il punto sui concetti
chiave di quella «iconologia critica» o «iconologia del presente» in cui Mitchell
si è impegnato sin dai tempi di Iconology, la sua prima grande incursione in
quel nuovo campo, dei visual culture studies, che avrebbe egli stesso attiva-
mente concorso a costruire (Mitchell 1986).
Si tratta di concetti che sono poi filtrati, a volte anche sottotraccia, in molte
altre riflessioni nell’ambito della cultura visuale: la nozione di pictorial turn,
prima fra tutte, in parallelo all’iconic turn di Gottfried Boehm; la distinzione
tra image e picture («le pictures sono la dimora in cui le images prendono
residenza, i corpi in cui si incarna il loro spirito», Mitchell 2015: 77, tr. it.),
con in controluce l’antropologia delle immagini di Hans Belting,1 o il concetto,
volutamente ibrido, di imagetext, immaginetesto, tutto attaccato e senza se-
parazione tra i due, capace di accogliere in sé tanto quei testi che la semiotica
chiamerebbe sincretici, perché fondati contemporaneamente su più linguaggi
espressivi che si intersecano,2 quanto le immagini che si annidano anche tra
le parole – per esempio dietro le metafore. O, ancora, il fortunato concetto
di metapicture, immagine di immagini e in quanto tale dispositivo capace di
offrire un nuovo angolo di riflessione – l’anatra-coniglio delle Ricerche filo-
sofiche di Wittgenstein, per esempio, emblema dell’irriducibilità del punto di
vista, a ricordarci che le immagini sono sempre immagini per qualcuno.
Già da questa breve rassegna è evidente come la riflessione di Mitchell si sia
espansa, in mille rivoli, lungo il territorio via via sempre più esteso e variegato
della cultura visuale – per una mappatura rimandiamo al puntuale e prezio-
so lavoro cartografico di Andrea Pinotti e Antonio Somaini (Pinotti-Somaini
2016) – ma soprattutto come abbia via via raccolto e convogliato le riflessioni
e gli stimoli di altri autori e discipline che hanno fatto teoria delle immagini.
La selezione dei saggi per la seconda parte del dittico, Sfondi, chiarisce
proprio la genesi di un punto di vista così plurale rintracciandone le origini
nelle radici più profonde del pensiero dell’autore, arrivato all’iconologia da un
percorso obliquo che egli stesso riassume, in un paragrafo che traccia l’intera
parabola del suo lavoro:
Dal momento che io ero giunto allo studio della storia dell’arte dalla sfera della
letteratura e della teoria letteraria, spronato da un interesse generale per la teoria da
una parte e da un interesse specifico per l’arte composita del pittore-poeta William
Blake dall’altra, mi sembrava sempre più ovvio che la materia effettiva del mio lavoro
dovesse essere la relazione tra diversi media, forme artistiche, modalità sensoriali e
codici di significazione, così come quella tra le discipline impegnate nel loro studio.
(Mitchell 2015: 126, tr. it.)
1 Sull’antropologia delle immagini in Belting cfr. in particolare Belting 2001, e
anche Belting 2005.
2 Sul sincretismo tra linguaggi espressivi differenti – e sulle semiotiche
sincretiche come quelle semiotiche-oggetto che «costituiscono il loro piano di
espressione […] con elementi appartenenti a molte semiotiche eterogenee» cfr.
Greimas-Courtès 1979-1986: 320, tr. it.).
4Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
Lo sguardo plurale di Mitchell si forma infatti da subito sull’«arte composi-
ta» di Blake, al tempo stesso poesia, pittura (illustrazione?) e grafica (calligra-
fia?), che diventa da subito l’evidenza di un’irriducibile commistione, quella
tra testo e immagine – la madre, per l’autore di Iconology e dei successivi
Picture Theory (1994), oltre che di What do pictures want? (2005), di tutte le
commistioni tra media.
Figura 2. William Blake, Jerusalem, tavola 4, capitolo 1, 1804-1820.
«Dove comincia la scrittura? Dove comincia la pittura?» (Barthes 1984:
27, tr. it.) era già la domanda di Roland Barthes, anch’egli sempre vigile nei
confronti delle intersezioni tra forme e tra linguaggi, in particolare nell’in-
terrogarsi sulla poesia figurata giapponese, ed è una domanda che molti altri
studiosi sia all’interno del paradigma semiotico che nel campo interdiscipli-
nare della cultura visuale si sono posti e continuano a porsi, riflettendo sulle
molteplici intersezioni tra verbale e visivo.3
3 Facciamo riferimento, per esempio, a Schapiro (1996). Sempre all’interno del
paradigma semiotico, ricordiamo in particolare Polacci 2010. Nell’ambito della cultura
visuale James Elkins si è molto soffermato sia sulle intersezioni tra i due linguaggi che
sui casi più estremi, quelli in cui si assiste a una sorta di inesorabile spostamento dalla
scrittura all’immagine. Cfr. in particolare Elkins (1999).
5Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
La stessa domanda sui confini tra i linguaggi, cambiando volta per volta
oggetto, è quella che si ripete implicitamente Mitchell, ragionando sui media
che sono l’ambiente naturale in cui vivono e proliferano le immagini. Ambien-
ti o situazioni, più che dispositivi, sottolinea Mitchell in “Estetica dei media”
(2013, in Mitchell 2015, pp. 119-130) e come tali capaci di fare da sfondo (an-
cora una volta, questa parola) a più modalità sensoriali, che spesso si innesta-
no le une sulle altre.
Non esistono media puramente o esclusivamente visivi, né compartimenti
stagni nella linea d’evoluzione temporale dei media. Opera invece un «proces-
so continuo di ri-mediazione di forme più antiche» (seguendo Bolter-Grusin
1999), che rilegge continuamente forme e linguaggi, propone e ripropone le
forme mediali del passato in nuove forme, e modella combinazioni diverse
degli elementi estetici dei media, sempre in coerenza con «l’universo sensibile
che abitiamo» (Mitchell 2015: 127, tr. it.).
Anche per questo sfilano, nei saggi raccolti in questo libro, la fotografia e
l’architettura, la street art e la scultura, il terrorismo come guerra alle immagini
e la clonazione come eccesso di immagine – temi interconnessi tra loro, al cuo-
re del volutamente ambiguo Cloning Terror, che mette faccia a faccia il terrore
della clonazione e la riproduzione incontrollata del Terrore (Mitchell 2011).
Scienza delle immagini riconnette concetti e riflessioni di saggi ormai clas-
sici e già noti ai lettori anche in traduzione italiana (in particolare i saggi ora
in Mitchell 2017) a nuovi contributi, innestando al tessuto già consolidato da
saggi come “Pictorial Turn” (1992) e da “Che cosa vogliono davvero le im-
magini?” (1996) riflessioni più recenti, come il già citato “Estetica dei media”
(2013), tema quanto mai urgente nell’agenda della visual culture che discute
di digital turn.
In questa prospettiva, in cui si dipanano i fili delle riflessioni precedenti
per intrecciarle a un nuovo sguardo sul presente, è proprio Mitchell stesso,
nella coda che conclude la silloge, a introdurre l’immagine dell’immagine di
Sekula e a offrirla al lettore come una vera e propria metapicture del discorso
che lega insieme i saggi della raccolta:
La fotografia cattura una doppia apparizione, una cosa reale e la sua impressione,
quest’ultima rivelata da un leggero spostamento dell’oggetto che espone la sua traccia
o immagine postuma. È una “stampa a contatto” che esemplifica il doppio carattere
indessicale e iconico dell’immagine fotografica stessa, che produce significato attraver-
so la sua somiglianza formale e il suo status di traccia materiale simile a un’impronta.
[…] Dunque, nonostante la sua collocazione nel mondo completamente artificiale di un
cantiere navale moderno, essa ci ricorda che l’immagine è un fenomeno che attraversa
i confini tra natura e cultura, tra i processi fisico-chimici di natura non umana e le cre-
azioni dell’uomo. (Mitchell 2015: 227-228, tr. it.)
Presenza contemporanea di due apparizioni, quella di una cosa reale, la
chiave inglese, e quella della sua evanescente impronta, la fotografia di Sekula
è dunque deliberatamente lì per fare da segno – e come tale proponiamo di
leggerla qui, in queste pagine –, ovvero per indicare la via e ricordarci le mol-
teplici nature delle immagini.
6Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
Il doppio profilo della chiave inglese, che scopriamo solo grazie al suo spo-
stamento (non sappiamo quanto fortuito o quanto opera di Sekula, ma in fon-
do non è questo che ci interessa), allude direttamente, all’interno della cornice
teorica di Mitchell, all’apparire di ogni image «come figura su uno sfondo, in
un sistema annidato in un ambiente» (Mitchell 2015: 227, tr. it.), e alla com-
plessità di ogni apparire che è all’incrocio tra la natura di ogni specifico visibile
e le sue condizioni di vita. È dunque prima di tutto «allegoria grafica della rela-
zione tra figura e sfondo, tra oggetto e spazio» (ibidem) ma è anche, seconda-
riamente, rappresentazione della struttura portante dell’argomentazione, qua-
si un diagramma filosofico (per dirla con Fabbri 2015) del pensiero di Mitchell.
Da un’altra prospettiva, che lo stesso Mitchell introduce e somma alle pre-
cedenti in via metaforica, parlando della «tecnoscienza dolce delle immagini»
come di «una sorta di chiave inglese per aggiustare le connessioni tra scienze
dure e scienze molli» (Mitchell 2015: 228, tr. it), la chiave inglese di Sekula è
lì per introdurre, sin dalla copertina, il tema più profondo delle riflessioni che
Mitchell compie in Image Science, intorno e a margine del suo lavoro pre-
cedente sulle immagini, tema che corre sotterraneo attraverso tutti i saggi:
quello del confine e della sua continua messa alla prova.
A partire da qui, più in senso figurativo (e figurale) che in senso metaforico,
la chiave inglese abbandonata, a riposo dall’esercizio delle sue funzioni sul
banco di un saldatore ormai in bancarotta («Welder’s booth in bankrupt Todd
Shipyard. Two years after closing», recita la didascalia), rimanda anche alle
possibilità di connessione tra domini diversi ma comunque sovrapponibili,
e in potenza solidali tra loro: le discipline delle immagini, da una parte, nel
vasto dominio dei visual culture studies, ma soprattutto le scienze dure e le
scienze umane, a loro modo alle prese con le immagini e forse, suggerisce Mi-
tchell, sollecitate a riflettere su una saldatura possibile tra sguardi differenti.4
3. Tra scienze dure e scienze molli: confini e direzioni di ricerca
tra visualità e visualizzazione
«Fenomeni che attraversano i confini» sono infatti le immagini, oggetti
materiali e tangibili ma allo stesso tempo molto più di questo, capaci di migra-
re, trasformarsi e circolare liberamente, attraverso lo spazio e il tempo – come
la dialettica tra image e picture ricorda e come, prima ancora, testimoniano
Aby Warburg e il suo progetto di Atlante.
Ed è al centro delle attenzioni di Mitchell anche il confine tra discipline,
che stimola frizioni (quando non attriti) tra iconologia e storia dell’arte da una
parte e semiotica, sociologia dei media, e cultural studies dall’altra – confine
già sfidato da chi, come e prima di Mitchell, ha provato ad allargare le ma-
4 Intendiamo qui, sulla scia del Dictionnaire (Greimas-Courtés 1986, voce
Figura), il figurale come base fondante del figurativo, a prescindere dalle singole
realizzazioni figurative sulla superficie del discorso. Una possibilità per sfuggire alla
proliferazione di metafore visive per la nuova scienza delle immagini (dalla chiave
inglese al guanto da boxe, cfr. Mitchell 2015: 223-229, tr. it.) e allo stesso tempo per
comprenderle meglio, come operatori di un contatto (e di una presa) più fine sui confini
delle cose.
7Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
glie dell’iconologia e della storia dell’arte e a prolungarne lo sguardo al di là
dell’opera d’arte canonica. Pensiamo, in particolare, oltre al già citato Belting,
a Alpers (1983) e al suo interesse non per l’arte olandese ma per la cultura
visuale olandese, e a Elkins (1999) e al suo interesse nell’allargare le maglie di
un “dominio delle immagini” che non può più contenere solo le art images ma
deve invece aprirsi alle non-art images.
Tuttavia, all’origine della decisione di Mitchell di aver messo insieme, a
dialogare tra di loro, questi saggi e non altri sta un’altra riflessione su un al-
tro confine, quello più importante: quello tra scienze dure ed esatte e scienze
“molli”, ovvero tra le immagini come fondamento della conoscenza scientifica
e le immagini come oggetto di indagine per le scienze umane.
Nella consapevolezza che né le prime né le seconde possono fare a meno
delle immagini, la scienza dolce che Mitchell immagina in dialogo tra i due
approcci proclama l’esigenza di guardare alle immagini – e a tutte le immagi-
ni, senza distinzioni – in modo scientifico, esatto, quantitativo, e qualitativo,
denso, insieme. Senza dimenticarsi di noi che le guardiamo, prestando anzi «la
stessa attenzione all’osservatore e all’osservato, al soggetto e all’oggetto», una
cura che, per esempio, accanto ai territori percorsi dalla cultura visuale, il para-
digma semiotico si premura da tempo di prodigare, attraverso lo sguardo sulle
immagini proposto, primi tra tutti, da Louis Marin (pensiamo, in particolare,
a Marin 1989 e Marin 1994) e rilanciato da Omar Calabrese e dalla sua scuola.5
L’ultimo confine da indagare, allora, corre proprio tra (e dentro) le im-
magini, tra quelle che – semplificando molto – ci ostiniamo ad ascrivere al
regime dell’autentico, come la fotografia analogica, e quelle che tacciamo di
manipolazione, come le immagini digitali; tra le arti che consideriamo pura-
mente visive, frutto di procedure più o meno standard di rappresentazione, e
quelle che invece riconosciamo come ibride, composite, frutto di una sintesi
che oltrepassa in vari modi la visualità standard.
Siamo proprio sicuri, provoca Mitchell, che certe immagini scientifiche ca-
paci di farci vedere l’invisibile non abbiano nulla a che vedere con la manipo-
lazione, nel momento in cui ci offrono un «guadagno di realtà»? Perché sem-
briamo preoccuparci più dell’aderenza delle immagini digitali al loro oggetto
e non delle nuove possibilità di controllo sulla produzione e sulla circolazione
delle immagini che il digitale offre? E ancora: perché non parlare anche di
migrazione – e di clandestinità – delle immagini, oltre che di circolazione?
Sono temi capitali, che è interessante ritrovare nello sguardo di un Mitchell
che ripercorre i suoi propri passi, sin dai tempi di Iconology, ben calcandone
l’impronta, e che percorrono appunto, sotto altre forme, molte altre riflessio-
ni: per intercettarne solo alcune, quella di Françoise Bastide, biologa e semio-
loga, vicina a Latour ma allieva di Greimas, e delle sue riflessioni sull’icono-
grafia delle immagini scientifiche, oltre che delle loro strategie comunicative;6
5 Sul pensiero di Omar Calabrese sulla semiotica dell’immagine ci riferiamo
in particolare a Calabrese (1985), ma cfr. anche Lancioni (2013) e Corrain-Lancioni
(2012), per gli sviluppi successive interni alla sua scuola.
6 Cfr. per esempio i saggi raccolti in Bastide (2001), in particolare Bastide
(1985).
8Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
quella di Peter Galison, e dei suoi studi sull’oggettività scientifica come fatto
di visione;7 quella di Lev Manovich, sul modo in cui i software contribuisco-
no a dare forma alla nostra esperienza nel mondo digitale,8 e quella di Victor
Stoichita, sull’alterità nella visualità e sulle molteplici «immagini dell’altro»
(Stoichita 2014).
Ora più che mai, più o meno implicitamente – ora che il livello delle imma-
gini che ci sommerge sale sempre più velocemente giorno dopo giorno – sia-
mo consapevoli che nessun occhio è innocente, come ammoniva saggiamente
Ernst Gombrich, e che quello che vediamo in realtà contribuiamo a costruirlo,
ma occorre anche prendere coscienza della complessità della visione e dei do-
mini delle immagini:
Se dobbiamo avere una scienza delle immagini, allora, il primo passo è quello di
liberarla dalla tirannia dell’occhio fisico e corporeo, inteso in senso letterale, e ricono-
scere che le immagini […] attraversano differenti domini: ci sono immagini mentali,
matematiche e verbali così come ce ne sono di pittoriche e visive. (Mitchell 2015: 40,
tr. it.)
Bisogna, ovvero, esplicitare il passo successivo, per la «scienza dolce delle
immagini» ma più in generale per le scienze che guardano alle immagini e
attraverso le immagini: non soltanto la visione è socialmente costruita e situa-
ta, non soltanto la costruzione del nostro vivere sociale è sempre più visuale,
ma è il nostro stesso modo di pensare e di misurare il mondo che passa sem-
pre più inevitabilmente attraverso le immagini, intrecciando in modo sempre
più complesso l’approccio puramente quantitativo delle scienze dure a quello
denso delle scienze umane, per esempio per guardare all’ambiente digitale.
“How to see one billion images”, per esempio, è il titolo dell’introduzione di
Lev Manovich al suo nuovo libro, Cultural Analytics (2020), in cui si propone
di illustrare le dinamiche del suo metodo di direct visualization, alla ricerca di
una restituzione immediata, quantitativa ma aperta all’analisi qualitativa, del
visibile. E sempre più forte, nel campo dei big data, è l’esigenza di provare a
mettere a punto procedure di visualizzazione che non siano soltanto ingegne-
ristiche ma che sappiano cogliere le sfumature di una complessità che è perce-
pita come densa (si sente sempre più spesso parlare, infatti, di thick data, di
dati di un’altra natura, “estratti” attraverso procedure etnografiche, quindi di
osservazione e di ascolto).9
È da questa prospettiva che l’ibrido di Mitchell di una scienza che sappia
essere anche dolce – e che a chi scrive ricorda il Paolo Fabbri che invitava a
mantenere un dialogo tra scienze umane e scienze disumane – può essere
utile per guardare a una visualità sempre più complessa come quella contem-
poranea.
7 Cfr. in particolare Daston-Galison (2007).
8 Cfr. in particolare Manovich (2013) e (2017).
9 Sui thick data cfr. per esempio, Wang (2016). Il riferimento di Wang, nel
coniare l’espressione thick data, è a Clifford Geertz (1973) e alla «thick description»
dell’antropologia e dell’etnografia.
9Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
Bibliografia
Alpers, Svetlana
1983 The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago,
University of Chicago Press (tr. it. Arte del descrivere. Scienza e pittura nel
Seicento olandese, Torino, Boringhieri, 1984).
Barthes, Roland
1970 L’empire des signes, Genève-Paris, Skira-Flammarion (tr. it. L’impero dei
segni, Torino, Einaudi, 1984).
Bastide, Françoise
1985 “Iconographie des textes scientifiques: principes d’analyse”, Culture
Technique, 14 (tr. it. “Iconografia dei testi scientifici. Principi d’analisi”, in
Una notte con Saturno. Scritti semiotici sul discorso scientifico, a cura di B.
Latour, P. Fabbri, Roma, Meltemi, 2001, pp. 167-213).
2001 Una notte con Saturno. Scritti semiotici sul discorso scientifico, a cura di B.
Latour, P. Fabbri, Roma, Meltemi.
Belting, Hans
2001 Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München, Fink (tr.
it. Antropologia delle immagini, Roma, Carocci, 2011).
2005 “Image, medium, body. A new approach to iconology”, Critical Inquiry,
31, pp. 302-319 (tr. it. “Immagine, medium, corpo: un nuovo approccio
all’iconologia”, in Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, a cura
di Andrea Pinotti e Antonio Somaini, Milano, Raffaello Cortina, 2009, pp.
73-98).
Bolter, Jay. David, Grusin, Richard
1999 Remediation. Understanding new media, Cambridge, MIT Press (tr. it.
Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano,
Guerini, 2003).
Calabrese, Omar
1985 La macchina della pittura, Bari, Laterza (nuova ed. Firenze, La casa Usher,
2012).
1999 “La memoria geroglifica. Riflessioni semiotiche sul frontespizio dei Principi di
Scienza Nuova di Giambattista Vico”, in Eloquio del senso, a cura di Pierluigi
Basso e Lucia Corrain, Milano, Costa & Nolan, 1999, pp. 324-336.
Corrain, Lucia; Lancioni, Tarcisio
2012 “Geometrie del senso. Ripensare la semiotica dell’immagine a partire da La
macchina della pittura di Omar Calabrese”, E/C. Rivista dell’Associazione
Italiana di Studi Semiotici.
Daston, Lorraine; Galison, Peter
2007 Objectivity, New York, Zone Books.
Elkins, James
1999 The Domain of Images, Ithaca, NY, Cornell University Press.
Fabbri, Paolo
2015 “Diagrammi in filosofia: G. Deleuze e la semiotica ‘pura’”, in Immagini che
fanno segno. Modi e pratiche di rappresentazione diagrammatica nelle
informational images, a cura di Valentina Manchia, Carte Semiotiche. Rivista
Internazionale di Semiotica e Teoria dell’Immagine, pp. 27-35.
10Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
Geertz, Clifford
1973 “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, in Id., The
Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York, Basic Books, pp. 3-30.
Greimas, Algirdas J., Courtés, Jacques
1979-1986 Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,
I-II, Paris, Hachette (tr. it. Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del
linguaggio, Usher, Firenze, 1986, ora anche tr. parz. in Semiotica. Dizionario
ragionato della teoria del linguaggio, Milano, Bruno Mondadori, 2007).
Lancioni, Tarcisio
2013 “Immagini in prospettiva. Forme e figure dell’enunciazione visiva”, in
Semiotica delle soggettività. Per Omar, a cura di Massimo Leone e Isabella
Pezzini, Aracne, Roma, pp. 281-288.
Manovich, Lev
2013 Software Takes Command, New York, Bloomsbury Academic.
2017 Instagram and Contemporary Image, http://manovich.net/index.php/
projects/instagram-and-contemporary-image
2020 Cultural Analytics, Cambridge, Mass.-London, MIT Press.
Marin, Louis
1994 De la représentation, Paris, Le Seuil/Gallimard (tr. it. Della rappresentazione,
a cura di L. Corrain, Milano, Mimesis, 2014).
1989 Opacité de la peinture, Essais sur la représentation au Quattrocento,
Paris, Usher (tr. it. Opacità della pittura. Saggi sulla rappresentazione nel
Quattrocento, Firenze, La casa Usher, 2012).
Mitchell, W.J.T.
1986 Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago, The University of Chicago Press.
1992 “The Pictorial Turn”, Artforum, 30, pp. 89-94 (tr. it. “Pictorial Turn”, in Id.,
Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, a cura di Michele Cometa e Valeria
Cammarata, Milano, Raffaello Cortina, 2017, pp. 79-106).
1994 Picture theory. Essays on verbal and visual representation, Chicago,
University of Chicago Press.
1996 “What do Pictures Really Want?”, October, 77, pp. 71-82 (tr. it. “Che cosa
vogliono davvero le immagini?”, in Id., Pictorial turn. Saggi di cultura
visuale, a cura di Michele Cometa e Valeria Cammarata, Milano, Raffaello
Cortina, 2017, pp. 107-124).
2005 What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago, University
of Chicago Press.
2011 Cloning terror. The war of images, 9/11 to the present, Chicago, The
University of Chicago Press (tr. it. Cloning terror. La guerra delle immagini
dall’11 settembre a oggi, Lucca, La casa Usher, 2012).
2013 «Media Aesthetics», foreword to Thinking Media Aesthetics
Media Studies, Film Studies and the Arts, edited By Liv Hausken, New York, Peter
Lang, pp. 15-18 (tr. it. “Estetica dei media”, in Scienza delle immagini.
Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media, Monza, Johan & Levi, 2019,
pp. 119-130).
2015 Image Science. Iconology, Visual Culture, and Media Aesthetics, Chicago, The
University of Chicago Press (tr. it. Scienza delle immagini. Iconologia, cultura
visuale ed estetica dei media, Monza, Johan & Levi, 2019).
2017 Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, a cura di Michele Cometa e Valeria
Cammarata, Milano, Raffaello Cortina.
Pinotti, Andrea; Somaini, Antonio
2016 Cultura visuale. Immagini, sguardi, media, dispositivi, Torino, Einaudi.
11Flux_Saggi
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media
Valentina Manchia | Tra visualità e visualizzazione
Polacci, Francesca
2010 “Dispositivi sincretici: per una semiotica verbo-visiva”, in Dario Tomasello,
Francesca Polacci, Bisogno furioso di liberare le parole. Tra verbale e visivo:
percorsi analitici delle Tavole parolibere futuriste, Firenze, Le Lettere, 2010,
pp. 83-185.
Sekula, Allan
1995 Fish story, Düsseldorf, Richter.
Schapiro, Meyer
1996 “Script in Pictures: Semiotics of Visual Language” in Words, Script and
Pictures. Semiotics of Visual Language, New York, Braziller (tr. it. “Scritte
in pitture: la semiotica del linguaggio visivo” in Id., Per una semiotica del
linguaggio visivo, Roma, Meltemi, 2002, pp. 192-236).
Stoichita, Victor I.
2014 L’image de l’Autre. Noirs, Juifs, Musulmans et «Gitans» dans l’art occidental
des Temps Modernes, Paris, Hazan, 2014 (tr. it. L’immagine dell’Altro. Neri,
giudei, musulmani e gitani nella pittura occidentale dell’Età moderna,
Firenze, La Casa Usher, 2019).
Wang, Tricia
2016 “Why Big Data Needs Thick Data”, Etnography Matters, , 20 gennaio 2016.
Valentina Manchia Dottore di ricerca in Semiotica e Comunicazione simbolica
presso l’Università di Siena, attualmente insegna al Politecnico di Milano, all’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, a ISIA Urbino e IAAD (Bologna e Torino),
dove si occupa di semiotica, comunicazione e progettazione visiva, design e cultura
visuale. Ha curato, per La Casa Usher, il numero di Carte Semiotiche dal titolo Im-
magini che fanno segno. Modi e pratiche di rappresentazione diagrammatica nelle
informational images (2015). Suoi saggi e articoli sono apparsi, oltre che in pubblica-
zioni collegate a convegni nazionali e internazionali, su Lexia, E/C, Progetto grafico,
Alfabeta2, Doppiozero. È membro del CROSS – Centro di Ricerca “Omar Calabrese”
di Semiotica e Scienze dell’immagine.
12Puoi anche leggere