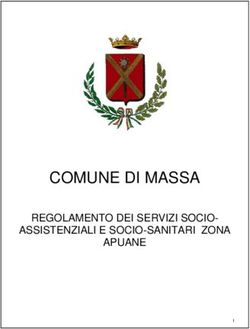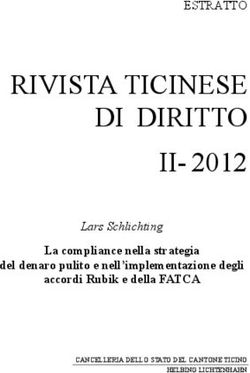RIFLESSIONI (NON DIAGNOSTICHE) SULLA DIAGNOSI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Per adottare e assumere un linguaggio condiviso con una comunità scientifica,
garantire il passaggio e lo scambio di informazioni, infatti “eliminare la diagnosi
significherebbe dare ai nostri articoli nomi come ‘Storia evolutiva di pazienti che
manifestano scissione, difficoltà nel mantenere relazioni, comportamenti auto
mutilanti,rappresentazioni incostanti, difficoltà a modulare gli affetti e vari altri
sintomi’ ” (Westen, 1998b,p.120)
Per elaborare un preciso piano di intervento e trattamento per il paziente che può
prendere spunti e ricollegarsi a informazioni rilevate dalla letteratura clinica e dalla
ricerca scientifica (Horwitz, Gabbard, Allen, 1996; Roth, Fonagy, 2004; Fonagy,
2005; Leuzinger-Bohleber, Target,2002; Gabbard, 2008).
Per orientare la ricerca scientifica: non è possibile, infatti, sistematizzare certe
informazioni se non si utilizzano dei parametri condivisi e la ricerca, sia clinica che
empirica, è necessaria per il progresso delle conoscenze psicologiche. La diagnosi,
secondo questa prospettiva, sarebbe un punto di congiunzione tra un sapere
idiografico, fondato sull’approfondimento delle peculiarità individuali di un
soggetto, e un sapere nomotetico che rimanda a leggi e regole generali e condivise. La diagnosi descrive un processo nel tempo ed è, paradossalmente, l’ultimo atto di una relazione Mentre nell’ambito della ricerca la direzione della diagnosi deve necessariamente essere quella all’idiografico al nomotetico, in ambito clinico deve procedere dal nomotetico all’idiografico (Kagan), producendo un lingaggio che descriva esperienze empiriche singolari e situate. E,poiché la psichiatria non è una branca della filosofia teoretica (né una ricerca accademica), deve tendere ad abolirsi in quanto scienza.
1) L’esplicitazione degli strumenti e delle procedure volte alla raccolta delle informazioni.
2) Considerare la letteratura clinica e applicativa e la solidità empirica degli strumenti selezionati.
3) Tenere presente che le diagnosi possono modificarsi col trascorrere del tempo, dunque scegliere delle
procedure che siano stabili ma allo stesso tempo flessibili.
4) Considerare che la diagnosi avviene all’interno di una relazione tra due persone e considerare che una
buona alleanza terapeutica fonda le sue radici in una adeguata alleanza diagnostica (Lingiardi, 2002).
5) Una diagnosi attendibile deve essere complessa, dunque tenere conto di diverse dimensioni e aspetti
del funzionamento dell’individuo: motivazioni, stili cognitivi, tratti di personalità, disturbi clinici,
rappresentazioni di sé e degli altri; proprio per questo spesso è necessario che si avvalga di diversi
strumenti, dunque sia multistrumentale e multidimensionale. E’ necessario sottolineare anche che
tutti gli strumenti e le procedure adottate si inseriscono all’interno di una cornice che è il colloquio
clinico, strumento di elezione per tracciare una buona diagnosi (Mc Williams, 1999).
6) La diagnosi, inoltre, per essere valida, non può prescindere dal senso che la persona attribuisce a sé
stesso, alle sue esperienze ed alle sue caratteristiche (Barron, 1998).
7) E’ importante aggiungere che l’oscillare tra le due polarità della conoscenza, idiografica e nomotetica,
con cui si intende il dibattersi tra una conoscenza di tipo specifico e peculiare (idio) dell’individuo ed
un’altra più generalizzabile che fa riferimento a leggi (nomos) condivise, trovi lo psicologo clinico a
doversi destreggiare in quell’ acceso dibattito che da tempo è presente in ambito clinico e di ricerca
scientifica. Descrittive (DSM, IC10)
Danno un nome (etichetta) ad una serie di segni e sintomi che vanno rilevati per lo
più attraverso l’osservazione diretta dei comportamenti di un paziente e attraverso
quanto riferito dal paziente stesso. Presunta ateoreticità e ruolo dell’osservazione
(“evidence” based)
Strutturali (PDM, SWAP200, STructural Interview Personality
Organization e la Inventory Personality Organization di O.Kernberg,
OPD)
Focalizzate su rappresentazioni e processi impliciti del paziente per formularne una
valutazione e dunque si stabilisca di avvalersi di un certo grado di inferenzialità da
parte del clinico. Maggiore arbitrarietà, ma anche maggiore potenza esplicativa.
Di funzioni (TAT, SWAP) o di contenuti (ORT)
Es: la SWAP che individua quattro domini funzionali principali: 1) le motivazioni, i
bisogni, i valori morali e ideali; 2) le risorse e le caratteristiche affettive e cognitive; 3)
l’esperienza di sé, degli altri e delle relazioni tra sé e gli altri e 4) le principali esperienze
evolutive . Funzioni e contenuti sono spesso considerati parallelamente poiché altamente
interrelati tra loro: (come nel PDM che permette una descrizione psichica di un soggetto
considerando sia il tipo di organizzazione della personalità sia il suo funzionamento
mentale) Diagnosi prototipiche nomotetiche, politetiche
Logica prototipica, (SWAP o del PDM),che osserva il grado di sovrapposizione tra
la descrizione di un soggetto in esame e delle descrizioni di prototipi, considerando
“ideale” e “irreale” la manifestazione completa e universale di un disturbo.
Logica monotetica, che considera un disturbo come una serie di criteri definiti che
devono essere tutti presenti in un paziente perché se ne possa fare diagnosi.
Logica politetica secondo cui una diagnosi di un certo disturbo può essere emessa
qualora il soggetto presenti almeno un certo numero di caratteristiche definite per il
disturbo in esame. La logica politetica, a differenza di quella monotetica, definisce
un disturbo come un insieme di caratteristiche specifiche ma suscettibile di più di
una presentazione clinica.
Concezione essenzialista secondo cui gli individui possono essere descritti
considerando una serie di elementi piuttosto stabili e slegati dal contesto, un
esempio è il modello dei i cinque grandi fattori (FFM): coscienziosità, energia,
apertura mentale, gradevolezza e stabilità emotiva.
Di contro esiste anche una Concezione condizionale per definire i tratti
della personalità, come ad esempio nel caso della SWAP per tratti si intende delle
tendenze a reagire in modo specifico a determinati stimoli esterni o interni vissuti
dal soggetto.DSM PDM
Lo stato di malattia Lo stato di malattia
è separato e diverso dallo è lungo un continuum in cui
stato di salute all’estremo opposto vi è la normalità
Qualitativamente Quantitativamente Il termine categoria rimanda ad una logica della malattia mentale come
presente o assente, dunque all’esistenza di una chiara distinzione tra aspetti che
sono da considerarsi sani e altri patologici. Su questa logica, infatti, si basa la
diagnosi per mezzo del DSM.
Il concetto di dimensionalità, invece, rimanda ad un approccio nei confronti
della psicopatologia quantitativo: dunque una certa caratteristica non viene
considerata solo presupponendone presenza o assenza ma osservandone in che
quantità può essere rilevata. Questa logica sottende diversi strumenti per
l’analisi delle caratteristiche di personalità, come quelli che seguono il modello
dei Five Factor Model (FFM, Costa e McCrae, 1992 a), per cui un certo tratto va
osservato considerando un continuum tra normalità e patologia ed identificato
sulla base dell’intensità con cui si presenta. nale è quello della SWAP per la
valutazione dei disturbi della personalità.Numerosi dati, biologici e genetici, psicodinamici e di ricerca scientifica (Oldham et al., 2005) sostengono sempre più l’ipotesi dell’esistenza di correlati biologici, anamnestici e prognostici di determinati tratti e dimensioni della personalità, mentre non ci sono risultati a sostegno della logica categoriale applicata ai disturbi della personalità (Livesley, 2006 b; Paris, 2006). Applicare delle categorie per valutare i disturbi della personalità è, al contrario, rischioso per gli alti tassi di comorbilità, la scarsa attendibilità e stabilità e le elevate varianti interne ad uno stesso disturbo (Herzig, Licht, 2006). Un modello misto, che si avvale di una logica sia categoriale che dimensionale è quello della SWAP.
Il
•È un
comportame Sintomo
Sintomo nto osservato
e riferito
è valutato
nella
relazione
•Classifica non Le Categorie
comprende diagnostiche
Categoria •Fenomenologico ricoprono lo
diagnostica •ha eliminato la spettro
soggettività del clinico
dimensionale
• Incremento degli item
• Non coglie la ricchezza e la Il Disturbo si colloca
complessità delle sindromi
Disturbo osservabili empiricamente
nel continuum della
dimensione
• Insieme di sintomi
• Scarsa validità diagnostica
La Dimensione individua un
Etichet • Comorbidità ambito in cui l’individuo si
ta • Esprime ciò che si HA non ciò esprime nel suo modo di
che si È essere UNICO Dilthey: Scienze della natura e Scienze umane
Spiegare vs. Comprendere
Costrutto di malattia vs. Forma di vita
PRESUNZIONE DI A-TEORETICITA’
Pericolosa mistificazione: la neutralità non è neutra(Setting
Freudiano/sperimentale), ma dis-umana.
Implicito rifermento non alla mente, ma al cervello, e quindi al costrutto di
malattia(cfr. rapporto tra dati neurologici – spiegati - e psicologici –significanti)
Il che conduce all’appaiamento DSM-Farmaco
…E alla deculturazione della diagnosi, che diviene un atto tipico di una cultura
globalizzata
Lupo essenzialista travestito da agnello nominalista• Impulso primario (Winnicott), o attività endogena primara (Sander) produce
• Una iniziativa finalizzata iscritta nel sistema disposizionale neurobiologico
che, da parte sua
• organizza l’interscambio tra l’organismo e il suo ambiente attraverso il
quale (interscambio) l’organismo e/o il contesto sono modificati” (Sander) e
• Si esprime attraverso un comportamento, che esprimerà
• agentività
12 ILLEGITTIMITA’ DI DIAGNOSI SU “IL BAMBINO”
ANCORA SUL COSTRUTTO DI “MALATTIA”
Equiparazione della psico-pato-logia alla (psico)patologia
Implicita presa di posizione sul ruolo del “disturbo” nella specie umana vs. le speci animali
(cfr.: necessità di polimorfismo derivato dalla despecializzazione e dalla coscienza)
Proliferazione della diagnosi di depressione e problema della depressione sotto-soglia
Tendenza implicita a produrre normoticità
NUMERO IMMENSO ED IPERIMMENSO: sistemi non-lineari
complessi
FEEDBACK BI-MODALE
I comportamenti sono prodotti dal cervello quanto il cervello lo è dai comportamenti:
genetica ed epigenetica
Diagnosi come processo relazionale e storicizzato. Soggettività psicologica ed
epistemologica del diagnosta.
SPECIFICITA’, SENSIBILITA’ E FALSI POSITIVI
A soglie (criteri sintomatici) più alte aumenta la specificità, ma diminuisce la sensibilità.
Ad esempio i requisiti per un Disturbo Depressivo Maggiore attualmente identificati con 4 sintomi e 2
settimane di durata avrebbero potuto essere molto più rigidi (ad esempio 6 sintomi e 4 settimane).
Basse soglie = rischio di falsi positivi Grado in cui operatori diversi concordano sulle
diagnosi:
Consente a clinici indipendenti di giungere alla medesima
diagnosi su un paziente
Capacità di riferirsi univocamente ad una determinata
malattia
attenzione alla sola
attendibilità senza
Comorbidità
curare la validità15
I principali presupposti assunti dagli Autori per costruire questo strumento
clinico e di ricerca sono:
I tratti di personalità sono intesi come tendenze a reagire, condizionati dai contesti
intrapsichico e interpsichico, piuttosto stabili
Gli stili, i tratti e i disturbi di personalità vengono considerati seguendo una logica
dimensionale: la valutazione è effettuata non definendone presenza/assenza ma
considerandone con quanta intensità si presentano o si avvicinano a dei prototipi
diagnostici.
Sono ritenuti fondamentali quattro domini funzionali su cui deve basarsi una diagnosi
adeguata: 1) motivazioni, standard ideali, valori morali, paure e conf litti; 2) stili cognitivi,
strategie e capacità di regolazione delle emozioni, meccanismi di difesa, risorse
psichiche; 3) rappresentazioni di sé, degli altri e delle relazioni sé e altri; 4) modalità di
sviluppo dei domini precedenti.
La diagnosi deve poter essere funzionale, dunque ad una chiara e condivisa etichetta
dovrebbe poter essere accompagnata una formulazione del caso che possa
sufficientemente informare e tracciare le principali linee diagnostiche di un soggetto,
espressa con un linguaggio semplice e comprensibile da professionisti di formazione e
orientamento differenti. Questo permetterebbe di trovare un accordo tra la tendenze a
categorizzare propria di un approccio, ancora troppo ancorata ad una visione prettamente
idiosincratica. Un altro importante presupposto degli Autori è colmare lo iato esistente tra
clinica e ricerca. Sottolineano l’importanza di allontanarsi dalle auto valutazioni
da parte dei pazienti affinchè possano essere riconosciuti processi inconsci ed
impliciti controllando scientificamente l’inferenzialità e la soggettività spesso
associata alle valutazioni emesse dai clinici: “lasciamo fare ai clinici ciò che
sanno fare meglio, cioè ascoltare, osservare e trarre inferenze; e lasciamo che la
statistica faccia ciò che sa fare meglio, cioè aggregare i dati in modo affidabile”.
Un’ ulteriore caratteristica che distingue il metodo SWAP è la procedura
diagnostica matching prototype (Westen, Shedler, 2000 a) che fonda la
valutazione non più sul conteggio di un certo numero di criteri ma da quanto il
quadro clinico tracciato di un paziente sia vicino a quello di un prototipo di un
determinato disturbo. La SWAP conta 200 affermazioni chiare e dal linguaggio semplice, frutto di sette anni di selezione,
con un livello medio di astrazione e liberi da gergalità e diretti a comportamenti esplicitamente
osservabili. Il clinico distribuisce le affermazioni sulla base di quanto vicine siano alla modalità del
soggetto in esame, secondo la procedura Q-sort che adotta una logica ipsativa (si valuta quanto l’item
descriva il soggetto non in confronto ad altri soggetti ma in confronto alle altre affermazioni applicate
al soggetto stesso).
Il pool di item deriva dai criteri dell’Asse II del DSM, da alcuni criteri dell’Asse I, dalla letteratura
clinica ed empirica degli ultimi cinquant’anni sulla personalità.
La valutazione SWAP può essere effettuata dopo 3-5 colloqui con un paziente o dopo aver condotto
l’Intervista Clinico Diagnostica (CDI; Westen, Mudderrisoglu, 2003). Questo è il compito del clinico,
in quanto successivamente un calcolatore statistico, in modo automatico, dalla distribuzione
effettuata elabora la diagnosi del soggetto.ESEMPIO DI AFFERMAZIONI DESCRITTIVE:
TENDE AD EVITARE LE SITUAZIONI SOCIALI PERCHE’ HA PAURA DI TROVARSI IN
IMBRARAZZO O UMILIATO
TENDE A SENTIRSI UN EMARGINATO, UN OUTSIDER, SI SENTE PRIVO DI QUALUNQUE
APPARTENENZA
NON HA RELAZIONI NE’ AMICI STRETTI
L’ELOQUIO TENDE AD ESSERE VAGO, SCONNESSO, PIENO DI DIGRESSIONI E DETTAGLI
SUPERFLUI, ECC.
LA SUA PERCEZIONE DELLA REALTA’ Può DETERIORARSI GRAVEMENTE SOTTO STRESS (PER
ESEMPIO PUO’ DIVENTARE DELIRANTE Le descrizioni così sono state aggregate per formare i prototipi diagnostici PD. Dunque un soggetto
valutato in fattori PD verrà osservato rispetto al grado di somiglianza che presenta con questi
prototipi.
Per quanto riguarda la diagnosi degli adulti il calcolatore effettuerà delle correlazioni tra il profilo del
soggetto in esame e dei prototipi. I prototipi sono di due tipi: 10 sono quelli derivati dalle diagnosi di
Asse II del DSM più un prototipo di paziente senza disturbo di personalità. Questi prototipi sono il
frutto delle descrizioni emesse da 237 clinici che avevano più di 18 anni di pratica clinica e con
formazioni e orientamento diversi a cui è stato chiesto di descrivere per mezzo delle affermazioni
SWAP dei pazienti ideali con un certo disturbo di personalità diagnosticabile in DSM e un paziente
sano dal funzionamento elevato.
oltre all’individuazione di una categoria diagnostica, la procedura SWAP permette di effettuare una
formulazione del caso mettendo insieme, in un elaborato coerente ,le prime 30 descrizioni che
risultano maggiormente descrittive del soggetto in esame ed integrandole con degli aspetti
anamnestici ed evolutivi
dalle prime analisi (Westen, Shedler, 2007) condotte su un campione statunitense valutato con la II
edizione della SWAP è emersa una nosografia empiricamente derivata differente da quella conosciuta
anche in Italia: emergono 10 disturbi raggruppabili in 4 cluster: interiorizzante, esteriorizzante,
borderline, stile di alto funzionamento. La SWAP-II pare metta in evidenza non solo le caratteristiche
comuni a diversi pazienti con gli stessi tratti ma anche le differenze che caratterizzano uno stile in
confronto a tutti gli altri.8 AMBITI FUNZIONALI SU CUI RACCOGLIERE INFORMAZIONI: 1. Temperamento 2. Affetti prevalenti 3. Pattern relazionali 4. Identificazioni 5. Autostima 6. Credenze patogene 7. Stili e meccanismi di difesa 8. Problematiche evolutive principali.
Il PDM è il risultato del rapporto tra psicoanalisi e psichiatria, e rappresenta il primo tentativo di una
nosografia psicoanalitica sistematica tramite l'organizzazione delle scoperte empiriche ottenute
tramite strumenti psicodiagnostici.
Si articola in tre sezioni che descrivono rispettivamente le categorie diagnostiche utilizzabili nella
valutazione degli adulti, adolescenti e bambini. La terza poi raccoglie alcuni contributi teorici.
La Diagnosi per gli Adulti si articola su tre assi:
1. Asse P: valuta i pattern e i disturbi della personalità che sono collocati lungo un continuum di
organizzazioni di personalità che segue il modello di Kernberg da una
personalità sana a una più disturbata. L’asse delinea quindi dei tipi di personalità che si
sovrappongono solo in parte al DSM;
Asse M: è dedicato alla valutazione del funzionamento mentale e si basa sull’assessment di 9
funzioni. Sulla base della valutazione di queste aree, il funzionamento di ogni individuo va collocato
lungo un continuum di 8 livelli, da un livello di capacità mentali ottimali a uno caratterizzato da gravi
lacune del funzionamento mentale;
Asse S: è dedicato alla valutazione dell’esperienza soggettiva dei sintomi connessi alle diverse
sindromi dell'Asse P. Personalità è ciò che si è, non ciò che si ha.
Molti pazienti infatti si rendono conto che ciò che vogliono cambiare è
strettamente legato a ciò che essi sono. È quindi importante che il terapeuta
comprenda gli aspetti della personalità dell’individuo in modo globale, in
quanto questi possono essere i loro problemi psicologici ma anche i loro punti
di forza.
In quest'ottica la Personalità è definita come un’insieme di pattern
relativamente stabili di pensare, sentire, comportarsi e mettersi in relazione
con gli altri.
Il modo in cui cerchiamo di adattarci alle esigenze della vita e di tenere a bada
l’ansia, il dolore e le minacce all’autostima è un aspetto importante della
personalità che può rivelarsi adattivo o disadattivo.I Criteri Essenziali per Fare una Diagnosi di Disturbo di Personalità
il paziente o le persone che lo conoscono riferiscono che il suo funzionamento
psicologico ha sempre causato sofferenza a se stesso e agli altri in modo stabile
nel tempo;
importante differenziare il disturbo di personalità dalle sindromi sintomatiche,
dagli effetti diretti di danni cerebrali e dalle psicosi;
importante valutare se quello che sembra un disturbo della personalità non sia
invece una risposta ad uno stress cronico.Livello di Organizzazione della Personalità
Secondo gli studi di Clarkin e Kernberg (2004), per acquisire una certa maturità
psicologica gli individui devono sviluppare alcune capacità vitali che nei pazienti con
disturbi della personalità vengono compromesse. Si può quindi collocare la
personalità dell’individuo lungo il continuum della gravità analizzando le seguenti
capacità:
1. Identità: vedere se stessi e gli altri in modi precisi e articolati;
2. Relazioni Oggettuali: mantenere relazioni intime stabili e soddisfacenti;
3. Tolleranza degli Affetti: esperienza e percezione negli altri della gamma di affetti;
4. Regolazione degli Affetti: regolare impulsi e affetti per favorire l’adattamento;
5. Integrazione del Super-Io, dell’Io Ideale e dell’Io: sensibilità morale coerente e
matura.
6. Esame di Realtà: comprendere le nozioni convenzionali di ciò che è realistico;
7. Forza dell’Io e Resilienza: rispondere in modo positivo agli stress e riprendersi da
eventi dolorosi senza difficoltà eccessive.
Nelle personalità sane sono tutte presenti, in quelle nevrotiche 2-3 possono essere
problematiche, in quelle borderline sono molto problematici i primi 4 punti e l’esame
di realtà.La Distinzione del Livelli nel PDM è quindi tra:
1. Personalità Sane: quindi con assenza di disturbi della personalità, in cui le
capacità precedenti sono tutte presenti. Alcune persone che sotto stress diventano
sintomatiche possono comunque essere considerate sane, in quanto posseggono una
f lessibilità che gli permette di affrontare le sfide della realtà;
2. Disturbo di Personalità Nevrotico: nonostante siano in possesso di molte delle
capacità prima citate, queste persone tendono a rispondere agli stress con una gamma
limitata di difese e meccanismi di coping. I pattern difensivi disadattivi si limitano
quindi ad una particolare area.
I pazienti nevrotici generalmente comprendono le loro aree di difficoltà e stabiliscono
un’adeguata alleanza terapeutica;
3. Disturbi di Personalità Borderline: le persone con disturbo borderline tendono
ad avere difficoltà relazionali ricorrenti, incapacità di intimità emotiva, periodi di
angoscia e di grave depressione, vulnerabilità all’abuso di sostanze e sono ad elevato
rischio autolesivo.
Questi soggetti fanno un uso eccessivo di meccanismi difensivi primitivi che
implicano un alto livello di distorsione della realtà, come la scissione e
l’identificazione proiettiva. 1. Disturbi Schizoidi di Personalità:
Pattern costituzionali maturativi: molto sensibile, timido, reattivo agli stimoli;
Tensione/preoccupazione principale: paura dell’intimità/desiderio di intimità;
Affetti principali: dolore emotivo generale quando iperstimolato, affetti così
potenti che sente di doverli reprimere;
Credenza patogena relativa a se stessi: la dipendenza e l’amore sono pericolosi;
Credenza patogena relativa agli altri: il mondo sociale esercita pressioni e mette
pericolosamente a rischio di sentirsi invasi;
Modi principali di difendersi: ritiro, sia fisico che nella fantasia, e
preoccupazioni idiosincratiche. 2. Disturbi Paranoidi di Personalità:
Pattern costituzionali maturativi: può essere irritabile/aggressivo;
Tensione/preoccupazione principale: attaccare/essere attaccato dagli altri con
l’intenzione di umiliare;
Affetti principali: paura, rabbia, vergogna, disprezzo;
Credenza patogena relativa a se stessi: l’odio, l’aggressività e la dipendenza sono
pericolosi;
Credenza patogena relativa agli altri: il mondo è pieno di persone che possono
sfruttare e attaccare;
Modi principali di difendersi: proiezione, identificazione proiettiva, diniego e
formazione reattiva.3. Disturbi Psicopatici (Antisociali) di Personalità
Il PDM distingue due categorie del disturbo:
- Passivo/Parassitario: più dipendente e manipolatorio;
- Aggressivo: esplosivo, attivamente predatorio e violento.
- Pattern Costituzionali Maturativi: possibile aggressività e alta soglia di
stimolazione emotiva; - Tensione preoccupazione principale:
manipolare/essere manipolato;
- Affetti principali: rabbia e invidia;
- Credenza patogena relativa a se stessi: posso fare tutto ciò che voglio;
- Credenza patogena relativa agli altri: tutti sono egoisti, manipolatori e
spregevoli; - Modi principali di difendersi: cercare di raggiungere un controllo
onnipotente. 4. Disturbi Narcisistici di Personalità: i disturbi narcisistici si collocano al confine dello spettro nevrotico
fino alle condizioni più gravi.
Sono soggetti che tendono a somatizzare e concentrano le loro energie nel confronto con le altre persone,
tendendo a idealizzare o svalutare le altre persone:
- quando le idealizzano si sentono speciali per avere una relazione con loro; - quando le svalutano si sentono
superiori.
I Sottotipi sono:
- Arrogante: crede di avere tutti i diritti, svaluta le altre persone e colpisce sopratutto per quanto è
vanitoso/manipolatorio o carismatico/dominante;
Depresso/Svuotato: si comporta in modo da ingraziarsi gli altri, cerca persone da idealizzare, è facilmente
ferito e prova un’invidia cronica per le persone che vede in una posizione di superiorità.
Pattern costituzionali maturativi: non sono disponibili dati univoci;
Tensione/preoccupazione principale: Inflazione/Deflazione dell’autostima;
Affetti principali: vergogna, disprezzo e invidia;
Credenza patogena relativa a se stessi: ho bisogno di essere perfetto per sentirmi bene;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri apprezzano la ricchezza, la bellezza, il
potere e la fama, per cui più ne ho e meglio mi sento;
- Modi principali di difendersi: idealizzazione e svalutazione. 5. Disturbi Sadici e Sadomasochistici di Personalità:
E' individuato un solo Sottotipo:
Disturbi Sadomasochistici: alcuni individui oscillano tra comportamenti sadici e sadomasochistici,
e questi pazienti sono emotivamente più vivi ma le loro relazioni sono comunque intense e
turbolente.
Sono individui che si lasciano dominare fino all’estremo ma possono anche attaccare la persona alla
quale si erano sottomessi.
Tendono a vedersi come vittime dell’aggressività altrui alla quale possono rispondere solamente
sottomettendosi o contrattaccando violentemente.
Pattern costituzionali maturativi: sconosciuti;
Tensione/preoccupazione principale: patire umiliazioni/infliggere umiliazioni;
Affetti principali: odio, disprezzo e piacere (godimento sadico);
Credenza patogena relativa a se stessi: ho il diritto di infliggere dolore e umiliazioni alle altre persone;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri esistono in quanto oggetti del mio dominio;
Modi principali di difendersi: distacco, controllo onnipotente, ribaltamento e agiti.6. Disturbi Masochistici (Autofrustranti) di Personalità:
I Sottotipi individuati sono:
Masochista Morale: si colloca a livello nevrotico di personalità e ritiene che l’autostima dipende dalla sofferenza, in
quanto il senso di colpa inconscio porta a non riconoscere e a non dare valore alle esperienze di soddisfazione e
successo. Questi pazienti iniziano una terapia cercando compassione per le proprie sfortune, attraverso il dolore e la
loro apparentemente altruistica sottomissione masochistica agli altri, e trasmettono sottilmente un senso di superiorità
morale;
Masochista Relazionale: si colloca a livello borderline di personalità e crede inconsciamente che la relazione dipenda
dalla propria sofferenza o vittimizzazione. Vivere senza questa relazione, per quanto abusante, è inimmaginabile.
Secondo questi individui è necessario stare male perché gli altri si mostrino disponibili. In terapia questi pazienti
possono provocare nel terapeuta una forte compassione che può evocare in loro atteggiamenti masochistici (come
diminuire il proprio onorario, vederli a orari impensabili fuori dalle ore di studio) ma poco dopo si scoprono irritati e
perfino sadici. L’affettuosa accettazione di un terapeuta che ascolta le difficoltà del paziente può spingerli a dar credito
alla loro ipotesi iniziale, cioè che il terapeuta si sta interessando a loro solo perché stanno male e questo li porta a star e
sempre più male. Sono i pazienti che tipicamente si mettono nei guai durante il periodo d’interruzione della terapia in
quanto è il loro modo di vendicarsi inconsciamente del terapeuta assente.
Pattern costituzionali maturativi: sconosciuti;
Tensione/preoccupazione principale: soffrire, perdere le relazioni e l’autostima;
Affetti principali: tristezza, rabbia e senso di colpa;
Credenza patogena relativa a se stessi: la mia evidente sofferenza dimostra la mia superiorità morale e/o serve a
mantenere le mie relazioni di attaccamento;
Credenza patogena relativa agli altri: le persone si occupano degli altri solamente quando questi sono in difficoltà;
Modi principali di difendersi: introiezione, identificazione introiettiva, rivolgimento contro il sé e atteggiamento
moralizzatore. 7. Disturbi Depressivi di Personalità: nonostante nel DSM tale disturbo sia stato eliminato in
quanto incluso all'interno dei Disturbi dell'Umore, i soggetti con tale personalità si collocano al polo
nevrotico.
Le ricerche hanno stabilito l’esistenza di due versioni di depressione sintomatica:
Introiettiva: la persona è preoccupata dalla definizione di sé, da pensieri autocritici. È caratterizzata
dal senso di colpa, tendenza all’autocritica e al perfezionismo. Cercano dentro di sé la spiegazione
delle loro esperienze dolorose e, quando sono maltrattati o abbandonati, tendono a credere che in
qualche modo sono loro ad essere in torto. Con tali pazienti è fondamentale far esplicitare loro i
sentimenti negativi, specialmente l’ostilità e le critiche, poiché spesso idealizzano il terapeuta e
vogliono essere dei bravi pazienti. Con tali pazienti il trattamento breve è pressoché inefficace.
Anaclitica: la persona è preoccupata dalla dimensione relazionale, dal tema della fiducia e dal
mantenimento delle relazioni di attaccamento. È caratterizzata da vergogna, alta reattività alla perdita
e al rifiuto e senso di vuoto. Si caratterizzano per il livello di disagio e la disorganizzazione cui vanno
incontro quando fanno esperienza di perdite e separazioni. Spesso lamentano una disperazione
esistenziale, il sentimento che la loro vita sia vuota e priva di significato. Alcuni di loro rispondono
bene al trattamento breve
Comunque il trattamento di elezione per entrambi è una terapia intensiva a lungo termine, in quanto
l’interpretazione e l’insight sono fondamentali per avere un miglioramento degli introiettivi, mentre
gli analitici devo fare esperienza dell’affidabilità della relazione terapeutica.
Pattern costituzionali maturativi: possibile predisposizione genetica alla depressione;
Tensione/preoccupazione principale: bontà/cattiveria o solitudine/relazionalità;
Affetti principali: tristezza, senso di colpa e vergogna; Credenza patogena relativa a se stessi: c’è
qualcosa di intrinsecamente cattivo o inadeguato in me; Credenza patogena relativa agli altri: le
persone che mi conosceranno davvero mi rifiuteranno; 7. Disturbi Depressivi di Personalità (continua)
Modi principali di difendersi: introiezione, capovolgimento, idealizzazione degli altri e svalutazione
di sé.
Manifestazione Opposta: Disturbi Ipomaniacali della Personalità: si collocano all’estremo
borderline. Sono individui caratterizzati da potenti dinamiche depressive oscurate dal diniego che
produce uno stato relativamente stabile di umore elevato, queste persone possono avere un’energia
notevole, ma le loro relazioni con gli altri sono superficiali a causa di un’inconscia paura del legame.
L’uso del termine non deve farci confondere il disturbo ipomaniacale di personalità (curabile con una
psicoterapia) e con l’ipomania intesa come disturbo dell’umore (una condizione a implicazione
biologica che viene trattata in modo più adeguato con i farmaci).
I terapeuti tendono inizialmente a trovare stimolanti queste persone, ma dopo poco si sentono
confusi, in quanto questi individui sono resistenti alla terapia ed è difficile tenerli in trattamento data
la loro paura di un legame, per questo si concorda con il paziente che vuole abbandonare la terapia
che esso continuerà a venire per alcune sedute già stabilite. Molti terapeuti si concentrano sul far
riconoscere al paziente che la loro intera esistenza è caratterizzata da fughe continue.
Pattern costituzionali maturativi: un probabile alto livello di energia; Tensione/preoccupazione
principale: ignorare il dolore/soccombere al dolore; Affetti principali: tristezza, rabbia, euforia e
dolore inconsci; redenza patogena relativa a se stessi: se smetto di fuggire e mi lego a qualcuno sarò
traumaticamente abbandonato, per questo me ne vado per primo; Credenza patogena relativa agli
altri: posso affascinare gli altri così che non vedano le qualità che inevitabilmente li porterebbero a
rifiutarmi;
Modi principali di difendersi: diniego, idealizzazione di sé e svalutazione degli altri. 8. Disturbi Somatizzanti di Personalità:
- Pattern costituzionali maturativi: possibile fragilità fisica, malattie nella
prima infanzia e alcuni report di abusi subiti nell’infanzia;
- Tensione/preoccupazione principale: integrità/frammentazione del sé
corporeo;
- Affetti principali: disagio generale, rabbia inferita e alessitimia che impedisce
il riconoscimento delle emozioni;
- Credenza patogena relativa a se stessi: sono fragile, vulnerabile e rischio di
morire; - Credenza patogena relativa agli altri: gli altri sono forti, sani e
indifferenti;
- Modi principali di difendersi: somatizzazione e regressione. 8. Disturbi Dipendenti di Personalità:
- Pattern costituzionali maturativi: possibile attitudine alla calma e sociofilia;
Tensione/preoccupazione principale: mantenere/perdere le relazioni;
Affetti principali: piacere nella sicurezza dell’attaccamento, tristezza e paura della solitudine;
Credenza patogena relativa a se stessi: sono inadeguato e bisognoso;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri sono forti ed io ho bisogno delle loro cure;
Modi principali di difendersi: regressione, capovolgimento ed evitamento.
I Sottotipi sono:
- Passivo-Aggressivo: dato che l'aggressività passiva è un tratto e non un'organizzazione della personalità, la
dipendenza ostile può essere un sottotipo del disturbo dipendente. Questi individui risentono di essere legati ad
un’altra persona e a non riuscire a staccarsene, si definiscono in riferimento alle altre persone ma con una valenza
negativa. Attaccano per prevenire l’attacco (come i paranoici), si aspettano di essere maltrattati (come masochisti) e
hanno preoccupazioni narcisistiche nucleari. Uno dei compiti principali della terapia è accrescere il loro senso di
identità. Sono una grande sfida sul piano terapeutico, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a dare un nome ai loro
sentimenti negativi, per non alimentare la loro oppositività il terapeuta non deve mostrarsi troppo interessato ai loro
progressi.
Pattern costituzionali maturativi: possibile irritabilità;
Tensione/preoccupazione principale: tollerare i maltrattamenti/vendicarsi;
Affetti principali: rabbia, risentimento e piacere negli agiti ostili.
Credenza patogena relativa a se stessi: l’unico modo per avere dignità è sabotare le realizzazioni altrui;
Credenza patogena relativa agli altri: tutti vogliono che io mi conformi alle loro regole;
Modi principali di difendersi: proiezione, esteriorizzazione, razionalizzazione e 9. Disturbi Dipendenti di Personalità:
Manifestazione Opposta: Disturbi Controdipendenti della Personalità: alcuni individui
hanno un bisogno di dipendenza inconsapevole che scacciano attraverso il diniego e la
formazione reattiva. Hanno perciò un disturbo dipendente di personalità mascherato dalla
pseudo-indipendenza. Si definiscono nelle relazioni come quelli da cui gli altri dipendono e
sono orgogliosi della loro indipendenza, guardano con disprezzo i segni di fragilità emotiva e
dipendenza, raramente cercano una terapia, quindi vanno aiutati ad accettare i loro desideri di
dipendenza come una componente naturale dell’essere umano. Se la terapia riesce a da andare
avanti si manifesta un lutto per gli originari bisogni di dipendenza e si fa strada un senso di
indipendenza più autentico.
Pattern costituzionali maturativi: sconosciuti ma è probabile una maggiore aggressività
rispetto ai dipendenti;
Tensione/preoccupazione principale: dimostrare la propria mancanza di dipendenza;
Affetti principali: disprezzo e diniego delle emozioni più deboli;
Credenza patogena relativa a se stessi: non ho bisogno di nessuno;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri dipendono da me;
Modi principali di difendersi: diniego, capovolgimento e agiti.10. Disturbi Fobici (Evitanti) di Personalità: non si sa se i disturbi fobici o evitanti possono essere
equiparati a quello di seguito descritti.
Pattern costituzionali maturativi: possibile disposizione ansiosa o timida;
Tensione/preoccupazione principale: sicurezza/pericolo verso oggetti specifici;
Affetti principali: paura;
Credenza patogena relativa a se stessi: se evito alcuni oggetti specifici sono al sicuro;
Credenza patogena relativa agli altri: persone + forti possono tenermi magicamente al sicuro;
Modi principali di difendersi: simbolizzazione, spostamento, proiezione, razionalizzazione ed evitamento.
Manifestazione Opposta: Disturbi Controfobici della Personalità: si organizzano attorno alle difese
dalle loro paure. Sono le persone che amano le situazioni rischiose, che si animano di fronte al pericolo e
hanno la reputazione di non perdere la calma anche in situazioni estreme. Tendono in modo irresistibile a
mettersi in situazioni di pericolo per dimostrare la loro impavidità. Anche loro presentano un pensiero
magico, quello di non farsi mai male, indipendentemente dai pericoli che vanno a cercare.
È improbabile che richiedano una terapia e parlare con loro di sentimenti non è certo agevole. Le reazioni di
controtransfert possono includere una certa ansia per i rischi cui vanno incontro e irritazione per le loro
fantasie onnipotenti.
Pattern costituzionali maturativi: sconosciuti;
Tensione/preoccupazione principale: sicurezza/pericolo;
Affetti principali: disprezzo, diniego della paura;
Credenza patogena relativa a se stessi: posso affrontare qualsiasi situazione senza avere paura;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri si spaventano facilmente ed ammirano il mio coraggio;
Modi principali di difendersi: diniego, formazione reattiva e proiezione. 11. Disturbi Ansiosi di Personalità:
gli individui a cui viene diagnosticato un disturbo d’ansia generalizzato possono essere meglio compresi sulla base dell’ipotesi
che abbiamo un disturbo della personalità in cui l’esperienza psicologica si organizza intorno all’ansia. Questo disturbo può
trovarsi in tutto il continuum e i soggetti al confine con l’area psicotica sono così pieni di terrore che non possono fare altro che
affidarsi a difese come la proiezione e il diniego, per cui in questi casi la diagnosi di disturbo paranoide è più appropriata.
Possono sembrare isterici o ossessivi, ma al contrario di tali pazienti sono sempre consapevoli della propria ansia perché le loro
difese sono inefficaci ad allontanarla. Al contrario dei fobici manifestano un senso globale di ansia liberamente fluttuante senza
avere idea di cosa li spaventi. Si possono riscontrare i seguenti tipi di ansia in ordine di gravità:
Angoscia Segnale: un affetto che indica che una determinata situazione si è rivelata in passato pericolosa;
Angoscia Morale: terrore di violare i propri valori profondi;
Angoscia di Separazione: la paura di perdere un oggetto dell’attaccamento;
Angoscia di Annichilimento: il terrore della frammentazione del sé.
L’origine di tale ansia si ritrova nel fallimenti delle strategie di coping e nella disregolazione affettiva.
Il controtransfert include una risposta di ansia, ma gli ansiolitici vanno somministrati con cautela per evitare la dipendenza. Il
terapeuta dovrebbe fornire al paziente lo sviluppo di un senso di sicurezza nelle proprie capacità di controllare l’ansia. Sono
quindi utili training di rilassamento, meditazioni e metodi cognitivo-comportamentali.
Pattern costituzionali maturativi: temperamento ansioso o timido;
Tensione/preoccupazione principale: sicurezza/pericolo;
Affetti principali: paura;
Credenza patogena relativa a se stessi: sono in constante pericolo a causa di forze sconosciute;
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri sono fonte di pericolo o di protezione;
Modi principali di difendersi: fallimento delle difese contro l’angoscia. Un’ansia indefinita può
mascherare angosce specifiche più disturbanti che sono mantenute al di fuori della coscienza. 12. Disturbi Ossessivo-Compulsivi di Personalità:
I Sottotipi sono:
- Ossessivo: ruminativo e cerebrale, per tale individuo l’autostima dipende dal pensare e dalle
realizzazioni intellettuali;
- Compulsivo: indaffarato, meticoloso e perfezionista, per tali individui l’autostima dipende
dal fare e dagli obiettivi pratici.
- Pattern costituzionali maturativi: possibile irritabilità e tendenza ad essere meticolosi;
- Tensione/preoccupazione principale: sottomissione/ribellione contro un’autorità che
controlla; - Affetti principali: rabbia, senso di colpa, vergogna e paura;
- Credenza patogena relativa a se stessi: la mia aggressività è pericolosa e va controllata; -
Credenza patogena relativa agli altri: gli altri cercano di controllarmi e io devo resistere;
- Modi principali di difendersi: isolamento degli affetti, formazione reattiva,
intellettualizzazione e annullamento retroattivo. 13. Disturbi Isterici (Istrionici) di Personalità : questi pazienti sono preoccupati dalle problematiche
legate al genere, alla sessualità e al potere, e possono presentarsi come all’eccessiva ricerca di attenzione e teatrali o
come individui inibiti e riservati. Inconsciamente tendono a considerarsi deboli e svalutati a causa del loro genere
sessuale ed a vedere le persone del genere opposto come potenti e invidiabili.
La descrizione borderline del DSM è essenzialmente l’istrionico organizzato a livello borderline.
Gli eterosessuali delusi dal genitore dello stesso sesso e iperstimolato da quello del sesso opposto possono sviluppare il
disturbo isterico di personalità. A differenza degli omosessuali, l’istrionico accetta il proprio genere ma lo vive come
fonte di svantaggi. Tali individui possono cercare di avere potere utilizzando la seduttività con le persone del genere
sopravvalutato.
L’intimità sessuale è fonte di grandi conflitti a causa della vergogna per il proprio corpo e la paura di essere danneggiato
dall’altro più potente. Hanno paura dell’iperstimolazione, più interna che esterna, e quindi vivono con angoscia i
propri sentimenti. Questo terrore può essere espresso dalla drammatizzazione, come se inconsciamente le emozioni
fossero derise della loro esagerazione. Possono anche essere presenti sintomi fisici privi di giustificazione medica che
esprimono conflitti dissociati (conversione). Come i narcisisti ricercano l’attenzione ma in maniera confinata alla
sessualità.
I Sottotipi sono:
Inibito: più comune nelle culture moralistiche e strutturate. Caratterizzato da riservatezza emotiva, inesperienza,
inibizione, sintomi di conversione e somatizzazione;
Eccessivamente Espansivo/Esuberante: più comune nelle culture liberali e caotiche. Caratterizzato dalla tendenza
alle crisi e alle drammatizzazioni, con seduttività e impulsività sessuale.
Pattern costituzionali maturativi: possibile sensibilità e sociofilia;
Tensione/preoccupazione principale: potere e sessualità del proprio genere/del genere altrui;
Affetti principali: paura, vergogna e colpa (per la competitività);
Credenza patogena relativa a se stessi: il mio genere mi rende debole, castrato e vulnerabile;
Credenza patogena relativa agli altri: le persone del mio stesso genere hanno scarso valore mentre le persone dell’altro
genere hanno potere, sono eccitanti, ma potenzialmente possono sfruttarmi e danneggiarmi;
Modi principali di difendersi: rimozione, regressione, conversione, sessualizzazione e acting out. 14. Disturbi Dissociativi di Personalità (d'Identità e Personalità Multipla) :
il disturbo si estende dall’area nevrotica a quella borderline.
Nel DSM il disturbo dissociativo dell’identità collocato tra le sindromi dissociative (disturbi
d’ansia). Quando le difese dissociative sono la risposta abituale allo stress, la dissociazione diventa elemento del carattere.
Quando una persona è ripetutamente traumatizzata o cresce in una famiglia in cui la dissociazione è adattiva vi sono le basi per
un disturbo dissociativo dell’identità.
Il disturbo non è raro e la storia traumatica alla base li fa tendere a compiacere i terapeuti poiché identificati come figure
autorevoli. Così i clinici che hanno scetticismo verso le amnesie scoraggiano i pazienti a parlare dei loro sintomi, e viceversa.
I sintomi possono essere di alienità verso se stessi o parti del proprio corpo, l’amnesia è un indicatore tipico del disturbo con un
dubbio persistente su quali esperienze sono vere e quali confabulate. Gli individui con questo disturbo possono sentirsi
profondamente lontani dalla possibilità di sviluppare un senso di continuità tra i loro stati del sé.
Suscitano un senso di confusione nel terapeuta che non riesce a raccogliere l’anamnesi, e, una volta rivelatasi la loro storia
traumatica possono suscitare sentimenti di compassione. Data la paura dell’abuso è opportuno che il trattamento proceda
lentamente ma gli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali e somatici delle esperienza che sono state dissociate devono
essere affrontati e reintegrati, ma ad un ritmo controllato dal paziente.
- Pattern costituzionali maturativi: capacità costituzionale di autoipnosi e traumi infantili fisici e/o sessuali, gravi e ripetuti;
- Tensione/preoccupazione principale: riconoscere il trauma/negare il trauma; - Affetti principali: paura e rabbia;
- Credenza patogena relativa a se stessi: sono piccolo, debole e vulnerabile a traumi ricorrenti; - Credenza patogena relativa agli
altri: gli altri mi traumatizzano, mi sfruttano oppure mi salvano; - Modi principali di difendersi: dissociazione. Disturbi Misti di Personalità/Altro: questa categoria serve ad includere gli individui che presentano combinazioni di tipi di personalità, come ad esempio fobico/isterico, e quelli con temi personali che non corrispondono alle costellazioni più comuni descritte in questa sezione.
1. Capacità di Regolazione, Attenzione e Apprendimento: sottolinea i processi
che consentono agli esseri umani di vivere le proprie esperienze e apprendere da
esse.
Prende in considerazione i Fattori Costituzionali e Maturativi come l’elaborazione
uditiva e il linguaggio, l‘elaborazione visuo-spaziale, la pianificazione e
l’organizzazione delle sequenze motorie e la modulazione sensoriale, e le capacità
connesse al Funzionamento Esecutivo tra cui memoria, attenzione, intelligenza
globale, elaborazione dei segnali affettivi e sociali.
All’estremo sano il soggetto è concentrato e organizzato ed è capace di apprendere
anche sotto stress. All’estremo compromesso l’attenzione è fluttuante e il soggetto
appare passivo.
2. Capacità di Relazioni e Intimità: è importante perché la mente è costituita
dall’internalizzazione delle proprie relazioni con gli altri, e si valuta il livello
psichico delle interazioni con gli altri che permette di avere informazioni sulle
rappresentazioni di se stesso e degli altri.
All’estremo sano il soggetto possiede la capacità di intimità, cura ed empatia anche
quando i sentimenti sono forti o sotto stress, mentre all’estremo compromesso il
soggetto appare indifferente e distaccato.3. Qualità dell'Esperienza Interna: cerca di cogliere il livello di sicurezza in se stessi e il rispetto di sé che caratterizzano la relazione di una persona con gli altri e con il mondo in senso più ampio. All’estremo sano il soggetto prova un’ampia gamma di emozioni, ha un senso di benessere e vitalità e mantiene l’autostima anche in situazioni di stress, mentre all’estremo compromesso prova sentimenti di impoverimento, vuoto e incompletezza. 4. Esperienza, Espressione e Comunicazione degli Affetti: è la capacità della persona di esprimere e comprendere l’intera gamma dei pattern affettivi pre-rappresentazionali e rappresentazionali. All’estremo sano il soggetto usa per la maggior parte del tempo un’ampia gamma di emozioni e desideri, anche sotto stress, comprende e risponde alla maggior parte dei segnali emotivi in modo accurato, mentre all’estremo compromesso il soggetto è per lo più afinalistico, frammentato, poco definito nell’espressività emotiva, distorce le intenzioni degli altri e interpreta in modo erroneo i segnali.
5. Pattern e Capacità Difensive: mette in evidenza il modo in cui gli individui cercano di fare fronte a desideri, affetti e altre esperienze, e il grado in cui distorcono l’esperienza nel corso di questo processo. È importante per una valutazione globale e permette di capire come il soggetto reagirà agli interventi. All’estremo più sano l’individuo dimostra di avere una capacità ottimale di fare esperienza di un’ampia gamma di pensieri, affetti e relazioni, e gestisce le situazioni stressanti con un uso minimo di difese, tendendo ad usare strategie di coping al servizio di un funzionamento emotivo sano e flessibile. All’estremo compromesso mostra un fallimento generalizzato nella regolazione difensiva. 6. Capacità di Formare Rappresentazioni Interne: riguarda la capacità dell’individuo di simbolizzare le esperienze affettivamente significative, cioè di organizzare l’esperienza in forma mentale, anziché somatica o comportamentale. Prende in esame la funzione riflessiva, per cui all’estremo sano il soggetto usa le rappresentazioni interne per fare esperienza di un senso di sé e degli altri e per esprimere un’ampia gamma di emozioni, e sa usare le rappresentazioni interne per regolare gli impulsi.
7. Capacità di Differenziazione e Integrazione: implica la capacità dell’individuo di costruire nessi logici tra le rappresentazioni interne, cioè di separare la fantasia dalla realtà, e di costruire connessioni tra le rappresentazioni interne dei desideri, degli affetti, del sé e delle relazioni con gli oggetti del passato, del presente e del futuro, inoltre di attribuire stati d’animo e rappresentazioni diverse e integrarle in un tutt’uno unitario. All’estremo sano il soggetto è in grado di mettere in relazione le esperienze interne del sé e del non-sé, all’estremo compromesso l’esperienza interna è tendenzialmente frammentata. 8. Capacità di Autosservazione (Mentalità Psicologica): riguarda la capacità dell’individuo di osservare la propria vita interiore. Questa categoria è un’estensione della capacità di differenziazione e integrazione. All’estremo sano il soggetto può riflettere su una gamma completa di sentimenti o di esperienze proprie o altrui, può riflettere sia nel presente che tenendo conto di una visione a lungo termine di se stesso, dei propri valori e dei propri obiettivi, mentre all’estremo compromesso non riesce a riflettere in modo genuino su sentimenti ed esperienze e la coscienza di sé consiste spesso in sentimenti polarizzanti o semplici e senza sfumature. La coscienza di sé è molto carente e c’è la tendenza alla frammentazione.
9. Capacità di Costruire o Ricorrere a Standard e Ideali Interni (Senso Morale): in quanto evoluzione delle altre funzioni mentali, ed esito dell’integrazione di un certo numero di esse, la capacità di formulare dei propri valori e ideali rispecchia la capacità di riflettere su di sé nel contesto delle esperienze presenti e future. All’estremo sano il soggetto presenta standard interni flessibili e integrati con un senso realistico delle proprie capacità e forniscono l’opportunità di provare desideri e sentimenti di autostima significativi. I sentimenti di colpa sono utilizzati come un segnale per riconsiderare il proprio comportamento. All’estremo compromesso invece gli standard e gli ideali interni e il senso morale sono tendenzialmente assenti.
1. Disturbi dell’Adattamento:
La diagnosi comprende un’ampia gamma di risposte disadattive croniche o
ripetute allo stress psicologico.
- Stati affettivi: variano da individuo a individuo. Vago disagio che deriva dalla
sensazione di essere in un cambiamento, sentimento di incertezza e
apprensione.
- Pattern cognitivi: concentrazione sullo stress attuale o marcato evitamento
del cambiamento. I pazienti sono preoccupati del cambiamento che stanno
affrontando.
- Stati somatici: accompagnano la reazione allo stress e la loro natura dipende
dalla risposta affettiva. - Pattern relazionali: aumento delle espressioni di
dipendenza o tentativi di distanziarsi dalle relazioni a causa della vergogna data
dall’aumento della sensazione del bisogno.Puoi anche leggere