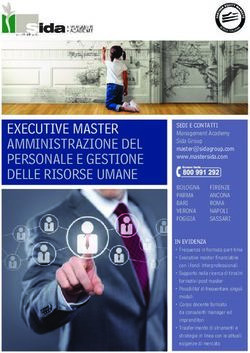Difesa fitosanitaria Innovazione e sperimentazione in agricoltura - Regione Piemonte
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Coordinamento editoriale Andrea Marelli Coordinamento tecnico Paolo Aceto, Alba Cotroneo, Luisa Ricci, Alberto Turletti Per informazioni REGIONE PIEMONTE Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Direzione Agricoltura Settore Servizi di Sviluppo Agricolo C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino Tel: 011.4321466 – Fax: 011.537726 Settore Fitosanitario Regionale Via Livorno, 60 – 10144 Torino Tel: 011.4321473 – Fax: 011.4323710 www.regione.piemonte.it/agri/ È vietata la riproduzione dei testi e dei materiali iconografici senza autorizzazione e citazione della fonte. Impaginazione e grafica: Verba Volant, Torino Stampa: Centro stampa Regione Piemonte Tiratura: 1000 copie – giugno 2012 Pubblicazione in distribuzione gratuita Supplemento al n. 77 dei Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura Registrazione al Tribunale di Torino n. 4184 del 5 maggio 1990 Direttore responsabile: Luciano Conterno
Presentazione La ricerca in agricoltura costituisce un fattore essenziale per la com- petitività e la sempre maggiore sostenibilità ambientale e sanitaria del settore e delle diverse filiere agricole, all’interno di un contesto di at- tenzione alla qualità e alla tutela del consumatore e al benessere degli animali, come quello piemontese. L’innovazione prodotta con l’attività di ricerca risulta strategica per le scelte imprenditoriali degli operatori delle filiere stesse e alimenta l’in- formazione che sta alla base della pianificazione della politica agricola regionale. La presente collana dal titolo Innovazione e sperimentazione in agricol- tura intende divulgare in modo sintetico i risultati ottenuti dall’attivi- tà di ricerca finanziata negli ultimi anni dalla Regione Piemonte ed è composta da quattro fascicoli monografici: Reflui zootecnici e fertilizzazione organica Coltivazioni e allevamento estensivi e biologici Qualità del latte e dei formaggi Difesa fitosanitaria Tale produzione editoriale integra e completa la divulgazione dei risul- tati della ricerca effettuata attraverso la pubblicazione degli stessi sulla rivista regionale “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”. Ogni volume contiene numerosi articoli divulgativi riferiti all’area tematica propria di ciascun fascicolo e si rivolge agli agricoltori, ai tecnici che operano in stretto contatto con gli operatori agricoli e alla comunità scientifica, tutti soggetti sempre più chiamati a fare sistema in un periodo difficile e di necessarie ristrutturazioni del settore quale quello attuale. I quattro volumi della collana sono scaricabili in pdf dalla sezio- ne “Pubblicazioni” del portale web della Direzione Agricoltura: www.regione.piemonte.it/agri/
Flavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
Il 2010 e il 2011 sono stati anni di recrudescenza della flavescenza dorata. Paola Gotta
La Regione Piemonte fin dall’inizio della comparsa della malattia ha pro- Chiara Morone
Regione Piemonte
mosso e finanziato progetti di ricerca integrata per chiarirne gli aspetti epi- Settore Fitosanitario
demiologici e ambientali al fine di mettere a punto idonee misure di lotta.
Cristina Marzachì
Nel triennio 2007-2009 è stato finanziato il progetto: Sabrina Palmano
Studi su fitoplasmi della vite e loro vettori: sensibilità varietale e efficienza Franco Mannini
di acquisizione di flavescenza dorata (FD), caratterizzazione, diffusione e Ivana Gribaudo
Istituto Virologia Vegetale C.N.R.,
vettori di legno nero (LN), tecniche di riduzione del danno – VIPLASMI Torino e Unità di Grugliasco (TO)
coordinato dal Settore Fitosanitario e con i seguenti partecipanti:
Settore Fitosanitario regionale (S.F.R.). Alberto Alma
Domenico Bosco
Istituto di Virologia Vegetale (I.V.V.) – C.N.R., Torino e Unità di Grugliasco. Federico Lessio
Di.Va.P.R.A. Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vi- Università di Torino (DI.Va.P.R.A.)
Entomologia e Zoologia applicate
dano”, Università di Torino. all’ambiente “Carlo Vidano”
Cadir Lab S.r.l.
Università Cattolica Piacenza, Facoltà di AGRARIA, Sede di Piacenza.
Gli studi condotti hanno avuto come obiettivo quello di dare risposta ad
alcune delle molte incertezze legate ai giallumi della vite ed in particolare
alla flavescenza dorata.
Le domande più frequenti
I vitigni coltivati in piemonte hanno una diversa
sensibilità alla flavescenza dorata (FD): perche?
Per dare risposta a questa domanda si è messo a punto un metodo per quan-
tificare la concentrazione del fitoplasma FD nella pianta infetta. Questo
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 23DIFESA
FITOSANITARIA
metodo è stato utilizzato per valutare, nei tre anni del progetto, il titolo di
FD in viti infette appartenenti a due cv con diversa sensibilità alla malattia:
Barbera e Nebbiolo.
Figura 1
Flavescenza dorata su Barbera.
Figura 2
Sintomi di flavescenza dorata su
Nebbiolo (foto G. Bosio).
In ciascuna delle cv analizzate, l’intensità della manifestazione dei sintomi
primaverili e di quelli estivi non è risultata correlata alla concentrazione
del patogeno nella pianta infetta. L’espressione del sintomo è quindi legata
alla situazione fisiologica della pianta ed a differenze in tal senso tra le due
cv. Complessivamente, si è osservato che nel corso della stagione vegetativa
il titolo di FD era sempre maggiore nelle viti della cv Barbera rispetto a
quelle di Nebbiolo (Tabella 1).
Tabella 1
Barbera Nebbiolo
Numero di cellule di fitoplasmi agenti di
Campionamento cellule FD/ng vite cellule FD/ng vite
FD per ng di DNA di vite nelle viti delle
cv Barbera e Nebbiolo nel corso dei estate 9725 992
campionamenti estivi ed autunnali del autunno 2320 288
2007, 2008 e 2009.
24 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURAFlavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
La concentrazione del fitoplasma all’inizio della ripresa vegetativa era in-
fluenzata dall’anno di osservazione. L’inverno meteorologico 2006-2007 è
stato molto mite e la concentrazione di FD nelle viti di entrambe le cv nella
primavera del 2007 è risultata la più alta del triennio. Negli inverni successi-
vi, molto più freddi, la concentrazione primaverile di FD in entrambe le cv
si è abbassata significativamente. È ipotizzabile che inverni rigidi risultino in
una diminuzione della concentrazione del fitoplasma in primavera, benché
un effetto indiretto della temperatura sulla fisiologia della vite, con ripercus-
sioni sulla moltiplicazione del fitoplasma non possa essere escluso.
Figura 3
Sindrome precoce di flavescenza dorata
su Moscato.
Diagnosi dei giallumi e dei virus della vite:
semplificazione dei metodi
L’utilizzo di metodiche di diagnosi rapide ed affidabili, abbinate ad un co-
stante monitoraggio dello stato fitosanitario dei vigneti, sono fondamentali
per limitare la diffusione delle malattie della vite, ma soprattutto nel caso dei
giallumi della vite, queste prevedono l’utilizzo di protocolli laboriosi non ap-
plicabili su larga scala. L’attività di ricerca condotta negli ultimi tre anni ha
riguardato lo sviluppo di metodiche innovative per la diagnosi rapida, adatta
ad un monitoraggio su ampia scala, delle principali malattie della vite asso-
ciate a fitoplasmi, Flavescenza dorata (FD) e Legno nero (LN), ed ad alcuni
virus floematici della vite, con particolare riferimento ai virus associati all’ac-
cartocciamento fogliare, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 e 3 (GLRaV-1 e
GLRaV-3), ed al complesso del legno riccio, Grapevine Virus A (GVA).
Sono stati messi a punto e validati protocolli sensibili ed affidabili che da
un’unica estrazione iniziale estremamente rapida e semplice, applicabile a
livello massale, permettono la diagnosi rapida di cinque tra i più impor-
tanti patogeni floematici della vite. Nel caso della diagnosi di fitoplasmi si
è riusciti a quadruplicare il numero delle analisi rispetto alle tecniche usate
precedentemente a parità di impegno economico e temporale.
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 25DIFESA
FITOSANITARIA
Quali sono i meccanismi di infezione e trasmissione
dei fitoplasmi, e sui meccanismi di risposta
e difesa all’infezione da parte della pianta?
Indagare su questi aspetti non è semplice. Le funzioni degli organismi vi-
venti dipendono dai loro geni ma a livello molecolare i giochi si svolgono
soprattutto a livello delle proteine: per questo motivo si è voluto procedere
ad un’analisi comparativa del profilo delle proteine totali di viti sane ed in-
fette da FD. L’obiettivo è quello di capire quali siano i sistemi coinvolti nella
difesa della vite all’infezione di FD e quali invece siano i sistemi infettivi
del fitoplasma correlato, tutte informazioni che potranno avere importanti
ricadute sulle strategie di controllo della malattia.
L’analisi di campioni di vite sani ed infetti da FD ha portato all’individua-
zione di proteine sovra o sotto-espresse nella pianta malata rispetto alla sana.
Tali proteine sono state identificate ed è stata individuata la loro possibile
funzione biologica.
La sovra o sotto-espressione di alcune di queste proteine in viti infette è stata
confermata anche a livello di trascrizione dei rispettivi geni. I dati ottenuti
hanno avvalorato l’ipotesi di un possibile coinvolgimento di questi geni nei
processi di risposta dell’ospite specifici all’infezione da fitoplasma.
Qual è il ruolo degli incolti ricchi di vite americana
sviluppatasi da vecchi ceppi di portinnesto
e presente come specie a portamento lianoso?
Tali incolti possono ospitare popolazioni talvolta consistenti di Scaphoideus
titanus, il vettore della FD, che si nutre e si riproduce comunque solo sulla
vite (sia americana che europea): gli stadi giovanili sono stati ritrovati dalla
fine di maggio fino alla metà di agosto, con un picco alla terza decade di
giugno (prevalentemente ninfe di III età); dalla metà di luglio in poi, sono
state trovate solo ninfe. Gli adulti sono presenti dall’inizio di luglio alla fine
di settembre-metà di ottobre. Talvolta gli stadi giovanili risultano infetti da
FD, acquisita dalla vite americana stessa.
Dove depone di preferenza le uova S. titanus?
La capacità di S. titanus di deporre le uova sul legno di uno o due anni è stata
studiata in ambiente controllato, immettendo circa 350 femmine mature in
un gabbione di rete escludi-insetto contenente circa 60 barbatelle di vite in
vaso, su 30 delle quali il legno di 2 anni era stato coperto da carta stagnola.
26 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURAFlavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
Nell’anno successivo, sono stati notati giovani di S. titanus in numero mag-
giore sulle barbatelle con disponibilità di legno di due anni; tuttavia, sono
state registrate nascite anche dal legno di un anno, che può quindi essere
usato dall’insetto per deporre le uova. Tale aspetto deve essere considerato
un rischio soprattutto nella filiera vivaistica, data la possibile contaminazio-
ne del materiale di propagazione con le uova del vettore.
S. titanus può compiere lunghi spostamenti
in volo e può colonizzare nuovi ambienti
Per lo studio della dispersione di S. titanus è stato applicato un tracciante Figura 4
(una soluzione acquosa di latte o albume d’uovo), con una pompa a spal-
Uova deposte nel ritidoma della vite.
la, direttamente sulle piante in un vigneto e in un incolto con vite ameri-
cana adiacente: gli insetti, posandosi sulle piante trattate, risultano quindi
marcati. Nel vigneto e nell’incolto sono poi state posizionate le trappole
cromotattiche gialle; gli adulti catturati sono stati sottoposti a diagnosi di
laboratorio (ELISA) per la ricerca del tracciante (latte o albume) e la verifica
della distanza percorsa in volo.
Nel corso di tale prova preliminare, sono stati catturati complessivamente 65
adulti di S. titanus; fra questi, 15 sono risultati marcati con latte (distribuito
nel vigneto) e 9 con albume (distribuito nell’incolto). Dei 9 insetti marcati
con albume, 5 sono stati ritrovati nel vigneto (2 su trappole di confine) e 4
nell’incolto; 3 insetti su 15 marcati con latte sono stati catturati nell’incolto,
su una trappola posta a meno di 3 m dal vigneto; gli altri 12 adulti marcati
con latte sono stati catturati nel vigneto. Il 60% degli adulti marcati con
albume è stato catturato entro 10 m dal punto trattato più vicino, mentre
la massima distanza di dispersione dall’incolto al vigneto è stata registrata a
21 m; gli insetti marcati con latte, nel complesso, hanno fatto registrare una
distribuzione più uniforme con catture fino a 30-32 m di distanza.
Questo studio è in corso di completamento: allo stato attuale, sono in fase
di analisi oltre 4000 esemplari di S. titanus catturati in incolti (trattati col
tracciante) e in vigneti posti a una distanza dall’incolto stesso compresa tra
2 e oltre 200 m.
In quale periodo è più efficiente l’acquisizione
di FD? Le viti risanate possono contenere ancora
il fitoplasma e trasmetterlo?
Per determinare l’efficienza di acquisizione dei fitoplasmi agenti di FD da
parte di S. titanus su viti risanate (viti dove si osserva la scomparsa, naturale
o indotta da potatura, dei sintomi della malattia) e sintomatiche sono state
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 27DIFESA
FITOSANITARIA
isolate ninfe sane su piante di cv Barbera e Nebbiolo infette in fase precoce
(fine maggio) e tardiva (agosto), e su piante di cv Nebbiolo risanate. Dopo
sette giorni, le cicaline sopravvissute sono state trasferite su viti sane in labo-
ratorio, e dopo un mese di incubazione sono state analizzate in PCR nested
per la presenza di FD.
Le prove di acquisizione hanno evidenziato un’efficienza bassa in fase precoce.
Le cicaline isolate su Nebbiolo risanato non hanno acquisito il patogeno.
È possibile indurre la resistenza a flavescenza
dorata nelle piante?
Sono state realizzate prove di trasmissione di FD mediante S. titanus da fava a
vite trattata con l’elicitore di resistenza benzotiadiazolo (BTH). Un campione
di insetti è stato poi recuperato dopo l’inoculazione e sottoposto ad analisi
molecolare per accertare l’efficienza di acquisizione del fitoplasma. Le piante
sono state analizzate per la presenza di FD circa 3 mesi dopo l’inoculazione.
Al termine del periodo di inoculazione sono sopravvissute percentuali iden-
tiche di cicaline sulle viti di controllo trattate con acqua (13) e su quelle
sottoposte ad uno o due trattamenti con BTH (11), che non sembra avere
attività tossica diretta su S. titanus. La FD è stata rilevata in una vite su 13 di
controllo mentre nessuna delle 22 viti trattate con BTH è risultata infetta.
Complessivamente, nelle prove svolte nel 2008 e nel 2009, 2 viti di control-
lo su 36 sono state infettate, mentre nessuna delle 56 viti sottoposte a uno
(28 piante) o due (28 piante) trattamenti con BTH 2,4 mM è risultata in-
fetta. La bassa efficienza di trasmissione ottenuta sulle viti di controllo non
permette però di trarre conclusioni certe.
Quali sono i ceppi di legno nero (LN) presenti,
quali sono le piante ospiti spontanee e i potenziali
vettori?
È stata analizzata la variabilità genetica esistente tra gli isolati del fitoplasma
dello Stolbur, agente del LN della vite, trasmesso in natura da Hyalesthes ob-
soletus. A questo scopo, isolati di LN da viti appartenenti a cv. diverse, piante
spontanee ed entomofauna potenzialmente vettrice sono stati caratterizzati
in otto vigneti rappresentativi della viticoltura piemontese nelle provincie di
AL, AT, BI, CN, TO e VC.
Nei vigneti in studio, il ciclo epidemiologico “convolvolo-H. obsoletus-vite
europea” è risultato più rappresentato rispetto a quello “ortica-H. obsoletus-
vite europea”. I risultati ottenuti hanno evidenziato la presenza stabile del
fitoplasma agente del LN all’interno dei serbatoi di piante spontanee nei vi-
28 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURAFlavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
gneti in esame. I casi di infezione registrati su vite sono invece diminuiti nel
corso dei tre anni. Anche all’interno di un singolo vigneto la popolazione di
isolati di LN non si presentava uniforme dal punto di vista genetico, e tale
variabilità si manteneva costante nel tempo nei diversi ambienti. Sono state
identificate specie vegetali spontanee ospiti di LN che potrebbero avere un
ruolo nella sua epidemiologia; è stato evidenziato il ruolo fondamentale di
una corretta gestione delle infestanti nei vigneti per il contenimento della
malattia in vite.
Per quanto riguarda i potenziali vettori di LN, è stato svolto un campiona-
mento delle forme giovanili di insetti appartenenti alla famiglia Cixiidae
dalla metà di maggio alla metà di luglio, sugli apparati radicali di piante
erbacee spontanee quali ortica (Urtica dioica), convolvolo (Convolvolus ar-
vensis) e artemisia (Artemisia verlotiorum). Le forme adulte di tali insetti
sono invece state raccolte da maggio a ottobre con retino entomologico, su
piante erbacee e arboree, e determinate in laboratorio. Gli esemplari sono
stati sottoposti a estrazione del DNA e Real-time PCR per l’identificazione
del fitoplasma agente causale del LN. Il campionamento con retino ha con-
sentito di catturare 319 esemplari appartenenti alle specie: H. obsoletus (su
ortica e convolvolo), Hyalesthes scotti (su olmo, salice e susino), Hyalesthes lu-
teipes (su olmo), Cixius wagneri (su olmo), Reptalus cuspidatus (su A. verlotio-
rum), Reptalus melanochaetus (su olmo), Reptalus. panzeri (su rovo bluastro)
e Reptalus quinquecostatus (su olmo). Il ritrovamento di forme giovanili sulle
radici ha confermato A. verlotiorum come pianta ospite per R. cuspidatus e il
convolvolo per H. obsoletus (quest’ultimo in passato allo stadio giovanile era
stato rinvenuto solo sulle radici dell’ortica). Dopo analisi PCR sono risultati
positivi a fitoplasmi agenti di LN le seguenti specie: H. obsoletus, H. scotti,
H. luteipes e R. cuspidatus.
Inoltre, è stata effettuata una caratterizzazione molecolare delle seguenti spe-
cie: H. obsoletus, H. scotti, H. luteipes, R. cuspidatus, R. melanochaetus, R.
panzeri e R. quinquecostatus. Dal momento che le diverse specie del genere
Hyalesthes non sono facilmente distinguibili tra loro semplicemente osser-
vandole al microscopio, e lo stesso vale per le specie appartenenti al genere
Reptalus, tale studio è servito a predisporre due chiavi di identificazione mo-
lecolare, una per le quattro specie di Reptalus e una per le tre specie di Hyale-
sthes più frequenti negli agroecosistemi vigneto. È stata evidenziata l’assenza
di variabilità intra-specifica in H. obsoletus, con particolare riferimento alle
popolazioni ottenute da ortica e da convolvolo.
Infine l’identificazione molecolare può essere applicata agli stadi giovanili,
privi di tratti morfologici distintivi, consentendo di ampliare il periodo di
monitoraggio degli insetti vettori e permettendo l’inequivocabile associazione
di ciascuna specie con l’effettiva pianta ospite. Le nuove chiavi potranno per-
tanto facilitare l’attività di monitoraggio dei potenziali vettori di legno nero.
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 29DIFESA
FITOSANITARIA
La termoterapia del materiale vivaistico
Dal 2004 sono in corso studi finalizzati all’ottimizzazione della tecnica
di termoterapia in acqua per l’ottenimento di materiale di moltiplicazione
viticolo esente da fitoplasmi. Tali studi hanno potuto realizzarsi grazie alla
messa in servizio presso il CEPREMAVI di una apposita apparecchiatura
finanziata dai Vivaisti Piemontesi associati alla Vignaioli piemontesi.
La sperimentazione ha permesso di acquisire la necessaria esperienza nella ge-
stione della termoterapia in acqua, evidenziando l’idoneità del trattamento a
50°Cx45’ sia effettuato sul materiale di moltiplicazione prima dell’innesto sia
sulle barbatelle innestate prima della commercializzazione. Prove preliminari
hanno indicato anche la praticabilità del trattamento a 52°Cx45’, che pare
più efficace nell’eliminazione del legno nero, ma con qualche cautela in più
per evitare riduzioni nella resa se applicato a cultivar considerate sensibili.
Sulla scorta dell’esperienze maturate negli anni precedenti, la sperimenta-
zione condotta nel corso del triennio 2007-2009 è proseguita per cercare di
dare risposte alle seguenti domande.
La durata della frigo-conservazione del legno dopo
la termoterapia in acqua comporta effetti negativi
sulla resa vivaistica?
L’esperienza è stata condotta per due anni (2008 e 2009) sottoponendo un
migliaio di marze clonali di Barbera e Nebbiolo, ed i rispettivi portinnesti,
a termoterapia in due date differenti in modo che metà del materiale su-
bisse circa due mesi di frigo-conservazione prima della propagazione per
innesto e la restante metà solo1 giorno. L’obiettivo era quello di verificare
sulla resa vivaistica l’effetto congiunto della termoterapia e della durata della
frigo-conservazione del materiale di propagazione.
Nel 2008 è stato adottato il trattamento termoterapico più severo a 52°Cx45’
effettuato rispettivamente in data 14/02 e 27/03. L’innesto del materiale è
stato eseguito il 28/03. Dopo il periodo di forzatura gli innesti-talea sono
stati posti in vivaio per poi essere estirpati in autunno. La durata del pe-
riodo di frigo-conservazione dopo il termotrattamento in acqua non ha
evidenziato differenze sensibili tra le diverse tesi, anche se quest’ultimo ha
penalizzato la resa vivaistica che si è attestata per entrambe le cultivar su un
modesto 50 % di barbatelle di prima scelta.
Nel 2009 è stato adottato il trattamento tradizionale a 50°Cx45’ effettuan-
dolo rispettivamente in data 16/02 e 7/04. La resa vivaistica è nettamente
Figura 5 migliorata (tra il 60 e l’80 %) ma anche in questo caso i dati non hanno
Particolare della vasca per termoterapia consentito di fornire un’indicazione precisa su quale tra le due modalità sia
in acqua. preferibile adottare.
30 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURAFlavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
In linea generale quindi si può concludere che la diversa durata di frigo-
conservazione in relazione al momento del termotrattamento in acqua è
risultata ininfluente sulla resa vivaistica finale.
Quali modificazioni fisiologiche e biochimiche
avvengono nel materiale sottoposto a termoterapia?
Nel corso della prova del 2009 sopra descritta sono anche stati condotti
studi per esaminare l’evoluzione delle riserve glucidiche del materiale
legnoso termotrattato. Le talee legnose di Nebbiolo e Barbera, raccolte in
febbraio e conservate in frigorifero per pochi giorni, hanno rappresentato
il punto di partenza dell’analisi (tesi 1). Altre tesi erano rappresentate dal
materiale termotrattato (50°C x 45’):
materiale trattato in febbraio (tesi 2) e quindi frigoconservato fino ad
aprile (tesi 4);
materiale mantenuto in cella frigorifera fino al trattamento termico tardi-
vo avvenuto in aprile (tesi 3).
Parte del materiale (controllo) è stato frigoconservato per l’intero periodo
senza subire trattamenti termici (tesi 5).
Le analisi sono state effettuate presso il Laboratorio della Camera di Com-
mercio di Torino in febbraio (tesi 1 e 2) e in aprile (tesi 3, 4 e 5). Un elemen-
to comune alle due cultivar è stata la variazione dei contenuti di zuccheri ed
amido del materiale stoccato in frigorifero tra febbraio ed aprile (tesi 1 vs
tesi 5): le percentuali dei vari zuccheri presenti diminuiscono a fronte di un
aumento dell’amido. Questi andamenti indicano una parziale conversione
della frazione solubile in amido, che secondo la letteratura avviene nelle
piante coltivate in campo nel periodo gennaio-marzo (2a parte dell’inverno).
In linea generale la termoterapia ha causato una riduzione del contenu-
to in glucidi solubili. Un altro aspetto è il calo drastico del contenuto in
zuccheri quando il materiale è stoccato per due mesi in frigorifero dopo la
termoterapia precoce (tesi 2 vs tesi 4). L’effetto del trattamento termico sulla
percentuale di amido invece non è risultato univoco; la variabilità osservata
potrebbe essere giustificata da una maggiore eterogeneità della presenza di
amido nella pianta e conseguentemente nel materiale di partenza.
Il germogliamento di talee uninodali sottoposte agli stessi trattamenti ha
confermato quanto già osservato in precedenza: la termoterapia causa
un ritardo nel germogliamento a 8 giorni nella cv Barbera, mentre per il
Nebbiolo le differenze non sono apprezzabili. I dati raccolti in vivaio negli
anni di sperimentazione della termoterapia in acqua hanno sempre mostrato
come l’iniziale ritardo del materiale trattato venga rapidamente recuperato
con l’avanzare della stagione.
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 31DIFESA
FITOSANITARIA
I risultati di un anno di sperimentazione non sono esaustivi, dato anche
il numero di fattori endogeni ed esogeni che influiscono sulle dinamiche
dei carboidrati nella pianta. In ogni caso le variazioni osservate non paiono
avere avuto influenza sulla resa vivaistica del materiale trattato, che – come
sopra riportato - non è risultata diversa da quella dei controlli.
La termoterapia in acqua su barbatelle innestate
con presenza di fitoplasmosi può avere un effetto
risanante?
La prova è stata condotta su scala semi-industriale con alcune migliaia di
barbatelle innestate in cui erano state riscontrate un certo numero di pian-
tine con sintomi riferibili sia ad FD che a LN, infezioni poi confermate
dall’analisi. Nel 2007 le barbatelle sono state sottoposte a tre tesi di tratta-
mento (testimone, 50°Cx45’ e 52°Cx45’) e rimesse in campo per un secon-
do anno di vivaio in condizioni controllate per minimizzare le reinfezioni.
Il monitoraggio del barbatellaio nel corso della stagione vegetativa ha evi-
denziato la ricomparsa di sintomi in numerose piantine della tesi testimone
(pari allo 0,8 %), di una sola piantina sintomatica nel 50°Cx45’ (pari allo
0,01 %) e di nessuna nella tesi 52°Cx45’.
Tali risultati confermano da un lato la possibilità, pur numericamente
modesta, di diffondere l’infezione tramite il materiale vivaistico a causa di
fenomeni di latenza e dall’altro l’utilità di un trattamento termoterapico
preventivo.
Analogamente nella primavera 2008 sono state termotrattate in acqua (testi-
mone non trattato, 50°Cx45’e 52°Cx45’) barbatelle innestate di Chardon-
nay in cui nel corso dell’estate precedente erano stati segnalati casi positivi
di LN. Tali barbatelle, nell’ordine di oltre un migliaio, dopo il trattamento
sono state rimesse in vivaio in luogo controllato. Il monitoraggio effettuato
nel corso della stagione vegetativa però non ha riscontrato sintomi poten-
zialmente riferibili a fitoplasmi. Il vivaio è stato mantenuto in sede senza
effettuare l’estirpo e nel corso del 2009 è proseguito il monitoraggio sulla
comparsa tardiva di eventuali sintomi senza peraltro riscontrare manifesta-
zioni ascrivibili a fitoplasmi.
La termoterapia in acqua è efficace anche
nei confronti del Legno nero?
Esperienze precedenti hanno indicato che con la termoterapia in acqua il
LN viene eliminato dal materiale di propagazione con maggior difficoltà
rispetto alla FD. Al fine di individuare un trattamento in grado di garantire
32 INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURAFlavescenza dorata della vite:
le novità della ricerca
l’idoneità del materiale anche nei confronti del LN si è testata l’efficacia
risanante del trattamento a 52°Cx45’.
A tal fine materiale legnoso prelevato con la potatura da 12 ceppi di svariate
cultivar che nell’anno precedente erano risultate infette da Legno nero è sta-
to sottoposto nel 2008 al trattamento termoterapico in acqua a 52°Cx45’.
Una quota corrispondente di materiale non è stato trattato per fungere da
testimone. Per ciascuna tesi oltre un centinaio di talee bigemma è stato po-
sto in vaso e collocato in una apposita serra a prova di insetto. Le analisi di
laboratorio (PCR-nested seguita da RFLP) hanno evidenziato la presenza di
9 campioni infetti da LN nelle piante testimoni (pari al 7,8 % del totale)
mentre tutte quelle delle tesi termotrattate sono risultate negative (Tabella
3). Va sottolineato inoltre che considerando solo lo Chardonnay, la trasmis-
sione nelle talee non trattate è risultata ben superiore rispetto alle altre cul-
tivar con il 35,3 % di piantine positive sul totale di quelle messe in vaso.
Nel 2009 tutte le piante in vaso sono state nuovamente sottoposte a diagno-
si tramite PCR evidenziando la positività al Legno nero in altri due cam-
pioni delle tesi non trattate (quindi sfuggiti ai controlli ’08) mentre i test di
tutte le piante originate dalle talee trattate a 52°Cx45’ si sono confermati
negativi.
Il termotrattamento in acqua a 52°Cx45’ si è quindi rilevato efficace
nell’eradicazione del LN e pertanto se ne consiglia l’utilizzo in tutte le
situazioni ad alto rischio di diffusione della malattia, anche se questo può
potenzialmente comportare un abbassamento della resa vivaistica.
INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 33Puoi anche leggere