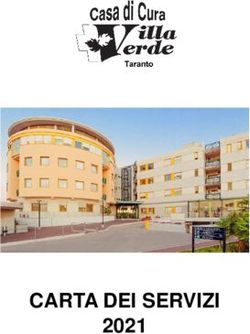ARIBERTO MIGNOLI BIBLIOFILO CURIOSO E RAFFINATO GIURISTA - La Biblioteca Storica Mediobanca
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La Biblioteca Storica
Mediobanca
ARIBERTO MIGNOLI
BIBLIOFILO CURIOSO
E RAFFINATO GIURISTA
ATTI DEL CONVEGNO
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2016
1SOMMARIO
Alberto Nagel
Introduzione 7
Sergio Scotti Camuzzi
Diritto della società per azioni e diritto dello Stato: analogie di
idee e problemi nel pensiero di Mignoli 8
Eva Cantarella
Saffo e le altre 28
Lucrezia Geraci
Spunti di riflessione tratti dalle lezioni del professore Ariberto
Mignoli sulla disciplina delle società per azioni 35
Daniela Marcheschi
Abitare il futuro: Ariberto Mignoli fra diritto, economia e cultura 48
Marino Viganò
«Per le fauste nozze...»
La collezione Mignoli di nuptialia del XIX e XX secolo 60
Appendice fotografica 66
5INTRODUZIONE
Alberto Nagel
Ariberto Mignoli è una figura difficile da ricordare: dotato di
una personalità unica, alla quale non è facile rendere
omaggio proprio per la sua rarità nel panorama italiano ma
non solo. E quindi con la famiglia Mignoli e grazie agli amici
che ci hanno dato una mano abbiamo potuto organizzare
questa giornata di ricordo della sua figura.
Non vogliamo ricordare solo il suo lato più accademico di
giurista e tralasciare altri aspetti più legati alla sua
personalità, la sua passione per i libri e le sue varie curiosità.
Definire questo insieme non è un compito facile, ma un
concetto che potrebbe essere utile è quello di humanitas.
Andando a vedere il concetto di humanitas latino prima
ripreso da Cicerone ma poi in alcuni passaggi anche da
Terenzio si possono trovare spunti interessanti. Nell’accezione
di Terenzio ci sono diversi valori caratteristici della figura di
Ariberto: filantropia, dignità, nobiltà d’animo, senso della
giustizia, buongusto, misura, eccellenza dell’ingegno e
mitezza d’animo. Sono tutti valori che ricordo essere molto
forti nella figura di Ariberto Mignoli.
7DIRITTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
E DIRITTO DELLO STATO: ANALOGIE
DI IDEE E PROBLEMI NEL PENSIERO
DI MIGNOLI
Sergio Scotti Camuzzi
1. Il pensiero di Ariberto Mignoli cui faccio riferimento è
espresso negli scritti raccolti in due volumi pubblicati a
Milano nel 2002 dall’Editore Giuffré, sotto il titolo La
società per azioni. Problemi - Letture - Testimonianze1.
Di tali scritti ho particolarmente utilizzato, perché
specificamente attinenti al tema in discussione:
1° gli articoli di Mignoli intitolati: Idee e problemi
nell’evoluzione della «company» inglese (pubblicato
in Riv. società 1960), La società per azioni oggi.
Problemi e conflitti (è la prolusione dell’anno
accademico 1989-1990, pubblicata in «Riv. Società»
1990), L’interesse sociale (pubblicato in «Riv. Società»
1958), Interesse di gruppo e società a sovranità
limitata (pubblicato in Contratto e impresa, 1986), I
quarant’anni della Rivista (è l’allocuzione introduttiva
1 Il primo volume è diviso nelle «Riflessioni sui principi» e «Riflessioni sulle discipline»,
e raccoglie articoli di Mignoli pubblicati (quasi tutti) sulla Rivista delle società.
Il secondo volume contiene le prolusioni, lette dal professore nell’anno
accademico 1962-1963 e nell’anno accademico 1989-1990, ai corsi di lezioni di
diritto commerciale da lui tenuti all’Università Bocconi, i suoi discorsi di
introduzione ai convegni della «Rivista delle Società» svoltisi a Venezia nel 1966,
nel 1981 e nel 1995 e, in una terza parte («Testimonianze. Memorie. Letture»), una
raccolta preziosa di brani di illustri Autori del passato, recensiti nella Rivista delle
Società fra il 1960 e il 1972, preceduta da necrologi di alto valore letterario e
storico e seguita da tre brevi pezzi poetici di Milton, di Hölderlin e dello stesso
Mignoli («Le mura della città»): quasi frammenti di un suo testamento spirituale.
A testimonianza della sua consapevole ed intenzionale umiltà, ricordo che
l’Autore disse che gli sembrava che questo secondo volume fosse più
interessante del primo.
8del convegno tenuto a Venezia nel 1995 sul tema I
gruppi di società, pubblicata in «Riv. Società» 1995);
2° alcuni degli scritti di Autori del passato che Mignoli ha
selezionato e raccolto: quelli di H. F. D’Aguesseau,
Mémoire sur le commerce des actions de la
Compagnie des Indes; di I. de Pinto, Traité des fonds
de commerce ou jeu d’actions; di H. O. Taylor, La
venerabile persona giuridica; di W. Rathenau, La
realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite
dall’esperienza degli affari (con introduzione di L.M. e
A.M.); di K. Marx, L’East India Company (con
introduzione di R. Banfi); di R. Hilferding, La società
per azioni (con introduzione di R. Banfi) di O. von
Gierke, Sulla storia del principio di maggioranza.
2. Quanto all’idea che fra diritto dello Stato e diritto della
società per azioni vi sia una similitudine spiccata e che la
dottrina dello Stato – dello Stato moderno, cioè dello
Stato sovrano quale concepito dal pensiero politico
dell’Europa rinascimentale, e poi evolutosi in Stato di
diritto, laico e democratico – influenzi la teoria delle
società (e/o viceversa?), essa è da Mignoli enunciata
espressamente, almeno come rilevazione di un fatto
storico, se non come postulato di necessità filosofica.
Cito da Idee e problemi nell’evoluzione della «company»
inglese: «È del resto costante nella dottrina delle società il
ricorso alla teoria dello Stato, da cui per tanti versi la
società deriva la sua fisionomia, il suo modo di
procedere, il suo stesso destino»; e ancora: (la società
commerciale – la società per azioni in particolare – nella
sua struttura organizzativa) «riproduce la divisione dei
poteri propria dello Stato»; e poi: «lo Stato disciplina a sua
immagine e somiglianza la grande società azionaria, sulla
9quale quindi si ripercuotono modi di vedere, dottrine e
tradizioni che influenzano le vicende della vita statale».
3. Ma è proprio vero che la società per azioni è foggiata
dallo Stato a sua immagine e somiglianza?
Non sono maggiori, e maggiormente significative – fra
diritto dello Stato e diritto della società per azioni – le
differenze più che le rassomiglianze? E non è forse vero
che, all’inverso, fu molte volte la dottrina e la prassi delle
società di commercio ad ispirare ed a guidare la dottrina
dello Stato?
Belle domande, ma l’interrogativo metodologicamente
più importante, cioé più utile per capire le cose, è un
altro, ed è questo: qual è il problema, il medesimo, in cui
si sono imbattuti sia i progettisti/costruttori dello Stato –
intendo dello Stato moderno, quello che, ancora oggi
modella la nostra società politica – sia i
progettisti/costruttori della società per azioni; qual è il
problema dei cui termini e/o delle cui soluzioni nella
dottrina delle società commerciali e nella dottrina dello
Stato si vedono somiglianze e addirittura identità?
E perché – se è vero (come sembra) che nella realtà
delle cose essa esiste – vi è siffatta analogia?
Al primo interrogativo, quello sul verso dell’influenza di un
modello sull’altro, la risposta dell’Autore è chiara; egli
pensa che sia venuta prima la dottrina e la pratica
politica, e che sia stata essa, quella dello Stato, ad
influenzare quella societaria, piuttosto che all’inverso. Ciò
non togliendo, però, che i giuspubblicisti ed i politici, sia
nella teoria che nella pratica, abbiano largamente
attinto ai concetti ed ai principi degli istituti del diritto
civile: in primo luogo del contratto (da Locke a Hobbes a
10Rousseau) – e, per diritto inglese, del trust –, facendo
capo al principio dei principi predetti, cioè pacta sunt
servanda, con la sua estensione anche ai re e agli
imperatori, sia nelle relazioni fra loro sia nelle relazioni con
i sudditi e/o con i parlamenti dai medesimi nominati.
Ricordo che l’abdicazione di Giacomo II, che consentì
alla rivoluzione dello Stato inglese del 1688/89 – la sua
conversione in monarchia costituzionale – di compiersi
senza spargimento di sangue, né reale né popolare, e
quindi di essere ricordata come «gloriosa», era stata
richiesta a motivo del suo breach of trust); e che l’ascesa
al trono di Guglielmo III d’Orange, suo successore, fu
possibile soltanto alla previa condizione, voluta dal
Parlamento, che egli giurasse di rispettare il Bill of rights
dei suoi sudditi: e fu così che nella realtà storica ebbe
principio lo Stato costituzionale.
Al secondo interrogativo – quale sia il tema centrale
comune, che rende omogenee la questione politica e
quella societaria – sono ancora gli stessi scritti di Mignoli a
specificamente rispondere. Si tratta, sia per lo Stato sia
per la società per azioni, del problema del potere; ed, in
entrambi i campi, nel duplice momento e per il duplice
profilo dell’attribuzione e dell’esercizio del potere2.
È il problema, precisa l’A., «della disciplina dei rapporti fra
governanti e governati, tra maggioranze e minoranze,
problema che si risolve in quello della
costituzionalizzazione, non solo della vita politica, ma
anche di quella economica del paese».
2 Cui di recente, nella cultura societaria contemporanea, si è aggiunta, con enfasi
forse eccessiva (laddove in quella politica è negletta), la considerazione del
profilo del controllo, di carattere preventivo ed amministrativo: ciò che è da
approvare, ma a patto che tale impostazione non vada a scapito (e alibi) della
responsabilità per il cattivo esercizio del potere, conseguendone una deleteria
burocratizzazione del governo ed una voluta esautorazione della funzione
giurisdizionale (che pur resti nell’àmbito del giudizio di legittimità).
11Il rilievo meriterebbe di essere preso a spunto per un
approfondimento del significato liberale che tale
“costituzionalizzazione” dell’attività economica (pubblica
e privata), di cui le società azionarie sono protagoniste,
assume nel quadro della nostra Carta costituzionale
(prima della imminente minacciata sua manomissione).
4. Vorrei, a questo punto, proprio sul problema del potere,
“mettere i piedi nel piatto”, e cioè entrare nel merito
delle similitudini – di alcune delle similitudini – fra diritto
dello Stato e diritto della Società per azioni, che Mignoli
esplicitamente o per implicito considera, e
considerandole afferma.
Si tratta dell’analogia che, nella prassi e nella riflessione
teorica dell’uno e dell’altro campo, si ritrova sui temi della
maggioranza, dell’interesse sociale, della personalità
giuridica3.
Com’è caratteristico degli insegnamenti di Mignoli,
queste analogie non sono da lui sostenute con
dimostrazioni logiche deduttive, ma con osservazioni,
lucidamente penetranti, dei dati di fatto della vita
sociale, della pratica degli affari e della politica vissuta;
cioè sono tesi sostenute non dalla ragion pura ma dalla
ragion pratica, che è ragione storica. Il pensiero di
Mignoli al riguardo è antitetico a quello di Spinoza, che
voleva che il diritto (naturale) fosse «ordine geometrico
demonstratum».
5. Mignoli invero fu un grande viaggiatore; e viaggiatore
non soltanto nello spazio, ma anche nel tempo; il suo
3 E poi sul tema della relazione fra Stato, o società per azioni, e mercato (ma
questa è un’angolazione di prospettiva un po’ diversa, che - suggerita o forse
richiesta da necessità contemporanee - vi proporrò alla fine, come esito e
compimento dell’indagine fatta da Mignoli).
12taccuino di viaggio è un atlante storico. Ed è cosi che il
paragone fra diritto dello Stato e diritto della Società per
azioni si dipana nel suo pensiero lungo gli ultimi quattro
secoli, fino all’età nostra; ed è così che, discutendo
sull’argomento, egli colloquia con pensatori del passato
come se fossero suoi contemporanei. Lo testimonia la
raccolta dei brani dei loro scritti che compone il secondo
dei volumi che Mignoli ha voluto lasciarci in eredità della
sua ricerca e del suo insegnamento.
Ebbene, per mostrare che quegli assunti circa l’analogia
fra il diritto della società per azioni e il diritto dello Stato
sono veri, Mignoli anzitutto fa un viaggio, a Londra e ad
Amsterdam, all’inizio del XVII secolo.
E poiché ancora, alla mia tarda età, sono i viaggi
avventurosi del pensiero che m’attraggono4, voglio
seguire Mignoli in questo viaggio e vi invito a venire
anche voi, e a guardare insieme le cose, gli uomini, i
paesaggi, le opere da lui visti e capiti.
6. È opinione condivisa che la prima nata della stirpe delle
società per azioni sia stata la East India Company,
costituita nel 1600 a Londra e fin dalla sua nascita dotata
– e probabilmente perciò fatta nascere –, per
concessione della regina (Elisabetta I), del privilegio
esclusivo (ossia del monopolio), del commercio con le
Indie Orientali e della navigazione sui mari solcati da
quelle rotte.
4 Perché in essi potrei incontrare, non più (o non più soltanto) il brivido dei perigliosi
percorsi o il fascino dei giochi pericolosi, dei labirinti ostinati, ma gli attimi
dell’illuminazione, la traccia, la cifra dell’alchemico enigma, udire le note
dell’armonia celeste, e trovare la chiave della comprensione delle cose e degli
uomini, e cioè del mistero di Dio – «e ceneremo insieme, e tu m’aprirai le porte
del tuo cuore».
13Di quella Compagnia, Mignoli segnala il «carattere
essenzialmente democratico»; qualità che del resto fu ad
essa pubblicamente e con invidia riconosciuta dagli
azionisti (specialmente dal popolo dei “sottopartecipanti”
cioè dei “piccoli azionisti”) della coeva Compagnia
Olandese delle Indie Orientali quando, nel 1621, essi
lodavano la cugina inglese come esemplare, al
confronto con la loro Compagnia della quale criticavano
la struttura oligarchica, lamentando la prepotenza dei
suoi amministratori, che la facevano da padroni, senza
aver avuto alcuna investitura da parte dei “partecipanti”,
cioè degli azionisti. In effetti, nella Compagnia olandese,
gli azionisti non avevano voce in capitolo; il governo era
nelle mani dei fondatori, i bewindhebbers, immanicati
con il potere politico, veri oligarchi, e restò a lungo nelle
mani dei loro successori, i quali, non nominati
dall’assemblea degli azionisti, esercitavano il loro potere
di governo con arroganza e senza darne conto.
Per entrambe le Compagnie il tema è il medesimo: è
quello dell’attribuzione e dell’esercizio del potere di
comando sui consociati e sulle cose ed attività messe in
comune (a chi darlo, per quale titolo; entro quali limiti, e
come, per quali finalità, esercitarlo).
Ed è il tema, ciò è da notare, che parimenti si presentava
a proposito della strutturazione degli Stati – gli Stati
nazionali sovrani – che nell’Europa occidentale, dal loro
originario modello di regni o principati assoluti (o
repubbliche oligarchiche presidenziali, come a Venezia o
a Firenze, o come il pontificato a Roma), in quell’epoca
andavano, ancorché lentamente, evolvendo – prima in
Gran Bretagna, poi, cento e cento anni dopo, negli altri
paesi europei – verso lo Stato di diritto, lo Stato
costituzionale nel quale oggi – passate le tragiche ere
fasciste, naziste e staliniste – trascorriamo (e, vi assicuro,
14per nostra fortuna), i giorni della nostra esistenza e
godiamo di un notevole grado di libertà.
Il problema è il medesimo e analoghi sono i concetti ed i
principi che i nostri avi hanno adoperato, e ancor oggi
noi adoperiamo, per impostarli e, se non per risolverli, per
utilmente affrontarli.
7. Due osservazioni di Mignoli circa la “democrazia”
societaria sono degne di nota.
La prima, l’osservazione del fatto che il carattere
democratico della Compagnia inglese trova spazio e
adatta coltura nella selezione aristocratica dei suoi soci (i
quali, addirittura, erano chiamati, come in ogni esclusivo
club era buona norma stabilire, a versare a fondo
perduto una tassa di ammissione), laddove la
Compagnia olandese era intenzionalmente “a larga
base azionaria”, cioè aperta a chiunque volesse
sottoscrivere anche una sola azione di modesto valore: e
ben sappiamo che la democrazia più facilmente alligna
in una omogenea compagnia di pari di nobile rango che
in una disparata accolita di estrazione popolare; e d’altro
lato, che tale carattere democratico della Compagnia
inglese, era ad essa impresso dalla regola, che è ancor
oggi alla base dello Stato inglese, di attribuire il potere
alla maggioranza: in tale potere non essendo però
compreso quello di governare, perché il mandato di
governare è dato ad amministratori terzi i quali, pur
dovendo essere graditi alla maggioranza degli azionisti (o
dei parlamentari), non necessariamente devono essere
da essa nominati (e nel governo dello Stato non lo sono)
e – soprattutto – hanno il mandato a governare non
nell’interesse della maggioranza ma nell’interesse
comune di tutti.
15La seconda è l’osservazione del fatto (Mignoli lo nota)
che per una decina d’anni dopo la sua costituzione la
Compagnia inglese usò computare la maggioranza per
capi e non “pesare” il voto dell’azionista in proporzione
del numero delle azioni da lui possedute. Rammento che,
mentre, nella dottrina e nella prassi dello Stato, il voto per
capi fu indiscusso anche quando il diritto di voto non era
dato a chi non fosse di censo ragguardevole, per contro,
nelle società per azioni, fu sempre pacificamente ritenuto
il criterio che il voto nell’assemblea degli azionisti dovesse
essere computato per azioni, cioè che dovesse essere
pesato in proporzione della quota di capitale posseduta.
Fu lo stesso Hobbes – il teorico dell’assolutismo del potere
della maggioranza popolare (computata per capi), nello
Stato – a sostenere che nella SpA era giusto adottare il
diverso criterio capitalistico, con l’argomento che è
giusto che il potere di decisione sia proporzionale al
rischio che ciascun partecipante corre; rischio che è
appunto quello di perdere il capitale conferito5.
E come mai, allora, fu che all’origine, nella East India
Company inglese, i voti contavano per capi? E che
soltanto una dozzina d’anni dopo la sua costituzione si
passò alla conta dei voti per peso, cioè pesando la
quota di capitale che il votante rappresentava?
Lo si spiega se si pone mente al fatto che, in origine, la
East India Company ebbe carattere prettamente
consortile. Invero, fino al 1612-1613 essa fu una regulated
Company, da ascrivere al novero delle corporazioni fra
mercanti; il cui fine (la precisazione/definizione è ancora
dovuta a Hobbes, là dove, nel Leviatano, tratta dei «corpi
politici per regolare il commercio») «non è il comune
5 Chiaro che il presupposto di tale ragionamento è che la società per azioni è una
società a responsabilità limitata dei soci; ed ovvia la conclusione che –
nell’accomandita per azioni – il potere spetta all’accomandatario.
16beneficio della corporazione tutta, ma il guadagno
particolare di ciascun mercante». Soltanto dopo essa
divenne una “joint stock company” e fu soltanto allora
che, coerentemente, si passò al criterio di computare il
voto di ogni singolo partecipante col peso della quota di
capitale da lui rappresentata.
8. Permettiamoci però, ora che abbiamo addestrato lo
sguardo a guardare queste cose, di gettarlo su un altro
paesaggio. Come mai, per diritto delle SpA, la
maggioranza nel consiglio d’amministrazione (e nel
Consiglio di sorveglianza, dove pure s’approva il bilancio)
si computa per capi?6.
E, sotto altri profili: qual’è l’àmbito cui si deve riferire il
potere societario: esso comprende la gestione
dell’impresa – o delle imprese – che costituisce l’oggetto
sociale? Quali i confini fra legge (potere del Parlamento
o dell’Assemblea) e decreto (o atto) di gestione (potere
del Governo o dell’Organo amministrativo)?
La discussione di siffatte questioni ci condurrebbe entro
territori appena esplorati – sia nella dottrina dello Stato
che nella dottrina societaria – e ancora incolti, e in parte
nemmeno mappati.
Su di esse però posso dire che, il nostro diritto societario è
un poco più avanti del diritto dello Stato. La piccola
riforma attuata dal diritto della SpA nel 2003-2004,
modificando i precedenti art. 2381 e 2364 cod. civ., ha
6 Non vi pare di sentire in questa sala l’eco di qualcuno che proclamava che i voti
non basta contarli, ma si devono pesare? Non è detto però che il senso della
celebrata affermazione non debba trarsi dalla Regola benedettina. San
Benedetto esortava i capitoli - le comunità - dei suoi monaci a dare il debito
peso, maggiore del numero, al voto della minoranza quando, per la sua
saggezza, lo meritasse.
17nettamente tolto dalle competenze dell’assemblea la
gestione dell’impresa esercitata dalla società. Nel diritto
dello Stato permane il grande sbaglio di non tenere
distinti e separati, nelle rispettive funzioni, Parlamento e
Governo, potere legislativo e potere esecutivo: il Governo
governa a colpi di legge, a sè asservendo il Parlamento,
così che il Parlamento malamente governa ed il Governo
malamente legifera, con una confusione deleteria di ruoli
e di funzioni.
9. Di notevole rilievo, perché di alto insegnamento morale,
sono le prese di posizione di Mignoli su due questioni che
– assai discusse nella dottrina in materia di società per
azioni – si presentano analogamente nella dottrina dello
Stato.
Si tratta della questione se la maggioranza – o gli
amministratori da essa nominati, o comunque di essa
fedeli – abbia il diritto, in nome dell’interesse sociale, di
danneggiare la minoranza; questione che implica l’altra,
se l’interesse sociale sia definibile come interesse comune
di soci o sia qualcosa d’altro, di più ampio respiro e di più
elevato valore.
Ricordo che il principio di maggioranza è fondato sul
presupposto – “di diritto naturale” – che, dovendosi
prendere la decisione migliore, la più efficace per
realizzare l’interesse sociale (definito come l’interesse
comune dei soci), sia la maggioranza a potere/dovere
decidere quale sia l’interesse comune e quale sia il modo
migliore di soddisfarlo. Si conviene che tali decisioni,
prima e primaria quella di individuare l’interesse sociale,
non sono sindacabili nel merito, se prese da votanti che
non versino in situazioni di conflitto di interessi. Ché se,
invece, taluno dei votanti in tale situazione versasse, lo
deve palesare, e deve – se vuole votare – scegliere il
18voto conforme all’interesse sociale (e contrario al proprio
interesse, che, appunto, si trova con quello in conflitto).
La questione del limite al prevalere della maggioranza,
essendo questo limite segnato dal conflitto di interessi, e
quindi implicando la definizione dell’interesse sociale, si
incrocia così con la questione sulla persona giuridica (è
comune recetta opinione che sia la SpA sia lo Stato sono
persone giuridiche), quando taluno reputi che la persona
giuridica – benché non abbia un’anima da salvare, né un
corpo da ferire e da far sanguinare – abbia però un
interesse suo proprio, che non è semplicemente
l’interesse comune dei soci, presente in ciascuno di loro
(in quanto socio), ed uguale per tutti, ancorché in misura
proporzionale al numero di azioni possedute, ma è
qualcosa di più composito e superiore.
Quando vi sia tale convinzione, il connubio fra interesse
sociale e persona giuridica è pericoloso. È un pericolo
ben noto alla dottrina dello Stato, perché è nell’ideologia
dello Stato che da quel connubio è nato il mostro della
«ragion di Stato», che giustifica il delitto di Stato contro i
cittadini dissenzienti.
Tanto diceva bene Stuart Mill quando predicava che un
buon sovrano è la miglior costituzione possibile,
altrettanto vedeva chiaro Tocqueville quando, e
all’estremo opposto, diceva la stessa cosa, ammonendo
che il peggior despota immaginabile è lo Stato
democratico/persona giuridica: l’immaterializzazione del
dispotismo è la jattura estrema e la tirannide senza
rimedio (lo ha provato la Terreur e la Grande Terreur nella
Francia di fine del XVIII secolo), perché, contro la persona
giuridica – o “il popolo” – che con impeto tirannico
persegue il suo disumano superiore interesse, non
valgono nemmeno, a differenza che contro un monarca
19assoluto e dispotico, gli ultimi rimedi dell’appello alla
coscienza del re (alla sua responsabilità verso Dio, o la
storia, o l’umanità), oppure – in opposta alternativa – del
meritorio, valoroso tirannicidio.
Anche senza arrivare a tali estremi, sta per vero che, se
s’ammette che la SpA persona giuridica, o lo Stato
persona giuridica, ha un interesse proprio, e un fine
proprio da affermare, superiore a quello comune dei
consociati, ne discende che gli azionisti, così come i
cittadini, devono cedere il passo e chinare il capo, e
rendersi conto che sono loro a dover essere strumenti e
servitori dello Stato o della società, per il conseguimento
di tali interesse e fine.
Fu per non piegarsi a questo torto alla libertà che Mignoli
si fece convinto e persuasivo assertore della tesi che
l’interesse sociale in altro non può consistere che
nell’interesse comune dei soci (in quanto tali) (e,
beninteso, dei soci attuali).
10. Vorrei infine, negli ultimi minuti di questa nostra
conversazione, guardare al tema dell’analogia fra
dottrina dello Stato e dottrina della società per azioni
sotto una differente prospettiva.
Vi prego di notare che finora l’analogia fra i due istituti
l’abbiamo riscontrata relativamente alla loro rispettiva
organizzazione (cioè guardando al loro interno).
Proviamo ora ad osservarla guardando alle loro relazioni
esterne.
Alludo specificamente, lo dico subito, alla relazione di
Stato e di SpA con il mercato. E vi preavverto che
scopriremo che questa relazione ha avuto di ritorno una
20rilevante incidenza sull’organizzazione interna degli istituti
– sia dello Stato sia della SpA – e sulla loro stessa essenza.
11. Anche questo territorio non è dissodato, ma non è
nemmeno inesplorato.
Ed anche per questa esplorazione conviene incominciare
con un viaggio nella storia: a Parigi nell’anno del Signore
1719. Scrive Janet Gleeson nella sua biografia di John
Law, The Moneymaker, edita a Londra nel maggio 2000
(tr. it.: L’uomo che inventò il denaro, Milano, Rizzoli, 2000):
«Per tutta l’estate del 1719 Parigi sprofondò in una follia
speculativa senza precedenti, che aveva per oggetto le
azioni della Compagnia del Mississippi. A metà agosto le
azioni che tre mesi prima valevano appena 490 lire
venivano arraffate al prezzo di 3.500 lire…». E Daniel
Defoe, in una corrispondenza a Londra da Parigi datata
12 settembre 1719, scriveva: «Non si vedono altro che
nuovi vestiti, nuove figure [?] e un numero infinito di
famiglie che hanno accumulato nuove fortune. A Parigi si
vedono in circolazione 800 nuove carrozze e le famiglie
arricchite comprano nuove stoviglie, mobili nuovi, vestiti
nuovi e un nuovo equipaggio [?], cosicché il commercio
si è sviluppato in maniera prodigiosa».
Era una bolla che sosteneva solo con aria i valori della
“carta”: sia della cartamoneta emessa dalla Banque
Générale, fondata dal Law e sostenuta dal «reggente», il
duca Philippe d’Orléans, sia delle azioni emesse dalla
Compagnia del Mississippi, anch’essa creatura dell’uomo
di affari scozzese.
Nell’autunno del medesimo anno, infatti, l’euforia finì nel
gelo. La “carta” – tanto le azioni emesse dalla
Compagnia del Mississippi quanto, che era peggio, le
banconote emesse dalla Banca – non valevano più
21niente (o molto poco); tutto (o quasi) il popolo dei
milionari (fasulli) di poco tempo innanzi era tornato ad
essere (od era divenuto) povero.
La Banque Générale – invece che trasformarsi nella
Banque de France, cioè nella banca dello Stato, come
avrebbe voluto il Law, e come stava per essere fatto –
chiuse gli sportelli e John Law lasciò Parigi.
Il debito pubblico francese, il debito di sua maestà (o del
suo Governo) – che la Banque Générale, con la sua
trasformazione in Banca di Francia, avrebbe dovuto
assumersi – rimaneva insoluto ed enorme.
La storia insegna, ma troppo pochi sono coloro che
ascoltano le sue lezioni.
12. Ora, per tornare al nostro tema ed al tempo nostro,
domandiamoci: qual è l’analogia che, nelle vicende
viste durante il viaggio a Parigi al tempo di Law, si coglie
fra società per azioni e Stato, per quanto concerne la
loro relazione con il mercato?
Al riguardo nulla il professor Mignoli ha esplicitamente
scritto, se non per cenni; ma implicitamente il tema viene
da lui trattato mediante la selezione e l’indicazione a noi
dei brani degli scritti di altri studiosi, da lui presentati nella
parte del volume II del suo libro intitolata Testimonianze -
Memorie - Letture.
Mi riferisco agli scritti di Marx e di Hilferding
(magistralmente introdotti da Rodolfo Banfi), e di
Rathenau.
13. È nello scritto di Hilferding, tratto dal suo celebre libro del
1910, che si descrive come la società per azioni (a diffusa
base azionaria) comporti istituzionalmente la
22mercificazione sia della proprietà dei mezzi di produzione
impiegati dall’imprenditore sia della stessa
attività/organizzazione d’impresa: con la conseguenza
che il centro dell’interesse caratteristico degli azionisti
come tali (quello che correntemente si chiama
“l’interesse sociale”) si sposta dall’ammontare del
profitto/dividendo, che è il “frutto” dell’azione, alla
quotazione del prezzo di vendita dell’ azione stessa sul
mercato (quotazione che a sua volta è funzione dei
dividendi attesi soltanto nel caso semplice, caso che
sovente è più teorico di scuola che pratico di realtà).
L’azionista, sottolinea Hilferding, assume così «il carattere
di capitalista monetario». La “trasformazione”
dell’impresa individuale (o dell’impresa collettiva di
poche persone) in società per azioni non ha soltanto
l’effetto di ampliare il numero dei contributori alla
formazione del capitale dell’impresa, ma anche l’effetto
di sostituire al capitalista industriale, qual’era
l’imprenditore individuale, una compagnia di capitalisti
monetari, quali sono gli azionisti della SpA7.
La società per azioni si trova a misurarsi e ad essere
misurata su due mercati: non soltanto quello dei prodotti
(che è il mercato di Adamo Smith, quello che misura, e
che fa, «la ricchezza della Nazione»), ma altresì quello
delle proprie azioni; la società per azioni si trova ad essere
in guerra con i competitors su entrambi tali mercati, dove
le regole – della guerra e della pace – sono ben
differenti.
7 È lo stesso Hilferding a notare – ben prima che Berle e Means ne facessero
oggetto di divulgazione nel celebre saggio del 1930 – che «la separazione della
proprietà del capitale dalla sua funzione produttiva [“industriale” NdR] ha
influenza anche sulla direzione aziendale».
2314. È stato Rathenau a scrivere icasticamente che la Società
per azioni ha avuto presso di sé fin dalla sua culla un
dono/giocattolo pericoloso, quello della quotazione in
borsa.
Ed è stato Marx a scrivere, dopo avere affermato che
fattore determinante della crescita storica del
capitalismo fu il sistema del debito pubblico, cioè del
debito dello Stato (che in origine è il debito del re verso i
mercanti ed i banchieri), a scrivere, ripeto, che «il debito
pubblico, ossia l’alienazione dello Stato – sia esso
dispotico, costituzionale o repubblicano – imprime il suo
marchio all’era capitalista».
È questo un punto importante per la nostra indagine sul
parallelo ed il confronto fra dottrina dello Stato e dottrina
della SpA.
Negli Stati moderni, il debito pubblico – scrive ancora
Marx nel brano che Mignoli ci invita a leggere – è «l’unica
parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi
effettivamente nel possesso collettivo dei popoli
moderni… di qui, con piena coerenza, viene la dottrina
moderna che un popolo diventa tanto più ricco quanto
più a fondo si indebita». C’è almeno una correzione da
fare a questa tesi (e la fece Abramo Lincoln, come
testimonia R. Banfi nel commento ai brani di Marx): che
ciò è vero soltanto se, e nella misura in cui, i titoli del
debito pubblico sono nelle mani dei cittadini, perché
allora (ma solo allora) (cito da Lincoln) «ai singoli privati
cittadini è facile comprendere che non potranno essere
troppo gravati da un debito di cui essi stessi sono
creditori».
Ma esiste una cifra comune nei problemi della
quotazione su un mercato della proprietà dell’impresa
24(per il tramite, si intende, delle azioni della SpA
imprenditrice) e della quotazione su un mercato del
debito di uno Stato?
Non so. Certamente – e tutti i giorni lo dicono politici e
gazzettieri, o secondo le convenienze lo tacciono in un
silenzio tetro (più che “assordante”, come invece s’usa
dire) – certamente, lo Stato ha ceduto le armi e la sua
sovranità è un pallido ricordo. Non alludo alla cessione di
sovranità che gli Stati nazionali hanno fatto all’ONU, o, in
Europa, all’UE ed in primis, su questo fronte, alla cessione
della “sovranità monetaria” alla Banca Centrale
Europea.
Non alludo – se parliamo della SpA – alla soggezione a, o
alla liberazione da, rapporti di dipendenza di gruppo.
Parlo della resa, che è una resa senza condizioni, che gli
Stati – gli Stati nazionali e le loro istituzioni sovranazionali di
carattere politico – hanno fatto nei confronti del
mercato: dico del Mercato globale, nonché delle sue
organizzazioni, cioè della WTO o delle sue emanazioni.
In una vicenda analoga a quella della mercificazione
dell’Impresa che avviene con la sua “trasformazione” in
SpA e con la quotazione sul mercato delle sue azioni,
incorre lo Stato relativamente al debito pubblico ed alla
moneta.
Lo Stato nazionale annoverava gelosamente, fra le sue
prerogative sovrane (che d’altronde i mercanti stessi gli
chiedevano di mantenere), l’emissione e il governo della
moneta. Al tempo nostro lo Stato (e l’Unione degli Stati
europei o nordamericani) subisce la mercificazione che,
sul mercato globale, avviene della sua moneta (per il
tramite della quotazione sul mercato finanziario del suo
25debito pubblico). Il governo della moneta sfugge così al
suo controllo. Lo Stato sovrano cede le armi al mercato.
A differenza che Luigi XIV, infatti, lo Stato non gode più né
dell’autorità né della potenza sufficienti per fare come
poté fare il «re Sole»: di dire ai banchieri suoi finanziatori di
ritenere estinto il suo debito verso di loro restituendogli
bensì lo stesso numero di monete d’oro che aveva avuto
in prestito, coniate con la medesima effigie ed il
medesimo nome di Luigi, ma con un titolo d’oro di non
poco inferiore. Ciò, beninteso, sotto pena di lesa Maestà
per chi l’avesse contraddetto, dubitando della sua
parola che quelli erano “Luigi d’oro”.
Al tempo d’oggi, il giudice di ultima istanza non è il re,
non è la Corte di Cassazione, non è la Corte di giustizia
europea, non sono le Corti Costituzionali degli Stati; è il
Mercato. L’indebitamento degli Stati può essere virtuoso
e “democratico”, come dicono Marx e Lincoln, ma
soltanto se è verso i loro cittadini; se il debito è verso il
Mercato ed i signori del Mercato, lo Stato ha perso la sua
sovranità sulla moneta. È logico allora osservare e dover
temere che l’unione monetaria europea sia in realtà
soltanto una fusione/concentrazione di imprese
finanziarie.
§§§
Questo è quanto, signori, quanto, dall’insegnamento di
Mignoli sull’argomento in discorso, ho tratto di utile per
gettare sulle cose e sugli uomini del nostro tempo uno
sguardo intelligente, intus legentem. Ed è pure quanto
basta per essere sereni nella consapevolezza dei nostri
compiti, anche se inquieti sul buon esito che il loro
adempimento possa avere sulla sorte della società dei
nostri contemporanei. Ed è pure quanto basta per porre
fine alla nostra conversazione, che rimane incompiuta, e
26perciò ha il pregio di essere foriera di nuovi incontri, che
mi auguro di poter avere con Voi, che intanto ringrazio
vivamente per l’attenzione che mi avete regalato.
27SAFFO E LE ALTRE
Eva Cantarella
La prima cosa che devo fare, dopo avere ringraziato di
questo invito a ricordare Ariberto Mignoli, è spiegare perché
per ricordare un grande giurista qual era Mignoli ho pensato
di parlare di Saffo (e le altre: vedremo perché e chi sono).
Le ragioni sono due: la prima è che come tutti sanno e
come è stato giustamente ricordato Mignoli non era solo un
grande giurista. Era uomo di inesauribile curiosità e di
vastissima, straordinaria cultura. E all’interno di questa
cultura, come dimostrano molti volumi della sua biblioteca,
la cultura greca occupava un posto particolare. Mignoli
infatti amava profondamente la Grecia e l’inestimabile
patrimonio che questa ci ha lasciato. Tutto, indistintamente,
ma con una speciale preferenza: quella per la poesia di
Saffo.
La seconda ragione è legata invece a un ricordo personale,
a me molto caro: quello di una vacanza fatta con lui, con
sua moglie Maatje e con alcuni comuni, carissimi amici
(Piergaetano Marchetti, sua moglie Ada e i loro figli).
Destinazione della vacanza, scelta da Mignoli: l’isola di
Lesbo. Più specificamente la citta di Mitilene, dove Saffo era
nata, e dove, in quei giorni, il suo nome, evocato da Mignoli,
tornava era spesso al centro nei nostri discorsi. L’ occasione
era, quasi sempre, il ricordo di un verso: «tramontata è la
Luna e le Pleiadi. E io giaccio sola…», ad esempio, era uno
dei più amati, che Mignoli, superfluo a dirsi, ricordava e
citava in greco. E così accadeva che la sera ci si
addentasse nella discussione di problemi storiografici
provocati dalla perplessità di Mignoli di fronte alla risposta
che, abitualmente, veniva data alla domanda che egli
continuava a porsi e a proporci: per quale ragione, per quali
28ragioni le donne greche, dopo Saffo, hanno lasciato così
poche tracce di sé, per (non dire che non ne hanno quasi
lasciate)?.
La risposta abituale che gli antichisti davano (e danno) alla
domanda era che Saffo era vissuta in un momento nel quale
non si erano ancora consolidate le strutture della polis, che
avrebbero di lì a poco rinchiuso le donne nel ruolo esclusivo
di riproduttrici del corpo cittadino, negando loro pressoché
ogni diritto nel campo del diritto civile ed escludendole da
gran parte delle attività sociali (i famosi simposi, ad
esempio), e privandole della possibilità di ricevere
un’educazione.
A Mignoli questa ipotesi sembrava troppo drastica. Non che
egli credesse in una Grecia senza difetti. Mignoli non
credeva nel “miracolo greco”, come veniva definito, fino a
pochi decenni or sono, il fiorire delle arti, della scienza, della
filosofia, del teatro nell’Atene di Pericle. Secondo i sostenitori
del “miracolo”, quel che era accaduto in Grecia nulla
aveva a che vedere con il resto del mondo a est del
Mediterraneo, e nulla gli doveva. Era alla Grecia, e solo a lei,
che l’Occidente doveva l’eredità sulla quale era costruita la
sua cultura.
Per molto tempo indiscussa, quest’idea si era tradotta nella
convinzione, profondamente radicata e diffusa, di una
superiorità dell’Occidente sull’Oriente, a dare un’idea della
quale basterà citare una celebre affermazione di Shelley:
«Siamo tutti greci», scriveva orgogliosamente il poeta nella
prefazione a Hellas (1821). E proseguiva: «Le nostre leggi, la
nostra letteratura, la nostra religione, le nostre arti hanno le
loro radici in Grecia. Se non fosse stato per la Grecia
saremmo ancora selvaggi o idolatri. Peggio ancora,
potremmo essere rimasti a uno stato così miserabile e
29estraneo alle istituzioni sociali come possono esserlo la Cina o il Giappone». Mignoli sapeva perfettamente (di nuovo, la sua biblioteca lo dimostra) che già nel secondo millennio i greci intrattenevano con l’Est contatti che andavano al di là degli scambi commerciali. Nel 1947, un grande saggio di un allora giovane studioso, Santo Mazzarino, aveva cercato e individuato i modi della trasmissione culturale, individuando i luoghi d’incontro delle diverse culture (gli ittiti, i lici, i frigi, i cari) e le vie attraverso le quali si erano diffusi incontrandosi tra loro e con quella greca) i costumi, le tradizioni, le correnti artistiche, le idee religiose, le teorie scientifiche, le conoscenze tecniche... Il titolo del libro era Tra Oriente e Occidente. La cultura greca, insomma, non era un “miracolo” che nulla doveva ad altre culture. Mignoli, molto interessato a questo discorso, condivideva le nuove ipotesi storiografiche. Ma insisteva sul fatto, se la cultura greca non era autoctona, questo non significava necessariamente fosse arretrata come si era arrivati a descriverla con riferimento alla questione femminile. E a provarlo ricordava, giustamente, che le fonti greche conservavano traccia di altre poetesse, che avevano vissuto e agito, artisticamente, anche nei secoli della polis. Le storie che più spesso ricordava erano quella di Mirtide che sarebbe stata che la maestra di Pindaro quella di un’altra allieva di Mirtide, Corinna di Tanagra, che avrebbe addirittura riportato ben cinque vittorie su Pindaro. Ma sulle vittorie di Corinna su Pindaro gravano non pochi dubbi: anche se questa fu certamente poetessa di fama e di varia ispirazione, come mostrano i titoli di lei rimasti e alcuni versi conservati da alcuni papiri di Ossirinco, è proprio 30
da un su frammento che possiamo dedurre che ella non
sconfisse mai Pindaro (la sua maestra) in cui scrive:
E io biasimo anche l’armoniosa Mirtide
perché, essendo donna,
venne con Pindaro a gara.
Apriamo un breve parentesi: anche se non è facile orientarsi
all’interno di notizie così incerte e frammentarie, è difficile e
non venire colpiti il biasimo per una donna che aveva osato
gareggiare con un uomo, espresso da una donna come
Corinna. Una conferma non da poco, si direbbe della
condizione di subalternità delle donne greche e di come
persino le più colte tra di esse avessero interiorizzato la
subalternità del loro ruolo. Ma Mignoli, pur non negandolo,
insisteva sulla sua tesi, ricordando altre donne che la
confermavano. E su questo aveva certamente ragione:
queste donne esistevano.
Sempre nel V secolo, ad Argo era vissuta Telesilla, poetessa e
guerriera protagonista di un singolare episodio, che
l’avrebbe vista organizzare le donne della città per
combattere contro Cleomene, re di Sparta. Celebrata dai
suoi concittadini, che le eressero una statua, nella quale era
raffigurata mentre, gettati i libri, calzava l’elmo per
combattere, Telesilla compose opere prevalentemente
legate al culto, di cui sono rimasti nove frammenti (forse
parte di Inni ad Apollo e Artemide) ed è celebre, in
particolare, per aver usato un verso (il gliconico acefalo)
chiamato dagli alessandrini telesilleo.
A Sicione, vicino a Corinto, nella stessa epoca di Telesilla
visse Prassilla, personaggio di rilievo nella sua città, ove, nel IV
secolo, venne eretta in suo onore una statua di bronzo e
autrice fra l’altro di un ditirambo Achille e di una
31composizione su Adone, di cui sono rimasti tre esametri, nei
quali Adone, interrogato nell’Ade su che cosa ci sia di più
bello al mondo, risponde nominando, oltre al sole e alla
luna, alcuni frutti. Nel IV secolo, forse a Teno, visse Erinna, di
cui restano circa sessanta versi del poemetto La conocchia,
composto in occasione della morte di un’amica, e tre
epigrammi nell’Antologia Palatina, uno dei quali scritto per
Bauci:
O stele e sirene mie e urna luttuosa,
e tu Ade che tieni la poca cenere,
a chi passa presso la mia tomba dite «salve»,
sia egli cittadino ovvero forestiero;
e che sposata appena mi ebbe la tomba, e ancor questo:
che Bauci mi chiamò il padre, che la mia stirpe
è di Telos, affinché sappiano; e che a me la compagna
Erinna su la tomba quest’epigramma incise.
In epoca ellenistica, infine, ecco Anite di Tegea in Arcadia
(cui i concittadini eressero una statua), chiamata, da
Antipatro di Tessalonica, «Omero femmina», famosa per i
suoi epigrammi paragonati da Meleagro a gigli purpurei, e in
effetti autrice di versi delicatissimi, come quelli scritti per la
piccola Mirò:
Al grillo, usignolo dei campi, e alla cicala amante degli
alberi
comune tomba eresse la piccola Mirò,
infantili lacrime versando: poi che inesorabile
Ade le portò via i suoi giochi.
32Infine ecco Nosside, vissuta alla fine del IV secolo a Locri
Epizefiri, la città in cui le famiglie nobili, appartenenti alle
Cento case, sembra si tramandassero il nome in linea
femminile, come alcuni desumono dal fatto che Nosside
ricordi il nome della madre, Teofili, e non quello del padre.
Di Nosside (che orgogliosamente si paragona a Saffo,
rimangono dodici epigrammi, alcuni dei quali, dedicati ad
argomenti letterari, non particolarmente felici. Ma Nosside,
come dice Meleagro, che definisce le sue poesie «odoranti
floridi giaggioli», cantava soprattutto l’amore, e un
epigramma d’amore pervenuto, infatti, rivela una genuina e
appassionata vena poetica, tutt’altro che letteraria:
Nulla è più dolce che amore: tutte le altre dolcezze
vengono dopo: dalla bocca io sputo anche il miele.
Questo dice Nosside: ma colei, cui non baciò Cipride,
ignora quali mai rose sono i suoi fiori.
Alla fine di tutte questi discorsi, Mignoli era soddisfatto. La
sua tesi non era infondata: vi erano state donne (non molte,
ma tutte significative) che erano riuscite a farsi spazio, a
conquistare un posto di rilievo e ad assicurare così il loro
nome alla storia, pur nel quadro di una società che tendeva
a non dare ascolto alla loro voce. Che conclusione trarre da
quel grande ripasso di cultura liceale (dei licei di altri tempi,
peraltro)?
Su un unico punto non si poteva discutere: nessuna delle
donne della cui attività culturale e letteraria è rimasta
traccia proveniva dall’Attica. L’unica intellettuale (non
poetessa, ma donna di eccezionale cultura) il cui nome è
legato alla storia di Atene è Aspasia; ma Aspasia non era
ateniese, proveniva dalla Ionia. Tutte le altre erano nate e
33avevano agito in zone diverse, nelle quali le condizioni di vita delle donne erano diverse da quelle delle ateniesi. La conclusione fu salomonica: gli ateniesi erano misogini. Gli altri greci lo erano meno. O forse, diceva Mignoli – su questo punto quasi irriducibile – non lo erano affatto. 34
SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI
DALLE LEZIONI DEL PROFESSORE
ARIBERTO MIGNOLI SULLA
DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER
AZIONI
Lucrezia Geraci
Sono profondamente onorata di rendere oggi omaggio ad
Ariberto Mignoli e ringrazio coloro che mi hanno invitata e, in
modo particolare, Sabina Mignoli.
Quando mi venne chiesto di prendere parte a questa
celebrazione, dopo una iniziale titubanza, accettai con
entusiasmo. La presenza di un consesso così prestigioso mi
hanno peraltro suggerito – dopo aver individuato l’oggetto
dell’intervento – un taglio non tanto tecnico quanto
autobiografico.
Vorrei infatti tratteggiare, con alcune pennellate, il
contenuto delle lezioni che il professore Ariberto Mignoli
teneva al corso di «diritto commerciale progredito» presso
l’Università Bocconi quando la frequentavo come studente.
Lezioni che, ancora prima dei suoi scritti, sono riuscite a
suscitare in me, come certamente in moltissimi altri studenti
iscritti, come me, a una Università dove all’epoca si studiava
solo economia, curiosità dapprima, successivamente
passione per il diritto delle società.
Molti dei presenti hanno avuto la fortuna di frequentare
Ariberto Mignoli come amici, ovvero colleghi, ovvero ancora
come clienti. Personalmente ho avuto il privilegio di seguire
le sue lezioni, ed è di esse che voglio raccontarvi, dopo
averne riletto gli appunti a distanza di oltre trent’anni.
35Di quelle lezioni mi sono rimasti impressi: il trasporto con cui Ariberto Mignoli commentava gli istituti del diritto; il sottile pensiero che lo portava ad una analisi prima ancora che giuridica, logica della norma, imbevuta dell’ineliminabile dato storico; l’importanza data alla singola parola, che per lui andava sempre «rispettata»8 perché «essa ha un lungo passato”9 e “nel tempo si è arricchita»10; la capacità di guardare oltre la specifica disposizione per coglierne le potenzialità evolutive nel tempo. Insegnava che non sempre occorrono nuove leggi perché a volte basta reinterpretare con slancio istituti apparentemente sopiti, e trovare soluzioni nuove a situazioni in evoluzione. Del resto in quegli anni scriveva: Bisogna lasciar parlare le cose stesse; lo spettatore deve essere portato sulla scena; gli si deve far conoscere il meccanismo dall’interno; fargli vedere come gli istituti si muovono, cambiano, assumono funzioni diverse da quelle che originariamente sembravano loro connaturali ed esclusive. È pieno di fascino scoprire erbe di cui si ignorava la virtù; seguire quello che la fantasia può produrre; vedere come essa si muova liberamente, non sia mai ripetitiva, come talora, con felice incoscienza, sfiori gli abissi11. E le sue lezioni erano ispirate e permeate da questo convincimento. In aula si presentava senza appunti, senza slide, senza documentazione di supporto. Solo il codice civile. Iniziava la lezione esaminando gli studenti; ne faceva l’appello riconoscendone, dopo le prime lezioni, i volti prima ancora del loro dichiararsi presenti – in effetti 8 A. Mignoli, La cultura del diritto civile, «Riv. Soc.», 1990, 512. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 A. Mignoli, Il giurista e il fatto, «Riv. Soc.», 1979, 1.016. 36
aveva un’ottima memoria – ne scrutava le espressioni,
sollecitandone poi, durante la lezione, le reazioni, quasi a
voler far comprendere che l’esame cominciava in aula.
Poi apriva il codice e introduceva un argomento. Sia che
commentasse un tema generale, o una specifica
disposizione, immediatamente il discorso si allargava e
l’orizzonte espositivo veniva dilatato, come si moltiplicano
le immagini quando riflesse in specchi posti frontalmente.
Non si limitava mai a fornire il puntuale commento di
singole norme: quello, semmai, arrivava dopo.
Cercava, anzitutto, i problemi che l’applicazione di un
istituto o di una disposizione poneva e si soffermava poi,
con ancora maggiore incisività, sulle situazioni, non
espressamente disciplinate, che richiedevano un
intervento interpretativo, a volte anche creativo, e –
quando non ancorato a pronunzie giurisprudenziali, come
spesso capitava, e continua a capitare, per il diritto delle
società – coraggioso. Il messaggio era chiaro: nel diritto
degli affari è la norma che deve adattarsi ai fatti, e non i
fatti alla norma.
Per il suo corso non indicava un libro di testo. Semmai
consigliava letture di approfondimento, anche di autori
stranieri, su singoli temi societari, ma solo quelle che
affrontavano questioni, – non inutili problemi da
azzeccagarbugli – suggerendone soluzioni anche
innovative. Non gli piacevano i commentatori astratti e
“sterili” o che non prendevano posizioni nette su una
determinata tematica e quindi erano privi di “virilità”; era
antidogmatico per eccellenza. L’esame verteva così sui
contenuti delle sue lezioni, e chi non frequentava il corso
non poteva certo trovare nei testi scritti il sapere che egli,
attingendo da una cultura sterminata e, al tempo stesso,
37dalla vita degli affari, sceglieva – da demiurgo quale era – di trasmettere in aula. Non sta a me ricordare la sua approfondita conoscenza, anche storica, dei diversi istituti – a partire dalla disciplina della East India Company inglese e, lui conoscitore della lingua olandese, della Compagnia olandese delle Indie orientali –; conoscenza che non gli derivava solo dagli studi giuridici, ma anche e soprattutto dalla sistematica lettura degli atti mercantili, poiché riteneva fondamentale documentarsi sulla concreta applicazione di un istituto. Non a caso il titolo di uno dei suoi articoli pubblicato durante i miei anni universitari è Il giurista e il fatto12. Ricordo che uno dei primi testi che mi fece leggere fu un “Prospetto” per il collocamento di obbligazioni della fine dell’800. In quel documento di una pagina erano già racchiuse – e me lo fece notare – tutte le informazioni necessarie ai sottoscrittori. Nulla a che vedere con gli attuali prospetti informativi, inutilmente lunghi, che le disposizioni comunitarie, oggi direttamente applicabili, non hanno contribuito a migliorare, e sui cui criteri di redazione proprio lo scorso lunedì la Consob ha annunciato un generale ripensamento anche a livello europeo. Faceva chiaramente comprendere che il contatto con la realtà era fondamentale. E così, quando manifestai il mio interesse al diritto delle società mi disse: «deve assistere a un’assemblea per rendersi conto di cosa è davvero una società per azioni. Ma le devo trovare l’assemblea giusta». Qualche tempo dopo mi comunicò che l’aveva trovata e mi fece partecipare all’assemblea della Montedison dopo la 12 Cfr. nota 4 38
Puoi anche leggere