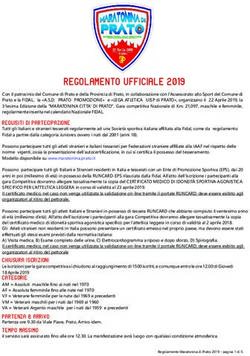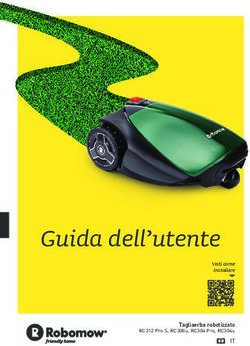Rilevamento dei prati di Cymodocea nodosa mediante Side Scan Sonar, ROV ed immersioni subacquee. Area costiera-marina tra Chiavari e Sestri Levante.
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rilevamento dei prati di Cymodocea nodosa mediante Side Scan Sonar, ROV
ed immersioni subacquee. Area costiera-marina tra Chiavari e Sestri Levante.
Mattia Barsanti1, Andrea Peirano2, Sergio Sgorbini2, Silvia Cocito2,
Carlo Nike Bianchi3, Carla Morri3
1
Università di Parma, D.S.T., Viale delle Scienze 78, 43100 Parma.
2
ENEA S. Teresa, Centro Ricerche Ambiente Marino, C.P. 224, La Spezia.
3
Università degli Studi di Genova, Dip.Te.Ris. Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse,
Corso Europa 26, I-16132 Genova
Riassunto
Nell’ambito degli studi ambientali condotti nel Golfo del Tigullio è stato effettuato un
rilevamento Side Scan Sonar (SSS) accompagnato da una serie di verità mare in immersione
subacquea e da osservazioni tramite Remotely Operated Vehicle (ROV), sulla piattaforma
costiera compresa fra Chiavari e Sestri Levante.
Lo scopo del lavoro è stato quello di realizzare la mappatura SSS dei prati di Cymodocea nodosa
con tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini digitali e di verificare inoltre la
possibilità di attribuire a determinate intensità del segnale SSS una misura della variabilità di
copertura dei prati della fanerogama marina.
I risultati dei rilevamenti mediante SSS e le relative verità mare ottenute mediante osservazioni
subacquee con il ROV hanno permesso la realizzazione di una mappatura GIS del prato di
Cymodocea nodosa. La comparazione tra le caratteristiche fenologiche del prato hanno
evidenziato una relazione con l’intensità del segnale SSS solo nei casi in cui la densità fogliare
superava i 120 fasci/mq.
Introduzione
E’ stata effettuata una campagna di rilevamenti SSS e indagini ROV sulla piattaforma costiera
del Golfo del Tigullio. Questo rilevamento completa le indagini precedenti di Delbono et al.
(2003, in questo volume) condotte per studiare le caratteristiche fenologiche della Cymodocea
nodosa e i relativi sedimenti di fondo, sui tre transetti di Chiavari, Lavagna e Sestri. Per le
informazioni sui lineamenti bionomici generali dell’area si rimanda ai lavori di Morri et al.
(1986) e di Bianchi e Peirano (1995), che forniscono inoltre mappature del prato di Cymodocea
nodosa antecedenti.
In questo contributo sono stati cartografati mediante tecnica GIS i limiti distributivi della C.
nodosa. Si è sperimentato inoltre una metodologia che permette, tramite SSS, di identificare aree
vegetate da fanerogame con diverse caratteristiche fenologiche che corrispondono, per quanto
visto nelle indagini precedenti, a aree con aspetti ambientali diversi, nel nostro caso condizioni
idrodinamiche differenti.
Materiali e metodi
Rilevamento Side Scan Sonar, indagini mediante ROV e immersioni subacquee
Il sistema utilizzato è un SSS doppia frequenza della GEOACUSTICS LTD; il sistema consiste
di un sensore trainato (pesce) sul quale sono installati i trasduttori acustici e collegato
all’imbarcazione con un cavo che rappresenta anche il canale di trasmissione dati all’elettronica
di superficie; le frequenze degli impulsi emessi dai trasduttori sono di 100 e 500 khz.
141Durante i rilievi è stata utilizzata la frequenza più elevata (500 khz) che consente una migliore
risoluzione delle immagini acquisite (Newton et al., 1975; Stefanon, 1985).
Il sistema utilizzato per il posizionamento dei rilievi è un NOVATEL-GPS RTK20 che offre un
accuratezza maggiore di 20 cm nel posizionamento dinamico dell’unità mobile, montata
sull’imbarcazione, relativamente all’unità fissa montata a terra.
I rilievi SSS sono state preventivamente posizionati su delle rotte parallele alla costa;
l'ottimizzazione dei tracciati ha tenuto conto dell'esigenza di sovrapporre parzialmente i tracciati
al fine di eseguire una copertura totale dei prati di Cymodocea nodosa e di sfruttare al massimo
la copertura (scansione) laterale del SSS.
A tal fine il pesce è stato trainato ad una profondità equivalente a circa il 10% della misura del
fondo, quindi i percorsi al largo sono stati eseguiti paralleli con una distanza di 130 m fra loro in
modo che, per un’altezza del pesce prefissa di circa 8 m, i dati SSS risultassero di qualità
ottimale per bersagli distanti fino a circa 80 m per lato.
Per i percorsi vicino costa la diminuzione del fondale ha imposto una distanza fra i percorsi di
circa 60 m.
Le rotte così ottenute sono state sovrapposte ad una carta di navigazione della zona dei rilievi in
scala 1:15.000 con doppio reticolato per i sistemi di proiezione UTM-ED50 e WGS84. I tracciati
SSS ottenuti tramite acquisizione digitale sono stati quindi rielaborati per mezzo del software
dedicato che permette di eseguire un mosaico dei tracciati e una carta finale georeferenziata;
sono state preparate carte di mosaico in scala 1:5000 coprenti complessivamente l’intera zona dei
rilievi (Tavole 1 a, b e c).
Sulla base dell'analisi dei sonogrammi sono state effettuate verifiche (verità mare) utilizzando
due tecniche. Nel caso di verifiche su vasti tratti di fondale è stato utilizzato un veicolo
filoguidato o ROV: l’ACHILLE M4. Nella tabella 1 sono riportate le coordinate dei punti di
immersione del ROV. In ogni zona indagata i percorsi con il ROV sono stati effettuati,
procedendo su transetti perpendicolari alla linea di costa (Fig. 1).
Fig. 1. Punti di immersione del ROV.
142Tab. 1. Coordinate geografiche WGS84 dei punti
di immersione del ROV.
Sigla Lat. N Long. E
1 44°19,3373' 9°17,6190'
2 44°19,3164' 9°17,6826'
3 44°19,2878' 9°17,7811'
4 44°18,8011' 9°17,9429'
5 44°18,7312' 9°17,9378'
6 44°18,4892' 9°18,2319'
7 44°18,3309' 9°19,4052'
8 44°18,2113' 9°19,8600'
9 44°18,0426' 9°20,0888'
10 44°18,1231' 9°20,9266'
11 44°17,7678' 9°21,6341'
12 44°16,9050' 9°22,8410'
Nel caso invece di verifiche puntiformi dei tracciati SSS è stata utilizzata l’immersione
subacquea. In 23 stazioni (Fig. 2) i ricercatori subacquei hanno compiuto osservazioni sulla
tipologia del fondale, con particolare riferimento alla presenza ed aspetto dei prati di Cymodocea
nodosa e sono state effettuate stime visive di copertura del substrato da parte di questa
fanerogama.
Fig. 2. Punti di immersione subacquee delle verità mare.
Risultati e discussione
1 – ROV
Le verifiche tramite ROV sono riportate limitatamente a tre stazioni a diversa tipologia
selezionate sulla base dei sonogrammi: (Fig. 3) Punta Chiappe, (Fig. 4) Foce Entella, (Fig. 5)
Sestri Levante.
143Le foto 1, 2 e 3 illustrano i risultati delle indagini ROV in corrispondenza delle tre zone
selezionate.
Fig. 3. Punta Chiappe. Immagine del sonogramma nella zona dei punti di immersione del ROV 1, 2 e 3. Sono
visibili i “ripples” e in basso a destra alcuni prati di Cymodocea nodosa – vedi Tavola 1 a (Zona A).
Foto 1. Punta Chiappe. Fondale a ripples profondi e ordinati, con granulometria più grossolana sulle creste.
144Fig. 4. Foce Entella. Immagine del sonogramma nella zona dei punti di immersione
del ROV 8 e 9 – vedi Tavola. 1 b (Zona B).
Foto 2. Foce Entella. Prati di Cymodocea nodosa densa e a foglie lunghe.
145Fig. 5. Sestri Levante. Immagine del sonogramma in prossimità del punto 12 di immersione
del ROV – vedi Tavola 1 c (Zona C).
Foto 3. Sestri Levante. Fondale disturbato con filare di Cymodocea
nodosa a bassa densità e foglie di media lunghezza.
Il confronto tra le immagini ottenute con il ROV ed i sonogrammi del SSS evidenzia la buona
corrispondenza tra la presenza areale del prato ed il contrasto cromatico nelle immagini ottenute
tramite SSS. Le strutture sedimentarie del fondale, quali i ripples, sono ben evidenziate con
entrambe le tecnologie utilizzate.
Di difficile caratterizzazione risultano invece la tessitura dei sedimenti nell’ambito delle classi
dimensionali della sabbia individuate da Delbono et al. (2003, in questo volume).
1462 - Osservazione dei prati di Cymodocea
Le osservazioni subacquee per le operazioni di verità mare, hanno dimostrato che i prati
campionati sono caratterizzati da una notevole variabilità. In particolare, il grado di copertura del
fondale, con andamenti alquanto irregolari, si mantiene su valori elevati (fino ad un massimo del
60%) nelle stazioni prossime a Chiavari, mentre appare assai minore avvicinandosi a Sestri, dove
si mantiene su valori inferiori al 5 % (Tab. 2, Fig. 6).
Tab. 2. Risultati delle verità mare in immersione subacquea. Coordinate geografiche WGS84.
Prof Copertura
Staz. Lat. N Long. E Tipologia
(m) %
a 44°18,998’ 9°18,292’ 11 60 Prato denso ed uniforme, con qualche radura sabbiosa.
b 44°18,883’ 9°18,353’ 12 30 Prato in ampie chiazze folte alternate a radure sabbiose.
c 44°18,637’ 9°18,470’ 15 10 Piccole chiazze.
d 44°17,891’ 9°20,600’ 16 25 Chiazze sparse più o meno dense.
e 44°18,768’ 9°18,517’ 12 40 Prato di ampie chiazze dense alternate a radure sabbiose.
f 44°18,475’ 9°18,956’ 14 10 Chiazze e filari.
g 44°18,406’ 9°19,431’ 11 15 Ciuffi isolati e piccole chiazze.
h 44°18,320’ 9°19,662’ 11 20 Chiazze folte alternate a radure sabbiose.
i 44°18,103’ 9°20,212’ 13 25 Prato moderatamente denso e continuo.
j 44°18,176’ 9°20,227’ 11 10 Chiazze e filari.
k 44°17,756’ 9°21,220’ 11 4 Filari isolati.
l 44°17,501’ 9°21,234’ 19 0 Sabbia non vegetata.
m 44°17,548’ 9°21,344’ 18 0 Sabbia non vegetata.
n 44°17,600’ 9°21,467’ 12 10 Brevi filari.
o 44°17,666’ 9°21,470’ 11 1 Piccoli filari isolati.
p 44°17,303’ 9°21,514’ 22 0 Sabbia non vegetata.
q 44°17,293’ 9°22,096’ 11 15 Chiazze e filari.
r 44°17,198’ 9°22,197’ 12 25 Prato discontinuo, in chiazze.
s 44°17,018’ 9°22,474’ 11 20 Prato continuo.
t 44°16,525’ 9°22,754’ 14 0 Sabbia non vegetata.
u 44°16,836’ 9°22,798’ 11 1 Radi e piccoli filari.
v 44°16,658’ 9°23,079’ 10 2 Brevi filari e piccole chiazze.
w 44°16,499’ 9°23,304’ 8 3 Filari radi e piccole chiazze.
Fig. 6. Valori della copertura del prato di Cymodocea nodosa
147Allo scopo di verificare se le zone caratterizzate da prati di C. nodosa con diversa copertura,
densità e parametri fenologici, sono identificabili da segnali di differente intensità del
rilevamento SSS, sono stati associati ai risultati ottenuti dal lavoro di Delbono et al. (2003, in
questo volume), le immagini SSS corrispondenti ai punti di prelevamento del transetti Chiavari,
Lavagna e Sestri Levante (Fig. 7, 8, e 9).
Fig. 7. Punti di immersione in prossimità di Chiavari. Fig. 8. Punti di immersione in prossimità
di Lavagna
Densità fasci/ mq
206
129 119 121
118
90
71
48
p
t
up
of
t
of
up
f
in
n
ro
su
i-i
pr
pr
s
v-
i-s
i-p
a-
v-
r
a-
v-
La
st
r
r
La
hi
st
hi
La
st
Se
C
Se
C
Se
Fig. 9. Punti di immersione in prossimità Fig. 10. Diagramma densità fasci /mq. Modificato da
di Sestri Levante. Delbono et al. (2003, in questo volume)
Dall’esame delle immagini del SSS si può affermare che esiste, in linea generale, una certa
relazione, benché non perfettamente quantificabile allo stato attuale, tra le caratteristiche
fenologiche del prato di Cymodocea nodosa e l’intensità del segnale SSS, in particolare le
densità > 120 fasci/mq sono chiaramente rilevate sui sonogrammi. Per valori inferiori come nella
zona di Lavagna, zona caratterizzata da un elevato idrodinamismo e dalla presenza di fenomeni
erosivi, i segnali SSS più deboli appaiono più difficilmente differenziabili dalla tessitura del
sedimento (Fig.10).
3 - Cartografia del prato di Cymodocea
Le immagini raster dei sonogrammi del SSS sono state trasformate in vettoriale per esaltare i
limiti superiore ed inferiore del prato di Cymodocea nodosa. Tali immagini hanno un formato
grafico TIFF (Tagged Image File Format), una profondità di colore pari a 8 bit, equivalente a
256 colori, una risoluzione di 42 cm e sono state georeferenziate sia al sistema UTM-ED50 sia a
quello Gauss-Boaga. Esistono diverse tecniche software di elaborazione delle immagini che
148permettono il passaggio da raster a vector in modo semi-automatico, ma queste tecniche non
hanno dato risultati soddisfacenti. La causa principale è attribuibile all’intervallo di valori dei
pixel, la cosiddetta “radianza”, che individua le zone del prato di Cymodocea nodosa
nell’immagine; tale intervallo non è univoco, ma si presenta anche in molte altre zone
dell’immagine dove il prato della fanerogama non è presente.
Si è proceduto quindi alla vettorializzazione attraverso la digitalizzazione manuale del prato di
Cymodocea nodosa. La digitalizzazione manuale è stata effettuata a due diversi gradi di
dettaglio: un dettaglio maggiore con scala 1:5.000, ed uno minore a scala 1:25.000, sono state
così create due carte del prato di Cymodocea nodosa (Tab. 3).
Tab. 3. Cartografia GIS del prato di Cymodocea nodosa a diversa scala nominale.
Cartografia GIS Scala Nominale Dettaglio
Tavola II - Prato di Cymodocea nodosa 1:5.000 Elevato
Tavola III - Prato di Cymodocea nodosa 1:25.000 Basso
La necessità di una rappresentazione del prato di Cymodocea nodosa con un dettaglio inferiore è
dovuta alla notevole variazione spaziale di questa fanerogama marina nel tempo, come
ampiamente riportato in letteratura. La Tavola II individua l’area “dinamica” della prato con una
migliore determinazione del suo limite inferiore e superiore.
Nella cartografia numerica, con la possibilità di variare la scala nella rappresentazione, il
concetto tradizionale di scala perde di significato. Il fattore di scala rimane come Scala
Nominale, intendendo con esso il grado di precisione degli strumenti e della metodologia
utilizzati nell’acquisizione del dato (Demers, 1997).
Fig. 11. Esempio di mappa tematica utilizzando la percentuale di copertura del prato di C. nodosa.
La caratteristica fondamentale dei sistemi GIS è la possibilità di agganciare delle informazioni
alfanumeriche, gli attributi, all’oggetto cartografico.
Un possibile esempio di quest’aspetto è la possibilità di integrare alla mappa del prato alcuni
parametri fenologici della Cymodocea nodosa creando così dei tematismi del prato della
fanerogama marina in grado di indicare differenti condizioni ambientali. Nella figura 11 è
riportata la mappa tematica della copertura di Cymodocea nodosa.
149Bibliografia
Bianchi C.N., Peirano A., 1995 - Atlante delle fanerogame marine della Liguria. Posidonia
oceanica e Cymodocea nodosa. ENEA, Centro Ricerche Ambiente Marino, La Spezia, pp.1-
146.
Del I., Bianchi C..N., Morri C., Peirano A., 2003 - Influenza della tessitura dei sedimenti e dei
fenomeni erosivi nella distribuzione del prato di Cymodocea nodosa nel tratto di litorale
compreso fra Chiavari e Lavagna. ENEA “Il Golfo del Tigullio – Liguria orientale.
Avanzamento degli Studi per la creazione di Strumenti della Gestione Costiera”.
Demers, M.N., 1997 - Fundamentals of Geographic Information Systems. J.Wiley&Sons.
Morri C., Bianchi C.N., Damiani V., Peirano A., Romeo G., Tunesi L., 1986 - L'ambiente
marino tra Punta della Chiappa e Sestri Levante (Mar Ligure): profilo ecotipologico e
proposta di carta bionomica. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova, 52 suppl: 213-231.
Newton R., Stefanon A., 1975b - Application of Side Scan Sonar in Marine Biology. Mar. Biol.,
31:287-291.
Stefanon A., 1985 - Marine sedimentology through modern acoustical methods: I. Side Scan
Sonar”.
150Puoi anche leggere