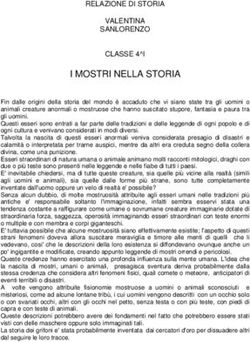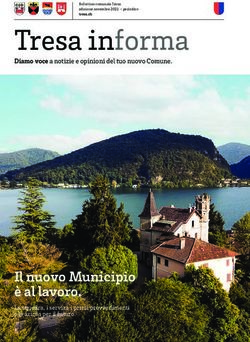Progetto di Plastica ornamentale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica Progetto di Plastica ornamentale Professor Danilo Ciaramaglia Giacomo Pinton 9425/T
indice Progetto di Plastica ornamentale ispirazione/descrizione Tavole definitive Bozzetto finale Ambientazioni Tesina Giampaolo Babetto
progetto di plastica ornamentale
ispirazione/descrizione
Il progetto trova la sua ispirazione nell’esplosione della geometria e dei colori dei graffiti.
Questo oggetto è una composizione di solidi realizzati singolarmente e poi assemblati. Tutti i
solidi sono diversi ma il principio costruttivo è analogo, ogni singolo elemento è costituito da
due basi uguali a «C» o «L», due facce laterali che seguono le basi piegandosi una o due volte,
due facce mancanti che mostrano il vuoto all’interno della struttura.
Per realizzare ogni singolo elemento, sono partito dalla creazione di due fascette di rame (facce
laterali) della stessa larghezza ma di diversa lunghezza. Per realizzare la piega in corrisponden-
za degli angoli della base ho inciso e poi limato sul solco. Dopo aver realizzato le due facce
laterali le ho posizionate su una lastra di rame e le ho saldate con essa; ho eliminato il rame
in eccesso creando quindi la prima base. Con lo stesso procedimento ho realizzato anche la
seconda base.
In fine ho rifinito il pezzo limandolo; ho usato una lima grossa per trattare la superficie in modo
da creare una “texture” in regolare.
Dopo aver realizzato tutti gli elementi li ho assemblati e saldati.
Per realizzare l’ossidazione ho lasciato per una settimana il pezzo a contatto con i vapori di
ammoniaca.ambientazioni
Giacomo Pinton Giampaolo Babetto corso di Plastica ornamentale professor Danilo Ciaramaglia Accademia di Belle Arti Venezia, anno accademico 2019-2020
In copertina Giampaolo Babetto, Spilla, 2013, oro giallo, pigmento
a destra Giampaolo Babetto
3indice
9 Giampaolo Babetto
25 Il linguaggio delle forme, intervista con Giampaolo Babetto
di Peter Nickl
30 BibliografiaHo sempre eliminato ogni tipo di decorazione dal mio lavoro, ho sempre voluto una forma pulita, non tanto per scoprire una geo- metria o il processo matematico che sta dietro alla forma, quanto perché mi conviene in qualche modo usare una forma pura. Il mio lavoro non è fatto di apparenza, vorrei che fosse qualcosa che nasce dall’interno, che comunica un’interiorità, però voglio che rimanga discreta, voglio che ci sia una rispondenza tra l’oggetto che realizzo e quello che sono io. Poi uso delle forme geometriche pure perché mi sono congeniali e cerco di sensibilizzarle, di comunicare me stes- so a queste forme. Anche il fatto che molte siano vuote è per questo motivo: il vuoto interno crea una tensione esterna. Se una di que- ste forme fosse piena sarebbe morta. La forma solida ma vuota dà all’oggetto una apparenza massiccia e si ha una sensazione di grande leggerezza quando la si prende in mano. giampaolo babetto da, Giampaolo Babetto, 1991
Giampaolo Babetto
Certamente i gioielli che realizzo sono chiari nella loro forma. Spero
però che si possa riconoscere che possiedono un’interiorità e una
esteriorità. Cerco comunque di trasmettere loro una vita interiore,
di instillare loro, per così dire, un’anima.
giampaolo babetto da, Gioielli di cultura, 2002
Giampaolo Babetto è uno dei massimi esponenti dell’oreficeria contemporanea.
Le sue origini sono la scuola dell’oro padovana, l’eredità di Mario Pinton, le influenze dell’arte
programmata e cinetica, e non sono da sottovalutare il periodo trascorso nei Paesi Bassi e quel-
lo negli usa. Le sue numerose docenze e gli incarichi d’insegnamento fra gli altri a Dusseldorf,
Londra, Salisburgo, Amsterdam e Providence (usa), sono esperienze che lo hanno arricchito fin
dall’inizio della sua attività e catapultato fuori dal mondo esclusivamente italiano.
Nelle sue opere è evidente lo studio della relazione dei corpi nello spazio, la storia dell’arte filtra-
ta e fatta propria, uno sguardo attento all’architettura, alla scultura e ai movimenti contempora-
nei, ma anche ai grandi maestri del Rinascimento.
Nel 1944 Mario Pinton docente all’istituto Pietro Selvatico di Padova diede vita a quel per-
corso che condusse la scuola padovana di oreficeria ad avere un linguaggio autonomo e una
connotazione riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Un percorso che coincide con
un movimento di ricerche ed esiti, un fenomeno che sarà siglato all’estero come «Scuola di
Padova» e che vede in Pinton [fig. 1], Pavan e Babetto i tre grandi maestri che pur nella loro
individualità rimangono legati da una matrice comune e che hanno segnatao la strada a suc-
cessive generazioni di artisti tra i quali vale la pena ricordare Graziano Visintin, Maria Rosa
Franzin e Stefano Marchetti .
Il concetto innovativo di gioiello, che prende forma in questo contesto, è quello dove invenzione,
conoscenza, forma, materia e perizia tecnica diventano elementi imprescindibili e convergenti
per la creazione non di un semplice ornamento o fine artigianato, ma di una vera e propria cre-
azione artistica.
1. 2. 3.
Mario Pinton, 1. Collana anatomica, 1975, oro giallo, rubino; 2. Anello, 1982, oro giallo, rubino; 3. Spilla, 1986, oro giallo, rubino
9È il pensiero a conferire forma e senso alla pratica allo stesso modo in cui è la pratica a suffra- La geometria si libera da tutte le istanze, le forme cubiche, le prospettive di cilindri o piramidi,
gare l’idea, conferendole consistenza e veridicità. Il gioiello diventa quindi autonoma espres- le assonometrie di parallelepipedi diventano spille, anelli, bracciali di intensa purezza [figg.
sione artistica. 6-14]. La semplificazione viene in parte mitigata dallo sporadico utilizzo di materiali diversi
Le caratteristiche che accomunano gli esponenti della scuola sono lo studio dell’arte antica non come ad esempio oro ed ebano, questo accostamento di materiali, lavorati in modo ben pre-
disgiunto dall’attenzione verso il contemporaneo, la geometria descrittiva che è considerata base ciso dall’artista rendono il gioiello equilibrato ed armonico: l’oro nella sua lucentezza impone
indispensabile per comprendere le forme, i rapporti, l’armonia della composizione. il rigore della forma e suscita tensione e forza e l’ebano, un materiale “caldo” addolcisce la
composizione[figg. 6-8].
Analogo risultato viene ottenuto attraverso la pigmentazione dei solidi con resine dai colori
Giampaolo Babetto nel 1969 sostituì Mario Pinton, suo maestro, nell’insegnamento di proget- primari, distese lisce sui volumi, e le profilature d’oro che contornano i perimetri dei volumi
tazione e disegno professionale. [figg. 9-11].
Fin da subito riesce a dare una personale interpretazione agli stimoli da lui ricevuti dal clima Questo gioco cromatico e della contaminazione di materiali condurrà l’artista ad un uso esaltante
culturale del momento, mi riferisco all’arte cinetica e programmata. Nelle opere di questo dei colori; caratterizzante l’arte di Babetto.
periodo elementi filiformi o lamellari, mobili, sono dotati di un autonomo movimento in rap- All’interno di una cultura votata alla massima semplificazione espressiva le sue opere si inse-
porto alla luce e al moto del corpo. Le collane modulari [fig. 4] ne sono un valido esempio. In riscono in una visione classica che riconduce i sui modelli ai valori della misura aurea rinasci-
queste non sono le soluzioni tecniche strutturali a prevalere ma l’effetto visivo della compo- mentale.
sizione che esprimere la leggerezza e il movimento del pezzo. Altro esempio significativo è la
spilla del 1969 [fig. 5], su una base quadrata vengono fissati molteplici listelli lasciati liberi in
una perpetua mobilità per l’effetto della movimentazione casuale.
6. 7. 8.
9. 10. 11.
4. 5.
4. Collana, 1968, oro verde; 5. Spilla, 1969, oro giallo
Con gli anni settanta Babetto supera il modello cinetico per concentrarsi su forme tridimen-
sionali, semplici, autonome, prive di ogni complessità dialettica, la componente minimalista, si
rafforza e porterà ad una grandissima semplificazione delle forme.
La geometria viene usata per tradurre all’esterno un’intima aspirazione all’ordine e alla misura 12. 13. 14.
al ritmo e alla armonia. Il suo uso della geometria richiama il rigore e la misura del passato, 6. Spilla, 1974, oro giallo, ebano; 7. Bracciale, 1976, oro giallo, ebano; 8. Anelli, 1979, oro giallo, ebano; 9. Anello, 1983, oro
giallo, resina; 10. Spilla e anello, 1983, oro giallo, resina; 11. Spilla, 1983, oro giallo, resina; 12. Spilla, 1976, oro giallo; 13. Spilla,
però espressi e riadattati alla sua concezione di ordine compositivo, dando vita a opere di gran- 1976, oro giallo; 14. Spilla, 1983, oro giallo
dissima forza ed espressione e allo stesso tempo di grazia ed equilibrio compositivo, elementi
chiaramente riconoscibili e visibili all’interno delle sue creazioni.
10 11È il Pontormo ad affascinare Babetto e a lui ritornerà più volte nel corso degli anni. Dagli affre-
schi di Poggio a Caiano Vertumno e Pomona (1519-1521), Babetto isola una fronda una foglia, un
drappo, angioletti e putti [figg. 17, 19-21]; dall’affresco dell’Annunciazione nella capella Cappo-
ni a Firenze del 1527-1528 estrapola un angelo [fig. 18].
17. 18.
15.
19. 20. 21.
17. Putto da Pontormo, spilla, 1990, oro giallo; 18. Angelo da Pontormo, spilla, 1991, oro giallo; 19. Anello da Pontormo, 1990,
oro giallo; 20. Bacco da Pontormo, spilla, 1995, oro giallo; 21. Bracciale da Pontormo, 1995, oro giallo, oro verde, rame
Queste figure però mantengono una severa riduzione formale. Nella distribuzione di rami fioriti,
di foglie, di particolari dei personaggi su anelli bracciali e collane si accentua il senso plastico sia
per i diversi spessori sia per il ricco cromatismo dei metalli. Ne Il Cristo morto, tratto dall’affresco
della Certosa del Galluzzo a Firenze, del 1995 [fig. 22] scopriamo una sofferta emotività. Il corpo
in oro bianco e niello è adagiato su un mantello completamente ricoperto di pigmento azzurro
che quasi raddoppia la figura.
16.
15. 16. Da Pontormo, 1989
Nel 1989, proprio all’apice della sua stagione minimalista, affronta la figurazione. Forse la ra-
gione è la partecipazione alla cultura postmoderna diffusasi alla fine degli anni ottanta a cui
aderiscono pittori scultori e architetti, liberati dalle costrizioni astratte di oltre mezzo secolo e 22. 23.
interessati al confronto con il grande passato rinascimentale e barocco. 22. Il Cristo morto, spilla, 1995, oro bianco, pigmento; 23. Trasporto di Cristo (Cappella Capponi), 1996, oro bianco, pigmento
12 13A partire dagli anni novanta Babetto sperimenta il «colore pittorico». Questo non è più netto e dere alla vista la sagoma sottostante. Questi lavori eseguiti con un unico foglio metallico hanno
uniforme, come nelle prime opere minimaliste, ma grumoso, come l’intenso blu di terra colorata un ambigua lettura: appaiono di una intensa fisicità e nello stesso tempo stupiscono per la loro
che avvolge il cristo morto [figg. 22-23]. leggerezza [fig. 29].
29.
24. 25.
24. Bracciale, 1990, oro bianco, pigmento; 25. Spilla, 1991, oro giallo, pigmento
Questo colore granuloso, pastoso che prende vita incontrando la luce diventa un dato fonda-
mentale, anche il geometrico non potrà piu essere esente da implicazioni emotive [figg. 24, 25].
Germano Celan nel 1996 individua un elemento sensitivo che investe le opere dalla fine degli
anni ottanta: «La materia si fa animata, si libera dal peso e pulsa di immaterialità». Celan coglie
l’intervento di elementi perturbativi nelle forme esatte, intuendo gli sviluppi futuri del lavoro del 30. 31. 32.
maestro. 29. Spilla, 2001, oro bianco, niello; 30. Spilla, 2001, oro bianco, niello; 31. Spilla, 2001, oro bianco, niello; 32. Bracciale, 2001,
oro bianco, niello
È forse in questi lavori che si può trovare il precedente degli sviluppi più poetici della produzio-
ne di Babetto, mi riferisco alle spille in oro giallo del 2005 [figg. 33-36].
26. 27. 28.
26. Anello, 1995, oro bianco, niello, pigmento; 27. Spilla, 1997, oro bianco, niello; 28. Orecchini, 1999, oro bianco, niello, resina
In opere come la spilla in oro bianco e niello del 2001 [fig. 26] si ha un passaggio dalla netta defi-
nizione delle immagini geometriche a un loro perturbamento strutturale. I volumi prima levigati
contengono adesso tracce di modellato.
La memoria anatomica si evidenzia in opere dall’apparente impostazione minimalista; le superfi-
ci di oro bianco rese nere dal niello coprente registrano impercettibili modulazioni che mimano,
con ombre e riflessi, membra, forme anatomiche che premono, e nel contempo deformano la 33. 34.
lamina che appare come un tessuto leggero, un delicato sudario che tenta di coprire, di nascon-
33. Spilla, 2005, oro giallo; 34. Spilla, 2005, oro giallo
14 15Anche le raffigurazioni geometriche si arricchiscono di pathos, dopo il Pontormo la pratica
astratta è contrassegnata dal perturbamento di superfici colorate e intensamente materiche, dalle
loro contrapposizioni non più esatte ma rese oblique, sghembe. I piani si intersecano e si so-
vrappongono a volte sconnessi tra loro, la loro sagomatura è spesso irregolare ai bordi, le lamine
sono solcate da una intensa scrittura di segni che le rende rugose. Le colorazioni sono porose,
pulviscolari, i rossi e i blu sono usati nelle tonalità più accese e spesso nel disegno astratto l’artista
interviene con pietre preziose, perle o grandi coralli [figg. 37-39].
35.
35. Spilla, 2005, oro giallo
Arti allungati con ginocchia leggermente prospicienti, mani diafane. Il corpo viene raccontato
nella sua vulnerabilità, nella sua impotenza, le proporzioni classiche si dissolvono e la leggerezza
diventa cifra stilistica di un lirismo espessionista.
37. 38. 39.
37. Spilla, 1995, oro bianco, pigmento, niello, corallo; 38. Spilla, 1995, oro bianco, pigmento, niello; 39. Spilla, 1995, oro bianco,
pigmento, niello
Verso i primi anni del nuovo millennio compare nelle composizioni geometriche l’uso di piani di
metacrilato trasparente dai colori accesi, incorniciati perimetralmente da profilature di oro bian-
co o giallo [figg. 40-44]. I piani distanziati, paralleli, ruotati o inclinati dialogano tra loro attra-
verso opacità, brillantezza dei metalli e trasparenza. I profili metallici segnano le linee costruttive
e di forza, evidenziano le rotazioni e inclinazioni.
40. 41. 42.
43. 44.
36. 40. Spille, 2000, oro bianco, oro giallo, metacrilato; 41. Anelli, 2001, oro bianco, metacrilato; 42. Collana, 2002, oro giallo,
metacrilato; 43. Spilla, 2001, oro bianco, metacrilato; 44. Spilla , 2002, oro bianco, metacrilato
36. Studi per mano, 2005
16 17Dello stesso periodo troviamo lavori in cui i componenti strutturali si dissolvono muovendosi in
libere segmentazioni in uno spazio vuoto [fig. 45]. Il filo con le sue libere aggregazioni si inseri-
sce nella costruzione geometrica [fig. 46] rende più mossa la tensione e vi introduce leggerezza
casualità e indeterminatezza. Si assiste alla distruzione delle forme volumetriche trasformate in
filamenti avvolgenti, in matasse che a volte contengono particelle colorate quasi a memoria delle
volumetrie disgregate o diamanti incastonati, saldati ai filamenti, quasi gemme di piccoli rovi
[figg. 47-49].
45. 46.
47.
48. 49.
45. Spilla, 2003, oro bianco, pigmento, vetro, diamanti; 46. Spilla, 2004, oro bianco, pigmento, vetro, metacrilato; 47. Spilla, 50.
2002, oro giallo, pigmento ; 48. Anello, 2003, oro bianco, diamanti; 49. Spilla, 2002, oro bianco, pigmento 50. Passione, 2004
18 19Le forme geometriche autonome, i gioielli che si realizzano in un unico gesto, mai privo di ten-
sione, continuano a essere infinitamente interrogate. Le forme semplici si tendono, si piegano
seguendo linee di forza immaginabili solo per l’effetto che hanno prodotto sulla lamina.
È la materia stessa che si carica di energia, le forme vibrano e vibrando esprimono come dirà
Babetto in un’intervista del 2002 «l’intera tensione del processo creativo».
I volumi puri non sono più modificati secondo le leggi della prospettiva, ma sono tirati, defor-
mati, dilatati. In questa lotta il pathos – ed è forse qui che Babetto si mostra profondamente
classico – è espresso pienamente perché per esprimerlo pienamente bisogna che l’espressione sia
perfetta, misurata, composta cioè sia «in forma». Le sue spille, di un blu profondo, i suoi anelli,
sfere perfette che mostrano la loro anima rossa, diventano fiori di una nuova tragica bellezza
perfettamente classici perfettamente moderni [figg. 51-55].
56. 57. 58.
51. 52. 53.
59. 60.
54. 55.
51. Spilla, 2013, oro giallo, pigmento; 52. Spilla, 2007, oro giallo, pigmento; 53. Spilla, 2007, oro giallo, pigmento; 54. Anello,
2004, oro giallo, pigmento; 55. Anello, 2010, oro giallo, pigmento
Di lui Fritz Falk, direttore del museo di Pforzheim ha scritto:
L’orafo Giampaolo Babetto riunisce in sé e nelle sue opere due principi: sia lui che i suoi gioielli sono con-
trassegnati dalla sensibilità e dalla precisione. Entrambi questi principi si completano nella geometria che
è premessa fondamentale per una utilizzazione più sensibile e precisa della forza creativa di Babetto. Qua-
lunque sia il suo sviluppo artistico anche in futuro sarà imperniato sui principi di sensibilità e precisione
legata alle tracce di antichissima magia ancora profondamente radicata e che accompagna da sempre la
creazione di un vero artista dell’arte orafa.
61. 62.
Babetto opera indifferentemente con linguaggi contrastanti, li approfondisce continuamente, 56. Spilla, 2012, oro giallo, pigmento; 57. Spilla, 2011, oro giallo, pigmenti; 58. Spilla, 2009, oro bianco, pigmento; 59. Collana,
non c’è conflittualità ma un profondo esercizio dei suoi molteplici modi espressivi sempre in 2017, oro giallo; 60. Collana, 2005, oro bianco, pigmento, niello; 61. Anello, 2017, oro giallo, pigmento; 62. Spilla, 2003, oro
costante evoluzione. giallo, pigmento
20 21Il 2013 è l’anno della mostra Ispirazioni (dal 4 ottobre al 22 dicembre al Museo Diocesano di
Padova) è l’occasione per approfondire quel percorso attraverso il sacro già affrontato nei vasi
liturgici per la chiesa di St. Michael di Monaco (2006), nella teca per la sacra Cintola a Prato
(2008) e nell’ostensorio in argento sempre per la chiesa di St. Michael (2008) [fig. 63] e che
proseguirà tra il 2015 e il 2016 con gli arredi liturgici per la Dick Sheppard Chapel nella chiesa
di Saint Martin-in-the-Fields a Londra [figg. 64, 65].
68. 69.
63. 64. 65.
63. Ostensorio, 2008, argento, oro bianco, pigmento; 64. Patena e calice, 2015-2016, argento; 65. Candeliere, 2015-2016, argento
È il tema della croce a essere vagliato – già a partire dal 2009 – in una ricerca che spazia e si 70. 71.
muove attraverso tutti i linguaggi del maestro: due barrette auree che s’intersecano perpendi-
colari, i rami nodosi di bronzo che calcano veri rami d’ulivo [fig. 74], piccole piastre rettango-
lari sulle quali si incrociano linee incise, piegate, impresse sul metallo con il fuoco, lastre che
mostrano la croce attraverso sovrapposizioni e tagli sottrazioni e aggiunte [figg. 70-73].
66. 67.
66. 67. Croci, 2009 72. 73.
68. Croce, 2010, argento; 69. Croci, 2010, argento; 70. Spilla croce, 2010, oro bianco, niello; 71. Spilla croce, 2013, oro giallo; 72.
Spilla croce, 2013, oro giallo; 73. Spilla croce, 2013, oro giallo, metacrilato
22 23peter nickl
Il linguaggio delle forme1
Intervista con Giampaolo Babetto
PN Giampaolo Babetto, la prima volta che si visita la tua casa si è catturati dal linguaggio delle
forme che sembra ispirare tutto. L’arredamento, i mobili, le posate, i tuoi gioielli nel laborato-
rio: tutto si compone in un’unità.
GB È più che comprensibile. Alla base di tutto c’è un linguaggio delle forme. Gli oggetti che mi
circondano li scelgo secondo gli stessi criteri formali validi anche per i miei gioielli. È proprio
questo a trasmettere l’impressione di un’unità formale.
PN In questa tua casa hai apportato migliorie e modifiche. Anche molti dettagli portano la tua
impronta...
GB Sì, è vero. Ho apportato molte modifiche, senza però aver mai manomesso le strutture ar-
chitettoniche originali. In fondo la casa è rimasta così com’era quando la comprai. Mi ci trovo
davvero a mio agio.
PN Certo, la casa e il laboratorio sono una cosa, ma della casa fanno parte integrante anche il
giardino e gli ulivi...
GB Sì, gli ulivi in un certo senso fanno parte della mia vita. Per me hanno qualcosa di molto
vitale, di primigenio, quasi di arcaico. Gli ulivi sono una mia passione. Per me produrre olio
è semplicemente un grande piacere. Quando sono in giro per l’Italia assaggio e compro i più
diversi tipi di olio come altre persone magari farebbero con il vino. L’Italia in questo senso è
una terra ricchissima.
PN Hai parlato dell’architettura della tua casa, delle sue strutture di base. Hai un grande amore
per l’architettura in genere. In che misura rappresenta per te anche una fonte di ispirazione?
74.
74. Rami, 2013, bronzo argento;
GB Amo l’architettura ed è anche una delle mie principali fonti di ispirazione. Fra gli architetti
del xx secolo ammiro particolarmente Mies van der Rohe e Louis Barragan. Fra i contempo-
ranei la mia predilezione va a Norman Foster e a Massimiliano Fuksas. Difficile dire da dove
derivino le forti affinità con questi architetti.
Da Giampaolo Babetto, Gioielli di cultura, Catalogo delle mostre, München, Galerie Handwerk, 11 Oktober 2002-16
1
November 2002, Poggio a Caiano, Scuderie storiche, 23 marzo 2003-1 giugno 2003, Prato, Gli ori, 2002.
24 25PN Hai studiato all’Istituto d’Arte “Pietro Selvatico” di Padova, all’inizio, se non sbaglio, perfi- PN C’era una qualche tradizione artigianale nella tua famiglia?
no architettura.
GB No, ma penso che possediamo tutti del talento nel realizzare delle cose manualmente.
GB Non solo vi ho studiato ma vi ho pure insegnato per quattrodici anni. Un tempo era una
scuola molto interessante. Negli anni Sessanta i corsi di argenteria erano tenuti da Mario Pin- PN Anche cucinare fa parte di queste doti? Sei un cuoco brillante.
ton. Le discipline erano smalto e arte del cesello e dello sbalzo. Pinton fu il mio insegnante ed
ebbe un’influenza determinante sulla mia formazione. A quei tempi c’era anche tutta una serie GB Non sono un vero cuoco, anche se mi piace cucinare. Mi rilassa molto servire una bella cena
di altri docenti bravissimi che insegnavano materie come disegno o plastica, per esempio. Nel agli amici e chiudere così in leggerezza la giornata davanti a una buona bottiglia di vino.
1969, quando Pinton divenne preside della scuola, assunsi io la direzione della sua classe che
poi ho tenuto fino al 1983. PN Mi chiedo: come riesci a combinare tutto? Progetti e realizzi gioielli, ti occupi del laborato-
rio, della casa, del giardino, insegni, ti dedichi ai tuoi ospiti...
PN Proprio allora fosti chiamato a ricoprire la cattedra della Fachhoschule, l’Istituto universita-
rio ad indirizzo professionale, di Düsseldorf quale successore del professor Friedrich Becker. GB Mi sforzo di attribuire lo stesso valore a tutte le mie attività. Creare dei gioielli è una parte di
Fu lui a chiamarti a Düsseldorf? me e sicuramente una parte importantissima, anche se le altre attività lo sono altrettanto. Non
mi piace stabilire delle gerarchie fra le cose che faccio.
GB Conoscevo il professor Becker. C’eravamo già incontrati diverse volte prima in occasione di
mostre. Ma non era stato Friedrich Becker, bensì il professor Hermman Jünger a fare il mio PN Sei comunque una persona molto organizzata e precisa.
nome a mia totale insaputa. Per me allora fu un’enorme sorpresa e naturalmente anche un
grande onore. Oltretutto a Düsseldorf mi sono trovato molto bene. L’insegnamento mi pia- GB Non lo so. Ho piuttosto l’impressione che tutto quel che faccio converga in una direzione,
ceva molto e trovavo anche molto stimolante sviluppare un contatto con gli studenti in una che si risolva cioè in maniera naturale e senza imposizioni, quasi come se il mio inconscio mi
lingua straniera. Mi dispiacque molto quando dovetti lasciare Düsseldorf. indicasse la strada da percorrere. Se faccio dei gioielli lavoro fra l’altro molto rapidamente,
d’impulso e con molta energia. Il processo di ricerca delle forme è intenso e concentrato anche
PN Mi ricordo bene. Per noi allora fu un piccolo choc. Molti avevano riposto in te delle grandi quando si tratta di forme semplicissime. Direi semmai che una parte di me è ben organizzata e
speranze quale successore del professor Becker. Ti dedichi ancora oggi all’insegnamento? strutturata, l’altra invece è libera. Se per caso mi imbatto in qualcosa di nuovo che mi accende
la fantasia, allora me ne approprio e provo a realizzarlo. In quella parte invece che io definisco
GB Sì, insegno presso una scuola di arte orafa di Firenze dal nome misterioso: Alchimia. Spero libera si evidenzia il giocatore. Amo le situazioni-limite. In un certo qual modo sono sempre
che questa scuola possa acquisire ancora maggiore importanza non ultimo per il suo buon alla ricerca dei limiti delle cose.A quel punto agisco come un giocatore, con la sola differenza
programma didattico. però che gioco con me stesso.
PN Ci sono molte gallerie a Padova, ora come prima anche delle ottime gallerie di arte orafa. Si PN Cerchi i tuoi limiti, ma ami anche le delimitazioni. I tuoi gioielli producono spesso l’effetto di
può dire che Padova rappresenta ancora oggi in Italia il centro principale per l’arte contem- un campo geometricamente misurato col compasso, chiaramente definito. Definire qualcosa
poranea del gioiello? con chiarezza si può fare solo se si possiede una chiarezza interiore.
GB Indubbiamente Padova è stata a lungo un centro per l’arte orafa contemporanea. Questa ere- GB Non so. Non mi è facile risponderti. Certamente i gioielli che realizzo sono chiari nella loro
dità è ancora viva e si evidenzia nel fatto che ancora oggi esiste tutta una serie di interessanti forma. Spero però che si possa riconoscere che possiedono un’interiorità e una esteriorità.
gallerie e soprattutto nel fatto che qui vivono molti orafi ben conosciuti. Cerco comunque di trasmettere loro una vita interiore, di instillare loro, per così dire, un’a-
nima. Solo allora il gioiello acquisisce una forza che permette di stabilire una comunicazione
PN Torniamo al tuo percorso di formazione. Dopo l’Istituto d’Arte “Pietro Selvatico” hai con- con chi lo osserva.
tinuato a studiare.
PN Fra le altre nei tuoi lavori traspaiono delle influenze o forse, detto altrimenti, delle ispirazio-
GB Sì, ho studiato per altri due anni all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ero iscritto al corso ni. Penso qui al Pontormo o anche al tuo confronto con De Stijl o con l’avanguardia russa.
di scultura del maestro Alberto Viani. Nel 1968 però l’Accademia venne occupata dagli stu- Che importanza ha avuto per te il Pontormo?
denti con la conseguenza che, di fatto, rimase chiusa per due anni. Per me allora fu un duro
colpo. Col senno di poi posso dire che non fu poi così male perché proprio allora iniziai a GB Nel mio intimo credo di essere un “classico”. Per me sono importanti i principi classici come
lavorare l’oro e a creare i miei primi gioielli. A onor del vero non furono ovviamente i primi chiarezza formale, misura e proporzioni. Nel caso del Pontormo mi ha molto impressionato
perché i primissimi gioielli li avevo già creati ai tempi della scuola rielaborando dei vecchi gio- come questo artista intenda proporzione e contenuto di una forma in maniera affatto diversa
ielli di mia madre. In genere non si accorgeva se le portavo via i suoi gioielli. Quando invece dalla mia. Quando per la prima volta vidi gli affreschi del Pontormo rimasi come folgorato.
gliene riportavo uno nuovo restava interdetta e pensava che fossi completamente impazzito. Volevo penetrare nel mondo di questo artista, volevo diventare creativo al pari suo. Ancora
oggi non so bene quale processo si sia innescato in quel momento. L’incontro e il confronto
PN Hai avuto una madre molto comprensiva... col Pontormo hanno rappresentato comunque per me una fase molto intensa e di grande
arricchimento. Riguardo alle somiglianze con elementi di De Stijl o con l’avanguardia russa,
GB No, molto comprensiva non lo era e mi sgridava anche, ma in fondo non era mai così grave. realizzando i miei progetti non ho affatto pensato a queste correnti stilistiche. Solo in seguito
Era soprattutto mio padre a mostrarsi comprensivo. Quando mia madre gridava a mio padre: da più parti mi sono state fatte notare certe affinità. E in fondo va bene anche così.
“Lorenzo, la mia spilla con i coralli e le perle è scomparsa un’altra volta”, mio padre mi striz-
zava l’occhio e diceva solamente: “Ma lascialo fare, è un ragazzo...” PN Sei rimasto affascinato dal colore per la prima volta con i gioielli della serie dal Pontormo?
26 27GB No, col colore ho iniziato a lavorare per la prima volta nel 1983 e precisamente con i colori di GB Quello che mi affascina è soprattuto l’idea del design. Non ho mai lavorato a un banco da
base nero, bianco e rosso. Erano tutti colori in resina sintetica. Grazie a questi gioielli ho vinto falegname.
nello stesso anno il gran premio della Japan Jewellery Association. La serie dal Pontormo con
i suoi “metalli colorati” è arrivata solo dopo e quasi contemporaneamente anche la serie a PN I tuoi gioielli recano forti tracce di manualità artigiana. Che importanza le attribuisci?
colori dei miei “gioielli decostruttivisti”. Almeno a me piace chiamarli così.
GB In quanto tale non molta. In pratica invece per me realizzare qualcosa con le mani è una vera
PN Citi spesso i concetti di tensione e armonia che definiscono contrapposizioni o anche poli e propria gioia. Ripetere per molte volte la medesima attività manuale equivale per me a una
contrari che si attraggono vicendevolmente. In che misura sono importanti per la compren- sorta di meditazione.
sione del tuo lavoro?
PN Di quali lavori si tratta?
GB Proverò a spiegarlo. Parto quasi sempre da una forma di base geometrica, non perché mi
interessi l’estetica della geometria o perché intenda condurla alle estreme conseguenze, ma GB Non intendo dire che mi ripeto creando i miei gioielli. Molti dei miei lavori consistono però
molto semplicemente perché lavoro volentieri con forme semplici. Rinuncio fin dall’inizio a spesso degli stessi elementi, delle stesse maglie, come nel caso di una collana lunga. Amo
tutti gli elementi decorativi. Una volta scelta la forma di base – mi piace lavorare con il pen- realizzare cento volte tali parti di un tutto. Lavorando manualmente le idee si liberano. Fare
tagono – prende il via un processo di minimizzazione. Cerco di riuscirci con un minimo di qualcosa manualmente è una cosa, un’altra invece è vagare col pensiero.
materiale e di dispendio tecnico, anche se questo è spesso accompagnato da grandi difficoltà
nell’esecuzione. Spesso combatto delle vere e proprie battaglie con materiali e forme in modo PN E con ciò saremmo di nuovo ritornati a Bernard Leach e a quella forza creativa che si spri-
che alla fine ne risulti un qualcosa di vibrante, un oggetto che pur nella sua semplicità riesca giona nella ripetizione permanente di un’attività artigianale. Proprio come consiglia il famoso
ad esprimere l’intera tensione del processo creativo. principio giapponese del Mingei.
PN Penso che tu ci riesca perfettamente perché la tensione è qualcosa che si sente in quasi ognu- GB Sì. Forse.
no dei tuoi gioielli: il rigore emana energia.
GB Per me questo è il massimo dei complimenti. A volte il lavoro a un gioiello ha qualcosa di
molto sensuale.
PN In quali ore del giorno stai seduto di fatto al tuo tavolo da orafo?
GB Non vorrei passare per presuntuoso, ma in realtà io lavoro sempre. Inizio molto presto e
lavoro fino a tarda sera. La giornata, come ho già detto, non dovrebbe concludersi lavorando,
ma semmai davanti a un buon bicchiere di vino. In questo momento non mi occupo solamen-
te di gioielli ma anche di design di mobili. Progetto una collezione di mobili per una grande
ditta. È un compito affascinante, non da ultimo anche perché non è comparabile col lavoro
di un orafo.
PN È possibile stabilire una relazione fra i gioielli e i mobili? E perché proprio i mobili? Non sa-
rebbe pensabile che accanto all’attività di orafo tu facessi anche disegni o sculture? Certo non
può essere un caso se fra una cosa e l’altra tu ritorni sempre a progettare dei mobili... A me
pare di vedere una corrispondenza stretta fra le forme dei mobili e i gioielli delle tue differenti
fasi creative. Penso qui per esempio al letto ispirato al Pontormo.
GB Forse ci sono dei punti di contatto anche se non possono essere essenziali visto che se si
lavora in un altro ambito creativo si è sottoposti anche a tutt’altre regole. Non solo si deve
pensare in altre dimensioni, ma va ripensato completamente il modello mentale. Ingrandire
e basta non è sufficiente perché così l’oggetto perderebbe in intensità. Perché dovrei però
fare disegni e sculture e non mobili? I mobili sono degli oggetti molto interessanti e stanno in
stretta relazione con l’architettura.
PN Quando progetti dei mobili, ti occupi anche di come vengono realizzati?
GB Se progetto mobili come pezzi unici li realizzo insieme ad un amico. Per la produzione indu-
striale invece vengo affiancato da un tecnico. Una produzione industriale risponde a criteri di
efficienza e di riproducibilità. Spesso sorgono problemi difficilmente risolvibili.
PN Lavori volentieri il legno? Hai mai lavorato a un banco da falegname?
28 29bibliografia
Babetto Giampaolo, Gioielli di cultura, Catalogo delle mostre, München, Galerie Handwerk, 11 Oktober
2002-16 November 2002, Poggio a Caiano, Scuderie storiche, 23 marzo 2003-1 giugno 2003, Prato,
Gli ori, 2002.
Babetto Giampaolo, Giampaolo Babetto. Arbeiten auf Papier 1965-2009, Catalogo della mostra, Mün-
chen, Galerie Fred Jahn, 15 März-12 April 2014, München, Galerie Fred Jahn, 2014.
Babetto Giampaolo - Casazza Ornella (a cura di), Babetto 1967-2007, Catalogo della mostra, Firenze,
Palazzo Pitti - Museo degli argenti, 14 giugno-23 settembre 2007, Livorno, sillabe, 2007.
Babetto Giampaolo - Baumer Dorothea (a cura di), Gioielli di cultura, Prato, Gli ori, 2002
Babetto Giampaolo - Talli Nencioni Anny (a cura di), Giampaolo Babetto, Zurich, Aurum, 1991
Cisotto Nalon Mirella - Spiazzi Anna Maria ( a cura di), Gioielli d’autore. Padova e la scuola dell’oro, Cata-
logo della mostra, Padova, Palazzo della ragione, 4 aprile-3 agosto 2008, Torino, Umberto Allemandi
& C., 2008.
Folchini Grassetto Graziella (a cura di), Gioielleria contemporanea «La scuola di Padova», Stuttgart,
Arnoldsche, 2005.
Hufnagl Florian (a cura di), Giampaolo Babetto. L’italianità dei gioielli, Catalogo della mostra, München,
Pinakothek der Moderne, 6 März-30 Mai 2010, Stuttgart, Arnoldsche, 2010.
Nante Andrea - Babetto Giampaolo (a cura di), Giampaolo Babetto. Ispirazioni, Catalogo della mostra,
Padova, Museo Diocesano, 4 ottobre-22 dicembre 2013, Pistoia, Gli ori, 2013.
30Puoi anche leggere