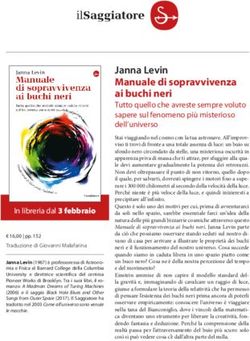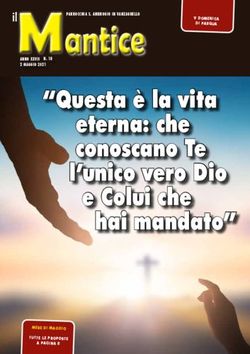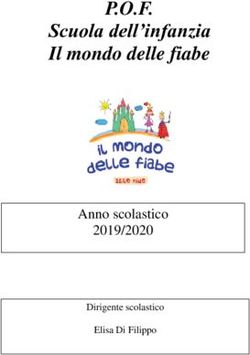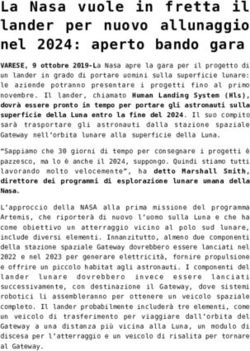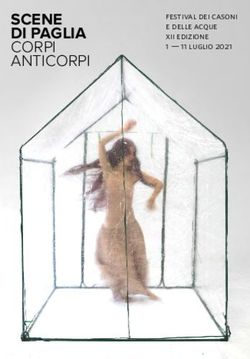Lo spettro di Sfera Ebbasta. Oltre l'ostentazione del gioco
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Lo spettro di Sfera Ebbasta. Oltre l’ostentazione del gioco Dallo schermo dei computer Sfera Ebbasta ci osserva e la sua figura picchiettata di riflessi metallici ricorda For the Love of God, il teschio di diamanti opera di Damien Hirst. Tra gennaio e febbraio 2018, all’epoca in cui usciva l’album Rockstar, Sfera Ebbasta iniziò a comparire ingigantito su grandi manifesti promozionali collocati all’ingresso e all’uscita delle più importanti stazioni della metropolitana milanese. Nella foto la sagoma, grande tre volte un essere umano, indossava aderenti pantaloni scozzesi a quadri, una pelliccia sintetica di colore rosa e mostrava al polso un massiccio orologio d’oro o dorato, protesi d’oro o dorate applicate sull’arcata dentaria, bracciali e anelli. L’immagine apparteneva alla stessa serie usata per la copertina del disco. Facciamo un salto indietro nel tempo. Nella seconda metà dell’Ottocento una legione di spettri si aggirava per l’Europa e gli Stati Uniti. Non erano i fantasmi del comunismo, ma gli ectoplasmi e le voci dei defunti che si palesarono nei salotti dei nostri avi sull’onda di una nuova moda: lo spiritismo. In questo contesto il «medium» non era solo colui che operava a cavallo tra due dimensioni, ma il mezzo fisico attraverso il quale il trapassato poteva tornare a manifestarsi. Nel paranormale di oggi e nella New Age c’è un nuovo termine: «channelling». Il «channelling» è il processo nel quale ci si fa portatori e veicoli di un messaggio proveniente da un’altra entità, che sia un angelo, un extraterrestre, un antenato, uno «spirito guida», un «maestro cosmico», un «operatore di luce»… Il sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol paragonava sé stesso a una «grondaia», cioè uno scivolo, una forma cava in cui scorreva e si amplificava la voce di un’intelligenza giunta da un altrove imprecisato. «Medium», «channeling» e «grondaia» sono tre termini chiave che possono servire a formulare un’ipotesi e una domanda: nel linguaggio e nel discorso messo in scena dall’artista e musicista Sfera Ebbasta, re della Trap italiana e nato nel 1992 a Cinisello Balsamo, c’è forse uno spettro che, mescolato all’io narrante, parla e attraversa come un anello di fumo il corpo e la voce dell’artista? Sul conto di Sfera Ebbasta si è polemizzato molto, specie all’indomani della sua partecipazione, il primo maggio 2018, al concerto organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma. Qualcuno ha moraleggiato a proposito dell’abito firmato Gucci (Sfera Ebbasta nella sua milanesità contemporanea e fashionista non usa «abito», ma il termine «outfit») e su Twitter, dopo una prima replica, ha dichiarato che sul palco del sindacato indossava perfino due Rolex. C’è un dettaglio di un episodio accaduto ventiquattro anni fa a Roma, che probabilmente pochi conoscono. Almeno un articolo di giornale racconta che due orologi erano stretti ai polsi di Kurt Cobain il giorno in cui, nel marzo del 1994, venne caricato a bordo di un’ambulanza e trasportato prima al Policlinico Umberto I e poi all’ospedale angloamericano. Overdose in seguito a un cocktail di Flunitrazepam, ovvero pastiglie Roipnol, e champagne. Gli infermieri romani sulle prime lo
avevano preso per un tossico, fino a quando non notarono la coppia formata da un Rolex d’oro al
polso sinistro e il quadrante di un Cartier su quello destro. La versione ufficiale racconta che Kurt si
trovava in un albergo di via Veneto e che fu Courtney Love, la moglie di Kurt Cobain, a chiamare i
medici.
Una versione mitologica narra invece che Kurt venne ritrovato come un Ercole addormentato nei
dintorni della stazione Termini. Giorni prima aveva staccato un pezzo di Colosseo per regalarlo alla
sua sposa. Una foto di Bruce Pavitt, fondatore dell’etichetta Sub Pop, lo immortala in una posa da
pensatore di Rodin, seduto per strada sul basamento di un palazzo storico. Gli occhi sono chiusi. Più
che «il pensatore» si potrebbe titolare questo scatto «Il fattone» o «Il poeta» o «Un americano a
Roma» o «Il pensatore alla fine della storia».
Ma cosa ci facevano quei due orologi addosso a un ventisettenne il cui vestiario era, di solito,
un’evocazione della marginalità suburbana e del guardaroba tipico degli homeless della provincia
statunitense? Blue jeans ridotti a brandelli, cardigan sformati, t-shirt hard rock usurate da troppi
passaggi in centrifuga, scolli a v di lana mangiati dalle tarme, spolverini animalier fuori moda. Nel
gioco di reciproci sconfinamenti crossover che all’epoca cominciava ad avvertirsi tra il rock’n’roll
bianco e il rap, forse Kurt Cobain, nella sua intelligenza sensibile e sottigliezza, pensò d’infilare quei
due orologi per giocare a sua volta con l’ostentazione delle merci e degli status symbol specifica
della cultura rap e gangsta rap.
Al tempo stesso, come noto, era consapevole fino alla disperazione non solo, probabilmente,
dell’aspetto effimero e svuotato di quel gioco puramente combinatorio e postmoderno, ma della
propria inconciliabilità sentimentale con la trasformazione in merce spettacolare del grunge, dei
Nirvana, della propria identità e infine di ciò che il critico e scrittore Mark Fisher ha definito le
«ambizioni utopico-prometeiche del rock»:
“con la sua straziante inedia, con la sua rabbia senza scopo, il leader dei Nirvana sembrò
l’esausta voce dell’avvilimento che attanagliava la generazione venuta dopo la fine della
storia, la stessa generazione cui ogni singola mossa era stata anticipata, tracciata,
comprata e svenduta prima ancora di compiersi. Cobain sapeva di essere soltanto un altro
ingranaggio dello spettacolo, che su MTV niente funziona meglio che la protesta contro
MTV; sapeva che ogni suo gesto era un cliché già scritto, e che persino questa
consapevolezza era essa stessa un cliché. Il vicolo cieco che paralizzò Cobain è lo stesso
descritto da Jameson: esattamente come la cultura postmoderna nel suo complesso, Cobain
si ritrovò «in un mondo in cui le innovazioni stilistiche non sono più possibili. Quello che
resta è l’imitazione di stili morti, parlare attraverso le maschere e con le voci degli stili di
un museo immaginario». Qui persino il successo equivale al fallimento, perché avere
successo significa soltanto che sei la carne di cui si nutre il sistema. Ma l’immensa rabbia
esistenziale dei Nirvana e di Cobain appartiene a sua volta a una fase ancora più vecchia:
dopo di loro sarà la volta di un pastiche rock che tenterà di replicare le forme del passato
senza nemmeno alcun tipo di turbamento. La morte di Cobain ribadì la sconfitta e
l’incorporazione delle ambizioni utopico-prometeiche del rock. Quando il leader dei Nirvana
morì, il rock stava già subendo l’ascesa dell’hip hop, il cui successo globale annunciava
proprio quella pre- corporazione del capitale a cui accennavo sopra”. (Realismo capitalista,
Mark Fisher, Nero Not edizioni, 2018)
Venti anni più tardi Sfera Ebbasta e la trap sembrano parlati dallo spettro del capitale, proprio come
i vecchi medium dell’800 erano parlati dallo spirito di un defunto. Quavo dei Migos, che con Sfera
Ebbasta ha collaborato a un featuring, un giorno viene intervistato e il giornalista gli rivolge una
domanda a proposito della trovata lirica che consiste nel ripetere decine e decine di volte la parola
«Versace» nel pezzo Versace. Quavo risponde che una volta ascoltato il beat spedito da Zaytoven, ilproducer, allora l’idea per magia «è venuta fuori dal nulla, tipo Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace». Ciò che conta, come nella vita di un’impresa, è il successo e il risultato. Il successo e la realizzazione di sè sono narrati attraverso l’ostentazione delle merci, dei trofei, dell’outfit, degli status symbol, dei marchi commerciali e grazie a una conta rituale delle donne possedute, della cocaina sniffata, dei sold out e dei dischi d’oro conquistati. Un po’ come quando Silvio Berlusconi a ogni tappa di campagna elettorale ripeteva l’elenco delle vittorie del Milan. Non c’è grande differenza. Si tratta in entrambi i casi di quantificare e misurare il proprio potere attraverso lo spettacolo dei successi e della merce accumulata. E ogni spettacolo prevede una ribalta e almeno uno spettatore o una spettatrice. C’è un momento di speciale densità e magia nel video di Nove maggio di Liberato, girato nel 2017 da Francesco Lettieri. Poco più che una bambina, la giovanissima e carismatica Lia Febbraio, pettinata con una doppia treccia, entra in un negozio di scarpe sportive e timidamente nel buio osserva incantata l’allestimento delle sneakers, ciascuna collocata in una nicchia retroilluminata che ricrea intorno al negozio e alla merce un’atmosfera di sacralità e mistero. La suggestione dell’ambientazione napoletana spinge a rivedere in Lia il profilo di una peccerella che si avventura al cimitero delle Fontanelle o in qualche cripta a venerare la teca di un santo. La critica, parlando di rap e trap, convenzionalmente interpreta la retorica degli status symbol, delle sneakers, degli orologi volgari, delle moto d’acqua, delle ville con piscina e delle macchine costose, come una forma di autobiografia e un racconto di emancipazione dalla povertà e dalle origini, senza però considerare come questa chiave di lettura possa essersi logorata nei decenni o non possa applicarsi ugualmente nello spazio e in contesti diversi. Atlanta non è Milano. E non può esserci emancipazione e libertà -«uscita dallo stato di minorità», direbbe Immanuel Kant- nella glorificazione di un orologio o nella ripetizione ossessiva del nome di un marchio. In realtà quel tipo di poetica, il racconto stereotipato dell’adolescenza nel parchetto in periferia, sembra sempre di più un semplice formulario, un cosiddetto «storytelling» utile a vendere sul mercato una storia, una biografia, ma pure a colmare un’afasia, una reale impossibilità di dire e rappresentarsi. L’elenco dei marchi ha un precedente in letteratura: i romanzi di Brett Easton Ellis. Quando Sfera Ebbasta in una strofa cita l’acqua Evian, la stessa bevuta da Patrick Bateman in American Psycho, l’omaggio diventa sublime, proprio perché realizza un coincidere di poetiche assolutamente puro e involontario. «L’ostentazione fa parte del gioco, da noi c’è ancora un po’ d’ipocrisia», ha dichiarato Linus di Radio Deejay durante un’intervista alla Dark Polo Gang. Forse Linus appartiene a quella fazione di giornalisti che apprezzabilmente, parlando di trap, non intende giudicare il linguaggio e la cultura di un’altra generazione. Tuttavia c’è il rischio di chiamare «ipocrisia» una refrattarietà all’ostentazione che forse risponde soltanto a una delicata e indecifrabile inclinazione dell’essere umano, e cioè il pudore. Nei giorni in cui la rete italiana e il giornalismo web commentavano «Avevo 2 orologi sul palco», ovvero il tweet di Sfera Ebbasta all’indomani della serata del primo maggio, la prestigiosa istituzione organizzatrice del concerto, cioè il sindacato, che rappresenta una forma storicamente incarnata di emancipazione sociale, restava spettacolarmente e tristemente ignorato sullo sfondo, in ombra, non illuminato, dimenticato, rimosso. Che amarezza, che sconfitta. Ma oltre e intorno alla parola e al segno, c’è il suono. Ed è forse nel suono che la trap esprime vera profondità; è nella cucina dei suoni
che costruisce un sapore di sé, compiendo la propria autobiografia e il racconto di una generazione. Perché l’autotune risulta così seducente? Perché ha avuto tanto successo? Forse perché è l’immagine acustica dell’accelerazione tecnologica, ergo illustra e prefigura il farsi digitale della nostra identità e quindi dice qualcosa di molto intimo e decisivo su di noi e il nostro tempo. L’autotune è lo spirito del tempo. La pulsazione dei bassi, profonda come un tonfo, è rapinosa e sensuale. Il sibilo rettile del hi-hat è altrettanto genitale ed erotico. I gomitoli di suoni elettronici incantano grazie a una nuova lingua. La fantasia e l’ardimento sperimentale nella scelta dei campioni, l’asprezza psicotica o la dolcezza acquatica a seconda dei progetti e degli artisti, esprime un coraggio sconosciuto alla produzione culturale italiana nel suo complesso. In ogni caso una generazione dice la sua e in quel preciso istante non ha quasi più importanza che lo faccia parlando in rima di un Rolex o di uno strano cono gelato. In quel momento lo spettro e la voce sono una cosa sola. Immagine di copertina da Metropolitan Magazine ph. Andrea Stevoli Biennale di Venezia: cultura e futura umanità Viva Arte Viva, la 57 edizione della mostra internazionale d’arte della Biennale di Venezia, ha aperto al pubblico il 13 Maggio 2017, dopo i consueti tre giorni di vernissage per professionisti, stampa, addetti ai lavori e frequentatori del mondo dell’arte. Il giro di media e stampa specializzata pre-biennale per addetti ai lavori ha iniziato già a lavorare da prima dell’inaugurazione. Il direttore artistico, la francese Christine Macel, sarebbe secondo i media italiani “giovane” (nata nel 1969, a quasi cinquant’anni in questo paese si è giovani se si ricoprono posizioni direttive). E in più non avrebbe scelto abbastanza artisti italiani per la sua mostra. Verrebbe voglia di costringere i giornalisti e fare dei corsi di aggiornamento su politiche culturali (aperti anche ai burocrati dei ministeri dei Beni Culturali e dell’Università più antiquati del continente europeo): gli artisti italiani sarebbero presenti anche nelle manifestazioni internazionali se si investisse nel sostegno alla produzione e circolazione di cultura contemporanea.
Perché alle biennali internazionali (Venezia in primis) ci si arriva se i direttori artistici vedono il tuo lavoro in giro per il mondo in mostre, altre biennali, festival ecc. Indovinate perché tanti artisti italiani hanno la residenza in Olanda o Belgio? Perché così dopo qualche anno di attività hanno accesso ai sostegni istituzionali per produzione e circolazione. E iniziano a girare in circuiti in cui le Christine Macel di turno avrebbero modo di vederne il lavoro. La mostra di Damien Hirst inaugurata qualche settimana fa a Palazzo Grassi ed a Punta della Dogana (Treasures from the Wreck of the Unbelievable, aperta il 9 Aprile 2017), definita senza mezzi termini “bellissima” o “bruttissima” dai commentatori del settore, ha invece riscaldato le aspettative biennaline degli addetti ai lavori, insieme ai consueti lotti numerici: quanti artisti? Quanti eventi collaterali? Quanti padiglioni nazionali? Quante nazioni alla prima apparizione a Venezia? Quanti padiglioni “nationless”? E soprattutto: quante shoppers dei padiglioni riusciremo ad accaparrarci? E quale padiglione ha fatto la borsa più bella? E a quante feste riusciremo ad infiltrarci? Carichi di tali questioni esistenziali profonde e sentimenti misti, ci siamo avvicinati a Venezia anche con la scottatura post Documenta di Atene ancora ben calda. La progettualità “politica” di uno degli eventi artistici periodici internazionali più influenti del pianeta, giocando sulle recenti vicende economiche del paese in collasso e della durezza dell’Unione Europea capitanata da una inflessibile Germania, proponeva un gesto forte, sulla carta, traslocare ad Atene, “Imparare da Atene”, come recitava il titolo “Learning from Athens”. Ma il contrasto tra la super produzione dell’evento e la povertà evidente della città, la sua incapacità di innestarsi veramente nel tessuto culturale locale presentandosi piuttosto come una astronave aliena pronta all’occupazione militarizzata, avevano più che altro prodotto l’effetto di evidenziare l’incapacità di eventi come questi di avere veramente un impatto sociale (volendo prendere per buone le intenzioni artistiche della mostra e non pensare a una deliberata attività di gentrificazione volta alla “riquaificazione” della città a biechi fini immobiliari). E quindi Viva Arte Viva, con questo titolo leggero e la promessa di occuparsi esclusivamente di opere d’arte, e di farci vivere delle esperienze legate esclusivamente all’arte, ha aperto illudendoci di avere bisogno di una esperienza estetica spensierata e scevra da qualsiasi narrazione. Perché poi pretendere che una operazione finanziaria globale come l’arte contemporanea possa fare intravedere delle soluzioni visionarie ai problemi del nostro pianeta? Dopo la Biennale Arte 2015 curata da un direttore artistico famoso per la sua retorica engagé come Enwezor e dopo l’amarezza di Learning from Athens, la disillusione delle grandi narrazioni sembra spingerci naturalmente a rivalutare la leggerezza, l’importanza della freschezza di una esperienza non mediata dalle nostre configurazioni mentali. Sulla carta inoltre, il lavoro della curatrice senior del Pompidou di Parigi è parso un onesto lavoro di ricerca che qualsiasi curatore dovrebbe fare: molti gli artisti giovani, spesso sconosciuti, e spesso scovati in mostre o biennali meno battute, come quelle di Sharjah o Marrakesh (è il caso di nomi come il marocchino Younes Rahmoun o l’Arabo Hassan Sharif), insieme ad artisti storici (come Rasheed Araeen o Maria Lai). Girare per le sale dell’Arsenale ed il Padiglione centrale dei giardini ha suscitato però impazienza, fastidio, se non proprio rabbia. Difficile leggere la mostra, trovare un significato che unisca le opere e che ci permetta di avere delle linee di senso generali alle quali appigliarsi. Certo, il senso è stato programmaticamente eliminato da un testo curatoriale che propone invece pura esperienza, come detto sopra.
Ma vagando per gli spazi dell’arsenale troppo pieni, troppo carichi (ed anche, purtroppo, davvero organizzati in maniera troppo decorativa), le opere si perdono, insieme alla relazione che dovrebbe mettersi in atto tra queste e noi spettatori. E forse quello che cerca un osservatore è invece una narrazione, che permetta di rintracciare delle linee generali, una lettura del mondo, una maniera di osservare i fenomeni e trarne degli insegnamenti. Tutto, anche lavori storicamente densi ed emozionanti come la documentazione del lavoro fatto ad Ulassai da Maria Lai o “The Circle of Fires” del cileno Juan Downey sembravano parte di una fiera di cose inutili da sorvolare distrattamente. Ma la Biennale non è solo la mostra del direttore artistico, ma anche l’ecosistema di padiglioni nazionali che, dentro ai Giardini, nell’Arsenale ed anche in giro per la città, pullulano e di anno in anno aumentano in maniera esponenziale, rendendo sempre più difficile la visita. Addetti ai lavori e spettatori sono costretti a piegarsi al diktat dell’espansione: un Arsenale sempre più grande, e sempre più riempito di mostre e padiglioni; aperture ed esposizioni in chiese, scuole, ex edifici industriali, palazzi nobiliari. Bisogna correre, cercando di assorbire il più possibile, di registrare dati ed emozioni, di rimanere in piedi, constatando di volta in volta l’impossibilità di avere una esperienza di tutto. E in questo senso la Biennale di Venezia fa anche ragionare sui meccanismi della cultura e sulla sua funzione nella società, non solo quella globale, ma nel caso di Venezia meravigliosa ed assaltata da turisti e nuovi padroni ricchi, anche degli abitanti della città. È vero che anche grazie alla Biennale (di Arte, Architettura, Danza, Musica e Tatro) ed al Festival del Cinema, oltre che alle istituzioni come L’Accademia, lo IUAV e l’Università Ca’ Foscari, la città è riuscita a sopravvivere al collasso economico dal Secondo Dopoguerra, diventando di fatto uno spazio internazionale e di passaggio per studenti, professori, studiosi, artisti e professionisti della cultura di tutto il mondo. Oltre che essere, naturalmente, una meta turistica che attrae ogni anno i milioni di visitatori. Ma è anche vero che il turismo di massa snatura la vita della città e la sta rendendo di anno in anno meno vivibile e meno vissuta: lo svuotamento di Venezia è un fatto. E viene da chiedersi in cosa, il turismo culturale dei grandi eventi come la Biennale che concentra in pochi giorni professionisti della cultura da tutto il mondo, sia diverso da quello dei gruppi di turisti che si aggirano come zombies nelle calli più battute della città, almeno per gli abitanti di Venezia. Certo, ci vestiamo forse un po’ meglio, parliamo parecchie lingue, sappiamo analizzare cinicamente le vetrine kitsch delle gallerie commerciali e dei negozi di grandi firme vicini a San Marco, ma ci aggiriamo ugualmente come alieni che non hanno alcuna relazione con lo spazio urbano che ci circonda e con i suoi abitanti. E quest’ultima è una questione rilevante, soprattutto se leggiamo – nonostante il disimpegno programmatico della Macel – l’arte contemporanea sempre più come spazio di ricerca e di costruzione di immaginari sociali e di modalità di vita quotidiana. Invitato nella mostra principale, Olafur Eliasson fa costruire a studenti e migranti delle lampade. Il suo laboratorio sta nell’edificio chiamato “Padiglione Italia”, al centro dei Giardini della Biennale, ogni lampada viene venduta a un prezzo simbolicamente alto (250 euro) che verrà devoluto a Ong internazionali. Mark Bradford, per il padiglione degli Stati Uniti, lavora con gli i prigionieri di un carcere della città e finanzia un negozio dei loro prodotti. E mentre l’informazione generalista sottolinea come questa Biennale sia “sui migranti” e come l’arte sia “politica”, io mi chiedo se questa spettacolarizzazione abbia davvero un impatto. Oltre, naturalmente, ad alzare la valutazione degli artisti presenti nei padiglioni, nell’esposizione principale
e negli eventi collaterali della Biennale. E mi chiedo anche se sia sostenibile politicamente e culturalmente la Biennale stessa. Se abbia un impatto che vada al di là del numero di turisti culturali che arrivano a Venezia per vederla e le quotazioni degli artisti. Dalla sua nascita, nel 1893, la struttura della Biennale ricordava quella delle esposizioni universali, che presentavano secondo una visione eurocentrica la produzione industriale e culturale mondiale. E se a Parigi si mostrava la Tour Eiffel ed i miracoli dell’ingegneria, a Venezia si mostrava l’arte. Dal 1907 si decide l’organizzazione dei Padiglioni stranieri. Il principio delle rappresentazioni culturali (che erano tutte europee all’inizio che solo nei decenni successivi aprono anche a paesi come l’Egitto ed il Brasile o il Venezuela) è rimasta immutata fino ad oggi, anche se il sistema dell’arte è globalizzato come la finanza e collezionisti e gallerie guardano poco alla nazionalità, a meno che questa serva a commercializzare narrazioni “politiche” sugli artisti (l’artista cubano contro Castro o l’artista cinese che urla libertà). Infatti, il numero dei paesi presenti con un padiglione nazionale è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni perché agenti culturali e governi di paesi emergenti preferiscono essere sul tavolo internazionale, invece di contestare l’impostazione di questa organizzazione che è l’emanazione della seconda rivoluzione industriale europea e di una organizzazione coloniale ed eurocentrica del mondo. La stessa Cuba, che ha inventato la Biennale de L’Avana nel 1984 proprio per contestare il modello Venezia e smascherare il meccanismo eurocentrico della narrazione della storia dell’arte, ha il suo padiglione da qualche edizione. Cui prodest? La vittoria dell’Angola come migliore Padiglione Nazionale nel 2013, anno del suo debutto veneziano, ha in un certo senso aperto una strada. Prodest a quanti vogliono entrare nel mondo dell’arte come “curatori” ed artisti ed essere immediatamente proiettati sotto i riflettori internazionali. E prodest al mercato veneziano di affitto di spazi e servizi. E quindi tra soldi pubblici e sponsors privati, anche Costa D’Avorio, Zimbabwe, e da quest’anno la Nigeria, hanno il loro padiglione. Che significa sostanzialmente affittare un palazzo privato a Venezia per sei mesi (operazione che può costare anche diverse migliaia di euro); pagare tutte le spese di produzione, viaggio, guardiania, comunicazione, curatoria; finanziare un bel festone con fiumi di alcohol, cena VIP e dj; e comprare naturalmente il logo della Biennale per venti mila euro. Questi fondi, insieme a una lettera firmata da un ufficio di qualche ministero di un paese qualsiasi, sono le conditio sine qua non per essere a Venezia. E così capita spesso (e il caso del Padiglione del Kenya del 2013 e 2015 ne sono un esempio) che un imprenditore edile italiano che conosce il meccanismo della Biennale e vive sulla costa del Kenya da decine di anni, riesca a fare un padiglione nazionale del Kenya pieno di artisti cinesi e totalmente privo di qualsiasi ricerca decente sul territorio e relazione con gli artisti del paese. Risultato: scandalo internazionale, la comunità artistica del Kenya ed africana in generale che si indigna, il governo che scrive una lettera dicendo di essere stato truffato, un giro di soldi comunque cospicuo che ha girato tra l’economia locale e quella di chi ha organizzato la farsa, con il bollino della Biennale. Il Diaspora Pavilion o il Research Pavilion che quest’anno vedono la luce, sono un tentativo di ridefinire i limiti della visione nazionale dell’arte e del sistema Biennale. Ma portano questo statement a Venezia e non altrove. Segno che in qualsiasi modo, a quasi 125 anni dalla sua istituzione la Biennale di Venezia, criticata e non, è sempre al centro di speculazioni, interessi e
tentativi di discussione e ridefinizione delle politiche culturali. Immagine di copertina di Martin Parr
Puoi anche leggere