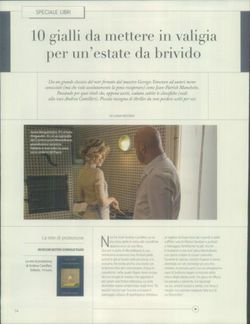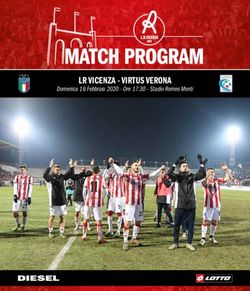La Rivoluzione Lucana del 1860 Tra Progetto,Azione E Mito - Antonio D'Andria History
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
History Antonio D'Andria La Rivoluzione Lucana del 1860 Tra Progetto,Azione E Mito Professorial Dissertation
Bibliographic information published by the German National Library: The German National Library lists this publication in the National Bibliography; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de . This book is copyright material and must not be copied, reproduced, transferred, distributed, leased, licensed or publicly performed or used in any way except as specifically permitted in writing by the publishers, as allowed under the terms and conditions under which it was purchased or as strictly permitted by applicable copyright law. Any unauthorized distribution or use of this text may be a direct infringement of the author s and publisher s rights and those responsible may be liable in law accordingly. Imprint: Copyright © 2018 GRIN Verlag ISBN: 9783668746510 This book at GRIN: https://www.grin.com/document/428526
Antonio D'Andria La Rivoluzione Lucana del 1860 Tra Progetto, Azione E Mito GRIN Verlag
GRIN - Your knowledge has value Since its foundation in 1998, GRIN has specialized in publishing academic texts by students, college teachers and other academics as e-book and printed book. The website www.grin.com is an ideal platform for presenting term papers, final papers, scientific essays, dissertations and specialist books. Visit us on the internet: http://www.grin.com/ http://www.facebook.com/grincom http://www.twitter.com/grin_com
ANTONIO D’ANDRIA
LA RIVOLUZIONE LUCANA
DEL 1860
TRA PROGETTO, AZIONE E MITOIndice Introduzione p. 5 Capitolo Primo Dalla «primavera dei popoli» all’insurrezione p. 9 Capitolo Secondo Il governo dell’emergenza p. 31 Capitolo Terzo La Prodittatura e l’Unificazione tra integrazione e resistenze p. 45 Capitolo Quarto Memoria e rappresentazione del 1860 in Giacomo Racioppi p. 71 Capitolo Quinto Dalla memoria al mito del 1860 tra Ottocento e Novecento: alcuni casi p. 95 Appendice p. 115
4
Introduzione
Nell’ambito del più generale contesto storiografico inerente il processo
di Unificazione nazionale, particolare attenzione riveste, per i ruoli e le
funzioni svolti da gruppi e classi dirigenti nel Mezzogiorno d’Italia ed in
Basilicata, l’insurrezione lucana del 1860, punto terminale del percorso di
unificazione e di concreta partecipazione politica iniziata dal cruciale 1799.
La storia politica e culturale della provincia della Basilicata è senza dubbio
caratterizzata dagli avvenimenti dell’Età napoleonica e dai bienni del 1820-
21, del 1848-49 e del 1860-61 che si inseriscono, con elementi peculiari,
nelle vicende del Mezzogiorno d’Italia soprattutto in riferimento al per-
corso risorgimentale. Essi possono definirsi come “anni d’apertura” verso
l’Italia unita, nei quali la progettualità politica si sposò ad un’azione sem-
pre più concreta ed operante sul e per il territorio provinciale.
Oggi, infatti, nell’ambito di un’accurata delineazione di contesti e
tracciati, generali e locali, di progettualità e di pratica politico-istituzionale
che contraddistinsero il concreto operare sul campo di gruppi e classi
dirigenti, la più recente storiografia ha focalizzato l’attenzione su una serie
di elementi che caratterizzarono il percorso risorgimentale e, in questo
contesto, il determinante periodo compreso tra la «primavera dei popoli» e
l’insurrezione lucana del 1860. In tale contesto, particolare rilievo
assunsero le reti, visibili e invisibili, dell’associazionismo politico sul
territorio, con la compartecipazione, diretta ed indiretta, di singoli e di
gruppi, sul piano della progettualità politica non solo a livello locale, fino
alla centralità della “rivoluzione” e della peculiare esperienza della
Prodittatura del 1860 in Basilicata.
Una provincia peculiarissima, questa, anche per l’immagine mentale che i
viaggiatori e, in genere, il resto degli italiani, avevano di essa: una provincia
quasi del tutto “intatta”, nella quale l’opera dell’uomo aveva solamente
“scalfito” la natura, senza incidervi, ma anzi armonizzandovisi.
Un’immagine di natura incontaminata in una terra quasi utopica, nella
quale il richiamo all’antico trovava «un repertorio di luoghi, una lista di
monumenti, una serie di valori che dovevano costituire una sorta di Campi
5Elisi sottratti […] all’aggressiva presenza della macchina» 1. Così, nel 1847,
Edward Lear visitava la Basilicata alla ricerca di memorie del passato
oraziano e federiciano. Melfi e Castel Del Monte, Venosa e San Michele
del Vulture rientravano nell’osservazione dell’artista britannico, attento
agli aspetti naturali e alle «rovine verdeggianti» in una prospettiva di
paesaggista, volta a mettere in evidenza la solitudine dell’uomo in una
provincia dominata dalla natura, in contrasto con la “civiltà” dei suoi
ospiti. Non a caso, queste sue impressioni “pittoresche” sarebbero apparse
con il titolo di Journal of a Landscape Painter in Southern Calabria (1852) 2.
Aspetti, quelli del contrasto tra la natura quasi “selvaggia” e la bontà
“naturale” dei lucani, evidenziati, in quello stesso anno, da Cesare Malpica
(1804-1852), poeta, romanziere e giornalista capuano che, nel maggio
1847, era partito da Napoli alla volta della Basilicata, visitando centri in cui
risiedevano persone a lui note o allievi che lo avevano invitato a constatare
con i suoi occhi la vita della media ed alta borghesia lucana. Il tutto svolto
in forma giornalistica, con il titolo La Basilicata. Impressioni (1847), questa
volta con particolare attenzione non soltanto agli aspetti paesaggistici,
quanto, piuttosto, a quelli come nel caso di Potenza, di trasformazione e
“redenzione” dell’ambiente, in un particolare momento di attività socio-
economica e politico-istituzionale 3.
Il tragitto di Karl Wilhelm Schnars, medico amburghese, nel novembre-
dicembre 1857, lo condusse dalla Puglia, attraverso nella zona ofantina.
Visitata ampiamente la zona vulturina, lo Schnars, attraverso il capoluogo
della provincia e con una deviazione per il Vallo di Diano, si spinse fino a
Saponara (odierna Grumento Nova) 4. Le rapide annotazioni dello
Schnars, pubblicate con il titolo Eine Reise durch neapolitanische Provinz
Basilicata un die angrenzenden Gegenden (1859) 5, di carattere aneddotico,
Abbreviazioni: ASCP = Archivio Storico Comunale di Potenza; ASFR =
Archivio Storico Filippo Rondinelli; ASP = Archivio di Stato di Potenza; DPL = T.
PEDIO, Dizionario dei Patrioti Lucani. Artefici e oppositori (1700-1870), vol. I. A-C,
Trani 1969; vol. II. D-I, Trani 1972; vol. III. L-O, Bari 1979; vol. IV. P-R, Bari 1990;
vol. V. S-Z, Bari 1990.
1 G. SETTEMBRINO-M. STRAZZA, Viaggiatori in Basilicata (1777-1880), Potenza
2004, p. 263.
2 Trad. it., E. LEAR, Viaggio in Basilicata (1847), Venosa 1990.
3 Cfr. G. SETTEMBRINO-M. STRAZZA, Viaggiatori in Basilicata…, cit., pp. 99-108.
4 Ivi, pp. 137-143.
5 Trad. it., K. W. SCHNARS, La terra incognita. Diario di un viaggiatore tedesco in
6spesso rapide ed essenziali, anche se in molti casi arricchite da dati desunti
dalle descrizioni del Regno e da eruditi locali, danno la misura della
catastroficità (anche a livello socio-economico e culturale) del sisma del
1857. Pubblicate, infatti, con riferimenti al terremoto, si situano al confine
tra la descrizione erudita e l’elegia per un mondo scomparso, una «terra
incognita» paragonata ai luoghi di fiaba della nativa Germania. Nella
Basilicata di metà XIX secolo, infatti, lo Schnars registrò l’immobilità
suggestiva dei luoghi, al di là, forse oltre la grande storia, immemori del
passato e del presente. Le osservazioni erudite sembrano soverchiare, in
effetti, quelle di carattere antropologico e socio-economico, sicché
l’immagine, pur suggestiva, che ne emerge è quella di una terra, appunto,
borderline, ulteriormente separata dal mondo dal tragico terremoto del
1857.
Eppure, come vedremo, in questa provincia apparentemente segregata
dal resto del Regno delle Due Sicilie si sarebbe consumato l’ultimo atto, il
più determinante, dell’Unificazione italiana e del conflitto tra moderatismo
e democratismo, che con il 1860 avrebbe trovato una conclusione solo
apparentemente definitiva, aprendo nuove vie per la lotta politica.
Lotta che, in effetti, aveva contraddistinto la Basilicata fin dal fatale 1799,
un momento di «scoperta della politica» che sarebbe continuato nel
Decennio napoleonico, che, nel quadro di un rideterminato rapporto tra
centro e periferia, anche a livello geografico-territoriale: l’Età napoleonica
nel suo complesso aveva concretizzato riforme appena abbozzate nel
corso del 1799, dalla legge eversiva della feudalità al riassetto territoriale
alla nuova maglia istituzionale-amministrativa nei territori provinciali 6. La
nuova borghesia di tradizione agraria, spina dorsale della nuova classe
dirigente provinciale, la cui condizione sociale si connetteva all’esercizio
delle professioni civili ed impiegatizie, si rafforzò nel Decennio grazie alle
opportunità provenienti dal mercato dei beni ecclesiastici e demaniali,
oltre che dal controllo stesso della gestione amministrativa locale 7,
specchiandosi, infine, nell’autorappresentazione del proprio potere e
impostando le basi per ridiscutere l’assetto economico-sociale provinciale,
come evidente dalla breve stagione rivoluzionaria e costituzionale del
Basilicata, Venosa 1991.
6 A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle due Sicilie, Bologna 1997, p. 41.
7 T. PEDIO, La Basilicata durante la dominazione borbonica, in Primo centenario dello
Stato Italiano contributi e ricerche storiche, a cura dell’Istituto per la storia del
Risorgimento italiano, Matera 1961, pp. 25-157.
71820-21.
Si era, dunque, innescato un processo di conflittualità politica nel quale
non piccola parte ebbero i legami familiari e clientelari, che connotarono
le schermaglie dei diversi schieramenti fin da subito. Dietro la bandiera
democratica e quella moderata, in effetti, si agitarono, lungo tutto il
tortuoso percorso che avrebbe portato all’Unità, schieramenti familiari,
legami economici e socio-culturali e che, esplicitatisi dapprima nel biennio
1848-49 (quando la maturazione delle classi dirigenti consentì maggior
dibattito politico di quanto non fosse avvenuto nell’immaturità del ’20-21),
avrebbero trovato più robusta espressione nell’ultimo triennio del Regno
delle Due Sicilie e, soprattutto, in quel notevole esperimento che fu il
Governo Prodittatoriale Lucano.
Chiusi i giochi, la legittimazione dell’operato dell’una e dell’altra parte
sarebbe passata dal campo di battaglia allo scrittoio, con una fioritura di
memoriali, ricordi, cronistorie, cronache che avrebbe riproposto, certo
con più acredine, la disillusione di quanti avevano agito con alacre lavorio
pensando di ottenere posti di rilievo nell’amministrazione del nascente
Stato unitario. L’autorappresentazione di questi “vinti” avrebbe, dunque,
insistito fortemente sull’«ardore di libertà» e contribuito, come si vedrà
(specie nel primo cinquantenario dell’Unità) alla mitizzazione del 1860
lucano accanto a quello nazionale ed altrettanto oleografico della
propaganda sabauda.
8Capitolo Primo
Dalla «primavera dei popoli» all’insurrezione
1. Dal 1848 alla tragedia di Sanza
L’ampio periodo tra gli snodi delle rivoluzioni del 1820-21 e del 1848-49,
pur se ampiamente riconducibile ad un significativo cambio generazionale,
non mise in discussione l’evoluzione, in senso costituzionale, dello Stato
napoleonico, fermo restando, da parte dei gruppi radicali, «un forte accen-
to sul democratismo della carta di Cadice», mentre, da parte dei moderati,
attestati sul costituzionalismo, il «valore di garanzia», con l’obiettivo di
contemperare le richieste dei nuovi gruppi sociali meridionali con quelli
che erano gli interessi della monarchia 1. Sicché lo stesso progetto federati-
vo sarebbe stato, di fatto, praticato in una logica fondata più
sull’apparenza che sulla sostanza. In tal modo si diluivano nel più grande
ed unificante tema della nazionalità i motivi di tensione tra i patrioti e ciò
spiegherebbe anche la rapidità con la quale, come detto, sia in Sicilia che
sul continente, proprio nel corso della «primavera dei popoli», si assunsero
distanze dal radicalismo, per non rischiare, proprio in nome della causa
nazionale ed in presenza di mobilitazioni di massa, l’estremizzazione del
processo politico-istituzionale 2.
La generazione di Bonaparte aveva, in effetti, lasciato il passo ad una
nuova classe dirigente che espresse, con la «primavera dei popoli» del
1848, un passaggio epocale in vista del 1860. Moderati e democratici,
infatti, avrebbero visto fallire le loro idee ispiratrici e, inevitabilmente,
sarebbero stati costretti a correggere il proprio progetto di pratica politica,
in modo da supportare un programma più attuabile e perseguibile.
I fermenti democratico-costituzionali furono, in effetti, sopiti ma non
spenti nel decennio precedente al 1848: tuttavia, nel Regno delle Due
1 A. DE FRANCESCO, Ideologie e movimenti politici, in Storia d’Italia, a cura di G.
Sabbatucci e V. Vidotto, 1. Le premesse dell’unità, Roma-Bari 1994, p. 281.
2 Ivi, pp. 305-306, 310-311.
9Sicilie, Ferdinando II continuava a negare ogni richiesta liberale e
costituzionale e reprimeva energicamente ogni manifestazione in tal senso,
anche se nei primi anni del suo regno aveva avviato un tentativo di
conciliazione con i sudditi ma, per una serie di disordini, fu costretto ad
abbandonare l’iniziale apertura a favore di un più accentuato paternalismo.
La Sicilia, in questo contesto, scontenta dell’annessione al Regno e mai
veramente accontentata dopo la rivoluzione del 1820-1821, divenne teatro
di un vera e propria rivoluzione: infatti il 12 gennaio del ’48 a Palermo i
manifestanti innalzarono le barricate e riuscirono a impadronirsi della
città 3, tanto che il re, nel tentativo di tamponare l’azione degli insorti
siciliani, il 18 e 19 gennaio emanò una serie di provvedimenti di apertura
alle istanze dei separatisti.
Le notizie raggiunsero inevitabilmente Napoli, provocando una serie di
forti contrasti tra il sovrano ed i sudditi entrarono durante lo stesso mese
di gennaio, finché il 27 un’imponente manifestazione liberale si svolse
nella capitale e gli alti ranghi dell’esercito si rifiutarono di disperdere la
folla. Le circostanze non permettevano ulteriori indugi, sicché il re dovette
concedere la costituzione, che rese nota con l’atto sovrano del 29, con il
quale si impegnava a concedere la carta costituzionale entro dieci giorni e,
nell’occasione, ne anticipava alcuni tratti. L’atto regio del 29 gennaio 1948
fu accolto da manifestazioni di giubilo e affetto dai sudditi, anche nelle
province e l’opinione pubblica europea venne favorevolmente
impressionata dall’apertura democratica di Ferdinando 4, ma il 15 maggio
del 1848 le promesse costituzionali del sovrano borbonico non furono
mantenute, poiché egli non permise la riunione del Parlamento, minando
l’attuazione del programma liberale e decise per l’intervento armato anche
in Sicilia: infatti, nel mese di settembre del 1848 il generale Filangieri
avrebbe conquistato Messina e Palermo e solo l’intervento congiunto di
Francia e Inghilterra portò ad un armistizio pacifico.
L’evoluzione degli avvenimenti italiani ed europei incoraggiavano la
politica reazionaria del Borbone 5, che scelse la linea dura: dopo aver
sciolto le camere il 12 marzo del ’49, facendo, altresì, proseguire
3 M. LACAVA, Cronistoria documentata della rivoluzione in Basilicata del 1860 e delle
cospirazioni che la precedettero, Napoli 1895, pp. 718-719.
4 A. SCIROCCO, Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno, in Storia del
Mezzogiorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, vol. IV/2, Il Regno dagli Angioini ai
Borboni, Napoli 1986, p. 722.
5 Ivi, pp. 744-748.
10Puoi anche leggere