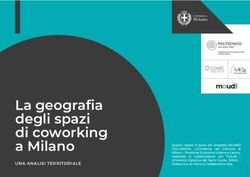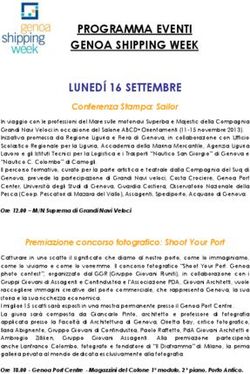LA PRIMA GUERRA MONDIALE - MATURANSIA.it
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. LE CAUSE DELLA GRANDE GUERRA: Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il nazionalismo era stato cruciale per legare le masse allo Stato, proiettando fuori dai confini nazionali le tensioni che agitavano la società, e aveva permesso di attenuare i conflitti di classe, agevolando il controllo sociale, ma aveva anche instillato una marcata aggressività verso l’esterno. Il positivismo e le scoperte scientifiche avevano segnato un netto miglioramento della qualità della vita e un profondo rinnovamento della cultura e della scienza, ma avevano incubato anche i germi del razzismo e della xenofobia. La libera concorrenza aveva spalancato nuovi mercati, ma aveva prodotto anche un’esaltazione della competizione economica. Le innovazioni della seconda rivoluzione industriale avevano favorito uno sviluppo economico, ma avevano messo a punto anche le prime arme di distruzione di massa. Lo Stato era intervenuto nell’economia assumendo per la prima volta la tutela degli interessi pubblici, ma questo aveva anche dilatato le spese militari. LA CORSA AGLI ARMAMENTI: All’ombra dei conflitti innescati dalla competizione imperialistica, si era sviluppata un’affannosa corsa agli armamenti. La Gran Bretagna, ad esempio, investì cifre sempre più ingenti e questo favorì la sua flotta. Il dominio dei mari era un’assoluta priorità strategica. L’ESPANSIONISMO TEDESCO: Tutti i principali protagonisti della Prima Guerra Mondiale, vissero gli anni della vigilia in modo tale da rendere quasi inevitabile lo scoppio delle ostilità. Le forze che erano state protagoniste della costruzione dell’impero tedesco, diventarono sostenitrici di una politica estera più aggressiva e a vasto raggio. Quando nel 1888 salì al trono Guglielmo II, queste forze imperialiste trovarono il proprio punto di raccordo nel pangermanesimo, ossia nel progetto della creazione di una grande Germania, capace di estendere i propri confini fino a contenervi tutti i popoli tedeschi sparsi per l’Europa. L’allestimento di una potentissima flotta da guerra, fu il segnale più esplicito delle ambizioni della Germania. LA RIVALITA’ ANGLO-TEDESCA: Gli storici sono propensi a ritenere la rivalità tra Germania e Gran Bretagna come le vera causa del conflitto mondiale. L’Inghilterra aveva assunto una posizione difensiva, che mirava a preservare la sua leadership mondiale, mentre l’aspirazione della Germania era quella di diventare una potenza globale. Dal punto di vista inglese, la costruzione di una flotta da parte della Germania era una minaccia diretta poiché il controllo degli oceani era una risorsa strategica vitale.
LE DIFFICOLTA’ DEGLI IMPERI MULTINAZIONALI: L’Impero Ottomano su scosso dall’ascesa al potere dei Giovani turchi, un movimento politico costituito da intellettuali e militari, che si era adoperato per rafforzare l’esercito. I Giovani turchi nel 1908 organizzarono un’insurrezione militare, in seguito alla quale ottennero un regime costituzionale. Questa fase di transizione, acuì le aspirazioni indipendentistiche e i progetti espansionistici dei popoli slavi e delle potenze europee. L’Austria-Ungheria decise di annettere al proprio territorio la Bosnia-Erzegovina. Questo passo creò scontento nella Serbia e nella Russia. Nello stesso anno, Creta fu annessa dalla Grecia mentre la Bulgaria ottenne il riconoscimento internazionale della propria indipendenza. In seguito alla guerra persa con l’Italia, l’impero ottomano fu costretto a cedere anche la Libia e il Dodecaneso. Si succedettero poi due guerre balcaniche. LA RUSSIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO: Tra i moti rivoluzionari che alimentarono la Prima Guerra Mondiale, fu quello russo del 1905 ad avere le maggiori conseguenze. Alla fine dell’Ottocento, l’Impero zarista era una grande potenza grazie a tre elementi: la vastità del territorio, il numero degli abitanti e la forza militare. Il problema principale erano i 100 milioni di contadini oppressi da tasse elevate e povertà. I contadini erano organizzati in comunità di villaggio che amministravano i territori dividendoli in quote per famiglie; ma la terra a disposizione non era abbastanza e le tasse non si potevano evadere. Durante il regno degli zar Alessandro III e Nicola II, fu proprio questo denaro ad alimentare lo sviluppo industriale. Sul piano politico la Russia conservava un regime politico autocratico e reazionario. LA RIVOLUZIONE DEL 1905: In Russia cominciarono ad affermarsi i primi partiti: il Partito costituzionale democratico, che rappresentava la borghesia e i nobili progressisti; e i socialisti rivoluzionari, radicati nelle campagne e promotori di rivolte contadine. Sia nelle fabbriche, sia nelle campagne, le tensioni sociali innescate dal processori modernizzazione esplosero nel 1905: lo zar fu costretto a concedere alcune riforme. Fu istituito un parlamento, la Duma, e furono concesse libertà politiche e civili. Il primo ministro varò anche una riforma agraria che prevedeva la frantumazione del mir; nasceva cosi un ceto di contadini ricchi. Per rafforzare il proprio potere, lo zar alimentò una vivace rinascita del nazionalismo.
I PROTAGONISTI FUORI DALL’EUROPA: Tra i protagonisti della Prima Guerra Mondiale fuori dall’Europa, soltanto due ebbero un ruolo significativo: Stati Uniti e Giappone. Gli USA furono l’unica potenza extraeuropea in grado di mettere in capo risorse economiche e apparati militari tali da aspirare ad un posto di rilievo negli equilibri mondiali. Il paese era stato attraversato da uno sviluppo impetuoso che lo portò ad essere il primo produttore di ferro, carbone, petrolio, rame e argento. Inoltre gli Stati Uniti potevano usufruire delle risorse di un’immigrazione massiccia che li trasformò in un melting pot. L’economia restava ancora rurale ma grazie alle tecnologie avanzate, in grado di produrre una grande ricchezza. Già alla fine dell’Ottocento questa prorompente forza economica iniziò a tradursi in un progetto di dominio mondiale. IL GIAPPONE: Il Giappone era stato in grado di partecipare alla competizione imperialistica grazie alla sua capacità di imprimere una brusca accelerazione al processo di modernizzazione delle proprie strutture. Alla fine dell’Ottocento, una serie di riforme disintegrò il volto del vecchio Giappone, investendo istituzioni importanti come la pubblica amministrazione, la scuola, l’esercito. Ad alimentare la modernizzazione fu soprattutto l’incremento della produzione agricola. Furono inoltre i grandi gruppi economici privati, i protagonisti di questa trasformazione, controllando una miriade di filiali industriali e finanziarie. L’imperatore conservava poteri illimitati e le caste militari rimanevano indipendenti dall’autorità politica. Il Giappone si ispirò ai modelli occidentali anche in una politica estera aggressiva, dotandosi di un imponente flotta da guerra. L’INIZIO DELLA GUERRA: Il 28 Giugno 1914 a Sarajevo, Bosnia, lo studente serbo-bosniaco Gavrilo Princip uccise l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco. Dal 1903, sul trono di Serbia era salito Pietro I, fautore di un ambizioso progetto di unificazione di tutti gli slavi della regione, che contava sull’appoggio della Russia. Per queste ragioni, l’annessione della Bosnia-Erzegovina da parte dell’Austria era stata causa di frizione con la Serbia. Tutti diedero per scontata una reazione austriaca che puntualmente arrivò. Il 23 Luglio l’Austria inviò alla Serbia una nota di protesta che esigeva la fine della propaganda antiaustriaca, l’arresto di alcuni sospettati, la partecipazioni di propri poliziotti alle indagini sull’attentato, poi, nonostante la Serbia avesse accettato molte di queste richieste, il 28 Luglio dichiarò guerra. Seguì una vera e propria reazione a catena: - il 30 Luglio la Russia ordinò la mobilitazione generale; - il 1 Agosto la Russia dichiarò guerra agli imperi centrali (Germania e Austria-Ungheria); - il 3 Agosto la Germania dichiarò guerra alla Francia; - il 4 Agosto la Gran Bretagna entrò in guerra a fianco della Francia e della Russia. I duellanti erano quindi: Imperi Centrali (Germania e Austia-Ungheria) contro la triplice intesa (Russia, Francia, Gran Bretagna).
Nel 1914 entrarono in guerra: Giappone a favore dell’Intesa e l’impero Ottomano a favore degli Stati Centrali; nel 1915, l’Italia che si schierò con l’Intesa e sul fronte opposto, la Bulgaria; nel 1916 la Romania seguita nel 1917 da altri sostenitori dell’Intesa: Stati Uniti, Cina e Grecia. I FRONTI DI GUERRA: In Europa i fronti principali di guerra furono due: quello occidentale, dove combatterono i tedeschi contro inglesi e francesi; e quello orientale dove si scontrarono la Germania e l’Austria-Ungheria contro la Russia e la Serbia. Successivamente con l’entrata in guerra di altre potenze, furono aperti altri fronti fuori dal suo confine. I fronti di guerra si estesero anche agli oceani dove la Gran Bretagna grazie alla sua flotta giocò un ruolo fondamentale: bloccare i rifornimenti marittimi agli imperi centrali (guerra sottomarina illimitata dichiarata dalla Germania estesa anche ai paesi neutrali diretti ai porti francesi o inglesi). IL FRONTE OCCIDENTALE: Fu sul fronte occidentale che si iniziò a sparare. La Germania per non essere impegnata su due fronti attaccò la Francia. Il piano Schlieffen prevedeva l’invasione della Francia passando per il Belgio e il Lussemburgo. I due piccoli stati erano neutrali ma questo non impedì ai tedeschi di occuparli. La travolgente offensiva tedesca si arrestò soltanto sul fiume Marna, in una grande battaglia che si trasformò in una carneficina. Dopo un’altra terribile battaglia combattuta nelle Fiandre, il fronte si stabilizzò lungo una linea di 800 km estesa dal canale della Manica alla Svizzera. IL FRONTE ORIENTALE: Anche sul fronte Orientale l’iniziativa dell’attacco fu presa dai tedeschi, che nei primi giorni di guerra fecero registrare due importanti vittorie contro l’esercito russo nelle battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri; i russi invece sconfissero gli austriaci in Galizia. Nella primavera del 1915 proprio dalla Galizia partì una offensiva degli Imperi Centrali che costrinse l’esercito zarista ad arretrare fino alla Beresina. Anche questo fronte si stabilizzò. La sconfitta dei russi e il fallimento della spedizione anglo-francese ebbero ripercussioni sul fronte balcanico: la Serbia accerchiata dalla Bulgaria e dall’Austria fu travolta, poi toccò ad un altro alleato dell’intesa, la Romania. Inattesa fu invece la vittoria dell’esercito Russo. Alla fine del 1916 nessuno dei due schieramenti aveva conseguito vittorie decisive.
L’ITALIA: DALLA NEUTRALITA’ ALLA GUERRA: Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’Italia era ancora legata agli imperi centrali della triplice alleanza, aveva però un valore esclusivamente difensivo. Poiché era stata l’Austria a proclamare guerra alla Serbia, prima l’Italia si dichiarò neutrale, poi si schierò contro la Germania e l’Austria-Ungheria. I neutralisti rappresentavano un vasto schieramento politico in cui confluivano liberali giolittiani, socialisti e la maggioranza dei cattolici; ad affollare il fronte opposto erano invece sindacalisti rivoluzionari, nazionalisti e liberali di destra. Entrambe erano coalizioni ideologicamente variegate: nella prima convivevano pacifismo cattolico e internazionalismo proletario del movimento socialista; nella seconda si intrecciavano i nazionalisti e le aspirazioni dei sindacalisti rivoluzionari. A sostegno della guerra dopo un’iniziale neutralità, si schierò Benito Mussolini. I neutralisti avevano la maggioranza in parlamento ma i nazionalisti erano capaci di accendere le piazze. Alla fine decisiva per lo schieramento affianco all’Intesa fu l’iniziativa della monarchia e del governo Salandra che vedevano nella guerra un modo per riorganizzare la scala sociale. Colloqui segreti portarono a stipulare il trattato di Londra; l’Italia si impegnava ad entrare in guerra in cambio di Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia e Istria, di gran parte della Dalmazia, di Valona e delle isole del Dodecaneso. SULL’ISONZO E SUL CARSO: IL FRONTE MERIDIONALE: Le truppe italiane iniziarono le ostilità contro l’esercito Austro-ungarico il 24 Maggio 1915 attaccando sul fiume Isonzo e sull’altopiano del Carso. Il piano del generale Luigi Cadorna si basava sul tentativo di forzare lo sbarramento austriaco e aprirsi la strada verso i Balcani e il Mediterraneo e porre le premesse territoriali per la trasformazione dell’Italia in una grande potenza. Con la stabilizzazione del fronte anche questa guerra di movimento si trasformò in una guerra di posizione e di trincea. IL FRONTE MEDIORIENTALE E IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI: Nel Medio Oriente, per indebolire la resistenza dell’Impero Ottomano, la Gran Bretagna e la Francia promisero l’indipendenza ai popoli arabi a essi soggetti promuovendo una vasta guerriglia antiturca. Queste promesse non erano però del tutto sincere: segretamente Francia, Russia, Gran Bretagna e Italia si accordarono per spartirsi quei territori dopo la guerra. Inoltre con la dichiarazione Balfour del 1917, il governo inglese fece balneare agli ebrei sionisti la possibilità di avere una loro sede nazionale in Palestina. Nelle retrovie del fronte orientale si ebbe uno dei risvolti più tragici della guerra. Con l’avvento al potere dei giovani turchi a capo dell’impero ottomano,il progetto della costruzione di uno stato etnicamente omogeneo portò al liquidare diverse etnie. Di questo genocidio, gli armeni furono le vittime più numerose.
LA MORTE DI MASSA: Dopo soli due anni su tutti i fronti erano già emersi i tratti che fecero della Prima Guerra Mondiale un’esperienza unica. Tra il 1914 e il 1918 a causa dei combattimenti morirono circa 9 milioni di uomini e tra i 30 e i 40 furono feriti. Cifre enormi a cui vanno aggiunti altrettanti milioni di vittime provocate dalla miseria, dalla fame e dalle malattie. LA TRINCEA: Scavate nella roccia, nel fango e nella sabbia, le trincee furono il simbolo della morte di massa. Chilometri e chilometri di buche e fossati in cui centinaia di migliaia di uomini si affollavano, vivevano e soprattutto morivano. Uno dei concetti tattici basilari usati dagli eserciti nei primi due anni di guerra fu infatti l’impiego dei medesimi reparti fino al conseguimento del risultato utili: le truppe dovevano sapere che non ci sarebbe stato riposo fino a quando non avessero conseguito la propria missione. Le conseguenze di questo criterio erano gravissime: una disponibilità ridotta di uomini freschi al momento dell’attacco, un clima di esasperazione, una ripetizione ossessiva e meccanica degli attacchi, una disperata volontà di auto annientamento. LA GUERRA DEI SOLDATI: Sulla testa dei soldati si schiantavano granate e proiettili di cannoni di grosso calibro. In questo sconvolgente impatto con la realtà della nuova guerra tecnologica e moderna, i soldati impararono a morire ma anche ad uccidere. I combattenti diventarono partecipi di un’esperienza che plasmava tutti secondo tratti comuni, che comprendevano anzitutto un senso di estraniazione psicologica e sociale nei confronti delle abitudini della vita civile. Nelle trincee si viveva anche con i cadaveri, il tanfo della decomposizione pervadeva il fronte intero. LE NUOVI ARMI: Un altro tratto che contraddistinse la prima guerra mondiale fu la straordinaria efficienza tecnologica delle armi. In particolare il potenziale distruttivo più alto fu quello dell’artiglieria. Molto efficienti si rivelarono anche le mitragliatrici. Gli straordinari progressi della chimica permisero l’invenzione di terrificanti armi: gli esplosivi ad alto potenziale e i gas tossici. Fu in quella guerra che si sperimentarono nuovi strumenti di offesa come l’aereo, il carro armato e i sottomarini. L’INDUSTRIA E IL RUOLO DELLO STATO: Proprio lo sviluppo di armi cosi distruttive evidenziò come la vittoria dipendeva dal potenziale economico-industriale dello stato. In questo senso, la prima guerra mondiale, servì all’Italia per dotarsi di un adeguata industria meccanica. Con i profitti aumentarono anche l’occupazione e la produzione di tipo militare e civile (ad esempio le automobili) con il decollo di un industria aereonautica competitiva a livelli internazionali.
L’intervento dello stato nell’economia conobbe un’espansione senza precedenti in tutti i paesi coinvolti nel conflitto. Per sostenere il rafforzamento degli apparati industriali,lo stato divenne il principale committente. Per alimentare la spesa pubblica si imposero nuove tasse, si chiesero prestiti internazionali, fu stampata una valanga di carta moneta che provocò un’impennata dell’inflazione. Affiorò un’economia basata su un rapporto triangolare di collaborazione tra Stato, industriali e sindacati. LA POLITICA: Lo stato di guerra provocò in tutti i paesi una diminuzione del potere dei parlamenti e l’aumento di quello dei governi e dei militari. Anche in Italia si varò un governo di unità nazionale guidato da Paolo Boselli. I paesi dove si ebbero le limitazioni più forti furono quelli dove i poteri del parlamento erano sempre stati deboli: la Germania e l’Austria- Ungheria. IL FRONTE INTERNO: Il controllo imposto sulla società riguardò anche la stampa che fu sottoposta a un’attenta censura, finalizzata a diffondere un’immagine eroica della guerra tacendo gli aspetti più cruenti. Al controllo della stampa si affiancò un’azione di propaganda che attraverso giornali, manifesti murali, cartoline, richiamava la popolazione civile a fare disciplinatamente la propria parte per sostenere lo sforzo bellico, nel lavoro, nella sottoscrizione per raccogliere fondi, nella sopportazione dei lutti e dei sacrifici. Con gli uomini mandati al fronte, la maggior parte dei destinatari di questi messaggi erano le donne. Le donne divennero infermiere e dovettero sostituire gli uomini nei campi e nelle fabbriche. IL 1917, LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA E L’INTERVENTO DEGLI STATI UNITI: STANCHEZZA E MALCONTENTO: Le popolazioni civili furono direttamente interessate alla guerra anche perché subirono le sue ripercussioni nella vita quotidiana. Ad esempio il blocco navale attuato dall’Intesa strangolò l’economia tedesca. Nell’inverno 1916 un pessimo raccolto di patate, alimento base della popolazione, rese la situazione alimentare drammatica: oggi si calcola che un milione di tedeschi sia morto per cause legate alla fame e alla sottoalimentazione. Anche in Italia le condizioni alimentari diventarono difficili. In alcune zone la razione giornaliera di pane scese a 125 g e spesso dalla dieta erano del tutto assenti i grassi. Talora la rabbia popolare per questa situazione esplose in aperte rivolte lasciando emergere una chiara richiesta di pace. Le grandi coalizioni patriottiche si sfaldarono. La popolazione civile in diversi stati diede vita a scioperi e sommosse. Tra tutte le voci di protesta, la più clamorosa fu quella di papa Benedetto XV che condannò apertamente la guerra definendola un’inutile strage.
L’ITALIA IN GUERRA: LA DISFATTA DI CAPORETTO: Per l’Italia, il 1917 fu un anno particolarmente drammatico per la gravissima sconfitta di Caporetto. Il 24-26 ottobre l’esercito italiano, attaccato da ingenti truppe austro-tedesche, dovette ripiegarsi abbandonando al nemico il Friuli e parte del Veneto. Gli Austriaci penetrarono in profondità in un’offensiva che si fermò solo sulla linea del fiume Piave. In un solo colpo, gli italiani persero tutti i vantaggi territoriali faticosamente strappati in due anni di guerra. Per preparare la resistenza e la riorganizzazione dell’esercito, il nuovo governo, a Boselli era subentrato Orlando, fece grandi promesse ai contadini in armi quali l’assegnazione di terre, l’assistenza delle famiglie, facilitazioni sulle licenze, aumentò il vitto, rinnovò l’equipaggiamento. L’industria lavorò a ritmi sterrati per colmare i vuoti delle perdite subite. Gli Austriaci furono fermati. Il generale Armando Diaz, successore di Cardona ebbe un compito fondamentale: colmare l’abisso che la sconfitta aveva scavato tra ufficiali e soldati. LA VITTORIA FINALE: Ora, si faceva leva non più sull’espansione territoriale, ma sulla necessità di difendere il territorio nazionale invaso dal nemico. Ci si rivolgeva alle varie popolazioni dell’impero austro-ungarico, alla ricerca del loro aiuto politico-militare in una sorta di guerra di liberazione nazionale da condurre al fianco del nostro esercito. Anche i criteri operativi dei militari si adeguarono alla nuova fase: all’offensivismo di Caradona si sostituì la strategia difensiva di Diaz. Le truppe italiane diedero segni di ripresa e questi divennero evidenti con la battaglia del Piave e l’offensiva finale, scatenata il 24 ottobre e conclusasi vittoriosamente con la rotta generale delle truppe austriache a Vittorio Veneto e su tutto il fronte. Il 4 novembre 1918 fu firmato l’armistizio che sancì la fine delle ostilità e la vittoria italiana.
LE CIFRE DELLA GUERRA: In poco più di tre anni di guerra, dalla parte italiana caddero 16800 ufficiali e 57100 soldati. Era morto un ufficiale ogni 34 soldati. Tra le varie armi, la fanteria era stata quella più colpita. Per quanto riguarda l’estrazione sociale, una statistica particolare, quella degli orfani, vedeva al primo posto le famiglie contadine seguite da quelle degli operai non agricoli. Il prezzo pagato dalle classi più povere era nettamente più alto di quello delle altre classi. DALLA GUERRA ALLA PACE: LA DISFATTA DEGLI IMPERI CENTRALI: Negli stessi giorni della vittoria italiana, la guerra stava finendo anche sugli altri fronti. Su quello occidentale i tedeschi attaccarono in massa nelle regioni della Piccardia e dello Champagne. Le truppe anglo-francesi, rafforzate da un contingente americano di un milione di uomini, respinsero gli attacchi e scatenarono una controffensiva, costringendo i tedeschi a ritirarsi dal Belgio e dalla Francia. Dopo la battaglia di Amiens, le speranze di vittoria della Germania si dileguarono definitivamente. Sugli altri fronti gli alleati della Germania furono sconfitti uno dopo l’altro. LA RESA DELLA GERMANIA: Solo la Germania rimase ancora in piedi. Furono i rivolgimenti interni a sancirne il crollo definitivo: il 30 ottobre 1918 si ammutinarono i marinai della flotta e il moto rivoluzionario si propagò immediatamente a Brema, Amburgo, Lubecca e Berlino. Il 9 Novembre a Berlino fu proclamata la repubblica. Il nuovo governo firmò l’armistizio l’11 Novembre 1918. La guerra era finita esattamente come era iniziata: alle operazioni militari si intrecciavano rivolgimenti interni, spinte indipendentistiche e moti rivoluzionari. Dopo poco tempo la Germania crollò sotto l’urto della crisi politica interna. Appariva ormai chiaro che la guerra non era legata soltanto ad aspirazioni di conquista territoriale, ma anche a progetti politici di trasformazioni della società. LA PACE: I RISULTATI La conferenza di pace si aprì a Parigi il 18 Gennaio 1919 con la partecipazione dei trentadue stati vincitori e senza i rappresentanti dei paesi sconfitti. Ci furono 14 punti elaborati da Wilson: pace definitiva, libero scambio, libertà di navigazione fuori dalle acque territoriali, disarmo, rispetto delle nazionalità e del diritto dei popoli dell’autodecisione, costituzione di un’associazione generale delle nazioni in senso alla quale dovevano essere
discussi e risolti pacificamente i dissidi internazionali. In realtà la pace fu modellata secondo gli interessi nazionali. Il trattato di pace con i tedeschi fu firmato a Versailles il 18 Giugno 1919. La Germania fu costretta a: - cedere tutte le colonie; - restituire l’Alsazia e la Lorena alla Francia, perdendo anche l’Alta Slesia, la Posnania e il corridoio di Danzica in favore della Polonia; i distretti di Eupen e Malrndv furono dati al Belgio; - pagare pesantissime riparazioni di guerra; - concedere alla Francia per quindici anni il bacino minerario della Saar. Alla Germania fu inoltre imposto: - il divieto di costruire aeroplani, artiglieria pesante e carri armati; - l’obbligo di smilitarizzare la Renania; - l’abolizione della coscrizione obbligatoria e la riduzione dell’esercito. La pace tra l’intesa e l’Austria venne firmata il 10 Settembre 1919: dalle macerie dell’Impero asburgico nascevano stati indipendenti: l’Austria, l’Ungheria, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia. Anche l’impero ottomano si dissolse, con la Turchia ridotta alla sola Costantinopoli e all’Anatolia settentrionale. Fu infine varata la Società delle Nazioni, con sede a Ginevra; ne restò esclusa la Germania.
Puoi anche leggere