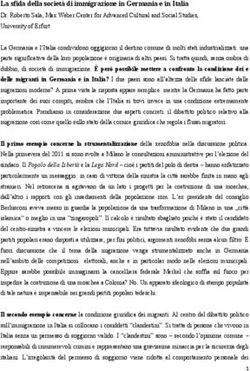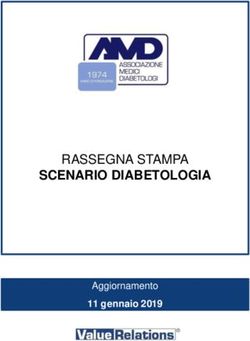L'ANTOLOGIA SOCIALE DI PAPA BENEDETTO - Modello economico e crisi nelle parole di Ratzinger
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’ANTOLOGIA SOCIALE DI PAPA BENEDETTO
Modello economico e crisi nelle parole di Ratzinger
www.vita.it 1
www.vita.itLa crisi «Si conferma nell’attuale crisi economica quanto è già apparso nella precedente grande crisi, che la dimensione etica, cioè, non è una cosa esteriore ai problemi economici, ma una dimensione interio- re e fondamentale. L’economia non funziona solo con un’autorego- lamentazione di mercato, ma ha bisogno di una ragione etica per funzionare per l’uomo. E appare di nuovo quanto aveva già detto nella sua prima enciclica sociale Papa Giovanni Paolo II, che l’uomo dev’essere il centro dell’economia e che l’economia non è da misu- rare secondo il massimo del profitto, ma secondo il bene di tutti, include responsabilità per l’altro e funziona veramente bene solo se funziona in modo umano, nel rispetto dell’altro. E con le diverse dimensioni: responsabilità per la propria Nazione e non solo per se stessi; responsabilità per il mondo – anche una Nazione non è isolata, anche l’Europa non è isolata, ma è responsabile per l’inte- ra umanità e deve pensare ai problemi economici sempre in questa chiave della responsabilità anche per le altre parti del mondo, per quelle che soffrono, hanno sete e fame, non hanno futuro. E quindi – terza dimensione di questa responsabilità – è la responsabilità per il futuro. Sappiamo che dobbiamo proteggere il nostro pianeta, ma dobbiamo proteggere – tutto sommato – il funzionamento del ser- vizio del lavoro economico per tutti e pensare che il domani è anche l’oggi. Se i giovani di oggi non trovano prospettive nella loro vita, anche il nostro oggi è sbagliato e “male”». Risposte ai giornalisti, Madrid, 18 agosto 2011 www.vita.it 2
Lo spread sociale Se preoccupa l’indice differenziale tra i tassi finanziari, dovrebbero destare sgomento le crescenti differenze fra pochi, sempre più ric- chi, e molti, irrimediabilmente più poveri. Si tratta, insomma, di non rassegnarsi allo “spread del benessere sociale”, mentre si com- batte quello della finanza. Discorso al Corpo diplomatico, 8 gennaio 2012 Imprenditorialità sociale, economia civile Nel contesto di questo discorso è utile osservare che l’imprendito- rialità ha e deve sempre più assumere un significato plurivalente. La perdurante prevalenza del binomio mercato-Stato ci ha abituati a pensare esclusivamente all’imprenditore privato di tipo capitalisti- co da un lato e al dirigente statale dall’altro. In realtà, l’imprendito- rialità va intesa in modo articolato. Ciò risulta da una serie di mo- tivazioni metaeconomiche. L’imprenditorialità, prima di avere un significato professionale, ne ha uno umano. Essa è inscritta in ogni lavoro, visto come « actus personae », per cui è bene che a ogni la- voratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso « sappia di lavorare “in proprio” » . Non a caso Paolo VI insegnava che « ogni lavoratore è un creatore ». Proprio per ri- spondere alle esigenze e alla dignità di chi lavora, e ai bisogni della società, esistono vari tipi di imprese, ben oltre la sola distinzione tra « privato » e « pubblico ». Ognuna richiede ed esprime una capa- cità imprenditoriale specifica. Al fine di realizzare un’economia che nel prossimo futuro sappia porsi al servizio del bene comune na- zionale e mondiale, è opportuno tenere conto di questo significato www.vita.it 3
esteso di imprenditorialità. Questa concezione più ampia favorisce lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie di im- prenditorialità, con travaso di competenze dal mondo non profit a quello profit e viceversa, da quello pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di sviluppo. Caritas in veritate, n.41 L’economia cooperativa La cooperazione nel suo significato più profondo indica l’esigenza della persona di associarsi per conseguire, insieme con gli altri, nuo- vi traguardi nell’ambito sociale, economico, culturale e religioso. Si tratta di una realtà dinamica e variegata, chiamata non solo a dare risposte ad esigenze immediate e materiali, ma a concorrere alla prospettiva di ogni comunità. Dando la dovuta priorità alla dimensione umana le cooperative pos- sono superare il profilo esclusivamente tecnico del lavoro agricolo, ne rivalutano la centralità nell’attività economica e così favoriscono risposte adeguate alle reali necessità locali. Si tratta di una visione alternativa a quella determinata da misure interne e internazionali che sembrano avere come unico obiettivo il profitto, la difesa dei mercati, l’uso non alimentare dei prodotti agricoli, l’introduzione di nuove tecniche di produzione senza la necessaria precauzione. Di fronte a una richiesta di cibo sempre più ampia, che necessa- riamente congiunge qualità e quantità degli alimenti, il lavoro del- le cooperative agricole può rappresentare qualcosa in più di una semplice aspirazione, mostrando in concreto un modo possibile www.vita.it 4
per soddisfare la domanda di una popolazione mondiale anche in crescita. Una loro presenza sempre più consolidata, poi, può porre fine alle tendenze speculative che ormai toccano persino i generi di prima necessità destinati all’alimentazione umana e arginare l’acca- parramento delle aree coltivabili che in diverse regioni costringono i contadini ad abbandonare le loro terre poiché singolarmente non hanno alcuna possibilità di far valere i loro diritti. Messaggio giornata mondiale dell’Alimentazione, 2012 Cooperazione internazionale La cooperazione allo sviluppo non deve riguardare la sola dimen- sione economica; essa deve diventare una grande occasione di in- contro culturale e umano. Se i soggetti della cooperazione dei Paesi economicamente sviluppati non tengono conto, come talvolta av- viene, della propria ed altrui identità culturale fatta di valori umani, non possono instaurare alcun dialogo profondo con i cittadini dei Paesi poveri. Se questi ultimi, a loro volta, si aprono indifferente- mente e senza discernimento a ogni proposta culturale, non sono in condizione di assumere la responsabilità del loro autentico sviluppo [139]. Le società tecnologicamente avanzate non devono confon- dere il proprio sviluppo tecnologico con una presunta superiorità culturale, ma devono riscoprire in se stesse virtù talvolta dimenti- cate, che le hanno fatte fiorire lungo la storia. Le società in crescita devono rimanere fedeli a quanto di veramente umano c’è nelle loro tradizioni, evitando di sovrapporvi automaticamente i meccanismi della civiltà tecnologica globalizzata. Caritas in veritate, n.59 www.vita.it 5
Microfinanza Anche l’esperienza della microfinanza, che affonda le proprie radici nella riflessione e nelle opere degli umanisti civili — penso soprat- tutto alla nascita dei Monti di Pietà –, va rafforzata e messa a punto, soprattutto in questi momenti in cui i problemi finanziari posso- no diventare drammatici per molti segmenti più vulnerabili della popolazione, che vanno tutelati dai rischi di usura o dalla dispera- zione. I soggetti più deboli vanno educati a difendersi dall’usura, così come i popoli poveri vanno educati a trarre reale vantaggio dal microcredito, scoraggiando in tal modo le forme di sfruttamento possibili in questi due campi. Poiché anche nei Paesi ricchi esistono nuove forme di povertà, la microfinanza può dare concreti aiuti per la creazione di iniziative e settori nuovi a favore dei ceti deboli della società anche in una fase di possibile impoverimento della società stessa. Caritas in veritate, n.65 Gruppi d’acquisto Anche nel campo degli acquisti, proprio in momenti come quelli che si stanno sperimentando, in cui il potere di acquisto potrà ridursi e si dovrà consumare con maggior sobrietà, è necessario percorrere altre strade, come per esempio forme di cooperazione all’acquisto, quali le cooperative di consumo, attive a partire dall’Ottocento anche grazie all’iniziativa dei cattolici. È utile inoltre favorire forme nuo- ve di commercializzazione di prodotti provenienti da aree depresse del pianeta per garantire una retribuzione decente ai produttori, a condizione che si tratti veramente di un mercato trasparente, che www.vita.it 6
i produttori non ricevano solo maggiori margini di guadagno, ma anche maggiore formazione, professionalità e tecnologia, e infine che non s’associno a simili esperienze di economia per lo sviluppo visioni ideologiche di parte. Un più incisivo ruolo dei consumatori, quando non vengano manipolati essi stessi da associazioni non ve- ramente rappresentative, è auspicabile come fattore di democrazia economica. Caritas in veritate, n.66 La buona impresa Nessuno ignora quanti sacrifici occorre affrontare per aprire o tene- re nel mercato la propria impresa, quale “comunità di persone” che produce beni e servizi e che, quindi, non ha come unico scopo il pro- fitto, peraltro necessario. In particolare le piccole e medie imprese risultano sempre più bisognose di finanziamento, mentre il credito appare meno accessibile ed è molto forte la concorrenza nei mercati globalizzati, specie da parte di quei Paesi dove non vi sono – o sono minimi – i sistemi di protezione sociale per i lavoratori. Ne deriva che l’elevato costo del lavoro rende i propri prodotti e servizi meno competitivi e sono richiesti sacrifici non piccoli per non licenziare i propri lavoratori dipendenti e consentire ad essi l’aggiornamento professionale. In tale contesto, è importante saper vincere quella mentalità indi- vidualistica e materialistica che suggerisce di distogliere gli inve- stimenti dall’economia reale per privilegiare l’impiego dei propri capitali nei mercati finanziari, in vista di rendimenti più facili e più rapidi. Mi permetto di ricordare che invece le vie più sicure per con- www.vita.it 7
trastare il declino del sistema imprenditoriale del proprio territorio consistono nel mettersi in rete con altre realtà sociali, investire in ricerca ed innovazione, non praticare un’ingiusta concorrenza tra imprese, non dimenticare i propri doveri sociali ed incentivare una produttività di qualità per rispondere ai reali bisogni della gente. Esistono varie riprove che la vita di un’impresa dipende dalla sua attenzione a tutti i soggetti con cui intesse relazioni, dall’eticità del suo progetto e della sua attività. La stessa crisi finanziaria ha mo- strato che entro un mercato sconvolto da fallimenti a catena, han- no resistito quei soggetti economici capaci di attenersi a comporta- menti morali e attenti ai bisogni del proprio territorio. Il successo dell’imprenditoria italiana, specie in alcune regioni, è sempre stato caratterizzato dall’importanza assegnata alla rete di relazioni che essa ha saputo tessere con i lavoratori e con le altre realtà impren- ditoriali, mediante rapporti di collaborazione e di fiducia recipro- ca. L’impresa può essere vitale e produrre “ricchezza sociale” se a guidare gli imprenditori e i manager è uno sguardo lungimirante, che preferisce l’investimento a lungo termine al profitto specula- tivo e che promuove l’innovazione anziché pensare ad accumulare ricchezza solo per sé. Discorso agli industriali, 18 marzo 2010 Cesare e Dio «Rendi a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» fu la ri- sposta di Gesù quando gli fu chiesto ciò che pensava sul pagamento delle tasse. Quelli che lo interrogavano, ovviamente, volevano ten- dergli una trappola. Volevano costringerlo a prendere posizione nel www.vita.it 8
dibattito politico infuocato sulla dominazione romana nella terra di Israele. E tuttavia c’era in gioco ancora di più: se Gesù era realmente il Messia atteso, allora sicuramente si sarebbe opposto ai domina- tori romani. Pertanto la domanda era calcolata per smascherarlo o come una minaccia per il regime o come un impostore. La risposta di Gesù porta abilmente la questione ad un livello superiore, met- tendo con finezza in guardia nei confronti sia della politicizzazio- ne della religione sia della deificazione del potere temporale, come pure dell’instancabile ricerca della ricchezza. Articolo per il Financial Times, 20 dicembre 2012 www.vita.it 9
Puoi anche leggere