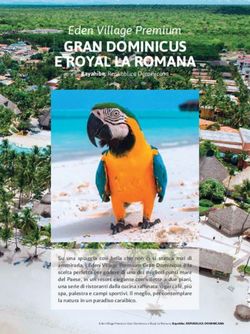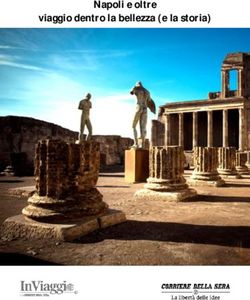Milano anni '50 - '60 crocevia della Cultura - ALDAI Gruppo - Federmanager ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA LETTERATURA ITALIANA AL TEMPO DEL BOOM ECONOMICO
Introduzione (1 di 2)
Il secondo dopoguerra è un'epoca di fervori, di entusiasmi, di rinati
fermenti culturali.
Giovani generazioni di poeti e di scrittori maturano al fuoco di questa
stagione, legandosi in particolare a certe città o a certi centri culturali.
Accanto ad essi mantengono una costante creatività e vitalità autori che
si erano formati nel primo Novecento e che, attraversata la profonda crisi
della dittatura e della guerra, si ripropongono da protagonisti.
Lo stretto legame della Letteratura italiana del periodo con Milano è
dovuto al fatto che più del 70% delle case editrici sono presenti sul suo
territorio: Milano diventa la capitale dell'editoria.LA LETTERATURA ITALIANA AL TEMPO DEL BOOM ECONOMICO
Introduzione (2 di 2)
Molti scrittori, pur non essendo nati a Milano, vi trascorsero periodi della
loro vita per poter sviluppare la loro carriera artistica, poiché Milano negli
anni '60 era una eccezionale “macchina culturale”.
La Milano del boom economico è stata anche una grande fonte di
ispirazione per scrittori, commediografi, pittori e registi che ne hanno
raccontato la vita che si esprimeva nelle fabbriche, nelle balere, nelle
polisportive, nei bar e nei quartieri di periferia.LA LETTERATURA ITALIANA AL TEMPO DEL BOOM ECONOMICO
Il periodo che si prende in considerazione: gli anni 50-60
Suddiviso in due fasi:
●la prima (1945-1956) che corrisponde all'epoca della
“ricostruzione”dopo gli immensi disastri provocati dalla seconda guerra
mondiale;
●la seconda (1956-1968), quella del “miracolo economico” fino agli
anni intorno al '68 che sono caratterizzati da profondi movimenti sociali e
politici di contestazione.LA LETTERATURA ITALIANA AL TEMPO DEL BOOM ECONOMICO
“La ricostruzione”
Gli anni che seguono la fine della guerra in Italia sono caratterizzati
dall'entusiasmo per il rovesciamento della dittatura, per il ritorno alla
libertà e per la fiducia nel rinnovamento del paese.
Questo clima si riflette anche nella letteratura, attraverso l'insofferenza
verso la produzione che aveva caratterizzato i decenni precedenti, e in
particolare l'ermetismo e il decadentismo, di cui vengono stigmatizzati il
culto della forma, la concezione aristocratica dell'arte, il lirismo evasivo.LA LETTERATURA ITALIANA AL TEMPO DEL BOOM ECONOMICO
Il Neorealismo
Viceversa, diventa sempre più forte l'idea che l'intellettuale abbia una
responsabilità civile e sociale, e che il suo compito sia quello di prendere
contatto con la realtà del paese, così da arrivare a conoscerne
chiaramente i problemi e contribuire alla loro soluzione.
Si rimette in moto una concezione della letteratura segnata
dall'impegno politico-civile, che avrà nel NEOREALISMO il suo
momento culminante.IL NEOREALISMO 7
IL SUPERAMENTO DEL NEOREALISMO
Numerosi autori si allontanano progressivamente dall'esperienza del
Neorealismo per soddisfare il bisogno di una più originale e matura
ricerca letteraria, anche attraverso l'elaborazione di uno stile inedito e
personale.
Il Neorealismo sarà spazzato via dallo sperimentalismo proposto dalle
nuove tendenze letterarie che si affermeranno alla fine degli anni '50 e
all'inizio degli anni '60 (Pasolini, poeti “novissimi”, riviste Officina
e Il Verri).
8IL SUPERAMENTO DEL NEOREALISMO
AUTORE CARATTERISTICHE
Elio Vittorini Parte da episodi di cronaca per offrire riflessione generale della
storia e del destino umano. Descrizione cruda, oggettiva e momenti
lirici.
Cesare Pavese Realismo:nella scelta di temo, ambienti, lingua, stile + Simbolismo:
supera i dati oggettivi per un'interpretazione metaforica della realtà.
Alberto Moravia Neorealismo: celebrazione vitalità popolare vs decadenza borghesia;
anni '60: impossibilità costruire rapporti umani autentici. Mescolanza
realismo e fantasia.
Pier Paolo Pasolini Descrive l'ambiente del sottoproletariato nelle borgate romane
celebrandone il vitalismo e l'autenticità, in polemica opposizione alla
degradazione della società dei consumi.
Leonardo Sciascia Impegno civile: analizza la condizione di arretratezza del Meridione,
denunciando soprattutto i fenomeni di tipo mafioso; scrittura che
mira alla chiarezza.
Italo Calvino Tema Resistenza senza toni retorici; filone fantastico-allegorico: tono
fiabesco per esprimere significati storico-politici; filone realistico:
problemi legati alla società neocapitalistica.
Carlo Emilio Gadda Sarcasmo che smaschera l'ipocrisia della borghesia; sperimentalismo
linguistico e stilistico (pastiche). Quer pasticciaccio brutto de via
Merulana (1957) inaugura una stagione di forti sperimentazioni
9IL PANORAMA CULTURALE ITALIANO
Principali istituzioni culturali
EDITORIA GIORNALI TELEVISIONE ISTRUZIONE
●creazione di una hanno un pubblico principale mezzo di
●
●
istituzione scuola
●
vera e propria ancora ristretto (1 comunicazione di
media unica (1962)
industria editoriale copia ogni 10 massa
abbonamenti)
è in grado di avviamento del
●
settore dominato
●
●
condizionare le processo di
dalle
opinioni, i consumi e scolarizzazione di
grandi case editrici
il linguaggio del massa)
pubblico
●scelte editoriali
influenzate dalle
leggi del mercatoLA CULTURA ITALIANA TRA METÀ ANNI '50 E INIZIO ANNI '70
Viene meno l'entusiasmo del neorealismo: la letteratura italiana si muove
tra il recupero della tradizione e la ricerca.
Importante ruolo delle riviste:
●Il Menabò (1959) di Vittorini e Calvino: produzione di consumo vs
letteratura impegnata; temi legati a nuova società.
●Officina (1956-59) di Leonetti, Pasolini, Roversi: rinnovamento formale
che non prescinda dalla tradizione e tenga conto della realtà.
●Il Verri (1956) di Anceschi: apertissima a ogni sperimentazione (teorie
●della Neoavanguardia).LA NARRATIVA DEGLI ANNI '60
GENERE AUTORI CARATTERISTICHE
Prime esperienze neorealiste, ma poi si
Romanzo di consumo Carlo Cassola volgono verso forme più libere e meno
(ripresa della narrativa tradizionale; Giorgio Bassani impegnate; alcuni mostrano
racconti ben confezionati che ritraggono Dino Buzzati predisposizione per il racconto
storie intimistiche, esperienze di viaggio, Mario Soldati grottesco/fantastico (influsso
favole, Alberto Moravia surrealistico)/umoristico.
vicende irreali in mondi lontani o Scrittori borghesi che scrivono sulla
immaginari) borghesia
●guasti del miracolo economico
P.P. Pasolini ●analizzano il mondo della fabbrica, i suoi
Romanzo di critica sociale Ottiero Ottieri meccanismi produttivi e le ripercussioni
Paolo Volponi sul piano della psicologia sociale e delle
(letteratura industriale)
Lucio Mastronardi abitudini di vita
Nanni Balestrini ●nuove forme narrative per adeguarsi ai
radicali cambiamenti sociali e culturali
degli anni '60
●confronto con epoche passate per
Già nel 1958 Giuseppe Tomasi di comprendere meglio i problemi del
Lampedusa con Il Gattopardo presente
Romanzo storico Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta ●diverse concezioni della storia:
1961 ripetizione inevitabile di errori/fuga dal
presente
●violenta reazione contro la letteratura
Giorgio Manganelli consumistica
Narrativa della Neoavanguardia Edoardo Sanguineti ●scelgono ottica degradata della
Luigi Malerba quotidianità
(Gruppo 63)
Alberto Arbasino ●dissoluzione della trama tradizionaleLa letteratura industriale Definizione: per letteratura industriale si intende un insieme di opere omogenee per area tematica nate negli anni in cui l'Italia abbandona l'economia agricolo- artigianale per compiere il passo verso l'industrializzazione. ●E', quindi, strettamente collegata all'industrializzazione e al conseguente formarsi della classe operaia. Il dibattito teorico su definizione e aspetti della letteratura d'industria fu lanciato nel 1961 sulle pagine del Menabò di letteratura n.4, la rivista fondata e diretta da Elio Vittorini e Italo Calvino, e continuò nell'anno successivo senza tuttavia arrivare ad una rigorosa definizione di genere. La discussione si concentrò sui temi ● ● - dell'alienazione causata dal lavoro seriale meccanizzato e parcellizzato, ● - del ruolo dello scrittore ● - dell'aspetto formale ●Vittorini:“[...] E lo scrittore, tratti o no della vita di fabbrica, sarà a livello industriale solo nella misura in cui il suo sguardo e il suo giudizio si siano compenetrati di questa verità e delle istanze […] ch'essa contiene”.
L'unico modo di esprimere efficacemente i problemi della società industriale è quello di
ricorrere ad una letteratura di avanguardia che utilizzi lo stesso linguaggio alienato in cui il
mondo si esprime.
Tra i rinnovamenti linguistici più significativi ci fu la messa in circolazione di termini
tecnici appartenenti al mondo del lavoro e di varietà linguistiche informali proprie del
parlato delle varie regioni.
Nel corso degli anni '50-'60 al dibattito teorico si accompagnò una
vasta produzione narrativa.
Tempi Stretti di Ottiero Ottieri (1957) è uno dei primi esempi di romanzo
industriale, in cui si descrive la vita dell'operaio in fabbrica, scandita dal ritmo di
produzione che mal si concilia con i bioritmi degli individui. Emerge il tema
dell'alienazione in un ambiente degradante come la fabbrica.
Donnarumma all'assalto di Ottiero Ottieri (1959), Italia del Sud, fine anni
Cinquanta. Una grande azienda settentrionale ha deciso di impiantare una nuova fabbrica
nel cuore del Mezzogiorno.
E' il 1954 quando Giovanni Testori pubblica Il dio di Roserio, il primo atto di quella
che diventerà una “commedia umana” lombarda; per setta anni, Testori tornerà
sempre sugli stessi temi: due raccolte di racconti, Il ponte della Ghisolfa, La Gilda
di Mac Mahon, due testi teatrali, La Maria Brasca, dove il mondo è quello delle
operaie di Niguarda, L'Arialda e un romanzo, Il Fabbricone. Al centro c'è il mondo
della periferia milanese.La trilogia di Lucio Mastronardi: Il calzolaio di Vigevano, che viene pubblicato nel 1959 sul primo numero de Il Menabò e che gli procura attenzione e considerazione dalla critica. Il maestro di Vigevano, finito di scrivere nel 1960 e pubblicato due anni dopo grazie alle referenze di Italo Calvino. Il meridionale di Vigevano, terminato nel 1963 e pubblicato nel 1964. In questi romanzi emergono i caratteri assurdi della realtà moderna nel passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale tra violenze, ricatti e ipocrisie in una piccola città di provincia. Del '62 tre romanzi: Una nuvola d'ira di Giovanni Arpino, che tratta del disagio esistenziale di tre operai militanti comunisti che a Torino, scoprendo la loro fragilità, individuano nella progressiva integrazione nella società consumistica l'unica possibilità di salvezza. La vita agra di Luciano Bianciardi, che mette in luce le tare della nuova società capitalistica con la surclassante cultura di massa, il benessere consumistico, l'alienazione. Memoriale, di Paolo Volponi, che tratta del rapporto tra uomo e lavoro industriale. E' la storia dell'ex contadino Albino Saluggia, che all'indomani della guerra trova lavoro in un'impresa in Piemonte, con cui però entra in conflitto e da cui finisce per essere allontanato. Del '65, Il padrone, di Goffredo Parise, un Bildungsroman il cui giovane protagonista viene assunto in una ditta commerciale milanese in cui vige il culto assoluto del padrone, il quale dispone degli operai come di puri oggetti. Il giovane ben presto viene a conoscenza di questa amara verità e, dopo inutili tentativi di ribellarsi al sistema, arriverà ad una completa sottomissione e a una morte metaforica.
Alcuni autori hanno intravisto nel lavoro industriale “una via di libertà” (Calvino), una condizione favorevole all'emancipazione sociale per le classi meno agiate, spesso di origini meridionali o all'acquisizione di una più matura coscienza di classe. Non tutta la letteratura industriale si concentra sulle figure di operai. Ne esiste un'altra, parallela, sulla condizione degli intellettuali. Anche in questo caso, il panorama mostra una serie di personaggi delineati con effetti di parodia o di straniamento: La nuvola di smog (1958) di Italo Calvino, che narra le vicende di un giornalista ossessionato dallo smog, impiegato presso una rivista sensibile ai problemi ambientali, “La Purificazione”, finanziata da una ditta tra le più attive a inquinare l'aria. Il senatore (1958) di Giancarlo Buzzi, dove il protagonista è un dirigente che lavora in un'azienda immersa dentro la nebbia, a cui non riesce di incontrare, malgrado gli sforzi, il suo capo, mentre continua ad avere colloqui con il fantasma del vecchio fondatore, morto ormai da diversi anni.
CARTOLINE DA MILANO
Quartiere QT8
Cuore di Brera
Ponte della Ghisolfa
La Maria Brasca
Rocco e i suoi fratelli
La ragazza Carla di Elio Pagliarani
Puoi anche leggere