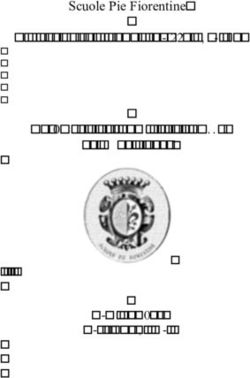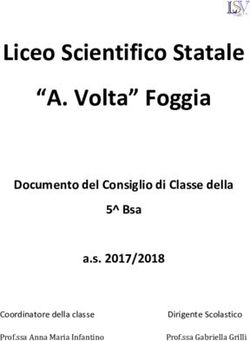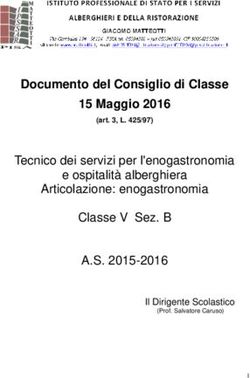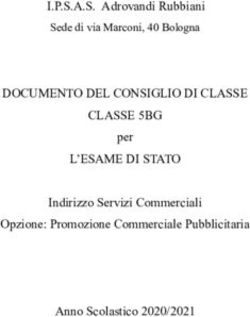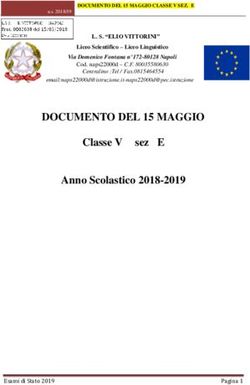ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE “P. Borsellino” - PA
ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO
2020 / 2021
DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO
DI CLASSE
(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98)
Classe Quinta Sez . BC
Articolazione “Enogastronomia”
C o o r d i n a t o r e prof.ssa Maria Benfante
“L’uomo è ciò che mangia” (Ludwig Feuerbach)INDICE Pag. Breve storia dell’IPSSAR Paolo Borsellino 2 Presentazione dell’Istituto 2 Informazioni sul curricolo 3 Il profilo in uscita 3 I nostri alunni 4 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 5 Il profilo in uscita servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione 6 enogastronomia Consiglio di classe 7 Composizione commissione d’esame 8 Presentazione classe 8 Metodologia e strumenti 10 Verifica e valutazione 11 Credito scolastico 11 Progetti e attività integrative e di ampliamento dell’Offerta Formativa 14 Percorsi di cittadinanza e costituzione e collegamenti con attività curricolari ed 15 extracurricolari Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato 16 Griglia di valutazione del colloquio 18 Programmi disciplinari svolti 20 Consiglio di classe 41 1
BREVE STORIA DELL’IPSSAR PAOLO BORSELLINO
L’IPSSAR “Paolo Borsellino” nasce nel 1954 come Scuola Professionale Per Il Turismo, con sede
nei primi anni di vita in via Torremuzza e, dopo qualche anno, nello splendido palazzo Jung
di via Lincoln, entrato nel 1959 in possesso dell’Ente Provinciale per il Turismo. Nel 1984 la
scuola si trasferisce presso l’attuale sede di piazza Giovanni Bellissima, nel quartiere
Pallavicino. Qui il numero degli iscritti, contenuto nei primi anni, sale vertiginosamente sino
a toccare la cifra record di 2500 nell’A.S. 1997/1998. È nel 1994, inoltre, che il Collegio dei
Docenti sceglie di intitolare la scuola a Paolo Borsellino (1940-1992. L’attività dell’Istituto è
prolifica: tutte le scuole alberghiere della Sicilia sono infatti figlie del Borsellino. Gli istituti
di Sciacca, Enna, Erice, San Vito Lo Capo, Cefalù e Balestrate nascono come sezioni staccate,
divenute in seguito autonome. Stessa sorte è toccata alle succursali cittadine, note oggi come
IPSSAR “Pietro Piazza” e IPSSAR “Francesco Paolo Cascino”. L’attuale IPSSAR “Paolo
Borsellino” presenta, a Palermo, una succursale in via Nicolò Spedalieri, quartiere
Montepellegrino, una sezione staccata presso la Casa Circondariale Pagliarelli e, dall’A.S.
2014/2015, una seconda sezione staccata presso la Casa Reclusione Ucciardone.
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’IPSSAR “Paolo Borsellino” di Palermo insiste su due diverse realtà territoriali: il quartiere
Pallavicino, per la sede centrale e il quartiere Montepellegrino, per la succursale. Pallavicino
è un quartiere densamente urbanizzato e ormai integrato con il centro della città, sebbene
all’aumento della popolazione non sia corrisposto un adeguato potenziamento dei servizi;
l’antica borgata manca oggi, paradossalmente, di aree di verde pubblico, di parcheggi e
strutture aggreganti per i giovani, fatta eccezione per la parrocchia e le sue attività sociali e
per la “Città dei ragazzi”, struttura comunale dedicata allo svago e alla cultura dei bambini e
dei ragazzi. Il quartiere Pallavicino risulta limitrofo a zone quali San Filippo Neri e Marinella
che, pur essendo state in questi ultimi anni protagoniste di volenterosi sforzi di riscatto,
restano segnate da problemi di carattere socio-ambientale. In prossimità sono presenti il
Centro Commerciale "Conca d'oro" ed il "Mercato San Lorenzo". La succursale insiste
nel quartiere Montepellegrino, che è estremamente variegato per estrazione socio-
economica dei suoi abitanti e per tipo di strutture presenti. Vi si trovano infatti industrie
come i Cantieri navali e piccole officine, il mercato ortofrutticolo della città e un mercato
rionale, grandi supermercati e piccoli esercizi, banche, uffici postali, negozi di vario tipo, una
caserma, centri aggregativi come palestre, cinema, teatri, campi sportivi, strutture ricettive
come alberghi e ristoranti. Sono presenti inoltre due istituti elementari, due scuole medie
inferiori, svariati istituti di istruzione secondaria sia pubblici che privati, un grosso centro di
formazione professionale presso l’Istituto Don Orione.
2INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Il percorso formativo dura cinque anni e prevede un primo biennio che, oltre ad assolvere
l'obbligo scolastico, affronta lo studio di aspetti generali propri dell’area comune di tutti gli
istituti superiori attraverso lo sviluppo degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico,
scientifico tecnologico, storico-sociale.
I primi due anni introducono l'allievo alle discipline caratterizzanti l'indirizzo specifico
alberghiero. Una buona formazione di base e lo studio delle scienze alimentari, sono i
presupposti fondamentali per dare concretezza al profilo formativo dell’Istituto.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli
studenti competenze e abilità più strettamente spendibili nel campo lavorativo, mettendo i
diplomati in grado di inserirsi nei processi produttivi e di servizio sapendosi gestire in modo
sempre più flessibile e autonomo, come richiesto da una realtà professionale articolata, in
continua e veloce evoluzione.
Le articolazioni professionalizzanti sono tre: “accoglienza turistica” (ricevimento);
“enogastronomia” (cucina); “servizi di sala e di vendita” (sala bar); l’opzione “prodotti
dolciari artigianali e industriali” (pasticceria) afferisce all’articolazione “enogastronomia”.
IL PROFILO IN USCITA SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ
ALBERGHIERA
Articolazioni ENOGASTRONOMIA
In tale indirizzo il Diplomato acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche,
organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione
della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici
settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il
cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei servizi,
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e artistici e del Made
in Italy in relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle esigenze
territoriali in termini formativi, permettendo alle scuole di declinarlo in Percorsi dal
contenuto innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche e comportamenti di sala,
al ricevimento, all'"arte bianca".
3I NOSTRI ALUNNI Il contesto socio-culturale è costituito per lo più da famiglie monoreddito, spesso numerose e a bassa scolarizzazione, talvolta destrutturate all’interno, magari non in grado di fornire modelli positivi o supportare i figli nel percorso di istruzione/formazione al quale non viene attribuita la dovuta importanza. I ragazzi giungono inoltre alla scuola superiore con un bagaglio di insuccessi e frustrazioni accumulato nel corso del precedente percorso didattico e con interessi professionali ancora poco definiti, con conseguenze gravi per la motivazione allo studio. La maggioranza degli iscritti a conclusione della terza media si attesta al livello di sufficienza. Nella scuola convergono però anche alunni altamente motivati nella scelta e supportati dalle famiglie che con loro credono in questo tipo di formazione. Alcuni alunni, infatti, scelgono questo indirizzo di studio con la consapevolezza di voler intraprendere, in futuro, un percorso lavorativo attinente al settore alberghiero. Tantissimi ex allievi ricoprono oggi importanti incarichi in aziende turistiche di rilievo nazionale e internazionale, alcuni di essi sono ambasciatori in Europa della professionalità, dell’orgoglio e del desiderio di riscatto di questa terra, grazie all’esaltazione della sua gastronomia e dei grandi valori dell’ospitalità, della dignità del lavoro e dell’onestà. Il loro successo, come esseri umani e come professionisti, è ragione di vanto per la nostra scuola e invito a raccogliere la sfida per altri sessant’anni e più. 4
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei
percorsi di istruzione professionale, gli studenti sono in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere
la realtà ed operare in campi applicativi.
5IL PROFILO IN USCITA SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
Per le articolazioni di enogastronomia e sala e vendita i profili professionali privilegiano
determinate competenze comuni legate all’utilizzo di:
tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici;
tecniche di comunicazione anche in lingua straniera;
strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici locali,
nazionali ed internazionali;
normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;
tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici.
Nello specifico l’articolazione di enogastronomia si professionalizza, attraverso il percorso
del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per:
la preparazione di piatti caldi e freddi;
l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e
efficienza nell’impiego delle risorse;
calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menu;
valorizzazione e promozione della tipicità del territorio;
strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti con
esigenze e necessità dietologiche del cliente.
6IL CONSIGLIO DI CLASSE È COMPOSTO DAI SEGUENTI DOCENTI,
CON INDICAZIONE RELATIVA ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA
NEI PRIMI DUE ANNI DEL TRIENNIO
Continuità
didattica
DOCENTE DISCIPLINA
III IV
anno anno
Fabio Lo Verso Italiano/Storia No No
Caterina Valenti Matematica No No
Francesco Bruno Lingua inglese Sì Sì
Agostino Aquilina Lingua francese Sì Sì
Antonina Marchese Scienza e cultura dell’alimentazione Sì Sì
Maurizio Vento Diritto e tecniche amministrative No No
Alfio Longarino Laboratorio servizi – settore cucina No Sì
Salvatore Pagano Laboratorio servizi – settore sala e _ No
vendita
Maria Rita Ferrara Scienze motorie e sportive Sì Sì
Giuseppe Cammarata IRC Sì Sì
Maria Benfante Sostegno Sì Sì
Alfredo Ruscica Sostegno No No
Maria Buffa Dirigente scolastico
7COMPOSIZIONE COMMISSIONE MEMBRI INTERNI
DISCIPLINA DOCENTE
Italiano- Storia prof. Fabio Lo Verso
Matematica prof.ssa Caterina Valenti
Inglese prof. Francesco Bruno
Diritto e tecniche amministrative prof. Maurizio Vento
Scienza e cultura dell’alimentazione prof.ssa Antonina Marchese
Laboratorio servizi – settore Cucina prof. Alfio Longarino
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe era all’inizio dell’anno composta da 23 alunni, 2 femmine e 21 maschi, tutti
provenienti dalla IVBC, ad eccezione di un’alunna iscritta per la prima volta nel nostro
Istituto e proveniente dalla scuola professionale Elis - scuola alberghiera mediterranea di
Palermo. Due alunni, però, hanno interrotto la frequenza scolastica per motivi personali
entro i termini consentiti dalla legge, cioè una il 10 marzo e l’altro 24 febbraio 2021. Pertanto,
allo stato attuale il gruppo risulta composto da 21 alunni, di cui 1 femmina e 20 maschi. La
storia della classe è alquanto complessa, poiché all’inizio del quarto anno sono stati immessi
cinque alunni: quattro di rientro, in quanto nel precedente anno scolastico, visto il numero
elevato di alunni della 3BC, erano stati assegnati ad una classe diversa, frutto di un
accorpamento di due indirizzi (sala e cucina); il quinto in quanto ripetente della 4BC;
pertanto le dinamiche di relazione tra gli alunni non sono sempre state del tutto produttive
e i metodi di studio da loro acquisiti non sono risultati omogenei.
Nel corso del triennio il Cdc ha lavorato assiduamente nel contenere atteggiamenti a volte di
disturbo, al fine di stimolare gli alunni a raggiungere un adeguato livello di conoscenze,
abilità e competenze, utilizzando un metodo di studio efficace, nonostante la classe fosse
numerosa ed eterogenea per preparazione, per interessi e partecipazione attiva al dialogo
educativo-didattico.
Oltre alla suddetta eterogeneità, un altro elemento di complessità è stato rappresentato dalla
discontinuità didattica del corpo docente, che ha visto avvicendarsi tre docenti di italiano,
due docenti di matematica e due docenti di economia aziendale.
8In conclusione, si sono riscontrate difficoltà che non sempre hanno consentito una maturazione omogenea del gruppo classe in termini di atteggiamento responsabile, di disponibilità al dialogo educativo e di collaborazione tra pari. Nonostante ciò, gli sforzi del Cdc hanno progressivamente consentito di giungere nel complesso ad un rapporto aperto e corretto con gli insegnanti, ad un comportamento generalmente rispettoso delle regole della vita scolastica e ad un atteggiamento inclusivo e affettuoso verso i compagni. Questo, in linea generale ha consentito la costruzione di un ambiente educativo funzionale allo sviluppo della personalità degli alunni e al riconoscimento e alla valorizzazione delle loro capacità e potenzialità. Dal punto di vista comportamentale il gruppo classe, partito da una situazione passiva, ha dimostrato progressivamente un atteggiamento positivo nel dialogo educativo, nel reciproco rispetto e nella disponibilità ad apprendere gli argomenti proposti; anche se sono stati necessari continui stimoli e rimodulazioni di strategie, che non sempre per una parte minoritaria del gruppo hanno sortito effetti. Nel complesso, però, la classe ha seguito con interesse lo svolgimento delle attività didattiche e anche buona parte di coloro che presentano una competenza lessicale e sintattica un po’ incerta, ancorata talvolta ad un metodo di studio meccanico e mnemonico, grazie alla buona volontà e all’impegno, sono riusciti a raggiungere risultati sufficienti. Altri, invece, hanno sempre dimostrato una maggiore padronanza delle competenze, pervenendo a risultati buoni o in alcuni casi più che buoni. Complessivamente, quindi, si può affermare che in maniera diversificata, la maggior parte del gruppo classe ha conseguito nel corso del triennio le competenze e i risultati attesi. Nelle discipline dell’area professionalizzante, in cui le abilità acquisite hanno avuto la possibilità di un concreto riscontro in occasione di servizi, eventi, collaborazioni e attività di PCTO, diversi alunni sono stati apprezzati per l’affidabilità e la correttezza nello svolgimento delle proprie mansioni; ma tutti, indistintamente, hanno trovato l’occasione per esprimere il proprio “saper fare”. Purtroppo la relazione educativa ed empatica con il gruppo classe, oltre che dalle succitate difficoltà, è stata anche molto penalizzata a causa dell’emergenza epidemiologica, le lezioni in presenza sono state interrotte e i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, per contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti utilizzando la Didattica a Distanza (DaD), attraverso attività in sincrono e in asincrono. In alcuni casi, in osservanza all’acquisizione delle competenze previste in fase di progettazione, si è preferito ridurre i contenuti al fine di svolgere attività di recupero e di consolidamento. Anche in questo difficile momento il gruppo-classe ha mantenuto un atteggiamento responsabile, seppur non sono mancati casi in cui gli alunni maggiormente timidi o quelli inclini alla distrazione abbiano manifestato maggiori difficoltà ad acquisire i nuovi concetti, pur cercando di impegnarsi nelle attività proposte dai docenti. Comunque, nonostante tali difficoltà, tale modalità di apprendimento ha favorito e permesso la continuità del processo educativo e di apprendimento. Incontri periodici del Consiglio di Classe hanno permesso la collaborazione di tutti i docenti nella programmazione e nell’organizzazione delle varie attività didattico-educative, nonché nella scelta della metodologia e degli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati in senso disciplinare, interdisciplinare e pluridisciplinare. 9
Dall’analisi dei diversi fattori considerati, pertanto, si può osservare che tutti gli alunni,
ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il
percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze che, oltre a
determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita
personale. L’elenco degli alunni e la relazione del PCTO sono di seguito allegati,
rispettivamente come allegato 1 e allegato 3.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Al fine di garantire la piena attuazione del processo di insegnamento-apprendimento, il
Consiglio di classe ha costantemente messo in atto metodologie e strategie diversificate e
quanto più adeguate alle reali possibilità di ciascun alunno, mirate sempre alla
personalizzazione del processo formativo del discente. La pluralità e diversificazione delle
strategie metodologiche è stata possibile grazie alla presenza di diversi spazi e ambienti di
apprendimento disponibili nell’Istituto: laboratori informatici e multimediali, aule LIM,
cucine professionali, pasticceria, sala bar, ristorante, biblioteca, aula magna.
Dal momento in cui ha preso avvio la didattica a distanza il processo di insegnamento–
apprendimento si è espresso attraverso metodologie, strategie, strumenti e approcci
didattici multimediali e innovativi.
Metodi Strumenti
• Lezione interattiva • Libri di testo
• Utilizzazione di mappe, schemi e • Fotocopie e dispense
tabelle • Lavagne interattive
• Problem solving • Registratori audio
• Cooperative learning
• Peer to peer
• Lavori di gruppo
• Utilizzazione audiovisivi
• Role playing
METODOLOGIA E STRUMENTI DURANTE LA DAD
Metodi Strumenti
In sincrono: video lezioni Google: Meet, Classroom, Drive, Documenti,
In asincrono: classi virtuali, piattaforme e- Jamboard, Moduli, Youtube
learning, e-learning objects, Apps. Power Point
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
10considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di
device inopportuni, dai libri di testo che solo all’inizio del pentamestre hanno ricevuto in comodato
d’uso, rispetto al lavoro assegnato.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche, che sono state un momento fondamentale del percorso formativo, in quanto
monitoraggio del processo insegnamento – apprendimento, sono state effettuate tramite:
• colloqui;
• prove strutturate e semi-strutturate, con esercizi di completamento, quesiti
vero/falso e a risposta multipla;
• questionari/problemi a risposta aperta;
• prove scritte di analisi testuale ed elaborati informativo/argomentativi;
• brevi composizioni in lingua straniera;
La valutazione è stata fatta tenendo conto, oltre che degli esiti delle prove di verifica e del
livello di acquisizione delle competenze, anche dell’impegno profuso, della partecipazione
attiva e consapevole, del metodo di lavoro acquisito, dei miglioramenti rispetto al livello di
partenza, del livello di maturità raggiunto e della storia personale di ogni singolo alunno.
IL CREDITO SCOLASTICO E IL CREDITO FORMATIVO
Il credito scolastico verrà attribuito, per il triennio, sulla base rispettivamente delle tabelle
A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n.53 del 03/03/2021, art 11.
Allegato A
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media dei Fasce di credito
voti ai sensi Allegato Nuovo credito
A al D. Lgs assegnato per la classe
62/2017 terza
M=6 7-8 11-12
6< M ≤ 7 8-9 13-14
7< M ≤ 8 9-10 15-16
8< M ≤ 9 10-11 16-17
9< M ≤ 10 11-12 17-18
11La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs. Nuovo credito assegnato per
Media dei voti 62/2017 e dell’OM 11/2020 la classe quarta
MAi fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del triennio, oltre alla media aritmetica si tiene conto dei seguenti criteri: frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica, crediti formativi. Le esperienze formative maturate al di fuori della scuola costituiscono il credito formativo e possono contribuire ad aumentare il punteggio del credito scolastico, che in ogni caso non può superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. Il collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per il riconoscimento dei crediti formativi: • Competenze acquisite IRC o materia alternativa (O.M.90/01, art.14; O.M. 30/07) e volontariato. • PCTO, stage e tirocinio formativo; • Partecipazione ad attività inerenti allo sport agonistico; • Partecipazione a concorsi di settore indetti da enti o associazioni; • Certificazioni di lingue straniere conseguite presso enti riconosciuti e riconoscimento di competenze informatiche (ECDL, Linux); • Partecipazione a progetti extracurricolari. 13
PROGETTI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE E
DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il livello di partecipazione alle attività extra-curricolari e agli eventi organizzati dall’Istituto
è stato abbastanza alto. In tali occasioni i ragazzi si sono sempre comportati in modo
adeguato e positivamente attivo. Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle
seguenti attività ed iniziative culturali sia scolastiche che extrascolastiche:
Descrizione attività n. alunni
coinvolti
PROGETTO PON “Io e mio futuro”, avviso del 08/03/2017- FSE-
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Modulo scoprirsi
imprenditore. Il progetto ha previsto 30 ore di lezione, valide ai fini del
PCTO, così suddivise: 10 ore di lezione con un dottore commercialista, tutta la classe
10 ore di lezione con un consulente del lavoro e 10 ore con un
imprenditore del settore ristorativo
ORIENTAMENTO
Incontro informativo con la Facoltà di scienze Agrarie di Palermo tutta la classe
FEDERAZIONE ITALIANA CUCHI
Incontro in videoconferenza di settore “Nic in School” presentato dagli
Chef Antonio Danise e Lorenzo Lacricola. Incontro di 2 ore valide ai fini tutta la classe
del PCTO
ACCADEMIA GUALTERIO MARCHESI
Incontro con i docenti di cucina dell’Accademia di Gualtero Marchesi per
proporre l’offerta formativa riservata agli alunni maturati nel percorso tutta la classe
enogastronomico. Incontro di 1 ora e mezza valido ai fini del PTCO.
PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO POST-DIPLOMA
Incontro in videoconferenza con la Scuola di Alta Formazione “In Cibum”,
i docenti hanno proposto il loro percorso post diploma. Incontro di 2 ore tutta la classe
valide ai fini del PCTO
14PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E
COLLEGAMENTI CON ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
I percorsi di costituzione e cittadinanza intendono sviluppare competenze trasversali che
conducono gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e alla fedeltà verso i propri
doveri di cittadini; hanno come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione
socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura, in termini di competenze
sociali, giuridiche ed economiche della realtà in cui si svolge e dovrà svolgersi il loro futuro.
Il percorso è stato elaborato e calibrato sulla base del tessuto classe e degli interessi
manifestati dagli studenti, che sono stati partecipi ed attivi.
Laboratorio di servizi enogastronomici - Attività n.
settore Cucina alunni
Relazione tra igiene e sicurezza degli
operatori del settore alimentare,
Sincrono e asincrono 21
dell’ambiente e degli alimenti nell’ambito
dello street-food e delle sagre.
Legislazione alimentare (cenni)
Igiene degli alimenti (cenni)
Sincrono 21
Sicurezza alimentare (cenni)
L’impresa alimentare (cenni)
Allergeni Realizzazioni di menu per
21
attività di street-food o sagre.
Igiene del personale di cucina. HACCP. Esempi pratici e procedure da
seguire nelle distinte fasi di
lavorazione degli alimenti.
Scienza e cultura dell’alimentazione Attività n.
alunni
Rischi alimentari collegati al consumo di pesce Commento al Regolamento CE
crudo. (Anisakis simplex) 21
n.853/2004
Rischi alimentari collegati al consumo di carni di Commento al Regolamento CE n.
bovini, ovini, caprini. (ESB). 21
999/2001.
Lingua e letteratura italiana / Storia Attività n.
alunni
L’Italia: una Repubblica democratica. Lettura e commento dell’art. 1 21
Il lavoro nella Costituzione italiana Lettura e commento degli
21
articoli 4, 35, 36 e 37
Il lavoro minorile Inchiesta in Sicilia di
L.Franchetti e S.Sonnino: Il
lavoro dei fanciulli nelle miniere 21
siciliane. Lettura di Rosso
Malpelo
La questione sociale tra la II Rivoluzione Le risposte della società:
21
industriale e la fine della II Guerra mondiale liberalismo e colonialismo,
15socialismo, “De rerum
novarum”, comunismo, fascismo
e nazismo.
La globalizzazione Ricerca su internet e dibattito. 21
Lingua francese Attività n.
alunni
Institutions en France : différences entre les Sincrono e asincrono 21
institutions françaises et italiennes
Diritto e tecnica amministrativa Attività n.
alunni
Gli interventi economici dello
L’intervento dello Stato nell’economia del
Stato 21
paese: aspetti sociali ed economici
L’economia mista
L’organizzazione dello Stato Gli organi costituzionali:
funzionamento e azioni di 21
controllo
La Costituzione italiana 21
IRC Attività n.
alunni
Costituzione e pluralismo religioso. Dalla Lettura e commento degli Art. 3,
21
costituzione Albertina ad oggi. Art, 7 e Art 8 della Costituzione.
Approfondimento del concetto di libertà Lettura e commento degli
dell’individuo a prescindere da razza, articoli 1, 2, 7, 16 e 18 della
religione, opinione politica, ceto e quant'altro. DICHIARAZIONE UNIVERSALE 21
Il diritto di espressione religiosa, di fondare DEI DIRITTI UMANI.
una famiglia e il diritto all'istruzione
Il concetto di devianza in sociologia e risvolti FOCUS e Dibattito sulla storia
etico-religiosi della carriera della prostituzione
e in particolare sulla tratta.
21
FOCUS e Dibattito sulla carriera
del Tossicodipendente e
dell’alcolista.
16INDICAZIONI PER LO SOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO In base all’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 art. 17 comma 1, comma 2 lettere a), b) e c), comma 3.4 che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. In ottemperanza di quanto dispone l’art. 18 che disciplina l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Lo svolgimento del colloquio d’esame avviene mediante la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto materie. Il Consiglio di classe, al fine di assegnare un argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato, ha deliberato, in data 21 aprile 2021, di assegnare a ciascun alunno un argomento diverso, tenendo conto della sua crescita professionale e didattica e delle esperienze personali maturate. Pertanto, le tematiche assegnate a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato oggetto di discussione ai colloqui sono riportate nell’allegato 2. 17
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Non ha acquisito i contenuti e i metodi
delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
I 1-2
modo estremamente frammentario e
lacunoso.
Acquisizione dei
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle
contenuti e dei
diverse discipline in modo parziale e
metodi delle II 3-5
incompleto, utilizzandoli in modo non
diverse
sempre appropriato.
discipline del
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi
curricolo, con
III delle diverse discipline in modo corretto e 6-7
particolare
appropriato.
riferimento a
Ha acquisito i contenuti delle diverse
quelle
IV discipline in maniera completa e utilizza in 8-9
d’indirizzo
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e
V 10
approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le
I conoscenze acquisite o lo fa in modo del 1-2
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le
Capacità di II conoscenze acquisite con difficoltà e in 3-5
utilizzare le modo stentato
conoscenze È in grado di utilizzare correttamente le
acquisite e di III conoscenze acquisite, istituendo adeguati 6-7
collegarle tra collegamenti tra le discipline
loro È in grado di utilizzare le conoscenze
IV acquisite collegandole in una trattazione 8-9
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze
V acquisite collegandole in una trattazione 10
pluridisciplinare ampia e approfondita
Capacità di Non è in grado di argomentare in maniera
argomentare in I critica e personale, o argomenta in modo 1-2
maniera critica e superficiale e disorganico
18personale, È in grado di formulare argomentazioni
rielaborando i II critiche e personali solo a tratti e solo in 3-5
contenuti relazione a specifici argomenti
acquisiti È in grado di formulare semplici
argomentazioni critiche e personali, con
III 6-7
una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti
È in grado di formulare articolate
argomentazioni critiche e personali,
IV 8-9
rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali,
V 10
rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato,
I 1
utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e Si esprime in modo non sempre corretto,
padronanza II utilizzando un lessico, anche di settore, 2
lessicale e parzialmente adeguato
semantica, con Si esprime in modo corretto utilizzando un
specifico III lessico adeguato, anche in riferimento al 3
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio Si esprime in modo preciso e accurato
tecnico e/o di IV utilizzando un lessico, anche tecnico e 4
settore, anche in settoriale, vario e articolato
lingua straniera Si esprime con ricchezza e piena
padronanza lessicale e semantica, anche in
V 5
riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore
Non è in grado di analizzare e
Capacità di comprendere la realtà a partire dalla
I 1
analisi e riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
comprensione in modo inadeguato
della realtà in È in grado di analizzare e comprendere la
chiave di realtà a partire dalla riflessione sulle
II 2
cittadinanza proprie esperienze con difficoltà e solo se
attiva a partire guidato
dalla È in grado di compiere un’analisi adeguata
riflessione sulle della realtà sulla base di una corretta
III 3
esperienze riflessione sulle proprie esperienze
personali personali
È in grado di compiere un’analisi precisa
IV 4
della realtà sulla base di una attenta
19riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un’analisi
approfondita della realtà sulla base di una
V 5
riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova
La commissione Il Presidente
20PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA
Docente: prof. Alfio Longarino
Libro di testo: In cucina- laboratorio di servizi enogastronomici di L. Santini, Poseidonia
scuola
MODULO 1
• La forza del territorio: enogastronomia e territorio
MODULO 2
• Marchi di qualità e altre tutele alimentari, elenchi ministeriali dei principali prodotti
tutelati.
MODULO 3
• I prodotti tipici italiani e la cucina regionale italiana. Principali ricette
MODULO 4
• Il menu
• I piatti del menu italiano ed i metodi di cottura
• I piatti del menu italiano e le salse
• Menu speciali per esigenze religiose diverse: musulmani, kosher, indu
MODULO 5
• Intolleranze alimentari ed altri stili alimentari
• Menu speciali per diverse patologie: celiachia, diabete, intolleranze diverse
MODULO 6
• La tutela della salute sul luogo di lavoro
MODULO 7
• Il sistema HACCP
MODULO 8
• Il servizio di catering e banqueting: regole fondamentali, esempi di
allestimento, menu per banchetti e ricevimenti, menu per ristorazione
collettiva.
Il docente
prof. Alfio Longarino
21SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE Docente: prof.ssa Antonina Marchese Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione- enogastronomia- Sala e vendita di A. Machado, Poseidonia Scuola La contaminazione degli alimenti. Le micotossine: aflatossine, ocratossine, fumonisine. Principali caratteristiche delle muffe produttrici di micotossine (Aspergillus, Penicillium, Fusarium). Gli agrofarmaci, i farmaci veterinari. Le materie plastiche, i metalli pesanti. Le malattie trasmesse dagli alimenti. Agenti biologici e modalità di contaminazione. I prioni e le encefalopatie spongiformi. Il materiale specifico a rischio per le encefalopatie spongiformi. I batteri: la cellula batterica: caratteristiche, morfologia, parete cellulare e colorazione di Gram. Riproduzione batterica. Spore batteriche. Tossine batteriche: enterotossine, neurotossine. I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo, radiazioni. Le tossinfezioni alimentari: caratteristiche morfologiche dell’agente patogeno, temperatura ottimale di crescita, pH, respirazione, resistenza/sensibilità alle alte e basse temperature, eventuali tossine prodotte, habitat, alimenti a rischio e prevenzione. Rischio biologico e dose infettante. Le più comuni tossinfezioni: salmonellosi, tossinfezione da Bacillus cereus, campilobatteriosi, listeriosi, tossinfezione da Clostridium perfringens, Botulismo e Botulismo infantile. Le parassitosi intestinali. Gli elminti: caratteristiche generali su platelminti e nematodi. Taenia saginata e Taenia solium: ciclo biologico, alimenti a rischio e prevenzione. Anisakis symplex, ciclo biologico, alimenti a rischio e prevenzione. Allergie e intolleranze alimentari. Le reazioni avverse al cibo. Le reazioni tossiche. Le reazioni non tossiche: le allergie e la risposta del sistema immunitario. Sintomi e complicanze delle allergie. Lo shock anafilattico. I più comuni allergeni. L’asma dei panettieri e dei pasticceri. Le intolleranze enzimatiche. Gli enzimi e il loro ruolo nel metabolismo. L’intolleranza al lattosio. Il lattosio negli alimenti. Il latte ad alta digeribilità (HD). La fenilchetonuria e la relativa dieta. Aspartame e fenilchetonuria. La celiachia. Il glutine, gli alimenti con e senza glutine. La dieta del celiaco. 22
Diete. Dieta mediterranea e relativa piramide alimentare. La dieta vegetariana: latto-ovo-
vegetariana, vegana, crudista, fruttariana.
Le malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio cardiovascolare. L’ipertensione arteriosa
e indicazioni dietetiche. Ipercolesterolemia e la relativa dieta.
Le malattie del metabolismo. La sindrome metabolica. Il diabete mellito. Tipi di diabete
mellito. Resistenza all’insulina. Indice glicemico. Indicazioni dietetiche.
Il docente
prof.ssa Antonina Marchese
23LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: prof. Fabio Lo Verso
Libro di testo: Le occasione della letteratura di G. Baldi, S. Giusso, M. Razeti, G.Zaccaria vol. 3,
Person-Paravia.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: prof. Fabio Lo Verso
Libro di testo: Le occasioni della letteratura di G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti e G. Zaccaria vol.
3, Paravia.
IL SECONDO OTTOCENTO
1. L’ETA’ DEL POSITIVISMO
• Il trionfo della scienza e la cultura filosofica del Positivismo. Il darwinismo.
• La narrativa francese: Realismo e Naturalismo
• Le poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano: caratteristiche,
analogie e differenze.
• Emile Zola: opere e poetica
• Giovanni Verga: biografia, ideologia e poetica. Il pessimismo verghiano.
L’impersonalità e la regressione. Produzione letteraria: Vita dei campi. Il “ciclo dei
vinti”: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo
2. LA CULTURA E GLI INTELLETTUALI
• La lirica di ispirazione classica: Giosue Carducci (vita, opere e poetica)
• La nascita della poesia moderna
• Charles Baudelaire: la vita e I fiori del male
3. L’ETA’ DEL DECADENTISMO
• Simbolismo e Decadentismo
• Gabriele D’Annunzio: vita e visione del mondo. Dall’esteta al superuomo. Il
panismo. Produzione letteraria: Le vergini delle rocce, le Laudi: Alcyone
• Giovanni Pascoli: vita e poetica. Il fanciullino e il nido. Produzione
letteraria: Myricae
IL NOVECENTO
4. IL ROMANZO E IL TEATRO ITALIANO NEL PRIMO NOVECENTO
• Luigi Pirandello: vita e visione del mondo. L’umorismo: il comico e l’umoristico.
Il contrasto tra “forma” e “vita”. L’irrazionale e la pazzia. Produzione letteraria:
24L’umorismo, “Uno, nessuno e centomila”, Enrico IV
5. LA NUOVA TRADIZIONE POETICA DEL NOVECENTO
• Giuseppe Ungaretti: vita e poetica. Il superamento delle linee poetiche
tradizionali: la parola pura. Il poeta e la guerra. Produzione letteraria: L’Allegria
LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI TESTI:
da L’argent di E. Zola - L’ebbrezza della speculazione
da Vita dei campi - Rosso Malpelo di G. Verga
da I Malavoglia di G. Verga - Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”
da Le rime nuove di G. Carducci - Pianto antico
da I fiori del male di C. Baudelaire - L’albatro
Corrispondenze
da Myricae di G. Pascoli - X agosto
Novembre
da Le vergini delle rocce di G. D’Annunzio - Il programma politico del superuomo
da Alcyone di G. D’Annunzio - La pioggia nel pineto
da L’umorismo di L. Pirandello - Un’arte che scompone il reale
da Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello - Nessun nome
da Enrico IV di L. Pirandello - Il “filosofo” mancato e la tragedia dell’impossibile
da l’Allegria di G. Ungaretti - Il porto sepolto
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Veglia
Il docente
prof. Fabio Lo Verso
25STORIA
Docente: prof. Fabio Lo Verso
Libro di testo: Storia e progetto di V. Calvani, vol. 5, A. Mondadori Scuola
L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO
1. L’EUROPA E LO SVILUPPO INDUSTRIALE
- L’Italia dal Risorgimento all’epoca post-unitaria
- La II Rivoluzione industriale e la questione sociale
- Nazionalismo, colonialismo, imperialismo e razzismo nella Belle Epoque
L’EUROPA DEI NAZIONALISMI
2. L’EUROPA INDUSTRIALIZZATA E IMPERIALISTA
• Il Novecento porta al governo il liberale Giovanni Giolitti
• Il progetto politico di Giolitti
• Le grandi riforme sociali e politiche
• La politica estera
3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• L’Europa verso la guerra
• La causa occasionale
• La posizione dell’Italia
• Da guerra lampo a guerra di trincea
• Il 1917: l’anno di svolta
• La conclusione del conflitto e i trattati di pace
L’EUROPA DEI TOTALITARISMI
4. LA RIVOLUZIONE RUSSA
• La Prima Guerra Mondiale e la “Rivoluzione di febbraio”
• Menscevichi e bolscevichi
• La “Rivoluzione di ottobre”
• La politica economica di Lenin
• Lo Stato totalitario di Stalin
5. MUSSOLINI E IL FASCISMO
• Il Biennio Rosso
• Mussolini fonda il Partito fascista ed entra in Parlamento
• La Marcia su Roma
• Le leggi fascistissime
• I Patti Lateranensi
• La politica economica
• La politica estera
266. LA CRISI DEL 1929
• La guerra ha arricchito gli Stati Uniti: gli Anni Ruggenti
• Il crollo di Wall Street
• La Grande Depressione
• Il presidente Roosevelt e il New Deal
7.IL NAZISMO
• La Germania dopo il trattato di Versailles
• Hitler espone in Mein Kampf la sua teoria razzista
• Hitler fonda il Partito nazista
• Le Leggi Eccezionali “nazificano” la Germania
• Le Leggi di Norimberga
• La ”notte dei cristalli”
• Germania e Italia appoggiano Franco nella Guerra di Spagna
• Hitler e l’inizio della vendetta
IL CROLLO DELL’EUROPA
8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• L’inizio: una guerra-lampo
• L’Italia entra in guerra
• La Battaglia d’Inghilterra
• L’Operazione Barbarossa
• La Carta Atlantica
• L’attacco di Pearl Harbor
• L’Olocausto
• Il 1943: l’anno di svolta
• La fine della guerra
Il docente
prof. Fabio Lo Verso
27IPSSAR “Paolo Borsellino” Anno Scolastico 2020/21
disciplina: Inglese – Testo in adozione: Cook Book
Docente: Bruno Francesco Club
Autori: Olga Cibelli - Daniela d’Avino - Casa ed. Clitt
Classe V^ BC Moduli settimanali di lezione N. 3
Curriculari N. 86
Numero di ore annuali svolte
Complementari ed integrative N. 0
CONOSCENZE:
- Gli alunni conoscono sufficientemente i contenuti essenziali della
disciplina;
- Producono vari tipi di testi semplici;
- Usano una accettabile terminologia specifica del settore ristorativo;
- Sanno rielaborare in modo semplice, sia scritto sia orale, il contenuto di un
testo.
COMPETENZE:
Obiettivi raggiunti - Gli alunni espongono sufficientemente i contenuti essenziali della
disciplina;
- Usano parzialmente la micro lingua;
- Producono semplici testi scritti in lingua Inglese;
- Interloquiscono con un vocabolario di base sulle tematiche studiate.
CAPACITÀ:
- Gli alunni comprendono vari tipi di testo e individuano gli elementi
essenziali;
- Riassumono in modo semplice gli argomenti oggetto di studio;
- Fanno parziali collegamenti interdisciplinari.
28CURRICULARI:
- Catering sectors – Commercial, Industrial, Contract and Travel catering
- Job searching – Staffing – Job opportunities
Contenuti svolti - The Menu – The Menu sequence
- Wine the bottled art – Wine appellations – Cooking with wine
- Meet the Masters
- Cross cultural diversity – Dine “Italian style” – Glowing Sicily
- Food and religion – Fasting – Kosher food
- Nutrition – Nutrients – The Healthy eating pyramid – Lifelong nutrition
- Banqueting – Buffet service – The Banqueting manager
- Culinary History: From the Renaissance to Globalization.
METODI:
- Lezioni frontali;
- In Plenum;
- Lavori di gruppo
Metodologie - Lezioni in DAD, in Modalità mista e in Asincrono
adottate STRUMENTI:
- Libro di testo;
- Riviste di settore;
- Fotocopie;
- Dispense.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE:
- Domande aperte;
- Semi strutturate;
Verifiche - Test di comprensione.
NUMERO VERIFICHE SCRITTE: Quattro - VERIFICHE ORALI: Quattro
Il docente
prof. Francesco Bruno
29LINGUA FRANCESE
Docente: prof. Agostino Aquilina
Libro di testo: “Superbe! Restauration cuisine et service” Christine Duvallier - Ed. Eli
MODULI CONTENUTI
Module 2 En cuisine • La brigade de restaurant
• La brigade de cuisine
• Les équipements de cuisine
• Les appareils de préparation des aliments
• Les appareils de cuisson
• Lexique des fruits et des légumes,
Module 4 Cuisiner • Les produits de la pêche
• La volaille
• La viande de boucherie
• Les corps gras : beurre, margarine, saindoux et huile d’olive
• Les techniques de cuisson au corps gras (frire, sauter, à la
plancha)
• Les techniques de cuisson mixtes (ragoût et braisage)
• Recherche sur le Couscous à base de poisson.
• La conservation des aliments
Module 5 La sécurité et • La conservation des aliments: techniques physiques,
l’alimentation techniques physique chimiques, par le froid, techniques
chimiques
• Santé et sécurité HACCP Analyse des risques pour la maitrise
des point critiques.
Le champagne synonyme de fête et convivialité
Le régime méditerranéen
Les aliments biologiques et les OGM
Module 6 Les menus
Les menus religieux
Banquets et buffets
Les fromages au menu
Les métiers de la restauration – Comment devenir chef de cuisine
Module 7 Théorie de la
Comment devenir directeur de la restauration
restauration
Recherche sur le Cous Cous Fest à San Vito Lo Capo
Les Institutions en France
Il docente
prof. Agostino Aquilina
30MATEMATICA Docente: prof.ssa Caterina Valenti Libro di testo: Matematica in pratica di I. Fragni, G. Pettarin, voll. 4/5, Cedam MODULO 1 - Funzioni reali di variabili reali Obiettivi specifici: • Saper usare correttamente ed in modo appropriato il linguaggio specifico; • Saper determinare l’insieme di definizione di una funzione; • Saper classificare le funzioni numeriche reali; Unità didattica 1: richiami sul calcolo algebrico e di geometria analitica • Equazioni di primo e secondo grado; • Disequazioni di primo e secondo grado; • Sistemi lineari; • Disequazioni fratte; Unità didattica 2: introduzione allo studio analitico delle funzioni • Intervalli ed intorni; • Concetto di funzione reale di variabile reale; • Classificazione delle funzioni in una variabile reale; • Dominio e codominio di una funzione; • Determinazione del Campo di esistenza di semplici funzioni lineari e quadratiche razionali intere e fratte e di semplici irrazionali; • Segno di una funzione, intersezione con gli assi cartesiani, grafico qualitativo (funzioni lineari e quadratiche razionali intere e fratte). MODULO 2 - Teoria dei limiti e delle funzioni continue Obiettivi specifici: • Saper usare correttamente ed in modo appropriato il linguaggio specifico; • Saper definire il limite di una funzione nei quattro casi possibili; • Saper stabilire se il grafico di una funzione ha uno o più asintoti verticali; • Saper stabilire se il grafico di una funzione ha un asintoto orizzontale • Saper stabilire se il grafico di una funzione ha un asintoto obliquo • Saper applicare le regole per il calcolo dei limiti di funzioni • Saper riconoscere alcune forme indeterminate delle funzioni algebriche • Saper stabilire se una funzione è continua in un punto, in un intervallo, nel suo insieme di definizione • Saper distinguere i diversi casi di discontinuità di una funzione Unità didattica 1: limiti di funzioni • Limite finito di una funzione in un punto; • Limiti sinistro e destro in un punto; • Limiti infiniti in un punto; • Limiti all’infinito; • Teoremi (enunciati), proprietà, operazioni con i limiti; • Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte e semplici irrazionali; • Risoluzione di forme indeterminate inf/inf e 0/0 di funzioni razionali fratte. 31
Unità didattica 2: funzioni continue
• La continuità in un punto ed in un intervallo;
• Continuità di alcune funzioni;
• Punti di discontinuità e classificazione;
• Teoremi (enunciati) e proprietà delle funzioni continue;
Unità didattica 3: complementi alla teoria dei limiti
• Concetto di Asintoto di una funzione;
• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui (funzioni razionali fratte);
MODULO 3 - Derivate delle funzioni di una variabile reale
Obiettivi specifici:
• Saper usare correttamente ed in modo appropriato il linguaggio specifico
• Saper definire la derivata di una funzione in un punto
• Saper il significato di derivata da un punto di vista geometrico
• Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica
• Saper confrontare continuità e derivabilità di una funzione
• Saper operare con le derivate
Unità didattica 1: il rapporto incrementale e la derivata
• Incrementi della variabile e della funzione;
• Definizione di rapporto incrementale e interpretazione geometrica;
• Derivata in un punto;
• Significato geometrico di derivata;
• Continuità e derivabilità;
Unità didattica 2: calcolo delle derivate
• Derivate di funzioni elementari razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali;
• Regole di derivazione (derivata della somma, del prodotto e del quoto)
• Derivate successive
MODULO 4 – Analisi del grafico di una funzione
Obiettivi specifici:
• Saper usare correttamente ed in modo appropriato il linguaggio specifico;
• Saper stabilire alcune caratteristiche di una funzione (zeri, crescenza, continuità,
andamento all’infinito) a partire dal suo grafico;
• Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione algebrica;
Unità didattica 1: derivate e caratteristiche geometriche delle funzioni
• Crescenza e decrescenza di una funzione, ricerca dei massimi e minimi locali attraverso
lo studio della crescenza e della decrescenza;
• Massimi e minimi assoluti;
• Flessi a tangente orizzontale.
Unità didattica 2: grafico di una funzione
• Rappresentazione grafica di funzioni algebriche;
• Funzioni razionali quadratiche intere e fratte.
Il docente
prof.ssa Caterina Valenti
32DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA Docente: prof. Maurizio Vento L’intervento dello Stato nell’attività economica • Il sistema economico misto • Gli aspetti economico-sociali • Le “partecipazioni statali” • Il processo di “privatizzazione” Le risorse finanziarie • La struttura finanziaria dell’impresa • La stima del fabbisogno finanziario: fabbisogno finanziario al momento della costituzione, fabbisogno finanziario durante la gestione • Le fonti di finanziamento • Da che cosa dipende la scelta tra le diverse fonti • L’istruttoria di affidamento bancario Analisi delle fonti di finanziamento Le fonti interne • Il capitale proprio • L’autofinanziamento Le fonti esterne • Il credito mercantile o debiti di funzionamento • I prestiti bancari • Il prestito obbligazionario • I finanziamenti pubblici • I finanziamenti da società finanziarie: Leasing e Factoring Il Bilancio d’esercizio Il bilancio è un obbligo Gli allegati del bilancio d’esercizio dal Codice Civile: • Art. 2423 C.C. • Art.2423 bis C.C. • Art. 2423 ter C.C. • Art. 2424 C.C. • Art. 2425 C.C. • Art. 2427 C.C. • Art. 2428 C.C. • Art. 2429 C.C. L’avvio di una nuova impresa: • Il business plan 33
• Il progetto imprenditoriale
• Analisi di mercato
• La struttura aziendale
• Le previsioni economiche-finanziarie
Le norme obbligatorie nazionali e comunitarie
• Lo Statuto dell’imprenditore commerciale nella attività ristorativa
• Il sistema di gestione della sicurezza
• La normativa antincendio
• L’igiene e la sicurezza alimentare
Il marketing
• L’evoluzione del concetto di marketing
• Le fasi del marketing territoriale
• Elementi e aspetti generali del marketing
Gli strumenti utilizzati nell’attività didattica sono stati:
Il libro di testo
Il Codice Civile
Il docente
prof. Maurizio Vento
34Puoi anche leggere