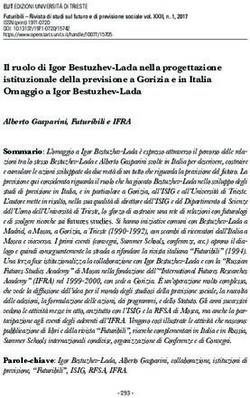Early Warning System and Rapid Response - per la prevenzione della diffusione dello scoiattolo grigio e di altri scoiattoli alloctoni nell'Italia ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Early Warning System
and Rapid Response
per la prevenzione della diffusione
dello scoiattolo grigio e
di altri scoiattoli alloctoni
nell’Italia centrale
+
'
' ' 'Early Warning System
and Rapid Response
per la prevenzione della diffusione
dello scoiattolo grigio e
di altri scoiattoli alloctoni
nell’Italia centrale
+
'
' ' '
Con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ dell'Unione EuropeaTesti di Dario Capizzi e Daniele Paoloni PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000204 U-SAVEREDS Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines Azione F.2 - Creazione ed implementazione di un Early Warning System and Rapid Response extra-regionale
SOMMARIO
Riassunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1) Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2) La minaccia delle specie alloctone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3) Il progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4) Il ruolo dell’Unione Europea - dalla Strategia per la Biodiversità al Regolamento
sulle specie aliene - e il quadro normativo italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.1) Obiettivi dell’Early Warning System and Rapid Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5) Il caso pratico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
5.1) Lo scoiattolo grigio e gli altri sciuridi alloctoni in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
5.2) Lo scoiattolo grigio in centro Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
5.3) Attuazione dell’EWRRS per l’Italia centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
5.4) Referenti istituzionali e stakeholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
5.5) Il funzionamento del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
6) Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45abstract (sented)
RIASSUNTO
Il presente documento ha l’obiettivo di sviluppare un sistema efficace di rilevamento rapido di nuo-
vi nuclei di scoiattoli alloctoni in espansione o di nuova introduzione nell’Italia centrale. Nello speci-
fico, sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1143/2014 si tracciano le linee guida per
un Early Warning System and Rapid Response per prevenire l’invasione dello scoiattolo grigio nel-
l’Italia centrale a partire dal nucleo presente in Umbria. Lo scoiattolo grigio, infatti, costituisce una
minaccia alla conservazione dello scoiattolo rosso, come dimostrato nel corso di studi compiuti in
Italia e nel Regno Unito, dove la specie ha causato la rarefazione e l’estinzione locale delle popola-
zioni di scoiattolo rosso. Scopo principale del Progetto LIFE U-SAVEREDS è quindi la conservazione
dell’autoctono Scoiattolo rosso in Umbria e la tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali del-
l’Italia centrale, entrambi minacciati dalla presenza e dall’espansione dell’alloctono scoiattolo grigio.
Nel documento si individuano i principali referenti istituzionali e stakeholders da coinvolgere in attività di
formazione e sensibilizzazione sulla problematica, onde ampliare il più possibile il numero di potenziali
segnalatori della specie invasiva al di fuori dell’Umbria. Le regioni individuate sono quelle situate al con-
fine con l’Umbria, vale dire Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Lazio.
Sono individuati i criteri sulla base dei quali definire l’attendibilità di una segnalazione e presentate le
tecniche di monitoraggio da mettere in atto una volta ricevuta una segnalazione ritenuta affidabile.
7
Infine, si identificano le strategie di gestione da mettere in atto nell’eventualità in cui le attività di
monitoraggio previste mettano in luce la presenza di individui di scoiattolo grigio.
SUMMARY
This document aims to develop an effective system for the rapid detection of new nuclei of alien squir-
rels expanding in (or newly introduced to) central Italy. Based on the provisions of the EU Regulation
1143/2014 we draw guidelines for a Rapid Response and Early Warning System to prevent the invasion
of the Grey squirrel in central Italy from the existing population in Umbria. The Grey squirrel is a serious
threat to the conservation of the Red squirrel, as demonstrated in studies carried out in United Kingdom
and Italy. In these countries the spread of Grey squirrel caused the depletion and local extinction of red
squirrel populations. The main purpose of the Life Project U-SAVEREDS are therefore the conservation
of the native populations of red squirrel in Umbria and the protection of biodiversity in forest ecosystems
of central Italy, both threatened by the presence and the expansion of the invasive Grey squirrel. The
main institutions and stakeholders to be involved in training and awareness activities are identified, in
order to broaden as much as possible the number of potential observers of the invasive species outside
of Umbria. Target regions will be those situated on the border with Umbria, i.e. Emilia-Romagna, Marche,
Tuscany and Latium. Furthermore, the criteria on the basis of which the reliability of the collected ob-
servations will be assessed are given, as well as the monitoring techniques to be implemented upon re-
ceipt of a reliable reporting. Finally, the management strategies to be implemented in the case that
monitoring activities would certify the presence of the Grey squirrel are presented.PREMESSA
Il presente volume si prefigge di tracciare le linee principali di un sistema di sorveglianza contro le
specie di scoiattoli aliene invasive, permettendo così una risposta gestionale in una fase precoce
dell’invasione: in sostanza, quello che in vari documenti e, soprattutto, nel recente regolamento
UE sulle specie aliene viene denominato Early Warning System and Rapid Response. Seppure la
trattazione è focalizzata principalmente nei confronti dello Scoiattolo grigio, le cui popolazioni umbre
mettono concretamente a rischio la conservazione dello Scoiattolo rosso nell’Italia centrale, quanto
previsto è suscettibile di applicazione, con i necessari aggiustamenti, anche nei confronti delle altre
specie di scoiattoli alieni già presenti in Italia, la cui minaccia viene analizzata e discussa.
L’obiettivo non è quello di individuare una rete di monitoraggio con competenze e ruoli ben precisi,
dal momento che la minaccia è distribuita su un territorio troppo ampio e frammentato tra innume-
revoli competenze amministrative. Più realisticamente, ci si propone di ampliare il più possibile la co-
noscenza e la consapevolezza della problematica della diffusione dello Scoiattolo grigio nell’Italia cen-
trale, sensibilizzando e formando il personale d’istituto e gli stakeholders presenti sul territorio.
In particolare, le azioni di monitoraggio e di gestione individuate sono quelle ritenute più idonee allo
stato attuale delle conoscenze e nella maggior parte dei contesti, ma la loro adozione dovrà esere
valutata caso per caso, tenendo contro delle caratteristiche specifiche del contesto ambientale in
cui si opera e delle competenze.
9
Da questo punto di vista, un ruolo determinante sarà rivestito dall’ASET (Alien Squirrel Emergency
Team), un gruppo operativo di specialisti previsto nell’azione F3 del Life U-Savereds, il cui appor-
to sarà fondamentale per il coordinamento e l’organizzazione delle attività per affrontare le even-
tuali minacce rilevate.1) INTRODUZIONE
Le specie alloctone invasive sono specie che non appartengono alla fauna originaria di una deter-
minata area geografica, ma che vi sono giunte per l’intervento diretto, intenzionale o accidentale del-
l’uomo, e sono considerate la seconda causa di perdita di biodiversità al mondo, seconda solamente
alla distruzione e frammentazione degli habitat. Tali specie sono identificate come uno dei fattori
chiave nel 54% delle estinzioni animali conosciute, e come il solo fattore nel 20% dei casi (Geno-
vesi et al., 2013). Le invasioni biologiche causano impatti negativi oltre che sulla biodiversità locale
e sulle specie autoctone, anche sull’agricoltura, l’industria, la pesca, le infrastrutture e la salute
pubblica (Vitousek, 1997; Wittenberg & Cock, 2001). Uno studio della Commissione Europea (Ket-
tunen et al., 2009; Scalera et al., 2012) ha stimato in oltre 12 miliardi di euro all’anno i costi a
scala europea di questo fenomeno. Il numero delle specie aliene invasive è in rapida crescita a li-
vello globale (McGeoch et al., 2010; Genovesi et al., 2013) e con esso crescono le evidenze degli
impatti ambientali e socioeconomici che queste provocano (Scalera et al., 2012).
L’introduzione dello scoiattolo grigio Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 in Europa rappresenta un
caso emblematico di invasione biologica: la specie alloctona sta sostituendo nel Regno Unito, in Ir-
landa e in Italia, attraverso un complesso processo di competizione tra le due specie (detto “esclu-
sione competitiva”), l’autoctono scoiattolo comune Sciurus vulgaris, più frequentemente conosciuto
come scoiattolo rosso (Wauters et al., 2002).
Recentemente, è stata scoperta una popolazione di scoiattolo grigio anche in Umbria, nel cuore del-
11
la penisola italiana, che ha fatto scattare un importante allarme per la conservazione della biodi-
versità forestale dell’Appennino e di tutto il centro Italia.
Per far fronte a questa minaccia, sette partner, tra cui la Regione Lazio, in qualità di beneficiario
associato, e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in qualità di ca-
pofila, hanno presentato all’Europa una richiesta di finanziamento tramite il programma LIFE+. Il
Progetto LIFE U-SAVEREDS “Management of grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel
and preventing loss of biodiversity in Apennines”, finanziato dalla Commissione, ha un approccio
gerarchico, in linea con quanto previsto dall’ultimo Regolamento europeo (N. 1143/2014) in ma-
teria, prevedendo nell’ordine: a) prevenzione, b) rilevamento precoce e c) gestione (con eradica-
zione o controllo).
Il presente documento tecnico nasce proprio nell’ottica di sviluppare un sistema efficace di rilevamento
rapido di nuovi nuclei di scoiattoli alloctoni in espansione o di nuova introduzione in centro Italia.2) LA MINACCIA DELLE SPECIE ALLOCTONE
Le specie aliene invasive (in inglese Invasive Alien Species, IAS) sono generalmente introdotte dal-
l'uomo (volontariamente o accidentalmente) al di fuori del loro areale originario, dove riescono a sta-
bilizzarsi, espandersi e dare origine a delle popolazioni che sono in grado di auto-sostenersi nel
tempo (Emerton & Howard, 2008), trasformando, di fatto, le aree in cui vengono a trovarsi con
conseguenze non preventivabili, sia per la conservazione della biodiversità locale, che per il be-
nessere umano. Le invasioni biologiche non sono certamente un fenomeno recente: le specie, sia
in tempi geologici che storici, si sono adattate, spostandosi, in risposta ai grandi fenomeni naturali
(dinamiche dei continenti, fenomeni vulcanici su ampia scala, cambiamenti sostanziali delle con-
dizioni ambientali) (Vermeij, 1991). Tuttavia è proprio negli ultimi decenni che, a causa della glo-
balizzazione, il sempre maggior volume di scambi commerciali a livello globale e la circolazione delle
persone (turismo, immigrazione, lavoro), hanno aumentato notevolmente la probabilità di intro-
durre specie esotiche, incrementando, così, il rischio di impatti negativi da parte di queste. La glo-
balizzazione ha portato, in parte, benefici economici e sociali, ma in nessun altro momento della
storia il tasso di invasioni biologiche è stato così elevato (Mack et al., 2000) e le conseguenze così
importanti (Mooney & Hobbs, 2000; McNeely et al., 2001; Reaser et al., 2003). Il fenomeno è in
continuo aumento: solo in Europa circa dieci nuove specie si insediano ogni anno, e tra queste
prevalgono invertebrati e pesci marini (Hulme et al., 2009).
L’insediamento di una specie introdotta è regolato da diversi fattori, tra cui i principali sembrano es-
sere la competizione e la predazione: la prima può ostacolare l’insediamento delle IAS, in quanto
13
le specie native sono meglio adattate a consumare le risorse locali e quindi limitano le risorse di-
sponibili per la specie esotica, mentre la seconda può condurre ad un aumento della mortalità
della specie invasiva e precluderne, così, la capacità di insediamento.
Nel fenomeno delle invasioni biologiche, tuttavia, non si devono tener in considerazione solamente
le caratteristiche degli “invasori”, ma, anche quelle degli ambienti “invasi”, poiché quest’ultimi sono
tanto più vulnerabili, quanto possiedono le seguenti peculiarità: basso stadio di climax (ovvero, lo sta-
dio finale del processo evolutivo di un ecosistema che denota il massimo grado di equilibrio), bassa
differenziazione delle comunità biotiche e assenza di predatori (Lodge, 1993). Questo è il motivo per
cui gli ecosistemi più a rischio di invasione biologica risultano essere quelli insulari e quelli delle
acque interne, nei quali le perturbazioni possono provocare impatti significativi ed irreversibili.
Solo in Europa, il Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE), che rappresenta
la più grande banca dati al mondo sulle specie aliene e un fondamentale strumento per lo sviluppo
di una strategia comunitaria di contrasto alle IAS, conta circa 11.000 specie non-native (di cui più
della metà sono rappresentate da piante terrestri). Di queste circa il 10-15% sono potenzialmente
pericolose per la biodiversità e per le attività antropiche e 163 sono classificate come “worst inva-
sive alien species” dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Figura 1). Dal 1950 ad oggi si stima che
più di una all'anno sia riuscita ad insediarsi nel Vecchio Continente con un trend che sembra non
mostrare segni di diminuzione. A tal proposito, Butchart et al. (2010), elaborando un indice per de-
scrivere il fenomeno relativo alle invasioni biologiche in Europa dal 1970 al 2007, hanno dimostrato
come il numero di specie aliene sia incrementato, nel periodo di riferimento, del 76% (Figura 2).Figura 1 - Distribuzione delle IAS più pericolose in Europa (DAISIE, 2011)
14
Figura 2 - Trend nella diffusione di specie aliene tra il 1970 e il 2007 in Europa (da Butchart et al., 2010)Nonostante l’impatto ormai assodato, l'introduzione di IAS continua, poiché alcuni canali (mezzi di
trasporto come gli aerei, le navi, in particolare le loro acque di zavorra, i treni, e i materiali che tra-
sportano come il legname e le derrate alimentari) non sono soggetti a controlli accurati, determinando
così la possibilità di sempre nuove introduzioni che vanno ad impattare profondamente sulla biodi-
versità locale e sulle attività antropiche.
L'entità degli impatti causati da una Invasive Alien Species in un certo ambiente è determinata dalle
interazioni tra questa e le specie native. La scomparsa di quest’ultime è, certamente, la conseguenza
più facilmente osservabile dell’impatto delle IAS e può avvenire in diversi modi, per inquinamento
genetico, predazione, interazione sanitaria, competizione diretta ed indiretta.
Oltre a quello sulla biodiversità, sta emergendo con sempre più forza l’impatto diretto delle IAS
sulla salute umana, che può essere legato principalmente alla trasmissione di patologie ed a rea-
zioni allergiche da contatto o da inalazione. Ad esempio, la zanzara tigre asiatica (Aedes albopic-
tus), introdotta in Europa soprattutto attraverso il commercio intercontinentale di pneumatici usati
ed ora diffusa in molti paesi dell'Europa meridionale, sembra che sia in grado, attraverso la sua pun-
tura, di veicolare più di 20 malattie, tra cui la febbre gialla.
Per ciò che riguarda gli aspetti inerenti le possibili reazioni allergiche, il contatto cutaneo con la pa-
nace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum), pianta tossica e invasiva, originaria del Cau-
caso ed importata in Europa per scopi ornamentali alla fine del XIX secolo, può determinare gravi
infiammazioni cutanee. Alcuni composti presenti nella linfa di questa pianta provocano delle foto-
15
dermatiti (Drever & Hunter, 1970; Lagey et al., 1995) nel momento in cui la pelle, successivamente
al contatto con la pianta, viene esposta al sole.
Nel loro complesso, gli impatti delle IAS comportano costi economici rilevanti, che possono esser ri-
partiti in due categorie: 1) perdite economiche direttamente causate dalle IAS; 2) stanziamenti di
fondi per riparare danni ecologici provocati dalle IAS (tutela di specie native, habitat ed ecosistemi,
prevenzione, eradicazione e controllo).
Per quanto riguarda l'Unione Europea è stato stimato un costo relativo alle IAS di almeno 12,5 mi-
liardi di euro/anno (Kettunen et al., 2009), che rappresenterebbero tuttavia una forte sottostima ri-
spetto ai 20 miliardi euro/anno ottenuti da altre stime (Pyšek & Richardson, 2010), con un’incidenza
economica maggiore nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, della selvicoltura e
della conservazione della natura.
Vi sono dei casi emblematici che aiutano a capire la portata locale dei costi legati alle specie aliene: nel
1980, in seguito ad un’introduzione accidentale, la medusa Mnemiopsis leidyi è riuscita a stabilirsi nel Mar
Nero, dando luogo ad un’esplosione demografica notevole che ha determinato conseguenze disastrose
per l’attività di pesca delle acciughe. I profitti economici della pesca sono scesi da 17 milioni di dollari/anno
a 0,3 milioni, causando un’evidente perdita economica (Knowler, 2005). Analogamente, l'introduzione
del parassita Gyrodactylus salaris nel Nord Europa, ha colpito i salmoni in diverse aree della Norvegia, cau-
sando una diminuzione della loro densità di circa l’86% nei corsi d'acqua interessati dalla presenza del
parassita. Le perdite, relative sia al reddito derivante dall'attività professionale, sia allo sfruttamento turi-
stico/ricreativo della pesca al salmone, sono state stimate in circa 20 milioni di euro/anno (Johnsen, 2006).Ed in Italia? Nei fiumi più della metà dei pesci sono alloctoni e specie come il siluro, predatore che
può superare i due metri di lunghezza ed il quintale di peso, stanno destrutturando le comunità itti-
che native. Sempre negli ambienti d’acqua dolce vanno ricordate specie come il gambero rosso della
Louisiana, che costituisce una minaccia diretta per l’autoctono gambero di fiume e per molte specie
di invertebrati, la nutria (Figura 3), in grado di causare con la sua azione di scavo il cedimento di in-
teri argini e le testuggini alloctone (Figura 4), importanti predatrici di avannotti e invertebrati. Nel nord
Italia sempre più numerosi sono i casi di allergie dovute all’espansione dell’ambrosia, pianta infe-
stante di origine nordamericana. Molte infrastrutture e monumenti sono danneggiati dalle radici del-
l’ailanto, albero invasivo dalle incredibili capacità vegetative. E in alcune aree del paese si assiste alla
progressiva scomparsa dello scoiattolo rosso, a causa dell’espansione dello scoiattolo grigio americano.
16
Figura 3 – Nutria (Foto di Dario Capizzi)
Figura 4 – Testuggine a guance rosse (Foto di Dario Capizzi)3) IL PROGETTO
Pur essendo ormai universalmente accettato dalla comunità scientifica che le problematiche legate
all’introduzione ed espansione delle specie alloctone hanno importanti ricadute sulla conserva-
zione della biodiversità locale e sulle attività umane, il dibattito e l'opinione pubblica tendono tal-
volta a misconoscere, per un vuoto di conoscenza e consapevolezza, la portata degli impatti recati
da queste specie e l’importanza di implementare azioni gestionali nei loro confronti (controllo o
eradicazione). Ciò è ancor più vero per quelle specie che hanno particolare appeal nei confronti dei
cittadini, quali ad esempio lo scoiattolo grigio o il daino. Si tratta infatti di specie indissolubilmente
legate a soggetti di cartoni animati e da sempre considerate, positive. I ratti o la nutria, invece, “pa-
gano” il loro aspetto generalmente considerato “brutto e sporco” e sono viste in chiave negativa.
Ad esempio, uno studio sperimentale sul controllo dello scoiattolo grigio in Piemonte ha portato
nel 1997 ad una forte opposizione da parte di alcuni gruppi animalisti, con conseguenti azioni le-
gali (Genovesi & Bertolino 2001). Successivamente, anche le azioni di gestione dello scoiattolo gri-
gio in nord Italia (LIFE EC-SQUARE, http://www.rossoscoiattolo.eu/) hanno incontrato opposizioni
locali da parte di associazioni e cittadini. Quante invece sono le azioni di contrasto alle operazioni
di derattizzazione, ad esempio?
Da tale difficile contesto sociale-comunicativo e dal fatto che questa è la prima volta che in Europa
lo scoiattolo grigio è stato introdotto in un'area caratterizzata da un'ampia e continua superficie bo-
scata (l'Umbria è per più del 50% coperta di boschi o aree alberate in genere), è nata l’esigenza
di dar vita ad una proposta progettuale ampia ed organica, che tenesse insieme la parte gestionale
17
con quella comunicativa, prevedendo, inoltre, delle azioni previste nel Regolamento Comunitario
n. 1143/2014 sulle specie aliene.
Scopo principale del Progetto LIFE U-SAVEREDS è quindi la conservazione dell’autoctono scoiat-
tolo rosso in Umbria e la tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali dell’Italia centrale, en-
trambi minacciati dalla presenza e dall’espansione dell’alloctono scoiattolo grigio.
Nel Progetto, quindi, accanto ad azioni di gestione attiva delloScoiattolo grigio sono previste altre
rivolte alla conservazione di nuclei di scoiattolo rosso in ambiente urbano tramite traslocazione o
rinforzo, miglioramento o ripristino di habitat idonei, sviluppo di un sistema di derattizzazione non
impattante sugli scoiattoli.
Inoltre, ad integrazione dell’Azione F.2, “Creazione ed implementazione di un Early Warning System
e Rapid Response extra-regionale” (di cui la redazione del presente volume fa parte), vi è l'azione
F.3 “Creazione ed implementazione dell’Alien Squirrel Emergency Team (ASET)”, che produrrà
anche in questo caso un protocollo operativo di intervento rapido per far fronte alla presenza di
nuovi nuclei di scoiattoli alieni in tutto il territorio nazionale, con un focus particolare sull'area ap-
penninica.4) IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA
DALLA STRATEGIA PER LA BIODIVERSITÀ AL REGOLAMENTO
SULLE SPECIE ALIENE - E IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO
Nel 2011, sulla spinta della Convenzione sulla Diversità Biologica, l’Unione Europea ha messo a
punto la Strategia Europea per la Biodiversità, con l’obiettivo di porre fine alla perdita di Biodiver-
sità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’Unione Europea entro il 2020.
La Strategia Europea per la Biodiversità è strutturata nei seguenti sei obiettivi prioritari:
a) favorire l’attuazione della normativa in materia ambientale;
b) proteggere e ripristinare gli ecosistemi, incrementando anche le infrastrutture verdi;
c) incentivare agricoltura e forestazione sostenibili;
d) incentivare la pesca sostenibile;
e) combattere le specie aliene invasive;
f) contribuire a bloccare la perdita di biodiversità a livello globale.
Tuttavia, uno strumento che ha determinato un radicale cambiamento del quadro normativo in
materia è rappresentato dal Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014, “recante disposizione
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”.
Il Regolamento, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, ha previsto anche la stesura di una lista di spe-
cie di “rilevanza unionale”, adottata dalla Commissione Europea il 13 luglio 2016, per le quali il Re-
19
golamento prevede stringenti restrizioni: esse non potranno essere portate né fatte transitare nel
territorio dell’Unione, e gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie atte a preve-
nirne l’introduzione o la diffusione accidentali. La norma comunitaria incoraggia più incisive azioni
su scala nazionale, nonché la collaborazione tra paesi confinanti, che potranno sviluppare piani con-
cordati per combattere le specie invasive.
La gerarchia di azioni previste dal Regolamento prevede appunto un primo sistema di preven-
zione, tramite il quale vi sarà un maggior controllo delle introduzioni, riducendo il rischio di in-
gresso delle specie nel territorio dell’Unione. Il sistema di rilevamento precoce ed eradicazione
rapida, invece, implica l’istituzione di un sistema di sorveglianza delle specie alloctone invasive
di rilevanza unionale, che dovrà essere istituito da parte degli Stati membri entro 18 mesi dal-
l’adozione dell’elenco stesso delle specie. In ultimo, nel caso in cui si accerti, per una delle spe-
cie di rilevanza unionale, una diffusione sul territorio nazionale già ampia, tale da rendere
impossibile l’intervento di eradicazione rapida, sarà invece necessario implementare delle misure
di gestione efficaci, volte al controllo (gestione permanente della specie) o all’eradicazione (ri-
mozione totale di tutti gli individui di quella specie).
La lista delle specie di rilevanza unionale, adottata dalla Commissione Europea il 13 luglio 2016,
comprende anche lo scoiattolo grigio.L’intero Regolamento UE n. 1143/2014 prevede una ben definita gerarchia di intervento nei con-
fronti delle IAS, che consiste in:
- prevenzione (capo II);
- rilevamento precoce ed eradicazione rapida (capo III);
- gestione (capo IV), per le specie già ampiamente diffuse.
Mentre il sistema di prevenzione mira ad agire sul controllo delle introduzioni, riducendo il rischio
di ingresso delle specie nel territorio dell’Unione, il sistema di rilevamento precoce ed eradicazione
rapida implica l’istituzione di un sistema di sorveglianza. A seguito di un eventuale rilevamento, gli
Stati dovranno quindi applicare, entro tre mesi, appropriate misure di eradicazione. In ultimo, nel
caso in cui si accerti, per una delle specie di rilevanza unionale, una diffusione sul territorio na-
zionale già ampia, tale da rendere non tecnicamente realizzabile l’intervento di eradicazione ra-
pida, sarà necessario implementare delle misure di gestione efficaci volte all’eradicazione, al
controllo numerico o al contenimento della popolazione
Per quanto riguarda l’Italia ed in particolare la questione dello scoiattolo grigio, già nel 2001 sono
state prodotte, dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le “Linee guida per il controllo dello
scoiattolo grigio in Italia” (Genovesi e Bertolino, 2001), che rappresentano lo strumento tecnico-ope-
rativo di riferimento per il monitoraggio e la gestione della specie.
Già nel 1999 e fino al 2007 lo Standing Committee della “Convenzione per la conservazione della
20
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa” (Berna, 1979) ha prodotto più richiami in materia di
specie alloctone (ed in particolare per lo scoiattolo grigio) nei confronti dell’Italia:
A. Raccomandazione n. 77 (1999) sull'eradicazione dei Vertebrati terrestri non-nativi;
B. Raccomandazione n. 78 (1999) sulla conservazione dello scoiattolo rosso in Italia;
C. Raccomandazione n. 114 (2005) sul controllo dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)
e altri scoiattoli alieni in Europa;
D. Raccomandazione n. 123 (2007) sulla necessità di limitare l'espansione dello scoiattolo gri-
gio (Sciurus carolinensis) in Italia, così da scongiurare la colonizzazione anche dei paesi
confinanti.
Successivamente il Decreto interministeriale del 24 dicembre 2012, “Disposizioni per il controllo
della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle specie Callosciurus
erythraeus, Sciurus carolinensis e Sciurus niger”, ha introdotto il divieto di commercio e di alleva-
mento e regolamentato la detenzione delle tre specie di scoiattoli alieni. Questo provvedimento,
che è stato uno dei risultati più importanti conseguiti dal progetto LIFE09 NAT/IT/00095 EC-
SQUARE, è stato quanto mai utile per la salvaguardia dello scoiattolo rosso, poiché ha messo fine
al commercio della specie alloctona ed eliminato, così, la pratica dei rilasci illegali di ulteriori indi-
vidui detenuti in cattività da parte dei privati cittadini.
Per quanto riguarda la gestione delle popolazioni in fase iniziale di insediamento o già ampiamente
diffuse, l’attuale quadro normativo nazionale è stato adeguato alla norma europea (Regolamento n.
1143/2014) grazie alla l. 116/2014 (art. 285, comma 12), modificando l'art. 2 della l. 157/92, in-
serendo dopo il comma 2 il seguente: “2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione dellespecie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di concerto con Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentito l’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la gestione di cui all’articolo 1, comma 3, è fi-
nalizzata ove possibile all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.»
Il Regolamento n. 1143/2014 sancisce il dovere per il nostro paese di adoperarsi nei confronti dello
Scoiattolo grigio, perseguendo la sua eradicazione o il controllo delle popolazioni.
4.1) Obiettivi dell’Early Warning System and Rapid Response
La localizzazione tempestiva di una specie alloctona è fondamentale nell’ottica di una rapida riso-
luzione del problema da essa costituito. Come esplicitamente scritto nel Regolamento UE n.
1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, “recante disposizioni volte a prevenire e ge-
stire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” (nota 24), “a partire dal momento
in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento pre-
coce e di eradicazione rapida per impedirne l’insediamento e la diffusione. La risposta più efficace
ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell’eradicare la popolazione il più presto possibile,
quando il numero di esemplari è ancora limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi
non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, sociali ed economici, si dovrebbero ap-
plicare misure di contenimento e di controllo. Le misure di gestione dovrebbero essere proporzio-
nate all'impatto sull'ambiente e tenere debitamente conto delle condizioni biogeografiche e
climatiche dello Stato membro interessato”.
21
La localizzazione di una specie alloctona in una fase precoce della sua diffusione permette infatti
di intervenire su un numero ridotto di individui ed in un’area circoscritta, o comunque non troppo
ampia. Le eradicazioni, infatti, hanno la massima probabilità di successo se compiute nelle prime
fasi dell’introduzione di una specie alloctona, mentre divengono via via più difficili con il passare
del tempo, quando la popolazione si accresce, gli individui si diffondono sul territorio, e l’eradica-
zione diventa assai più complessa e costosa, implicando inoltre la soppressione di un numero di
animali assai più elevato.
Negli ultimi anni si sta prendendo coscienza di questo specifico aspetto della gestione delle inva-
sioni biologiche, ed è nell’ambito di tale consapevolezza che il Regolamento prevede l’adozione di
pratiche riferibili alla strategia denominata “Early Warning system and Rapid response”. Il Rego-
lamento UE n. 1143/2014 definisce “rilevamento precoce” la conferma della presenza nell’am-
biente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa.
In particolare, un’intera parte del Regolamento (Capo III) è dedicata al “Rilevamento precoce ed
eradicazione rapida”.
Il Regolamento prevede l’adozione, da parte degli Stati membri, di un sistema di sorveglianza, di-
sponendo che questi si dotino di strutture operative preposte ad eseguire i controlli necessari a
prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, ri-
chiede agli Stati membri di notificare per iscritto alla Commissione il rilevamento precoce dell'in-
troduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e prevede l’obbligo
di eradicazione rapida.5) IL CASO PRATICO
5.1) Lo scoiattolo grigio e gli altri sciuridi alloctoni in Italia
In Italia sono presenti quattro diverse specie di scoiattoli alloctoni (Scoiattolo grigio, Scoiattolo va-
riabile, Scoiattolo di Pallas, Tamia siberiano), naturalizzate e con popolazioni spesso in incremento
in diverse aree del paese.
Lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) è la specie più conosciuta ed a maggior distribu-
zione. È uno scoiattolo arboricolo di media taglia (il suo peso può essere superiore ai 700
grammi) originario della porzione centro-orientale del nord America. Al di fuori del sub-conti-
nente nordamericano la specie è stata introdotta nel Regno Unito, in Sud Africa, in Irlanda, in
Italia ed in Australia (Koprowski, 1994). Solamente in quest’ultima nazione è stata eradicata
con successo nel 1973 (Peacock 2009), mentre nelle restanti aree lo scoiattolo grigio è dive-
nuto invasivo, tanto da guadagnarsi un posto tra le specie più pericolose sia a scala europea,
nel Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, che a scala globale, tra le 100 of
the World's Worst Invasive Alien Species (Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura).
In Gran Bretagna, la prima segnalazione di scoiattolo grigio risale al 1828 nel Denbighshire, una
contea del Galles settentrionale (Harris et al., 1995). La prima introduzione di cui si hanno ri-
scontri certi è, invece, datata 1876, quando alcuni individui furono rilasciati nel Cheshire (con-
23
tea inglese al confine con il Galles) per scopi ornamentali. Da quell’anno si verificarono diverse
introduzioni e traslocazioni in tutta la Gran Bretagna fino al 1929. Il processo di espansione ha
avuto un’importante fase in cui la specie si è insediata nelle Midlands e in tutto il sud dell’In-
ghilterra, tra il 1930 e il 1945, oltrepassando anche il confine con la Scozia. Contemporanea-
mente, si è assistito ad una fortissima rarefazione dello scoiattolo rosso, che ad oggi, sopravvive
in poche aree relitte del Regno Unito (con meno di 200.000 individui a fronte di più di 3 milioni
di scoiattoli grigi).
In Italia, lo scoiattolo grigio è presente attualmente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed
Umbria. La prima introduzione avvenne nel 1948 in Piemonte, quando due coppie, importate da
Washington DC (Stati Uniti d’America), furono rilasciate in un giardino privato presso Stupinigi,
in provincia di Torino. Nel 1966 cinque animali importati dalla città di Norfolk (Virginia, USA) ve-
nero rilasciati nel parco di Villa Groppallo a Genova Nervi (Bertolino et al., 2000). Una terza in-
troduzione si verificò nel 1994 a Trecate (provincia di Novara), quando il Comune finanziò il
rilascio di tre coppie in un parco urbano. Quest’ultimi individui vennero ricatturati due anni dopo
il rilascio. Successivamente si sono verificate diverse introduzioni in Lombardia, prevalentemente
nella porzione centro-occidentale della regione (Martinoli et al., 2010).
Come avvenuto nel Regno Unito, anche in Italia si sta verificando un processo di sostituzione tra
lo scoiattolo grigio e lo scoiattolo rosso. In Piemonte, lo scoiattolo grigio si espanso su un’area di
circa 2000 km2 tra Cuneo e Torino, nella quale lo scoiattolo rosso si è per larga parte estinto (Ber-
tolino et al., 2013).Figura 5 – Distribuzione dello scoiattolo grigio in Italia (da Shuttleworth et al., 2015)
Ma quali sono i meccanismi che portano alla sostituzione tra le due specie? Lo scoiattolo rosso e
24
lo scoiattolo grigio occupano una nicchia ecologica simile: entrambi sono arboricoli e diurni, con-
sumano le stesse risorse e producono un numero simile di piccoli negli stessi periodi dell'anno. Per
l’elevata sovrapposizione della nicchia, si va quindi delineando un quadro in cui una specie, lo sco-
iattolo grigio, risulta “vincente”, e l’altra “perdente” e destinata all’estinzione locale. Il meccani-
smo, riassunto con il termine “esclusione competitiva”, sembra essere il fattore più importante nel
processo di sostituzione che coinvolge i due Sciuridi. La competizione non si esplica attraverso
un’interazione diretta tra le due specie per la conquista delle risorse (Wauters & Gurnell, 1999), ma
vi sono una serie di fattori indiretti che portano la specie alloctona a prevalere su quella autoctona.
Questi si manifestano attraverso eventi negativi per la specie autoctona, che conducono ad un de-
cremento delle densità e ad estinzioni locali. In condizioni di simpatria con lo scoiattolo grigio, ad
esempio, la femmina di scoiattolo rosso non accumula una quantità di grasso sufficiente per rag-
giungere l’estro, si assiste ad un minor numero di piccoli per parto, ad alta mortalità giovanile e a
minor accrescimento della prole.
Lo scoiattolo grigio non presenta dimorfismo sessuale, né per taglia, né per colorazione del man-
tello (Koprowski, 1994) ed è facilmente riconoscibile per il caratteristico colore della pelliccia gri-
gio argento, dove si differenzia il dorso generalmente più scuro e la zona ventrale bianca o grigio
molto chiaro. Su dorso, zampe, inguine, muso, orecchie e zona perioculare, il pelo assume una co-
lorazione bruno-rossiccia. La coda possiede due caratteristiche bande laterali bianche, diagnosti-
che nel riconoscimento della specie, rispetto allo scoiattolo rosso che ha, invece, una colorazione
uniforme della coda. Lo scoiattolo grigio è diurno con picchi di attività giornalieri nelle prime ore del
mattino e il tardo pomeriggio. In inverno la specie non va in letargo, ma riduce notevolmente la sua
attività concentrandola nelle ore più calde della giornata.Il commercio, l’allevamento e la riproduzione dello scoiattolo grigio sono ad oggi vietati, mentre la
detenzione è stata regolamentata già nel 2013. La possibilità di ulteriori rilasci, seppur non del tutto
escludibile, si dovrebbe verificare con una bassissima probabilità. Quello che invece potrebbe ve-
rificarsi sono le traslocazioni di individui già presenti in natura, oltre alla possibilità, pressoché certa
in assenza di interventi di controllo, che le popolazioni attualmente presenti amplino il loro areale
di distribuzione.
Lo scoiattolo variabile (Callosciurus
finlaysonii) è originario di un’area che
comprende Birmania, Tailandia, Cam-
bogia, Laos e sud del Vietnam. Per
quanto riguarda l’Europa, gli unici nu-
clei naturalizzati sono presenti in Ita-
lia, dove sono note due popolazioni. Il
primo nucleo è in Piemonte, circo-
scritto ad un parco urbano del co-
mune di Acqui Terme, in provincia di
Alessandria, mentre il secondo assai
più esteso, interessa parte della costa
tirrenica lucana-campana (Aloise &
Bertolino, 2005). Entrambi i nuclei
sono frutto di introduzioni effettuate a
scopo ornamentale nel corso degli
25
anni ’80.
Lo scoiattolo di Finlayson, o scoiattolo
variabile, ha un mantello marrone-oli-
vastro nella parte superiore e color
crema ventralmente; la coda è fulva, a
volte con la parte apicale biancastra o
crema. Tuttavia, sia il dorso che la
coda sono caratterizzati anche da altri
pattern di colori (rosso mattone, grigio,
nero ecc.).
Le prime evidenze sulla diffusione
della specie ed il suo impatto sull’am-
biente indicano che lo scoiattolo varia-
bile ha il potenziale per diffondersi
assai velocemente e colonizzare con
successo habitat differenti, nonché
per rendersi responsabile di gravi
danni alle piante arboree. Tali danni
sono particolarmente ingenti nel corso
dell’inverno, e consistono in estese de-
Figura 6 - Scoiattolo grigio (Foto di Sandro Bertolino) corticazioni sui rami di diverse specie.Pur non essendo inserito nella lista di specie per la quale è regolamentata la detenzione e sono vie-
tati il commercio e la riproduzione, il commercio della specie negli ultimi anni appare molto dimi-
nuito. Pertanto, sebbene nuovi rilasci appaiano poco probabili, potrebbero comunque verificarsi
operazioni di traslocazione di individui.
26
Figura 7 - Scoiattolo variabile o di Finlayson (Foto di Dario Capizzi)
Il tamia siberiano (Tamias sibiricus) è un piccolo scoiattolo (50-120 g) di colore giallo ocra, con capo
e corpo bruno-rossastri. Caratteristiche distintive sono le cinque strie longitudinali scure molto evi-
denti presenti su dorso e fianchi. Anche la coda presenta alternanza di bande chiare e scure in
senso longitudinale. È una specie ad amplissimo areale, che va dalla Russia europea fino al Giap-
pone, comprendendo anche parte della Cina settentrionale. E’ stato introdotto in diversi paesi eu-
ropei, tra cui Austria, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania ed Italia (Bertolino et al., 2000).
In Italia, popolazioni stabilmente insediate sono presenti a Verona, Belluno e Roma, quest’ultima
nel parco urbano di Villa Ada. Le prime due popolazioni sono frutto di introduzioni compiute negli
anni ’70, la terza si è stabilita negli anni ‘80. Tuttavia, singoli esemplari sono stati segnalati in nu-
merose località italiane di Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Lazio (Ber-
tolino & Genovesi, 2005).
L’introduzione in Italia è avvenuta tramite fughe accidentali, come nel caso della popolazione di Bel-
luno, sfuggita ad un importatore di animali da compagnia, o in seguito a rilasci intenzionali di animali
detenuti in cattività, come si verifica nei parchi urbani. La specie è ancora oggi oggetto di commercio.In alcune zone dell’areale nativo della specie si hanno segnalazioni di danni alle colture cereali-
cole (Long, 2003), mentre le osservazioni preliminari compiute nelle località italiane d’introdu-
zione non segnalano danni alle piante forestali od ornamentali, né fenomeni di competizione con
specie autoctone, in particolare con lo Scoiattolo comune. In due località (Roma e Belluno) le due
specie vivono in simpatria ormai da diversi anni senza apparenti conseguenze sulla stabilità delle
popolazioni dello scoiattolo comune. Analoghe osservazioni preliminari sono state compiute in
Francia, dove è stato tuttavia ipotizzato che il tamia siberiano possa rendersi dannoso alle spe-
cie di uccelli che nidificano sul terreno (Riegel et al., 2000; Le Louarne & Quéré, 2003). La spe-
cie è stata di recente individuata come serbatoio della Borreliosi di Lyme, una zoonosi veicolata
dalle zecche, che può colpire anche l’uomo.
La specie è tutt’oggi, fra gli scoiattoli, quella maggiormente oggetto di commercio. Pertanto, la pro-
babilità di formazione di nuove popolazioni dovuta al rilascio di individui è altamente probabile.
27
Figura 8 - Tamia siberiano (Foto di Dario Capizzi)
Lo scoiattolo di Pallas (Callosciurus erythraeus) è uno scoiattolo di taglia medio-piccola con abitu-
dini arboricole e diurne. Il peso degli individui italiani varia tra 250 e 320 grammi. E’ originario delle
foreste sub-tropicali e montane dell’Asia, ampiamente diffuso in gran parte della Cina meridionale,
Myanmar, Cambogia, India, Malesia, Laos, Bangladesh, Vietnam e Tailandia. Frequenta la chioma
degli alberi e nidifica nelle loro cavità.
È stato introdotto in diverse aree del mondo per motivi estetici. Popolazioni naturalizzate sono pre-
senti in Argentina, Giappone, Hong Kong ed in Europa dove, oltre alla popolazione introdotta nel
nord Italia (nell’area del Lago Maggiore in provincia di Varese), la specie è presente in Francia,
Olanda e Belgio.Il mantello è di colore oliva-marrone sul dorso, la testa, i fianchi e gli arti, talvolta tendente al grigio
sui fianchi e gli arti. Il ventre, invece, è tipicamente rosso in alcune popolazioni, giallo-arancione in
altre. Negli animali a ventre rosso anche parte del capo ha una colorazione simile.
La coda si presenta fulva nella parte iniziale, tendente al bianco all’estremità finale. La colorazione
della coda è tale da apparire leggermente ad anelli.
Gli impatti causati da questa specie sono molteplici e vanno dalla competizione con lo scoiattolo
rosso (in Europa), al danneggiamento di piante forestali, sistemi di irrigazione, alberi da frutto e
piante ornamentali in parchi urbani.
Lo scoiattolo di Pallas è anch’esso, come lo scoiattolo grigio, inserito nel DM 24 dicembre 2012.
Pertanto la sua detenzione è regolamentata, mentre il commercio, la riproduzione e l’allevamento
sono vietati. Anche in questo caso, nuove popolazioni possono essere formate per traslocazione
degli individui presenti in natura.
28
Figura 9 - Scoiattolo di Pallas (Foto di Maria Vittoria Mazzamuto)5.2) Lo scoiattolo grigio in centro Italia
In Umbria, le prime segnalazioni di scoiattolo grigio risalgono al 2003, nelle aree circostanti un
Parco faunistico privato all’interno della Zona Speciale di Conservazione IT5210021 “Monte Malbe”.
È possibile ipotizzare che i rilasci siano avvenuti all’interno del parco stesso poco prima del 2000.
Tuttavia, fino al 2009 la sua presenza è rimasta pressoché sconosciuta alla comunità scientifica e
alle istituzioni. Approfittando di questo lasso temporale in cui non sono state messe in atto azioni
di contrasto, grazie alla sostanziale assenza di predatori e alle condizioni ambientali favorevoli
(anche a causa della forte disponibilità alimentare data da mangimi e granaglie somministrati agli
animali detenuti in cattività all’interno del parco), la specie si è progressivamente espansa fino a dif-
fondersi in un'area di almeno 50 km2, che comprende gran parte dell'area urbana di Perugia. Le
indagini genetiche, effettuate su alcuni individui catturati, fanno ipotizzare con un elevato grado di
probabilità che tale popolazione derivi da alcuni scoiattoli catturati illegalmente in Piemonte (Si-
gnorile et al., 2014).
Secondo una stima parsimoniosa il nucleo di scoiattoli grigi può esser quantificato in 1500 indivi-
dui presenti in circa 50 km2 (Figura 10). La distribuzione è ancora fortemente legata a quello che
sembra essere il sito di rilascio; tuttavia, dopo poco più di 10 anni dall’introduzione, le segnalazioni
nella periferia della città di Perugia si vanno moltiplicando e, contemporaneamente, si sta assi-
stendo alle prime estinzioni locali dell’autoctono scoiattolo rosso. Nella stessa area di indagine, in-
fatti, a fronte di 1500 scoiattoli grigi rilevati, i rossi risultano essere appena 110 circa.
La presenza di Sciurus carolinensis in Umbria rappresenta una potenziale minaccia per la biodi-
29
versità forestale di tutta l’Italia centrale, considerando le seguenti caratteristiche geografiche-eco-
logiche della regione:
- ampia diffusione di vegetazione naturale con elevata componente boschiva costituita preva-
lentemente da querceti;
- elevato grado di connettività ecologica dato da sostanziale assenza di barriere;
- posizione “baricentrica” nella penisola.
Inoltre, la continuità forestale dell’Appennino potrebbe divenire, in caso di mancata gestione della
specie alloctona, un percorso “preferenziale” per un'espansione lungo la penisola sia verso nord
che verso sud.
Le problematiche legate alla presenza dello scoiattolo nord-americano non si limitano solamente ad
un impatto fortemente negativo sulle biocenosi forestali, ma potrebbero interessare nel medio-lungo
periodo anche importanti settori agricoli locali, quali la viticoltura e la frutticoltura. Inoltre, la pro-
vincia di Viterbo, posta al confine sud-occidentale con l’Umbria, rappresenta una delle aree più im-
portanti in Italia per la coltivazione del noccioloe per la raccolta di castagne, due frutti
abbondantemente utilizzati come risorsa trofica dallo scoiattolo grigio. Quest’ultimo potrebbe quindi
arrecare, considerata anche la sua capacità di vivere ad altissime densità, seri impatti economici
alle produzioni locali, generando così anche problematiche di natura sociale.
Un modello predittivo, specificatamente sviluppato per valutare le possibilità di espansione dello
scoiattolo grigio in Umbria, (Corti et al., in prep) suggerisce che, a partire dal 2016 ed in mancanza
di idonee azioni gestionali, la specie alloctona potrebbe invadere completamente i comuni di Peru-Figura 10 – Distribuzione dello scoiattolo grigio in Umbria
30
gia e Corciano, raggiungendo inoltre il Lago Trasimeno, che si trova ad ovest del capoluogo umbro.
Nello stesso lasso di tempo, la specie sarebbe in grado di oltrepassare il Tevere. In 20 anni, lo sco-
iattolo grigio potrebbe raggiungere il confine tra Umbria e Toscana attraverso un potenziale corridoio
costituito da un’importante area boscata continua a nord del lago Trasimeno (valle del Niccone).
Contemporaneamente l’espansione potrebbe procedere nella porzione occidentale della regione, a
sud del Trasimeno. Nel 2042 lo scoiattolo alloctono potrebbe dunque raggiungere il confine con la
Toscana in un’area molto prossima anche al Lazio, mentre nel 2052 potrebbe essere avviata la di
colonizzazione dell’Appennino a partire dall’area del parco regionale di Monte Cucco.
Figura 11 – Modello di espansione dello scoiattolo grigio inell’Italia Centrale (Corti et al., in prep)5.3) Attuazione dell’EWRRS per l’Italia centrale
L’obiettivo di un sistema che permetta di localizzare tempestivamente una specie alloctona invasiva
è quello di rendere fattibile la sua eradicazione in tempi rapidi. Un’invasione fronteggiata ad uno
stadio precoce, infatti, permette di intervenire su un numero di individui limitato, con evidenti van-
taggi in termini di risorse da mettere in campo per risolvere il problema. Per comprendere tali van-
taggi, un caso esemplare da considerare è quello della nutria. In Gran Bretagna, grazie ad un
intervento tempestivo ed un’intensa attività di trappolamento, la specie è stata eradicata rapida-
mente. Al contrario, in Italia, così come in molti altri paesi, la situazione della nutria non è stata af-
frontata con adeguato tempismo, ed il risultato è che adesso la specie è capillarmente diffusa in
tutta la penisola ed in parte della Sicilia e della Sardegna, e la sua eradicazione è ormai impossi-
bile. Tuttavia, gli interventi di controllo eseguiti in Italia, necessari per il contenimento dei danni
che la specie arreca alle attività agricole e agli argini, interessano oggi diverse decine di migliaia di
individui l’anno, a dimostrazione di come il mancato intervento su pochi nuclei nella fase precoce
dell’invasione si traduca, nel lungo periodo, in una ben maggiore quantità di individui soppressi.
La situazione specifica della popolazione di scoiattolo grigio dell’Umbria è quella di un nucleo in via
di espansione, ma ancora territorialmente confinato. Sebbene la parte più consistente del progetto
LIFE U-SAVEREDS si occupi dell’eradicazione del nucleo di scoiattoli grigi localizzato intorno alla
città di Perugia e di attuare misure di conservazione e ripristino ambientale a favore dello scoiat-
tolo rosso, un’azione specifica (Azione 2Azione F.2, in sinergia con l’Azione F.3 “Costituzione del-
l’Alien Squirrel Emergency Team”) ha l’obiettivo di attivare un sistema di rilevamento precoce della
presenza di individui della specie target nelle regioni limitrofe all’Umbria, con lo scopo di intercet-
31
tare tempestivamente gli individui che dovessero disperdersi al di fuori del confine regionale, e di
individuare nuclei anche di altre specie di scoiattoli alloctoni che fossero presenti in centro Italia.
In sostanza, l’obiettivo specifico è quindi quello di una rete di monitoraggio che interessi le regioni
confinanti con l’Umbria (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio), con particolare riguardo alle
zone situate in prossimità delle aree di confine in cui sia nota la presenza della specie alloctona.
La rete dovrà coinvolgere rilevatori che, per la loro attività istituzionale, professionale o nel tempo
libero, frequentino le zone dove è maggiore la probabilità di imbattersi in esemplari di scoiattolo gri-
gio o di altre specie di scoiattoli alloctoni. Si tratta di zone boscate ed ecosistemi agroforestali, ha-
bitat di elezione di tali specie, oppure parchi urbani e aree verdi delle città, sedi, talvolta, di rilasci
indiscriminati da parte di privati cittadini.
L’attività dell’Azione F2 consisterà innanzitutto nell’individuare le figure più idonee, occupandosi
quindi della loro sensibilizzazione e formazione. E’ fondamentale, infatti, che i rilevatori e i referenti
comprendano la minaccia costituita da tutti gli sciuridi alloctoni e siano, oltre che spinti da forte mo-
tivazione, in grado di distinguere essi stessi la specie, o di porre precise domande in caso vengano
in contatto con altre persone che riferiscano di avvistamenti sospetti.
Nel prosieguo del capitolo si passeranno in rassegna le figure istituzionali e professionali e gli sta-
keholders coinvolti, ed il loro potenziale ruolo nella rete di rilevamento precoce dello scoiattolo gri-
gio e di altre specie di scoiattoli alloctoni nelle regioni limitrofe all’Umbria.5.4 Referenti istituzionali e stakeholders
Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali
Nell’Italia centrale vi sono alcuni Parchi Nazionali che potrebbero essere raggiunti dallo scoiat-
tolo grigio:
- il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una cui parte insiste sul territorio umbro, comprende
anche ampi settori dell’Appennino Marchigiano. Le provincie interessate sono Perugia (2 co-
muni), Ascoli Piceno (3 comuni), Fermo (2 comuni) e Macerata (11 comuni).
- il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a cavallo tra Abruzzo, Lazio e Marche,
è suddiviso tra le provincie di Ascoli Piceno (2 comuni), Rieti (2 comuni), L’Aquila (16 co-
muni), Pescara (10 comuni), Teramo (14 comuni). Soprattutto le prime due potrebbero es-
sere oggetto di interesse per la localizzazione dello scoiattolo grigio.
- il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, a cavallo fra To-
scana ed Emilia-Romagna, interessa le provincie di Forlì-Cesena (6 comuni), Firenze (2 co-
muni), Arezzo (4 comuni). Quest’ultima provincia è probabilmente quella a maggior rischio di
espansione dello scoiattolo grigio.
Nelle Marche, di interesse è la Riserva Naturale Gola del Furlo.
Parchi Regionali
Marche
32
Fra le aree protette regionali delle Marche, quelle che per la loro localizzazione potrebbero essere
interessate dall’espansione dello scoiattolo grigio sono il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa
e di Frasassi, in Provincia di Ancona (4 comuni), il Parco del Monte Cucco, Il Parco di Colfiorito, il
Parco Naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello, la Riserva Naturale di Torricchio.
Emilia-Romagna
I Parchi regionali dell’Emilia Romagna sono piuttosto distanti dal confine con l’Umbria. Tuttavia,
anche in considerazione della continuità boschiva esistente, alcune aree protette potrebbero, in
caso di ritardi nell’operazione gestionale, essere coinvolti a lungo termine nell’espansione dello sco-
iattolo grigio.
Parco Storico di Monte Sole
Parco della Vena del Gesso Romagnola
Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa
Parco del Corno alle Scale
Toscana
La maggior parte delle aree protette regionali della Toscana sono assai distanti dal confine con
l’Umbria: si ritiene quindi poco probabile che possano essere interessate dall’espansione della po-
polazione di Scoiattolo grigio attualmente presente nella regione limitrofa. Tuttavia potrebbero en-
trare nella rete di monitoraggio per l’individuazione di eventuali altri nuclei di scoiattolo grigio o
delle altre specie di scoiattoli alloctoni. Soltanto alcune piccole riserve localizzate in prossimità del
confine con l’Umbria sono da ritenersi in pericolo per l’espansione della popolazione umbra e do-Puoi anche leggere