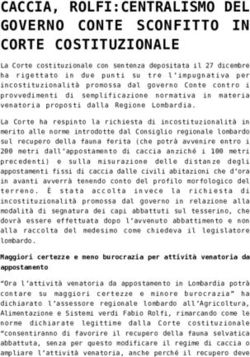Da Versailles a Torre Maura: il pane e la critica - Fondazione ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Da Versailles a Torre Maura:
il pane e la critica
Abbiamo amato la decostruzione, la differenza, la
resistenza. Abbiamo coltivato la contaminazione, l’i-
bridazione, la moltitudine. Oggi queste parole, con le
quali abbiamo per anni scritto di filosofia, scomposto
tradizioni e composto teorie, da carismatiche astra-
zioni diventano prosaiche concrezioni, e non sono
OLIVIA GUARALDO come le avevamo immaginate. A forza di decostruire,
Professoressa associata di di de-naturalizzare, di de-familiarizzare siamo arrivati
filosofia politica presso il ad un punto in cui ogni retorica emancipativa che po-
Dipartimento teva guidare l’intento originario è svanita. Prevale un
di Scienze Umane dell’Università relativismo incattivito e paradossalmente identitario.
di Verona, dove dirige il Centro Le differenze e i loro diritti hanno moltiplicato le pre-
Studi Politici Hannah Arendt. tese di riconoscimento mettendo minoranze contro
minoranze, in una balcanizzazione delle identità politi-
camente sterile. Non c’è più un noi, o se c’è è il noi del
consumo ‘on demand’, nell’era del prodotto ‘customi-
zed’, confezionato in serie ma su misura, secondo la
preferenza individuale. La resistenza, poi, c’è, è vero,
ed è quella di gruppi o movimenti antagonisti, con
larghi progetti emancipativi ma piccoli seguiti. La resi-
Pubblicato su stenza di massa è invece quella di crescenti populismi
http://www. che mal sopportano le istituzioni democratiche, i loro
leparoleelecose. pesi e contrappesi (lungaggini), i loro orizzonti valoriali
it/?p=38219 (ipocriti, corrotti). Le moltitudini non sono per la libertà
e l’uguaglianza ma per la casa popolare agli italiani:
la rivolta del pane non ha più le fattezze gloriose della
marcia delle donne su Versailles, ma quelle odiose di
Torre Maura, con tanto di calpestio ostinato sui panini
per i bambini Rom. La contaminazione e l’ibridazione
prendono ora le concrete forme di una paura collet-
tiva a cui nessuna e nessuno si sottrae: una fottuta
paura di morire per un virus cinese ci avvolge come
un incantesimo.
Non funzionano più i buoni propositi emancipati-
vi che presupponevano la critica. Una critica che ci
istruiva su cosa non andava, su come le cose fos-
sero diverse da come apparivano, su quali rapporti
1di forza (visibili e invisibili) determinavano il presen-
te dell’oppressione, dello sfruttamento, dell’ingiusti-
zia. La critica ha continuato a predicare le sue verità
nascoste – purtroppo ad essa non ha fatto seguito
nessuna presa del Palazzo d’Inverno né tantomeno
la coscienza di classe diffusa, l’autonomia operaia, la
sovversione, o, come diceva Marx, “l’abolizione dello
stato di cose presente”. Le cose sono senz’altro più
complesse e articolate di quanto questo pezzo possa
argomentare (che poi dev’essere breve ed efficace,
altrimenti non verrà letto. Altro problema della critica:
il suo linguaggio da iniziati, la sovradeterminazione
di ogni termine usato, in codice per chi sa, e capisce
l’ammiccamento, gli altri non meritano.) Certo è che
alla radicalità (linguistica, politica, culturale) di quella
critica – che è sempre anche critica sociale[1] – ha
fatto seguito una sua sconcertante irrilevanza. Più è
radicale meno è efficace. Più è radicale, però, più è
contenta di sé.
Gli effetti di questa irrilevanza sono, almeno per
chi ci tiene agli intenti emancipativi di ogni sapere
(come chi scrive), duplici: da una parte un arrocca-
mento sdegnoso e sdegnato, pessimista sul presen-
te e nostalgicamente attaccato alle identità politiche
di un tempo, a quel Novecento che non c’è più, ma
che viene pietrificato, ossificato, trasformato in fossile
(orientalizzato, direbbe Edward Said, ma qui sto ca-
dendo nel tranello dell’intellettualismo che vorrei cri-
ticare), ossia escluso dalla storia, rivendicato come il
tempo delle vere contrapposizioni, delle vere identità
politiche, delle vere lotte per l’uguaglianza, dei veri
movimenti antagonisti. Come se ci fosse un passato
che non muta al mutare del presente che lo segue. Il
Novecento come preistoria.
Dall’altra, una incapacità di provare entusiasmo, fe-
licità, speranza per ciò che si mostra, ciò che continua
ad accadere nella realtà (perché le cose accadono, la
storia si muove) e che ha dell’emancipativo, del posi-
tivo, del nuovo. Insomma, una sorta di atteggiamento
dogmaticamente sospettoso verso tutto, perché die-
tro ogni manifestazione del nuovo si può nascondere
il Satana multiforme del neoliberismo: Greta Thunberg
2è una ragazzina eterodiretta, l’esempio lampante di un
essere umano trasformato in marchio dal capitale. I
Fridays for future sono solo l’espressione giovanile di
una cultura mediatica completamente inconsapevole
delle vere dinamiche di sfruttamento della natura fat-
ta dalle grandi corporation. Le Sardine un fenomeno
nato sui social, effimero, buonista, moderato, incon-
sistente e privo di qualsiasi agenda politica. Manca a
queste istanze, secondo il sopracciglio aggrottato del
critico o della critica, la serietà, la cattiveria, la prepa-
razione, la consapevolezza. Non ci può essere politica
seria senza un sapere critico serio.
Sarà per questi motivi (ma altri potrebbero essere
elencati) che, come afferma Mariano Croce, anziché
farsi portatrice di una spinta trasformativa, la critica
sarebbe paradossalmente connivente con un man-
tenimento ambiguo dello status quo: “la critica per
un verso oscura e travisa i fenomeni che osserva e
per l’altro accentua (o persino determina) le storture
sociali che denuncia”[2]. Detto altrimenti, l’apparente
immobilità dell’oggi se da una parte ha avuto i suoi
gloriosi rappresentanti nei teorici della fine della Storia
e nei celebratori dell’eterno presente della prosperità
occidentale, dall’altra essa sembra essere appunto
sostenuta da coloro che attraverso l’esercizio costan-
te e pervasivo di un atteggiamento critico e sospetto-
so, cinico e distaccato, inibiscono atteggiamenti af-
fettivi differenti, positivi e propositivi, riconducendoli
tutti, sempre e comunque, alla cornice di un regime
di potere/sapere neoliberale che mira a investire, per
sfruttarli, gli aspetti più intimi, emotivi, relazionali della
soggettività.
Certo il neoliberismo esiste, così come esiste un
“realismo capitalista”[3] che predica ormai da un tren-
tennio che “there is no alternative” a questo mondo
del consumo, della competizione come modello rela-
zionale, dell’economia estrattiva, della medicalizzazio-
ne del disagio e della psicologizzazione della devianza
(ecco che ricado nel gergo, ma detto semplicemente
ciò significa: “se sei sfigato è per colpa tua, se sei
povero è perché non hai voglia di lavorare, se sei un
‘loser’ è perché non hai rischiato abbastanza”), della
3diffusa solitudine che si trasforma in estraniazione e
necessariamente in infelicità.
Noi che aderiamo all’ipotesi – ma più che un’ipotesi
è una sfida – della postcritica siamo convinte e con-
vinti che non si combatte il neoliberismo con le vec-
chie armi della critica. Essa rischia, pericolosamente,
di confermare l’ipotesi thatcheriana del “there is no
alternative”. Ci chiediamo, dunque, se sia possibile
abbandonare il piglio scettico, sospettoso, incattivi-
to e nostalgico, proprio di un certo discorso critico
prevalente nella teoria sociale e politica, senza rinun-
ciare ad una tensione trasformativa. Anzi, siamo con-
vinte (e convinti, perché ad una differenza teniamo,
quella sessuale) che proprio abbandonando il mood
scettico-sospettoso e contrarista della critica possia-
mo recuperare tensione trasformativa, abbracciando
un’erotica del cambiamento. Proprio perché il discor-
so critico ha bandito dal suo registro discorsivo mo-
dalità affettive diverse da quelle del sospetto, del “le
cose non sono così come sembrano”, si è condannata
all’irrilevanza. E proprio perché non vogliamo essere
irrilevanti, aderiamo alla postcritica. Che pure non è
una scuola, un progetto, un partito, un movimento, ma
un atteggiamento. Forse anche un ritmo. Una bossa
nova, che, come la musica brasiliana ideata da Jobim,
è un innesto vivificante del nuovo sul vecchio, una sua
raffinata e molto sensuale rivisitazione.
Dunque è un mood affettivo quello che guida la po-
stcritica: uno dei suoi intenti è far riaffiorare gli affetti,
che da sempre muovono l’agire. Non si tratta però di
dire in che cosa consistano gli affetti, se sono veri e
autentici oppure se sono eterodiretti, sfruttati dal ‘si-
stema’ per fare profitto. Si tratta piuttosto, per chi fa
un lavoro intellettuale, di situarsi, su un piano di oriz-
zontalità, insieme agli attori sociali, per capirne le mo-
tivazioni senza pretendere di spiegare a loro il senso
del loro stesso agire. Nessuna avanguardia, nessuna
direttiva teorica. Situandosi affettivamente nell’intrec-
cio delle relazioni umane, ci si immerge nel tessuto del
reale e, al massimo, si cerca di stabilire connessioni,
di fare da ‘leganti’ . Ogni presa di posizione è un si-
tuarsi entro un fascio di energie: tale energia, “si può
4utilizzare per un arroccamento distante, sospettoso,
presago di mali a venire per noi e per tutti. Essere
critici nel senso più deleterio”, oppure ci si pone nel-
la “linea delle connessioni in modo tale che l’energia
eserciti la forza incrementale della moltiplicazione.”[4]
Certo è che gli affetti da incrementare e moltiplicare
sono gli affetti aggregativi, erotici, generativi e non
quelli già troppo moltiplicati virtualmente e realmen-
te dell’odio, del risentimento, della paura, dei panini
calpestati.
La novità della postcritica risiede quindi anche (e
soprattutto) in un atteggiamento, che, come dice Rita
Felski, si congeda dal cinismo, dal disincantamento,
dalla pretesa che il lavoro intellettuale debba coinci-
dere con il “dire no” piuttosto che con il “dire sì”. A
questo congedo corrisponde invece una attenzione
e una considerazione per affetti positivi e riparativi,
propri di ambiti semantici di parole come “ispirazio-
ne, invenzione, riconoscimento, conforto, riparazione,
passione”[5].
La forma di energia proposta dalla postcritica – nel
cui fascio il teorico, la teorica si può situare, cercan-
do di stabilire connessioni – permette agli affetti ge-
nerativi e propositivi che la filosofia da tempo fatica
a cogliere, di guadagnare la superficie, di affiorare.
Perché essi insistentemente si affacciano sul teatro
dell’accadere, in forme carsiche, sconnesse, prive di
scopi grandiosi eppure reali, concretamente attive,
dinamiche, produttrici di senso per chi le agisce, indi-
pendentemente dagli scopi che possono raggiungere.
I Fridays for future, le Sardine, ma anche le piccole
comunità di associazionismo, sia sociale sia culturale,
che popolano i nostri territori di provincia ma rara-
mente guadagnano visibilità. Vale la pena, mi pare,
di cogliere, “a partire dalla posizione nella quale sto”
(che poi è una nobile postura femminista, il “partire
da sè”), le linee di energia dentro cui posso inserirmi,
per tessere legami, avviare connessioni, potenziando
quell’erotica del legame che il nostro tempo ha dimen-
ticato trasformando ogni erotica in consumo osceno
di corpi.
Uno dei principali elementi generativi della postcri-
5tica è proprio questa apertura all’accadere, senza so-
spetto, estranea ad ogni postura ‘preventiva’ che rifiu-
ta la realtà. Penso che ‘accadere’ sia proprio una pa-
rola postcritica – sono felice che esista questa parola,
interrompe l’autoreferenzialità della filosofia come cri-
tica, la silenzia. Permettetemi di fare una connessione,
forse forzata: accadere si dice in inglese “to happen”,
ed è proprio la happiness del to happen che dovrem-
mo essere in grado di saper cogliere, senza sospetti
di infiltrazioni delle spie neoliberiste, quando le per-
sone si ritrovano insieme – in piazza, in una stanza,
in un corteo, un’assemblea, una riunione. La felicità
pubblica dello stare insieme viene prima di ogni riven-
dicazione, di ogni progetto, di ogni agenda politica, di
ogni conflitto. C’è un elemento sorgivo, direbbe Adria-
na Cavarero, nel ritrovarsi insieme in una piazza, che
testimonia di una origine non utilitaristica della politi-
ca, bensì innanzitutto affettiva[6]. Gli scopi dell’agire
politico (comune, collettivo, plurale) sono sempre se-
condari rispetto al piacere, alla gioia, alla felicità dello
stare insieme. Come dice Hannah Arendt, chi fa la
rivoluzione scopre la libertà nell’atto stesso della libe-
razione[7]. Non è la liberazione (e la violenza che la ac-
compagna) il momento decisivo della rivoluzione, ma
la libertà, l’accadere miracoloso dell’iniziare qualcosa
di nuovo insieme ad altri, l’accadere partecipativo che
abbiamo ormai scordato di chiamare politica. Se non
prestiamo occhi ed orecchi a questa erotica che sta
al fondamento della democrazia, faremo vincere altri
affetti, assistendo inermi alla polarizzazione fra un af-
fetto dell’incattivimento incrementale e un affetto del
cinismo compulsivo, del disincantamento come unico
accesso alla verità.[8]
Postcritica è un venire dopo la critica, perché di
necessità, come dice ancora Felski, “è una questione
di modi di pensare che non ci sorprendono più, e allo
stesso tempo bloccano altri percorsi in quanto ‘insuf-
ficientemente critici’. Ad un certo punto la critica non
ci porta più da nessuna parte”[9].
Farò, in conclusione, un esempio di come possa
funzionare la postcritica come prospettiva analitica
e affettiva ad un tempo, facendo riferimento ad una
6ricerca di stampo sociologico ed etnografico che ho
di recente supervisionato. La ricerca si occupa delle
procedure per la richiesta del diritto d’asilo a migran-
ti LGBTQ, condotta anche sul campo, con operatori
del settore e richiedenti, e mette in evidenza come il
dispositivo di accoglienza umanitaria sia – come tut-
ti i dispositivi giuridici – spesso duro e violento nel
suo funzionamento. I metodi dell’intervista fatta dalle
commissioni territoriali al fine di capire se il richieden-
te dice la verità e ‘merita’ la protezione internaziona-
le sono spesso approssimativi, mettono in atto una
violenza simbolica nei confronti dei richiedenti asilo
che porta a rendere ancora più vulnerabili i richiedenti
stessi. Il ricercatore, la ricercatrice può, in una pro-
spettiva critica, elencare tutti i luoghi in cui la violenza
simbolica si attua, analizzare con precisione il fun-
zionamento dei dispositivi giuridico-istituzionali che
rendono il processo di richiesta d’asilo un percorso
sofferente, ingiusto, violento appunto. Ma se la ricerca
si limita a questo approccio critico che ne sarà di quei
soggetti che proprio al dispositivo di asilo fanno rife-
rimento per riappropriarsi di una vita vivibile? Che ne
sarà degli investimenti affettivi dei richiedenti stessi,
delle loro speranze, delle loro aspirazioni future? La
prospettiva postcritica cerca invece di tessere lega-
mi, di mettere in connessione i soggetti e i processi
che li determinano. La postcritica, in altre parole, non
considera i dispositivi di potere, le istituzioni, come
oggetti alieni calati dall’alto, verità rivelate, ma pro-
dotto umano, dentro il quale gli umani agiscono, si
muovono, modificano quelle stesse istituzioni. Al fine
di non feticizzare i dispositivi di governo come enti-
tà sovrannaturali contro le quali si può solo agire la
critica e resistere, e proprio perché soggetti e poteri
stanno assieme in una dimensione relazionale, è indi-
spensabile prendere atto delle potenzialità creative e
propositive che tale relazionalità ci consegna. Posso-
no esserci storie di accoglienza e di rifiuto, e la ricer-
catrice, il ricercatore che si trova davanti a tali storie
può in maniera postcritica, far emergere non solo al
violenza e la discriminazione, ma anche le potenzialità
creative che emergono quando sono in gioco i corpi,
7i loro affetti, i loro desideri. Ci sono storie di connes-
sioni possibili, appunto fra corpi e desideri, che anche
un processo violento e ingiusto come quello dell’in-
tervista e della richiesta d’asilo fanno accadere.[10]
Abbiamo il dovere – perdonatemi, questo è ancora
un moralismo che risente molto della critica – di farci
moltiplicatrici e moltiplicatori di tali connessioni.
Post-scriptum: concludevo questo testo il 27 feb-
braio 2020. Reputo necessaria una postilla a quanto
detto. Il dilagare della pandemia da Covid-19 ci ha
messo di fronte in maniera inaudita alla concretezza
del nostro essere connessi, interrelati, reciprocamente
dipendenti (nel bene e nel male). Abbiamo visto incar-
narsi, al di là di ogni immaginazione, concetti che la
critica ha, negli anni passati, usato prepotentemente,
ma sempre e solo in senso metaforico (contaminazio-
ne, contagio, ibridazione, immunità). Una riflessione
postcritica si chiede appunto se i nomi esauriscano
le cose, se le metafore dicano, possano dire, tutta
la verità sui processi, o se invece siano dispositivi
che a volte anziché svelare occultano, selezionando
porzioni di realtà a loro piacimento. Cosa intendeva-
no dire quei concetti, prima della pandemia? Erano
trasfigurazioni, eleganti e apparentemente efficaci, di
processi biologici in processi politici. Erano concet-
ti ‘critici’ che speravano di svelare verità nascoste.
Forse lo hanno fatto, sono stati efficaci strumenti di
comprensione della società, del potere (il paradigma
immunitario, la nuda vita, la biopolitica, e di converso
la contaminazione, l’ibridazione come auspicabili oriz-
zonti trasformativi dell’eurocentrismo di certa teoria).
Oggi la pandemia esaurisce del tutto la pretesa non
tanto che quei concetti possano funzionare, quanto
che possano essere usati metaforicamente. E il loro
essere oggi “nome vero della cosa” – nel senso in cui
Guido Calogero definiva il “pensiero arcaico” parlando
dei presocratici – ribalta, capovolge del tutto la loro
funzione critica. Oggi dicono cose diverse, quelle pa-
role.
Qualsiasi cosa la parola autorevole del filosofo sen-
tenzi, c’è una realtà molecolare che pretende ascolto:
ci sono – realmente – alveoli polmonari colpiti dal virus
8che devono essere ossigenati lentamente e costan-
temente al fine di rendere ancora possibile il respi-
ro. Questi alveoli sono parti essenziali di corpi che
occupano letti di terapia intensiva, i quali non sono
sufficienti per tutti. Si decide quindi l’isolamento per
evitare il sovraffollamento dei reparti di emergenza,
per scongiurare l’impossibilità di permettere ai polmo-
ni di tutti i malati di venire ossigenati. Si decide quindi
la restrizione di libertà per poter curare delle vite, per
non dover scegliere tra vite degne di essere vissute e
vite sacrificabili. Chi può stabilire quali vite siano de-
gne e quali no? Una – forse inevitabile, in assenza di
lockdown – distinzione tra chi è sacrificabile e chi no
ci avrebbe avviato sulla pericolosa strada, quella sì,
della selezione biologica, della nuda vita.
La materialità corporea – quel corpo che noi tutte
e tutti siamo – sembra ora rifiutare le metafore che
lo trasfigurano. Alveoli polmonari, questi sconosciuti
– la loro fame d’aria è l’orizzonte di senso nel quale
dobbiamo per ora muoverci, senza trasfigurare. Così
come immunità è ora condizione auspicabile, realtà
anticorpale a cui tutti vorremmo avere accesso. E
ibridazione o contaminazione sono invece condizio-
ni da rifuggere, perché estremamente pericolose per
l’organismo. Ma l’orecchio critico non è disposto ad
ascoltare il richiamo dell’organico, e per questo falli-
sce nel cogliere il nuovo della pandemia, lo riporta a
schemi noti, orizzonti rassicuranti (stato di eccezione,
biopolitica, nuda vita).
La prospettiva postcritica suggerisce altresì che
nella risposta umana – quindi culturale, sociale, poli-
tica – a questa pandemia limitarsi alla critica signifi-
chi abdicare a una responsabilità verso il mondo, per
amore, fedeltà, attaccamento verso le proprie gri-
glie interpretative. Singifica, come direbbe Heinrich
Blücher, mantenersi codardamente solo nell’orizzonte
del pessimismo. Certo è implicita nell’attuale situazio-
ne la potenziale risposta autoritaria, il rigurgito fascista
sempre latente nelle società spoliticizzate della tarda
modernità: società indifferenti alla partecipazione po-
litica, fatte di persone per la maggior parte politica-
mente disinteressate, che sono il prodotto, direbbe
9ancora Hannah Arendt, di un modello di pensiero che
già dalle sue origini, in Platone, presuppone una di-
stinzione necessaria tra governanti e governati, tra chi
comanda e chi obbedisce, con conseguente adora-
zione consapevole e inconsapevole per il conducator.
Tuttavia, nell’attuale situazione è implicita anche
un’altra tendenza – chi la definisce sdolcinata, chi
patetica, chi retoricamente patriottica, allontanando
criticamente da sè come una “peste” qualsiasi pos-
sibile adesione a sentimentalismi popolari – un’altra
risposta. È la risposta di solidarietà, di comunanza,
di vicinanza fisicamente sospesa ma emotivamente
prossima delle molte istanze di aiuto, di cura, di canto
e di poesia che in questi giorni di lockdown abbiamo
visto fiorire. Si potrebbe dire, parafrasando Benjamin,
che l’umano diventa significativo nelle “stazioni del
suo decadere”, come la storia del mondo nel Trauer-
spiel tedesco (qui sto sprofondando nella citazione di
maniera, ma non resisto alla pulsione). E le stazioni
del suo decadere sono i momenti del fallimento, della
sofferenza, della percezione di una vulnerabilità indif-
feribile. Purtroppo – e questo è un segno altrettanto
chiaro della nostra abitudine critica – tale somiglian-
za siamo disposti a riconoscerla in tutta la sua nuda
incontrovertibilità solo nel “caso serio” della morte,
nella sua ravvicinata possibilità. Oggi più che mai que-
sta categoria – la vulnerabilità – si è materializzata,
si è fatta carne, come il Cristo. Oggi più che mai tale
categoria è una condizione comune (perché tutte e
tutti abbiamo alveoli polmonari). Ma proprio perché la
morte non rimanga l’unico orizzonte in cui ci percepia-
mo uguali (“‘a livella”) auspico che questo momento
faccia emergere l’occasione per trasformare, come la
riflessione femminista dice da anni, tale vulnerbaili-
tà in risorsa, azzardando una torsione positiva della
comunanza, e magari provando a considerare altre
cornici per dire l’uguaglianza e la libertà (la nascita, la
felicità pubblica, la democrazia sorgiva). Le connes-
sioni possibili oggi sono molte, e la postcritica ci aiuta
a immaginarle, a dare loro voce e dignità teorica. Le
canzoni dai balconi non sono una dolciastra e pateti-
ca espressione dell’italiano medio, ma, come ha detto
10Bonnie Honig, una “serenata per la democrazia”[11].
E se ogni serenata è un canto all’amata che non c’è,
così anche il nostro cantare, insieme ma lontani, dai
balconi come dalle bacheche di Facebook, esprime
il desiderio di relazione, il desiderio di toccarci e di
parlarci, il desiderio democratico di stare insieme pro-
prio nel momento in cui la relazione è impossibile. Chi
avrebbe mai detto che le nostre società spoliticizzate
e individualiste, comsumiste e neoliberiste, avrebbero
scoperto, proprio nel divieto della relazione e della
socialità, l’insostituibile “pleasure in the company of
others”? In ogni avvenimento collettivo la dimensione
erotica della socialità fa la sua comparsa, balugina,
ma la forma che prenderà non è mai scontata: essa
può diventare generatività democratica ma può anche
de-generare nella pusione totalitaria.
Sta ovviamente a noi, a tutte e tutti noi, trovare le
parole che dicano questo desiderio, per immaginare
forme nuove in cui esso possa diventare per tutte e
tutti – non solo per alcuni, in genere coloro che si
autconvocano nella posizione di comando – piacere.
OLIVIA GUARALDO
NOTE
[1] Cfr. Natascia Tosel, “La vita bassa. Per una postcritica molecolare”,
prossimamente in questa indagine.
[2] Mariano Croce, “Etnografia della contingenza: postcritica come ricerca
delle connessioni”, Politica e società, 1, 2017: 81-104, p. 82.
[3] Mark Fisher, Realismo capitalista, Nero, Roma, 2018.
[4] Mariano Croce, Postcritica. Asignificanza, materia, affetti, Quodlibet,
Macerata, 2019, p. 82.
[5] Rita Felski, The Limits of Critique, The University of Chicago Press,
Chicago 2017, p. 17.
[6] Adriana Cavarero, Democrazia sorgiva, Cortina, Milano, 2019.
[7] Hannah Arendt, Sulla rivoluzione, Einaudi, Torino, 2009.
[8] Ho trattato di questo argomento in “Illusione e realtà nell’epoca della
post-verità”, in Giulia Bistagnino, Carlo Fumagalli (a cura di) Fake news,
post-verità e politica, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2019, pp. 33-52.
[9] Felski, The Limits of Critique, cit., p. 9.
[10] Olivia Guaraldo, “Fra corpi e storie: ambiguità e potenzialità del disposi-
tivo SOGI”, in Massimo Prearo, Noemi Martorano (a cura di), Migranti LGBT.
Pratiche, politiche e contesti di accoglienza, ETS, Pisa, 2020.
[11] Bonnie Honig, In the Streets a Serenade, 14/03/2020 http://politicssla-
shletters.org/uncategorized/in-the-streets-a-serenade/
11Puoi anche leggere