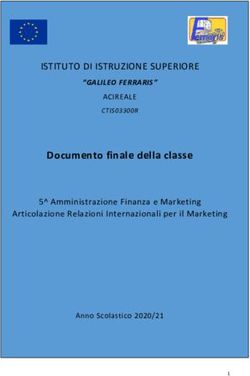Breve storia della medicina - Tarda Antichità e Medioevo - Fabio Cavalli - Moodle@Units
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Tarda Antichità Il Cristianesimo delle origini, specie quello paolino o quello legato all'esperienza ascetica orientale fu fortemente influenzato dalle filosofie del I - II d.C. secolo, per cui il corpo venne disprezzato (ad esempio per gli Gnostici l'anima era intrappolata nel corpo, per cui il corpo era una costrizione da cui liberarsi grazie alla morte che, peraltro, non poteva essere provocata). La cura del corpo in questa ottica era di fatto contro natura, e la malattia assieme alla morte poteva rappresentare una via per la purificazione dal peccato. Bisogna stare attenti comunque a non sopravvalutare l’influenza di queste concezioni sulla medicina dell’epoca: se da una parte è evidente che il Cristianesimo (ma d’altronde anche il diffondersi di culti orientali quali il mitraismo o i culti isiaci) ebbe un’influenza sul pensiero generale del rapporto corpo / salute, questo avvenne lentamente e in modo diverso nelle varie aree geografiche. Questa possibile discrepanza tra vita "reale" e documenti scritto è causata dal tipo di letteratura con cui ci andiamo a confrontare ed è lo stesso problema, anche se leggermente meno importante, che troviamo per l’Alto Medioevo: le fonti cominciano ad essere (e di fatto successivamente sono le uniche) di origine cristiana e soprattutto di tipo monastico, cioè provenienti da una élite intellettuale che aveva fatto dell’ortodossia un principio di vita e, per certi versi, di potere. La divisione dell’Impero tra Oriente ed Occidente comportò inoltre una serie di fenomeni destinati a ripercuotersi sulla letteratura medica, anche se (e qui è difficile quantificare), la pratica medica non ebbe particolari modificazioni in sé, almeno sino al cambiamento del paesaggio politico e sociale del IV-V secolo. Innanzitutto si palesò una differenza culturale tra il mondo latino e quello greco: per secoli questi due mondi si erano incrociati e spesso integrati mentre adesso mostrano tutte le loro differenze: un mondo fortemente influenzato dai costumi “orientali” il greco- bizantino, più sincretisticamente “europeo” il latino, influenzato sempre di più da costumi e consuetudini galliche o germaniche. Un'altro grave problema fu la differenza linguistica: se la medicina “erudita” a Roma era (come abbiamo visto con Galeno) espressa in lingua greca affiancata ad una letteratura latina perlopiù di tipo generalista (come nel caso di Celso) o di tipo pratico (come ad esempio nel caso di Scribonio), dopo la divisione “culturale” ancorché politica dell’Impero, i testi di medicina si spostarono da Occidente ad Oriente con esiti molto diversi: mentre in Occidente la magra letteratura medica latina si arricchisce di qualche operetta di 1
terapeutica o di più estese sintesi di ricette come nel caso di Marcello Empirico, nel mondo bizantino si continua ad adottare (ed anzi a consolidare) il patrimonio scientifico galenico: in ultima analisi la medicina di stampo scientifico si sposta ad Oriente. Anche perché l'Occidente cominciava ad avere ben altri problemi. Bizantini e Arabi L'antica città di Bisanzio era un piccolo porto, colonia della più nota Megara, in posizione strategica nella mappa dei traffici commerciali tra Oriente ed Occidente. Nonostante la fortunata posizione geografica, si dovrà aspettare l'epoca di Settimio Severo (193-211 d.C.) per vedere valorizzata la città come sede militare avanzata. Settimio Severo inoltre abbellì la città con grandi edifici pubblici, un ippodromo imponente, terme monumentali e donò alla città il titolo di colonia romana. Quando Costantino (324-347) la scelse come sua dimora, Bisanzio era una città grande e ricca, ma Costantino la ampliò ancora rendendola degna della corte imperiale e cambiandole nome in Costantinopoli. La città fu pensata da Costantino come una "Seconda Roma", come la definì successivamente con un decreto, ma senza alcuna volontà di antitesi con l'Urbe: già con la tetrarchia si era cercato di rafforzare il potere imperiale, indebolitosi soprattutto nelle provincie lontane dal governo centrale di Roma e l'istituzione di questo nuovo centro di potere amministrativo doveva portare ad una stabilizzazione dell'Impero. Roma, già da tempo, non era più l'unico cuore dell'Impero: Diocleziano ad esempio aveva abbandonato Roma per vivere a Nicomedia, mentre Massimiano risiedette a Milano, Sardica, Tessalonica ed Antiochia. L’impero bizantino ha inizio nell’anno 395 d.C. quando l’imperatore Teodosio I (379-395) affida ai figli Arcadio ed Onorio rispettivamente la parte orientale e la parte occidentale dell’Impero romano. Mentre l’Occidente diventava un puzzle di regni barbarici, anche Costantinopoli ebbe un periodo di paralisi. Tra il IV ed il V secolo fu sede di violenti scontri per motivi religiosi (Eresia di Ario, monofisismo, Concilio di Costantinopoli). La situazione cambiò con l’ascesa al trono di Giustiniano (527-565), che credeva nella restaurazione dell’Impero, convinto che l’unificazione religiosa fosse il preludio dell’unificazione territoriale. I generali di Giustiniano, Belisario e Narsete, riconquistarono il territorio africano occupato dai Vandali e parte di quello iberico occupato dai Visigoti. Dopo vent’anni di guerra occuparono anche l’Italia e le isole del Mediterraneo. Questa ricostituzione dell’orbis Romanus non fu senza conseguenze, come per esempio la rivolta di Nika, dovuta a tensioni interne, che provocò un terribile incendio a Costantinopoli. Giustiniano ricostruì la città cercando di farne il simbolo della 2
sua grandezza e di creare, attraverso una nuova arte, la nuova Costantinopoli. Con la ricostruzione della basilica di Santa Sofia, la Megàle Ekklesìa di Bisanzio, si può iniziare a parlare di arte bizantina, così come di storia e cultura. Giustiniano riorganizzò la struttura statale. A lui si deve inoltre la codificazione del diritto romano: nel 529 viene pubblicata la prima edizione in lingua latina del Codex Iustinianus, mentre nel 533 vennero pubblicati i cinquanta libri dei Digesta (sentenze dei giuresconsulti) e le Institutiones, destinate all’insegnamento. Dopo Giustiniano iniziarono i problemi legati alle pressioni dei popoli orientali, degli Arabi ina Africa, degli Slavi e dei popoli germanici in Occidente. Durante il regni di Eraclio (610-641) l’Impero venne diviso in temi, cioè in territori ben definiti, ognuno dei quali costituiva un’unità amministrativa e militare allo stesso tempo, con a capo uno stratega. Ciò che contraddistingue la cultura bizantina in tutte le sue espressioni è l’incontro - arricchito da apporti orientali - della grecità pagana con la nuova spiritualità cristiana e la fusione del vecchio e del nuovo mondo in una entità culturale autonoma ed originale. Suo merito fu la conservazione dell’eredità greco-classica per un periodo di più di dieci secoli, e la sua riconsegna, alla caduta dell’Impero d’Oriente (1453), al nuovo mondo europeo. Carattere distintivo dell’evoluzione storica dell’impero bizantino fu la mancanza di quelle devastazioni, distruzioni e ricostruzioni che caratterizzarono il Medioevo dell’Impero d’Occidente, anche se Costantinopoli dovette sempre difendersi dai nemici che la circondavano. La medicina Per quanto riguarda l'arte sanitaria, bisogna distinguere tra le opere pervenuteci dagli scrittori medici ed il rilievo sociale della medicina e della sanità pubblica. Per quanto riguarda gli scrittori, si può dire che i medici bizantini costituivano di fatto un'unica setta galenica. Galeno non ha lasciato se non deboli tracce nella letteratura medica latina del periodo a lui successivo mentre il suo magistero fu determinante nel mondo di lingua greca tramite Alessandria, che di fatto è la responsabile della immensa fortuna postuma di Galeno. Alessandria si trova ad essere focale anche per i medici bizantini: sappiamo dalle biografie redatte nel IV secolo come gli studiosi si spostassero da un centro ad un altro e come Alessandria fosse ancora il centro indiscusso della medicina. Il crescente influsso di Galeno si evidenzia, ad esempio, nell'opera di Oribasio di Pergamo, discepolo del maestro alessandrino Zenone e medico personale dell'imperatore Giuliano 3
(l'Apostata): le sue Collezioni mediche, opera enciclopedica sul sapere medico e compilata su richiesta imperiale, contengono per la maggior parte stralci di opere galeniche. Anche gli altri medici bizantini di rilievo, Paolo di Egina ed Ezio di Amida, si rifanno ai testi galenici se non alla stessa opera di Oribasio. Ad Alessandria (così come era successo per i testi di medicina greca, confluiti nel Corpus Hippocraticum) si riordinano i testi galenici, privi di un ordine sistematico, a fini didattici: ne risultò un canone di 16 scritti da leggersi nella sequenza stabilita. Il canone comprendeva anche quattro soli trattati del Corpus Hippocraticum, cosicché Ippocrate veniva ad essere completamente adombrato da Galeno. Questa sarà la situazione, tra l'altro, che troveranno gli Arabi al momento della conquista dell'Egitto, situazione che influenzerà pesantemente, come vedremo, la medicina occidentale dopo il Mille. La sanità pubblica a Bisanzio Le fonti storiche ci confermano la presenza del medico pubblico nelle città greche a partire dal V secolo a. C.: ogni città-stato cercava di assicurarsi la presenza di un medico (iàtros, poi archiàtros). In periodo imperiale si ritrova la figura del basilikòs iàtros (medicus palatinus) come medico dell’imperatore. Se Vespasiano (69-79) fissò i privilegi che venivano accordati al medico pubblico, questi vennero più o meno mantenuti anche dopo la separazione dell’Impero, e talora, come da Costantino o da Giustiniano, ampliati. Per volontà di Costantino anche a Bisanzio era stato garantito il diritto alla distribuzione gratuita del grano – la romana annona civis – che permetteva la sopravvivenza a tutti i suoi cittadini. Teodosio II riorganizzò l’approvvigionamento rendendolo costante, attirando così masse di affamati in città che superò Roma come numero di abitanti. La folla di inurbati indigenti necessitava di aiuti sanitari ed assistenziali: i primi centri di soccorso nacquero per volontà di alcuni monaci. Il monaco Macedonio, nominato vescovo nel 346 e nel 351-360, fu promotore della costruzione di una struttura monastica nella quale gli indigenti trovavano aiuti ed ospitalità ed i poveri malati venivano curati. Con Macedonio e con il suo allievo Maratonio nascono alcuni centri in città denominati ovvero “ospizi per i poveri” ma di cui le fonti dell'epoca mettono in rilievo la duplicità dell'assistenza. Anche l’armeno Eustazio, anch’egli semi-ariano contribuì alla fondazione di centri di assistenza e cura, influenzando il pensiero di san Basilio. Basilio stesso fonda un complesso assistenziale dove specifica che sono presenti “infermieri, medici, portantini ed aiutanti”. Nel VII secolo si ricorda anche lo xenon di Christodotes che si trovava a fianco della basilica di Santa Anastasia, mentre a riguardo dello xenon (o nosokomeion) di Sampson abbiamo notizie della presenza di chirurghi e assistenti che 4
praticano sui malati. La conquista araba Nel VII secolo una vasta parte del mondo orientale venne invasa dai conquistatori arabi. La penisola arabica aveva conosciuto, assai prima dell'avvento di Muhammad, un periodo di grande civiltà, specialmente nella sua parte settentrionale dove si erano potute realizzare esperienze di civiltà sedentarie (al contrario delle regioni più desertiche centromeriodionali più adatte alla vita nomade). Del regno di Saba, collocabile nell’attuale Yemen, ci è noto fin dall'VIII secolo a.C. e il regno nabateo entrerà a far parte dell'Impero romano nel I secolo d.C. Muhammad (o Maometto), nato nel 570 alla Mecca, riunì, non senza fatica, le tribù arabe intorno ad una nuova religione monoteistica simile a quella giudaico-cristiana ma con forti semplificazioni dottrinali e adatta ad una società ancora prevalentemente tribale. Alla morte di Muhammad, nel 632, la nuova religione andò diffondendosi molto rapidamente nella regione mesopotamica e oltre, favorita dalla decadenza sia dell'impero romano che dell'impero persiano, entrambi lacerati da conflitti interni e dissensi religiosi. I successori di Maometto, i primi quatto Califfi, dopo avere stabilizzato la situazione politica interna, iniziarono una politica espansiva molto aggressiva: la vittoria decisiva nella battaglia dello Yarmuk (636) sugli eserciti bizantini di Eraclio dette inizio alla penetrazione araba verso oriente e, contemporaneamente, verso l'Egitto, occupando Alessandria (643) e penetrando nella Cirenaica. Con la dinastia califfale degli Ommayyadi continuò l’espansione dell’Islam con la conquista degli attuali Afghanistan ed Uzbekistan e l’espansione nell’India nord-occidentale. Contemporaneamente, nel 711 le forze arabe sbarcano a Gibilterra ed iniziano la conquista di Spagna e Portogallo, strappandole ai Visigoti Furono fermati solo sui Pirenei nella storica battaglia di Poitier del 732, sconfitti dai Franchi di Carlo Martello. Nel 750 la dinastia Ommayyade fu sostituita da quella Abbaside. All’epoca dei primi quattro califfi, la capitale dell’impero musulmano era Medina e gli Ommayadi la avevano spostata a Damasco. Gli Abbasidi la spostarono ancora più ad est nella città di Baghdad. La prima dinastia Abbaside regnò fino al 1258 e sotto questa dinastia vi fu la conquista della Sicilia che fu araba dall’827 fino al 1091, quando fu conquistata dai Normanni di Roberto il Guiscardo. La dinastia ebbe termine quando l’ultimo califfo fu sconfitto ed ucciso dai Mongoli. Da quel momento il controllo dell’Impero fu preso dai Mamelucchi (ex schiavi degli Abbasidi) ed i Califfi della seconda dinastia Abbaside (1258- 1517), che risiedevano al Cairo. Nel frattempo una nuova realtà stava per cambiare completamente il quadro storico dell’Islam: l’avanzata dei Turchi. Questi erano in origine una 5
popolazione nomade dell’Asia centrale che, nella loro espansione verso occidente, si convertirono presto all’Islam. La loro espansione fu irrefrenabile e, dopo essersi stanziati nella parte orientale dell’Impero Abbaside, iniziarono la conquista dell’Europa Orientale. Nasceva così l’Impero Ottomano che durò fino al 1918, quando fu smembrato come conseguenza della sconfitta nella prima guerra. Nel 1453, sotto il Sultano Maometto II°, l’Impero Ottomano conquistò Costantinopoli (Bisanzio), mettendo così fine alla millenaria storia dell’Impero Romano d’Oriente. La medicina araba Alessandria come centro di irradiazione della cultura medica era destinata a perire, dopo la conquista araba, anche se questa sorte non fu condivisa dai testi medici: anzi la ricezione che la medicina galenica ebbe in lingua araba fu pari se non superiore alla sopravvivenza del galenismo in ambito bizantino. La scuola di Alessandria aveva i suoi adepti anche in Siria, dove si assiste, nel VI secolo ad una intensa opera di traduzione in siriaco dei testi medici greci, specie grazie all'opera di Sergio di Rēšʽainā che tradusse in siriaco almeno 27 opere di Galeno. Questa ricezione di Galeno sui medici siriaco-cristiani che esercitarono la loro attività alla corte della dinastia abbaside fu grandissima ed erano disposti a pagare personalmente nuove e migliori traduzioni. Nel IX secolo Hunayn ibn Ishāq, di origine arabo-cristiana al servizio del califfo abbaside di Baghdad traduce in arabo dal siriaco le opere galeniche. Il passaggio dal siriaco all'arabo avvenne piuttosto rapidamente favorito soprattutto dal fatto che fra i musulmani più influenti c'era un discreto numero di persone interessate ad una cultura enciclopedica. La vita intellettuale nei domini islamici era abbastanza omogenea, per cui anche la medicina galenica recepita nel IX secolo a Baghdad fosse diffusa allo stesso modo da Cordova a Bukhara. Se la medicina bizantina non mostra particolari segni di originalità, nell'Islam si ebbero, talora, manifestazioni originali del pensiero scientifico, anche medico, arrivando anche a sottoporre a critica l'insegnamento galenico o ad aderire maggiormente ai modelli del Corpus ippocratico. La storia della medicina araba si divide per convenzione in tre grandi periodi: il primo, che abbiamo già visto, concentra l'attenzione sulle traduzioni delle opere della tradizione greca (ma anche persiana e indiana), il secondo, denominato anche "periodo aureo" va da X al XII secolo, seguito dalla cosiddetta "decadenza" che si conclude nel XIII secolo. Dell'età aurea, il rappresentante principale può essere considerato il medico-filosofo Rhazes, forse il pensatore più indipendente di tutto il medioevo islamico. Fu direttore dell’ospedale di Baghdad e della sua città natale di Rayy ed ebbe un gran numero di discepoli. Ribadisce che nella medicina 6
non devono esserci arresti e che perciò si vede costretto a criticare Galeno, così come Galeno stesso aveva criticato i suoi maestri. La sua opera più importante è il Kitāb al-hāwī fi al-tibb, nota in latino col nome di Continens, raccolta postuma dei suoi scritti ed appunti di lezione: contiene un enorme numero di osservazioni cliniche, secondo lo spirito del Corpus Hippocraticum. Famoso il suo trattatello sul morbillo ed il vaiolo, che verrà tradotto in Europa nel XVIII secolo. Nel periodo successivo si hanno ulteriori sviluppi del pensiero medico islamico, specialmente per quanto riguarda l’applicazione della medicina “umorale” (o meglio delle qualitates”). Inoltre grazie alla ricezione delle Arie acque e luoghi ippocratico e dal suo commento galenico, si svilupparono i rapporti fra salute e geografia e specialmente i rapporti tra salute e astrologia, che però nel mondo arabo rimasero abbastanza controversi. A partire dal X secolo compare una letteratura che tenta di sintetizzare ed enciclopedizzare l’opera galenica, come l’opera di ‘Alī ibn al–‘Abbās al-Mağusi, tradotta da Costantino Africano come Pantegni. Ma sono sempre più gli scrittori che criticano Galeno, specialmente i peripatetici più ortodossi che male accettavano il platonismo galenico. Al Fārabi (m. 950) cerca di risolvere le contraddizioni esistenti tra medicina e filosofia con un attacco indifferenziato ai filosofi medici, Galeno in testa: importante il suo tentativo di separare la medicina dalle scienze naturali, negandone la dignità di scienza e ”declassandola” ad arte pratica. Tra i grandi autori arabi di questo periodo spicca per importanza ed originalità di pensiero uno studioso che fu al contempo filosofo e medico di grande fama: Abu Ali al-Hussein Ibn Sina noto con il nome di Avicenna. La sua influenza sulla medicina occidentale fu grande, specialmente attraverso un’opera che divenne presto uno dei libri di medicina più utilizzati nell’ambito universitario: il Qanun fit at-tibb, tradotto da Gherardo da Cremona in latino col nome di Canon Medicine. L’opera, volta a sistematizzare il pensiero medico antico, è divisa in cinque libri a seconda della materia trattata: il primo libro tratta della medicina teorica, il secondo dei medicamenti semplici, il terzo delle malattie trattate a seconda della loro localizzazione, il quarto delle malattie generali, il quinto della farmacologia cioè della preparazione dei medicinali. Il Canone è innegabilmente legato alla tradizione aristotelica dei quattro elementi così come è derivata dagli studi galenici la sua concezione anatomica, anche se spesso e volentieri qualora i due grandi studiosi antichi vengano in contrasto la predilezione di Avicenna per Aristotele piuttosto che per Galeno è fuori discussione. Sebbene il trattato si presenti come una sorta di enciclopedia medica, esso risulta essere in realtà più una sapiente erudizione libresca che non piuttosto una raccolta sistematica di osservazioni ed esperienze personali. 7
In questa sede non è interessante mostrare le caratteristiche della medicina islamica quanto il debito che l'Occidente medievale contrasse con la ricezione arabo-islamica della medicina di lingua greca, che di fatto scomparve (ma era esistita poco anche nella tarda antichità) nell'Occidente medievale. E' chiaro che quando i testi galenici ritorneranno in Occidente saranno testi trascritti, tradotti e "traditi", come sempre succede nelle opere di traduzione, da autori / scienziati che tentarono spesso un difficile connubio tra Galeno (e talora Ippocrate) e la filosofia greca, specialmente aristotelica. Questo, ovviamente è solo un discorso di testi e non di prassi: ma come abbiamo visto, prassi e testi talora si uniscono (non sempre, ovviamente, ma quando lo fanno nasce ogni volta non tanto una medicina nuova quanto una nuova figura di medico): sarà dalla disponibilità dei testi arabi, tradotti ancora e questa volta in latino che l'Occidente dopo il Mille potrà "risistemare" la medicina fuori dalle "scienze meccaniche" dove era stata nuovamente relegata nell'Alto medioevo. 8
Alto Medioevo in Occidente Dal punto di vista delle istituzioni, il passaggio tra tarda antichità e medioevo fu un fenomeno traumatico (non per nulla la suddivisione tra tarda antichità e alto medioevo è una “invenzione” degli storici delle Istituzioni) ma molto probabilmente per la gran parte della popolazione e comunque della società questo passaggio fu avvertito in maniera relativa (un po’ come il contadino uzbeko al tempo della caduta del Muro di Berlino e al collasso amministrativo dell’Unione Sovietica. La situazione ovviamente non era omogenea: le città mutarono più delle campagne, l’Italia più della Gallia (e della Britannia, che aveva prima degli altri sofferto la crisi istituzionale dopo il ritiro dell’amministrazione romana all'inizio del V secolo d.C.), l’est più dell’ovest, anche se in definitiva il V secolo si apre con una situazione territoriale ancora stabilmente regolata a livello di diokesis da quei membri del patriziato romano o del notabilato locale che, dopo l’editto di Costantino e la cristianizzazione (quasi esclusiva) dei centri urbani, erano diventati vescovi e quindi in qualche modo amministratori e responsabili di uno “stato” laico che non c’era più e di un altro spirituale che non c’era ancora (con un vescovo di Roma primus inter pares rispetto agli altri e forse con maggiori problemi dei suoi colleghi). Il monachesimo, che in questo periodo trova il suo massimo sviluppo, rappresenta esso stesso una regolamentazione del territorio, talora in contrapposizione a quello episcopale, attraverso una rete di possedimenti che rendono il monastero una struttura “signorile” (con i suoi dipendenti laici, generalmente di stato servile) fortemente strutturata ma aderente ad un modello di vita (per i “signori”, ovvero per i monaci ) basata su una rigida regola spirituale. Il resto del territorio viene controllato dai laici, a vario titolo: piccoli proprietari, vecchi latifondisti nell’Italia Meridionale e così via. Una struttura sociale e territoriale che verrà regolarmente messa in crisi ma mai dissolta, in Italia, dall’arrivo dei “barbari” (chiameremo così i vari popoli, spesso strutturati semplicemente a livello di chefferies, che traversarono il nostro Paese generalmente per saccheggiare, come era successo nel secolo precedente) o dal tentativo bizantino di riunire la Penisola in un unico dominio. Il passaggio a qualcosa di diverso si ebbe, in Italia, nella metà del secolo successivo, quando una doppia crisi sconvolse la società a tutti i livelli, ovvero i venti anni di Guerre Gotiche e la peste (quella cosiddetta di Giustiniano), preceduta da una carestia senza precedenti. Una crisi profonda soprattutto demografica che porterà (stavolta davvero) a un collasso del territorio. L’arrivo di Alboino con i suoi Longobardi, di fatto un piccolo e composito esercito, fu la fase finale della crisi 9
accompagnata da un riassetto territorio peninsulare che si troverà diviso tra nord e sud per la prima volta e per sempre. Nonostante che i rilievi archeologici mostrino una regressione dei centri urbani, in effetti non vi fu un vero abbandono quanto una diversa destinazione d’uso degli spazi pubblici che, dopo il collasso amministrativo imperiale, non avevano ormai più senso di esistere. Tra l’altro il riutilizzo di materiali edilizi di vecchie insulae cittadine mostrano una certa vivacità sociale, che dovette certamente rallentare se non subire un trend negativo alla metà del secolo VI, sia per il protrarsi nel tempo ma anche nello spazio delle guerre goto-bizantine che per il decremento demografico, difficile da quantificare ma che probabilmente fu molto vistoso, dovuto alla contemporaneità (come del resto si riscontra in questi casi) di carestia / catastrofe alimentare e mortalità epidemica da peste bubbonica, che per la prima volta nella storia del mondo occidentale si affacciò alle sponde del Mediterraneo. Senza contare la paralisi dei commerci marittimi per la presenza di pirati musulmani provenienti dalle coste africane e di navi da guerra bizantine. Insomma, alla fine del VI secolo si è quasi compiuta la trasformazione del paesaggio antropico e sociale, territorio che troverà nuove sistemazioni nei secoli successivi con la dominazione franca ed il consolidarsi dei domini signorili della nobiltà di stirpe longobarda, ormai stabilmente insediata nel territorio. Questo quadro è ovviamente incompleto e parziale: la parzialità è data dal suo italo-centrismo che d’altronde può essere giustificato dal fatto che la penisola italiana era la principale terra dell’Impero e che subì certamente il maggior divario tra benessere tardo-antico e nuovo status altomedievale. Anche se, ad essere sinceri, le evidenze che abbiamo degli insediamenti rurali mostrano fenomeni di lunga e lunghissima durata dovuti alle caratteristiche produttive. L’alto medioevo, nella sua seconda parte (IX-X secolo) si complica per la presenza di due fenomeni fondamentali: l’organizzazione feudale delle proprietà terriere (fenomeno presente nelle Gallie e nelle Germanie e con forme diverse anche in Italia centrosettentrionale) e l’incastellamento. Questo secondo fenomeno, nato per la difesa dagli attacchi ungari che devasteranno tutta la penisola a brevi e rapide ondate successive dall'862 al 955, darà rapidamente luogo all’istituzione di signorie locali e ad un controllo frammentato e multiforme del territorio, con la creazione di microeconomie locali che saranno poi il nucleo su cui germinerà quella che gli storici chiamano la “rinascita del secolo XII". Questo mostra come certi storici, fortunatamente pochi, manchino del senso del ridicolo. 10
La medicina Generalmente si afferma che nell’alto medioevo, dopo il collasso delle strutture amministrative dell’Impero Romano, i medici laici continuarono ad esercitare nelle città, divenute in genere meno abitate e più rare. Ma la cultura medica antica, almeno in parte, fu conservata nei monasteri, attraverso l’opera sia dei copisti che salvarono alcune grandi opere mediche dall’oblio, sia degli infirmarii, veri e propri luoghi di ricovero e cura dove monaci-medici pensavano alla salute dei confratelli. L’analisi, seppure nella sua estrema sintesi, corrisponderebbe a verità se non fosse che la “cultura medica antica”, almeno in Occidente, si era se non persa, almeno sbiadita già dopo il III secolo. La divisione dell’Impero tra Oriente ed Occidente aveva portato, tra i suoi risultati, ad un Occidente di lingua latina e ad un Oriente di lingua greca, con il risultato che la diffusione di testi medici, quasi esclusivamente in lingua greca, rimanesse appannaggio dell’area greco-bizantina dove peraltro non si continuò tanto a produrre nuova letteratura quanto a conservare e chiosare la precedente oppure a diffonderla verso nuove zone di interesse, mediante traduzioni, come nel caso del siriaco e della diffusione ad oriente dei testi galenici. Insomma, come abbiamo visto, nell’Occidente tardo-antico i testi di medicina si riducono essenzialmente ad elenchi organizzati di rimedi accompagnate da poca teoria. La situazione passa così, direi in maniera silenziosa, all’alto medioevo. Ovviamente il corpus testuale subisce una ulteriore contrazione dovuta alla scelta dei materiali da copiare negli scriptoria monastici, ma questa contrazione è relativa perché la contrazione dei testi d’uso era già avvenuta. Non così a Bisanzio, dove si continua a copiare e conservare la letteratura (o le epitomi) galenica e ippocratica, tanto che i testi greci di medicina (quelli “originali” e non mediati dai traduttori arabi) ritorneranno in Occidente, pressoché intatti, nel Rinascimento dopo il Concilio di Firenze. Certamente il già magro corpus medico in lingua latina della Tarda Antichità verrà ulteriormente assottigliato dalla scelta dei bibliotecari monastici: scompare di fatto l’opera di Celso ed una parte dei peraltro pochi scritti latini di Galeno: insomma si riduce sostanzialmente quella parte teorica della medicina che evidentemente adesso non riveste quell’importanza che si presume abbia avuto nei secoli d’oro dell’Impero. Il “presume” è ovviamente provocatorio: se gli storici della medicina non si danno pace riguardo all’assenza di “scuole mediche” nell’alto medioevo, spacciando un centro di copiatura di testi come la “scuola di Ravenna”, di fatto le “scuole mediche”, intese come centri pubblici di insegnamento, non c’erano mai state. La formazione, come abbiamo visto per Galeno era una formazione pratica: il tentativo, peraltro riuscito ma evidentemente effimero di Galeno di risollevare lo status del medico deve essere considerato 11
realmente una eccezione. Se ancora nel XIII secolo Vincenzo di Beauvais classifica la medicina tra le artes mechanicae al pari dell’arte della navigazione e della lavorazione della lana, significa perlomeno che il medico si forma “a bottega” di un altro medico e che la medicina era una disciplina eminentemente pratica. Da qui la scarsità di testi teorici e la relativa abbondanza di testi farmacologici e di diagnostica pratica, quali il Galenico De modo medendi ad Pisonem o gli Aforismi di Ippocrate. La discrepanza fra il testi circolanti nel mondo bizantino e quelli circolanti nell’Occidente altomedievale, gli uni ancora imperniati su un fondamento teorico di derivazione galenica e gli altri più o meno semplici prontuari diagnostico-terapeutici non è da attribuirsi soltanto al problema della lingua: se il testo medico nasce da una esigenza professionale, ben diversa quindi era la tipologia degli utenti del medico tra oriente ed occidente. In Occidente siamo di fronte a insediamenti spesso parcellizzati e città che avevano perso o avevano riacquisito un diverso apparato politico ed amministrativo con una economia generalmente basata sulla sussistenza (a parte alcuni beni da sempre commerciati quali i beni di lusso e le spezie), mentre in a Oriente persisteva il "vecchio" mondo gerarchizzato e produttivo con almeno una metropoli, Bisanzio, in grado di sostenere una richiesta di medici colti e una struttura di medici pubblici. Dopo il X secolo, in Occidente, quando la compensazione del decremento demografico altomedievale, l’introduzione di nuove tecniche agricole (e di controllo, anche in senso produttivo, del territorio) comincerà a produrre nuovamente eccedenze e permetterà la rinascita delle città e una nuova classe di artigiani e commercianti, la medicina sentirà l’esigenza di ridarsi uno statuto epistemologico solido. La società altomedievale non sente questa esigenza, non ha bisogno di un surplus culturale per il mantenimento della salute né i medici evidentemente aspirano ad uno status sociale diverso. Anche perché, a voler ben guardare, i testi teorici erano ancora presenti nei centri culturali dell’Italia Meridionale di influenza greca, come ad esempio a Vivarium, monastero fondato da Cassiodoro e particolarmente vivace nella conservazione del patrimonio testuale medico antico. Senza pensare ai numerosi medici ebrei, generalmente colti, particolarmente attivi proprio nell’area meridionale. 12
Il basso Medioevo Dopo il Mille, una volta neutralizzato il pericolo delle scorrerie ungare e saracene che avevano portato al fenomeno dell'incastellamento e quindi della nascita di signorie locali indebolendo il potere imperiale centrale, si assiste ad una "rinascita" della società occidentale caratterizzata da un notevole incremento demografico che andrà finalmente a compensare l'impressionante decremento del VI secolo, dall'introduzione di nuove tecniche agricole (il giogo, l'aratro pesante, il mulino ad acqua ecc.) e quindi da una spinta economica importante verso la produzione ed il commercio. Se da un lato si ha un'espansione della campagna a spese dell'incolto (con un conseguente calo d’importanza della silvicultura) e la nascita di una nuova signoria terriera, dall'altro l'uso esteso di nuovi strumenti tecnici e organizzativi rende possibile il distacco dalla terra di quote di lavoratori che vengono indirizzati sia alla produzione degli strumenti lavorativi più elaborati che possano permettere non solo il superamento del regime di sussistenza che aveva caratterizzato l’alto medioevo a anche alla produzione di un surplus commercializzabile. In definitiva si attua una più allargata divisione sociale del lavoro. Lo sviluppo produttivo dei secoli XI- XIII, aprendo gli orizzonti dei contadini verso nuove terre, nuovi insediamenti e nuovi modi di vita, conferisce loro un maggiore potere contrattuale. L'accrescersi delle forze produttive porta all'emergere di una molteplicità di bisogni a cui viene data soddisfazione attraverso una ulteriore divisione sociale del lavoro. Tutto ciò è in sintonia con lo sviluppo di concentrazioni insediative, le città, in cui le diverse produzioni sono tra di loro funzionalmente interdipendenti in quanto collegate, attraverso il mercato, con i vari bisogni della popolazione, urbana e rurale, circostante. La città diventa un centro di produzione di prodotti artigianali ed è, al tempo stesso, un prodotto dell'attività artigianale e mercantile. Se la produzione e la commercializzazione che si svolgono nell'ambito della divisione sociale del lavoro tra campagna e città appaiono le causali di tipo generale che spiegano la nascita-rinascita e lo sviluppo dei centri urbani, non bisogna però dimenticare una serie di altri fattori (politici, militari, ecc.) che concorrono al medesimo fine. La "rinascita urbana" si manifesta infatti in una pluralità di forme a testimonianza di retaggi culturali ancora presenti e di un processo storico che si va sempre più arricchendo e differenziando nelle varie regioni d'Europa. Al centro di questo processo stanno "uomini nuovi" che operano nell'ambito della produzione di beni non agricoli (artigiani) e nella loro commercializzazione (mercanti) e sulla cui attività occorre soffermarsi perché essi rappresentano gli artefici di quei presupposti che portano, assieme alla rinascita urbana, alla divisione tra campagna e città come 13
subordinazione delle campagne alla politica, alla economia e alla cultura delle città. I ceti urbani, nonostante i crescenti dislivelli di status al loro interno, si trovano compatti quando si tratta di opporsi ai vecchi poteri (imperatore, signore feudale, vescovo) servendosi dei contrasti tra questi per conquistare spazi di autonomia e di privilegio a spese, in primo luogo, delle campagne. Progressivamente le città si riscattano dal potere regio o signorile e si danno i propri statuti che sanciscono la fine dei vincoli feudali all'interno dei centri urbani e l'affermarsi della nuova autorità comunale. La città, in quanto moltiplicatrice di rapporti umani e di esperienze creative e ricreative, è essa stessa un prodotto culturale: l'accresciuta complessità delle produzioni e degli scambi fa sentire ai ceti in ascesa (artigiani, mercanti, banchieri) l'esigenza di possedere strumenti di calcolo, di lettura, di comunicazione scritta e parlata in varie lingue, esigenza che troverà realizzazione nei loro figli per mezzo di apposite scuole di cui le nascenti Università (a Bologna, Parigi, Oxford, ecc.) sono l'espressione massima di elaborazione intellettuale e di trasmissione culturale. Le scuole istituzionalizzano nel ceto urbano dominante quelle capacità che permettono il dominio politico ed economico e la sua trasmissione in seno ad una stessa famiglia. All'apogeo della floridezza economica delle città, nonostante i problemi politici che videro in Italia l'affrancamento dei Comuni verso i poteri tradizionali e oltre le Alpi la formazione degli Stati Nazionali, l'arrivo della Peste nera nel 1348 rimise in discussione gli equilibri economici e demografici. Molte città rimasero spopolate, molte terre dovettero essere abbandonate per mancanza di braccia. Entrò in crisi anche la produzione manifatturiera e artigianale. Nella seconda metà del Trecento iniziò quindi un nuovo, lungo ciclo demografico, caratterizzato da espansione, stagnazione e crisi, che durò fino al XVII secolo: la Peste del 1348 quindi, traumaticamente, mise fine al Medioevo, nonostante che per vari motivi il Medioevo si faccia scolasticamente terminare con la scoperta delle Americhe (o, magari con qualche ragione in più, con la caduta di Costantinopoli nelle mani di Maometto II nel 1453). La nascita delle Facoltà di Medicina Se per tutto l’Alto medioevo manca una vera e propria scienza o filosofia della natura legata alla medicina, tra il XI e il XIII secolo si iniziò un processo volto alla ricostituzione di una medicina a fondamento prevalentemente teorico, a partire dai primi, concreti tentativi fatti dai medici salernitani sulla base della disponibilità dei testi arabi di medicina, tradotti in quel periodo in ambito cassinense da Costantino l’Africano. 14
Anche se non esiste fino al XII secolo alcuna prova documentaria di una Scuola, sicuramente a Salerno c’era una lunga tradizione d’insegnamento medico: nell’Historia inventionis ac translationis et miracula sanctae Trophimenae, testo agiografico del X secolo, troviamo che, verso la fine dell’VIII secolo, a Salerno viveva un tale Gerolamo, archiatra, famoso per la sua grande scienza e per la sua biblioteca medica formata da immensa volumina, soprattutto di carattere medico. Al secolo successivo, inoltre, si ricondurrebbe l’attività medica di Trotula salernitana, di per sé personaggio storicamente controverso, ma che indicherebbe una tradizione locale di “matrone-medico”. Nella vicina Montecassino, inoltre, sotto l’abate Desiderio, Costantino Africano, alla fine dell’XI secolo, come abbiamo già visto, tradusse dall’arabo numerosi testi: trattati di dietetica, patologia, farmaceutica, che incrementarono considerevolmente le conoscenze occidentali sulla diagnosi, terapeutica e farmacologia e testi di medicina teoria: le due opere più importanti che tradusse Costantino sono la Ysagoge di Giovannizio e il Pantegni, una libera interpretazione del Libro regale di Haly Abas, derivato dall’Ars Magna o pantechne di Galeno, destinato a diventare il testo fondamentale di riferimento prima dell’adozione del Liber Canonis di Avicenna. Tutti questi testi, infatti, non rappresentavano una creazione originale dal pensiero islamico, ma provenivano direttamente dai testi medici d’ambito ellenistico di cui gli arabi erano venuti in possesso dopo la conquista di Alessandria e del mondo mediterraneo orientale. Costantino fu considerato per molto tempo come un autore di plagi in quanto, oltre a porre la propria firma sulle sue traduzioni, non volgeva letteralmente i testi ma li elaborava adattandoli alla cultura occidentale, operando a volte anche delle pesanti modifiche: tuttavia, è proprio per merito di questi adattamenti che i testi arabi furono assimilati dal mondo occidentale e cristiano senza particolari opposizioni. Grazie a questo nuovo corpus di testi i medici salernitani furono i primi ad iniziare il processo di riscatto della medicina teorica: con i commenti alla Ysagoge i maestri salernitani precisarono la loro ideologia sulla medicina e sui suoi principi, tentando di dare alla scienza medica una collocazione precisa nell’ambito del sapere umano. La medicina era infatti considerata, come abbiamo visto, una ars mechanica e non rientrava, quindi, né nelle arti del trivio (grammatica, retorica e dialettica), né in quelle del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica). Nella seconda metà del XII secolo venne divisa la filosofia, cioè l’intero sapere umano basato sulla ragione, in etica, logica e teorica, comprendente a sua volta la metafisica, la matematica e la fisica: ed è proprio dalla fisica che si fece dipendere la medicina, divisa in teorica, intesa come scienza 15
delle cause e in pratica, cioè la scienza dei segni. Per l’insegnamento i salernitani, in contemporanea con i maestri di Montpellier, si ispirarono alla scuola tardo-alessandrina sviluppando il genere del commento, basato sulla lectio e sulla quaestio, applicando anche alla medicina il procedimento della giurisprudenza e della teologia per risolvere gli argomenti contraddittori. La costituzione di una solida base teorica per la medicina era fondamentale per poter accedere all’insegnamento medico nell’ambito della nascente Università. Entrare nell’Università significava avere la possibilità di fare carriera, di avere fama, onore e ricchezza: il medico, infatti, era “l’ospite naturale di quelle miniere di cariche che erano le corti” e così le varie Università che cominciarono a sorgere nelle città culturalmente ed economicamente più vivaci dell’Europa iniziarono ad essere frequentate da studenti che non ricercavano più la via della perfezione monastica attraverso lo studio delle arti liberali, bensì da coloro che ricercavano una cultura in grado di preparare ad una professione, quale quella del medico o del giurista, in grado di garantire una carriera ecclesiastica o civile. I testi che furono usati in ambito universitario per la formazione del medico non provenivano soltanto da Montecassino. Le scuole di traduzione dei testi arabi e greci sorsero un po’ ovunque in tutta l’Europa: ad esempio in Inghilterra il vescovo di Lincoln, Roberto Grossatesta, instaurò ad Oxford un importante centro di traduzione di opere greche. Un altro centro di traduzione fu la magna curia palermitana sotto il regno di Federico II che costituì un grande centro di attrazione per i maggiori dotti europei, tra cui Michele Scoto (1180-1235), scrittore di opere scientifiche, astrologiche e magiche che contribuì alla diffusione delle opere di Averroè, Aristotele e di Alpetragio. Un centro molto attivo per le traduzioni dei testi di medicina fu quello di Toledo, centro che non pare abbia avuto una speciale fama di scuola di insegnamento medico, ma in cui venne tradotto un considerevole corpus di testi scientifici e medici. Dopo circa mezzo secolo dalla riconquista cristiana della città da parte di Alfonso VI di Castiglia, Raimondo, primo arcivescovo di Toledo (1125-1151), vi installò una scuola di traduzione con l’aiuto dell’arcidiacono Domenico Gundissalvi. Nello spazio di trent’anni si tradussero in latino le opere astronomiche di Albumasar, Alcabizio, Alfregeno e Albotegni, il De Intellectu di al-Kindī, opere filosofiche di al-Gazzālī, il Fons vitae di Avicebron, l’Almagesto di Tolomeo, opere scientifiche e parte del corpus aristotelico contenente la Physica, De caelo et mundo, De generatione et corruptione e parte dei Meteorologica. A Toledo furono anche tradotte, dal XII secolo, la maggior parte delle opere di Avicenna sotto la direzione di 16
Domenico Gundissalvi, aiutato da Ibn Daūd (Avendauth o Giovanni Ispano), israelita di lingua araba celebrato come il traduttore del corpus avicenniano. Di Avicenna, nella prima metà del secolo furono tradotte la parte di logica e fisica dello Sīfā’, mentre nella seconda metà del secolo fu tradotto il Canone. La sua traduzione fu merito di un chierico italiano che passò la maggior parte della sua vita a Toledo, Gherardo da Cremona, con l’aiuto del suo accolito, il mozarabo Galippus. Gherardo fece un’impresa notevole traducendo l’opera medica avicenniana vista la sua mole, la complessità e la sua natura tecnica anche se, bisogna notare, che la sua traduzione contiene numerosi errori e passaggi oscuri, oltre che numerose traslitterazioni di parole arabe riguardanti soprattutto i nomi di piante e minerali dalla non facile identificazione. Per far fronte a questo problema, a partire dal XIII secolo, si iniziarono a compilare dei glossari, dei lessici, come ad esempio la Clavis sanationis di Simone da Genova, che fornivano l’equivalente latino dei termini arabi traslitterati, non solo di quelli presenti nel Liber Canonis, ma anche di quelli presenti negli altri diversi testi arabi a disposizione. Una svolta nell’insegnamento medico universitario si segnala nel cinquantennio che va dal 1270 al 1320: in questo periodo si assiste all’ingresso, nel pensiero scientifico europeo, dell’aristotelismo, che segnò un nuovo modo di considerare i fenomeni naturali al di fuori di ogni preoccupazione teologale, attraverso l’applicazione di metodi e strumenti razionali. Il Timeo di Platone lasciò quindi posto ai testi di Aristotele, che divennero noti sia dalla traduzione dall’arabo avvenuta in un primo tempo nel 1210 da Michele Scoto a Toledo, che da quella dal greco, eseguita da Guglielmo di Moerbeke nel 1260 circa. La filosofia aristotelica entrò nelle università, dove fu applicata e sviluppata, non per il tramite della teologia bensì per mezzo di ciò che era in relazione con l’istruzione medica, e questo fu possibile anche in quanto i medici medievali riuscirono a rendere autonomo il sapere laico della medicina dalle istituzioni ecclesiastiche alla quale appartenevano come chierici. Nello stesso periodo, inoltre, furono introdotti dei nuovi testi, tra cui il “nuovo” Galeno nelle traduzioni di Burgundio da Pisa e di Gherardo da Cremona e, soprattutto, il Liber Canonis di Avicenna come testo base d’insegnamento, inizialmente adottato accanto all’Articella ma, dalla metà del secolo, riconosciuto come strumento indispensabile per l’insegnamento medico, per la pratica chirurgica ed anche come strumento di riferimento per la filosofia naturale, dato il suo carattere di tipo enciclopedico. Il sistema medico di Avicenna si basava su informazioni tratte dalla fisica, dalla matematica e dalla metafisica, mentre i concetti, le quattro cause, gli elementi, i temperamenti, gli umori e le facoltà, derivavano dalla filosofia, dalla fisica e dalla biologia del mondo antico, essenzialmente di 17
provenienza galenica ed aristotelica. Avicenna inoltre introduce la teoria dell’interazione tra le quattro cause aristoteliche, stabilendo non solo l’unità tra gli organi e le loro funzioni nel corpo, ma anche la relazione tra il corpo stesso con il tempo e lo spazio del mondo esterno, che avrà un peso considerevole non solo nell’ambito della filosofia naturale, ma anche, seppure filtrato e attenuato, nell’ambito della teologia, specialmente quella tomista. In ambito medico universitario, l’aristotelismo fece rinascere la discussione su come considerare la medicina, se arte o scienza: Aristotele poneva una distinzione nella medicina tra episteme e techne, termini poi tradotti in latino con scientia ed ars, secondo cui la scienza riguardava le cose universali e necessarie, le cui dimostrazioni derivavano dai principi primi, mentre per arte si intendeva un qualcosa legato al contingente. Aristotele considerava la medicina come un’arte, differenziandosi così dalla tradizione salernitana che attribuiva lo statuto di scienza sia alla teoria che alla pratica medica. La medicina però non era una scienza propriamente detta, in quanto comprendeva anche una parte pratica, operativa, anche se si differenziava dalle arti meccaniche in quanto non poteva prescindere dalla sua parte speculativa: pratica e teoria non erano quindi in opposizione, bensì in coordinazione. Nelle Università la practica era considerata al pari della theorica in quanto vera scientia anche per struttura formale, con i propri principi, le proprie procedure logiche e argomentative, in quanto modi operandi sunt probati hiis demonstrationibus evidentibus. La discussione di questa tematica divenne un topos quasi obbligatorio nelle introduzioni dei vari commenti dei testi generali di medicina, in cui venivano trattati gli statuti, la struttura e la posizione della materia. Una delle caratteristiche della practica era la sua vasta letteratura, composta da diversi generi a seconda di che ne era il fruitore: mentre il commento restò il prodotto di un insegnamento di alto livello, per l’opus si hanno raccolte di consigli, ricette ed experimenta. Dal XIII secolo si diffusero in tutta Europa, a partire da Bologna, l’uso di redigere i Consilia, trattatelli su singoli casi reali o immaginari a riguardo di una singola patologia riscontrata in un paziente di cui veniva resa nota l’età, lo status sociale, la complessione, i sintomi, il piano terapeutico e le cure realmente effettuate. I Consilia, anche se atti particolarmente alla pratica, furono raccolti e copiati sia dai maestri che dagli allievi a scopo didattico ed editoriale assumendo la forma di trattato specialistico strutturato in divisiones, dubia et responsiones, suppositiones, conclusiones, problemata e solutiones, tipico dell’insegnamento speculativo. Lentamente la practica andò incontro ad un processo di rivalutazione: considerata per molto 18
tempo secondaria rispetto alla speculazione, dalla alla fine del XIV secolo, complici anche le varie
epidemie (soprattutto quella di peste del 1348), si assistette ad un aumento della sua importanza
tanto che, nel tardo Quattrocento, i medici più importanti operavano in practica mentre la teoria
veniva considerata soltanto come propedeutica.
L’aver potuto vantare una traditio di testi, risultò di fondamentale importanza nel momento in cui
si ebbe la normalizzazione del sapere medico nelle Università, in quanto il corpus costituisce di per
se stesso una garanzia d’identità disciplinare e di stabilità delle conoscenze, un requisito di
scientificità e certezza. Con la normalizzazione della disciplina medica, e quindi di un modello di
medico erudito, figure professionali come vetule, barbieri, sortilegi, alchimisti, ostetrici, giudei
conversi, non avendo seguito un regolare corso di studi e non appartenendo alla corporazione
medica la cui identità scientifica e professionale si stava rafforzando, furono emarginati in quanto
esercitavano illegittimamente e senza permesso: erano visti come layci e banditi anche in quanto
prediligevano operare nello spazio domestico privato piuttosto che nelle pubbliche piazze, nei
pubblici ospedali o nei campi di battaglia.
Il medico nella società bassomedievale
Il medico cittadino "colto" della città, a partire dal XIII secolo, si colloca in una situazione sociale
ben diversa da quella dei suoi predecessori, che professavano un’arte “meccanica” sulla scorta di
un apprendistato artigianale basato solo in parte sulla conoscenza dei testi: la complessa
conquista da parte dei medici della cittadella del sapere universitario aveva dato i sui frutti e
quindi questo ormai agivano e vivevano in una società nella quale erano riservate, per loro, fama
e ricchezza: due cose ovviamente molto ambite ma difficili tanto da conquistare come da
mantenere. D’altronde il medico possedeva anche un potere sociale e politico che gli derivava
proprio dall’esercizio della medicina scientifica, vale a dire di una disciplina che aveva avuto
proprio in quel periodo una importante penetrazione nei costumi e nel pensiero degli strati colti e
ricchi della società: si pensi all’influenza del pensiero medico nella teologia del XIII secolo o, in un
versante meno elevato e più quotidiano, nell’alimentazione e nelle regole della tavola.
Abbiamo già visto precedentemente come il medico avesse comunque dei concorrenti, cioè degli
operatori della sanità a lui alternativi e che in qualche maniera potessero minare le basi del suo
status:
Si spaccia per medico qualunque idiota profano:
il giudeo, il frate, l’istrione, il barbiere, la vecchia;
19come fanno da medici l'alchimista o il saponaro,
o il custode dei bagni, o il falso oculista.
Cosi mentre ognuno cerca il lucro,
l’arte perde il suo pregio.
(Flos Salernitanum, XIV sec.)
Di fronte a questa concorrenza, il medico dotto deve trovare un modo per distinguersi, per
comunicare la superiorità del suo stato e della sua professione. Sceglie quindi un sistema di segni,
sistema che d’altronde verrà codificato rapidamente, con il quale possa essere rappresentato e
rappresentarsi, e che si estrinseca principalmente nell’abbigliamento e in una liturgia del rapporto
tra medico e malato.
Un elemento di questo complesso sistema segnico è il rapporto fra medico dotto ed il libro:
d’altronde è nel libro, nella letteratura medica cioè, che il medico trae gran parte della professione
e, come abbiamo visto, del suo status. D’altronde il libro, inteso come oggetto adatto ad essere
esibito, può venire utilizzato come buon testimone della preparazione del medico: un medico che
possiede molti libri mostra nel contempo garanzia di preparazione ed agiatezza che gli proviene
dal buon esercizio della professione, specie se i libri esposti nel suo studio sono ricchi per
decorazioni e legatura.
Questo apparato diremmo scenico dello studio del medico aveva pero la limitazione di essere
circoscritto alla sfera privata, anche se, comunque, lo studio era aperto al pubblico. Occorreva un
ulteriore apparato per la sfera pubblica: ecco quindi la necessità di indossare vesti e monili ed
usare cavalcature adeguate. L'iconografia dei secc. XIII-XV mette in evidenza come il medico
vestisse di un robone generalmente rosso, oppure, nelle raffigurazioni più antiche, di una veste
con sopravveste lunga, anch'essa generalmente di colore rosso. Molto spesso è presente al collo
una pelliccia, e il capo è sempre coperto da un berretto di varia foggia, spesso anch’esso ornato di
pelliccia. D'altronde il Flos Salernitanum avverte: una splendida veste ti procurerà parecchi
benefici, / un abito vile ti procaccerà una vile ricompensa, / poiché un medico povero riceverà vili
doni.
Ovviamente il momento più solenne di questa liturgia era rappresentato dalla visita medica. Il
primo approccio del medico cominciava di solito fuori della casa del malato, generalmente nel suo
studio dove parenti o famigli si recavano col segno della malattia, cioè con l'urina del malato, da
cui il medico traeva la prima indicazione sulla gravità dell'affezione. Questa fase era per così dire il
primo atto della rappresentazione che il medico andava ad interpretare. L'urina, generalmente,
20Puoi anche leggere