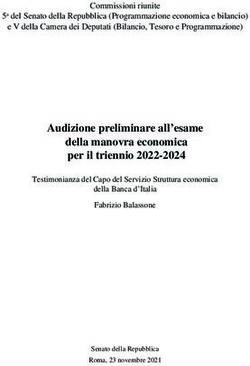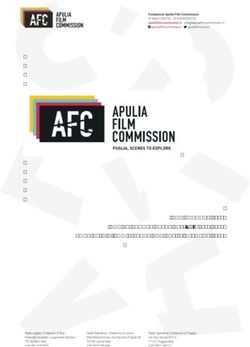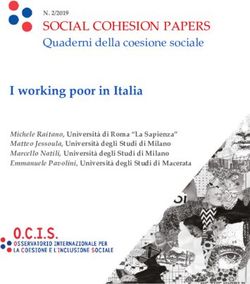Relazione del Presidente Maurizio Sella - Assonime
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Relazione del Presidente Maurizio Sella
Signor Ministro, Autorità, Signore e Signori,
questa Assemblea biennale si svolge, finalmente, in un clima economico in miglioramento,
dopo sette anni tra recessione e stagnazione. Il Paese ha un Governo che vuole cambiare
le cose, lavora nella direzione giusta e sa decidere. Per la prima volta da molti anni la
discussione pubblica può mettere al centro non la sopravvivenza, ma la positiva attesa di
una fase di trasformazione, speriamo di rigenerazione del Paese. La priorità dev’essere di
innalzare la crescita; il ritorno dell’instabilità politica può compromettere l’obiettivo.
Si compie oggi il mio primo biennio di presidenza dell’Assonime, poco fa l’Assemblea mi ha
confermato la fiducia per un secondo mandato. A tutte le associate, in particolare ai colleghi
imprenditori e agli esponenti aziendali che hanno voluto essere presenti, esprimo il mio
ringraziamento e la mia gratitudine. Considero Assonime un’istituzione al servizio del Paese,
perché il suo lavoro di interpretazione e proposta sull’evoluzione dell’ordinamento rende
un servizio utile non solo alle imprese, ma anche alle istituzioni con le quali l’Associazione
interagisce con continuità e autorevolezza.
Nell’ultimo biennio, le difficoltà dell’economia hanno inciso sulla compagine delle
associate. Tuttavia, il bilancio dell’Associazione è solido, grazie al severo contenimento
dei costi e allo sviluppo di nuovi servizi, anche a pagamento, apprezzati dalle imprese e
dal mercato. L’autorevolezza di Assonime è testimoniata dalla diffusione delle nostre
circolari, dall’ascolto che riceviamo nelle nostre risposte alle consultazioni per le modifiche
legislative e regolamentari, a livello nazionale e europeo, dalla collaborazione instaurata
con amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti e magistrature. La risposta del mondo
delle imprese è positiva, come indicano l’utilizzo dei nostri servizi da parte delle associate
e le numerose nuove richieste di associazione.
Per questi risultati dobbiamo ringraziare il direttore generale, Stefano Micossi, la sua
squadra di dirigenti e i suoi collaboratori tutti, che ogni giorno rinnovano, con il loro lavoro,
la grande tradizione di competenza tecnica e autonomia di giudizio dell’Associazione,
1che ne costituisce il vero carattere distintivo. Rivolgo uno speciale ringraziamento al vice-
presidente Innocenzo Cipolletta, che mi ha validamente coadiuvato, che sempre arricchisce
il nostro lavoro con idee stimolanti e che intendo confermare al mio fianco nel secondo
biennio.
Il quadro economico e l’azione di Governo
Tra il 2007 e il 2014 il PIL è diminuito del 9 per cento in termini reali, è rimasto invariato
in termini nominali. In queste circostanze difficilissime, un risultato importante dell’azione
dei Governi riformatori è stato di riportare il disavanzo del settore pubblico entro il limite
europeo del 3 per cento, dal 5,3 per cento del 2009. Questo risultato, però, sottende un
aumento della spesa pubblica in rapporto al PIL di oltre 4 punti percentuali, fino al 51 per
cento per le spese totali e al 46,5 per cento per quelle al netto degli interessi. Sono valori
vicini a quelli di altri grandi paesi europei, ma con livelli di efficienza della spesa molto
inferiori. La pressione fiscale è aumentata di due punti percentuali sul PIL, salendo al 43,5
per cento.
Tra il 2007 e il 2014 le spese sono aumentate di oltre 70 miliardi. La parte del leone è
stata svolta dalla spesa per le pensioni, l’assistenza e i sostegni alla disoccupazione. Si
sono arrestate le spese per il personale – che però rischiano di rimbalzare alla scadenza
del blocco contrattuale – e sono scese quelle per gli investimenti. Le prestazioni sociali in
denaro hanno consentito di limitare le tensioni sociali, ma ormai rappresentano il 44 per
cento della spesa totale al netto degli interessi, comprimendo la capacità di manovra del
bilancio. Intanto, il debito pubblico ha superato il 132 per cento del PIL.
Per l’abbattimento del debito pubblico non ci sono scorciatoie: dovremo mantenere a
lungo consistenti avanzi primari (ossia, al netto degli interessi), accelerare la dismissione
e l’efficientamento del patrimonio immobiliare in mano pubblica, restituire al mercato le
società controllate dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali. Gli avanzi primari
dovranno essere conseguiti frenando la spesa pubblica, con l’azione paziente e persistente
della spending review. Nel prossimo biennio incombono sul bilancio pubblico clausole di
salvaguardia che, se non si riuscirà a contenere la spesa, possono fare scattare aumenti
delle imposte per 25 miliardi di euro.
2Un sollievo importante dal debito può venire dalla ripresa della crescita e dal ritorno
dell’inflazione verso il 2 per cento. Il calo del prezzo del petrolio, la manovra di quantitative
easing della Banca centrale europea e il deprezzamento dell’euro spingono in questa
direzione, sullo sfondo di un quadro congiunturale in via di miglioramento. Ma senza
riforme profonde che liberino l’economia dall’incertezza normativa e fiscale e dai troppi
vincoli al funzionamento dei mercati la ripresa si affievolirebbe presto. Ricadremmo nel
sentiero di stagnazione già prevalente prima della crisi finanziaria.
Il Governo Renzi ha realizzato un risultato importantissimo con il Jobs Act, da molti
ingiustamente sottovalutato, i cui benefici già si manifestano. La riforma deve essere
completata con le politiche attive per spostare il lavoro verso impieghi a più elevata
produttività. Le imprese possono contribuire a questo processo spostando la contrattazione
a livello aziendale, dove è più facile scambiare incrementi salariali con incrementi di
produttività.
Anche il nuovo sistema elettorale e le riforme costituzionali, con l’adozione di un
bicameralismo differenziato, aiutano la crescita, perché rafforzano la capacità decisionale
dell’esecutivo, accelerano i processi legislativi e riportano al centro competenze chiave per
il buon funzionamento dell’economia, delle quali le Regioni hanno spesso fatto scempio.
Di altre importanti iniziative riformatrici del Governo parlerò tra breve. Prima voglio
soffermarmi su un altro aspetto generale. La ristrutturazione delle imprese meno efficienti
e lo spostamento del capitale verso impieghi più remunerativi e tecnologie innovative
procedono troppo lentamente; ne sono un riflesso i prestiti in sofferenza presso il sistema
bancario.
Rilevanti effetti positivi possono derivare dai provvedimenti in preparazione per allineare
ai livelli europei il trattamento fiscale delle perdite sui crediti, accelerare le procedure per
la crisi d’impresa e promuovere un mercato funzionante per la cartolarizzazione dei crediti
delle banche. Ma occorre accettare che le ristrutturazioni aziendali si sviluppino senza
impedimenti, evitando gli interventi tesi a mantenere l’occupazione in imprese non più
vitali, a scapito della crescita di quelle vincenti.
3La riforma della pubblica amministrazione
Le riforme richieste per sbloccare l’economia italiana sono ben identificate nel Programma
Nazionale di Riforma presentato dal Governo insieme al Documento di Economia e Finanza.
Spicca per importanza la riorganizzazione della pubblica amministrazione, prevista da un
disegno di legge all’esame del Parlamento.
Ma scrivere leggi non basterà. La principale sfida riguarda la gestione degli apparati
amministrativi, tuttora bloccata da logiche formalistiche e da una carente attribuzione
delle responsabilità. Occorre gestire le amministrazioni in funzione dei risultati. L’azione
amministrativa va più nettamente indirizzata al servizio dei cittadini e deve essere liberata
dall’interferenza diffusa della politica nelle scelte sull’impiego delle risorse.
In una prospettiva di efficiente utilizzo del denaro pubblico, il numero dei dipendenti
pubblici in Italia appare in linea con quello di altri paesi, ma vi è molto da migliorare nella
sua allocazione. Lo spostamento del personale dalle aree in cui esso è sottoutilizzato a
quelle in cui vi è un fabbisogno insoddisfatto, dopo adeguata riqualificazione, rappresenta
una priorità per assicurare il buon funzionamento dell’amministrazione e la qualità dei
servizi ai cittadini.
La semplificazione del procedimento amministrativo è centrale. Il disegno di legge sulla
pubblica amministrazione contiene proposte utili, prevedendo ad esempio che venga
compiuta una ricognizione dei procedimenti per i quali è sufficiente la segnalazione
certificata di inizio di attività o una semplice comunicazione preventiva.
Per dare affidabilità alle procedure semplificate, le norme devono fissare chiaramente i
presupposti per l’avvio e l’esercizio dell’impresa. L’autocertificazione di inizio di attività
non può funzionare se si lasciano all’amministrazione tempi lunghissimi per contestarne la
legittimità. Si dovrebbe escludere in ogni caso la possibilità di una revoca del provvedimento
per una mutata valutazione dell’interesse pubblico.
Il disegno di legge contiene anche una delega per la revisione della disciplina della Conferenza
dei servizi, finora risultata inefficace. Bisogna limitare drasticamente le ipotesi in cui sono
richiesti atti di assenso da parte di più amministrazioni e, quando ciò sia inevitabile, occorre
rafforzare i meccanismi di composizione dei disaccordi tra di esse e far rispettare i termini
per la decisione finale.
4Un tema di drammatica attualità per l’attrattività del nostro Paese agli occhi degli investitori
è il rischio regolatorio: troppo spesso le regole cambiano con effetti retroattivi. Sul tema,
Assonime ha presentato da tempo proposte che auspichiamo possano essere prese in
considerazione dal Governo e dal Parlamento.
In Italia vi sono circa ottomila società a partecipazione pubblica; la disciplina che ne regola
il funzionamento si è sviluppata negli anni con frequenti interventi normativi, ma senza un
disegno organico. La Corte dei conti ha evidenziato che oltre un terzo delle partecipate locali
è in perdita; secondo il Rapporto Cottarelli eliminando le società inutili o quelle costituite
per sole finalità clientelari, il numero complessivo potrebbe scendere a mille, con risparmi
significativi per le finanze pubbliche.
Nel suo Rapporto “Principi per un riordino del quadro giuridico delle società a partecipazione
pubblica”, Assonime argomentava che l’azionista pubblico dovrebbe esercitare i suoi poteri
attraverso i normali canali previsti dal diritto societario, senza intervenire direttamente sul
management.
In occasione della recente consultazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dell’Autorità nazionale anticorruzione, abbiamo sottolineato che non si possono trattare
come amministrazioni pubbliche le società che svolgono attività d’impresa sul mercato,
anche se sono controllate da soggetti pubblici. Le società che operano sul mercato richiedono
controlli e presidi organizzativi diversi da quelli delle amministrazioni.
Per le società che gestiscono servizi pubblici locali, sprechi e inefficienze sono quasi sempre
associati agli affidamenti delle concessioni senza gara: un sistema opaco che non serve
l’interesse pubblico alla qualità dei servizi e che occorrerebbe finalmente riportare alla
normale applicazione delle regole di mercato.
La delega al riassetto della disciplina sulle società partecipate, contenuta nel disegno di
legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, offre l’occasione per mettere
ordine nel sistema.
Nel settore degli appalti pubblici la disciplina vigente, composta da moltissime disposizioni
e improntata a procedure rigide e iperdettagliate, non è stata in grado di contrastare la
corruzione e la cattiva gestione delle risorse pubbliche. Anche per questo comparto vi è
oggi l’opportunità di un profondo cambiamento, in concomitanza con il recepimento delle
5nuove direttive europee sui contratti pubblici.
Serve una radicale semplificazione del quadro normativo, rispettando il divieto di
aggiungere varianti nazionali nella trasposizione delle disposizioni comunitarie. Secondo
l’impostazione europea, le amministrazioni devono poter scegliere il modo migliore per
soddisfare la domanda pubblica; a tal fine, occorre rafforzare la capacità gestionale e la
professionalità delle stazioni appaltanti, riducendone drasticamente il numero.
Dall’attuazione dell’Agenda digitale europea e nazionale può derivare un forte impulso
alla crescita, all’occupazione e a una migliore qualità della vita. I dati dell’ultimo Digital
Scoreboard della Commissione europea mostrano che il nostro Paese è in grave ritardo
rispetto agli obiettivi dello sviluppo dell’e-commerce e dell’utilizzo dei servizi di e-government
da parte dei cittadini. L’insufficiente sviluppo della banda ultra-larga penalizza gravemente
le applicazioni IT nella vendita di servizi online.
La strategia del Governo per la crescita digitale 2014-2020 identifica le azioni da intraprendere
e indica una serie di piattaforme abilitanti (anagrafe della popolazione residente, pagamenti
elettronici, fatturazione elettronica, open data, eccetera). Non basta automatizzare i processi
esistenti, occorre rivedere le organizzazioni sottostanti in profondità, adattandole alle
potenzialità del mondo digitale.
Non sono indicazioni nuove, ma la realizzazione è troppo lenta. Occorre agire per colmare
questi ritardi e farlo in fretta.
Legalità e sviluppo economico
La performance dell’economia italiana è zavorrata da un carico di corruzione enorme,
anomalo tra i paesi avanzati. Assonime interviene da tempo sul tema; abbiamo pubblicato
un Rapporto, da me fortemente voluto, che propone rimedi strutturali nella gestione delle
amministrazioni pubbliche e delle imprese. Gli interventi chiave per sradicare la corruzione
coincidono largamente con le riforme della pubblica amministrazione di cui già ho parlato.
Negli ultimi mesi il Parlamento ha inasprito le pene per i reati economici, istituendo anche il
nuovo reato di autoriciclaggio. Si delinea un forte allungamento dei termini di prescrizione,
in particolare per la corruzione: è una misura che, se riduce il rischio dell’estinzione
6dei procedimenti, non incoraggia i tribunali a lavorare più speditamente. L’esigenza di
durata ragionevole del processo appare sacrificata per calmare l’indignazione che scuote
l’opinione pubblica; ma la risposta giusta è assicurare il buon funzionamento, in tempi certi
e prevedibili, del processo.
La corruzione trova il suo terreno di coltura nel clientelismo e nell’occupazione partitica delle
pubbliche istituzioni. Non ci può essere miglioramento sul fronte della corruzione diffusa
senza un passo indietro dei partiti dalla gestione delle risorse pubbliche e un rafforzamento
dell’autonomia e della professionalità delle amministrazioni. La legge n. 190/2012 segna
un punto di svolta, con l’introduzione di modelli di gestione per prevenire i comportamenti
illeciti e l’istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Servono criteri di selezione meritocratica del personale, la responsabilizzazione dei dirigenti
e l’applicazione di standard trasparenti di valutazione dei risultati. Non si tratta di eliminare
la discrezionalità amministrativa, ma di esercitarla in maniera trasparente, sulla base di
obiettivi ben definiti e chiare attribuzioni di responsabilità. I controlli formali sul rispetto
delle procedure devono lasciare il posto al controllo rigoroso dei risultati.
L’azione di contrasto alla corruzione deve prevedere misure idonee a promuovere la cultura
della trasparenza e del rispetto delle regole tra le imprese. Accanto alle misure di repressione
servono efficaci sistemi di prevenzione dei comportamenti illeciti.
Il decreto legislativo 231/2001 ha promosso l’identificazione preventiva dei rischi di
corruzione e l’adozione di modelli organizzativi capaci di prevenirli. Un contributo può
venire anche da protocolli e rating di legalità e da politiche di corporate social responsibility
attuate con codici di autodisciplina.
Tuttavia, i modelli organizzativi predisposti dalle imprese non vengono tenuti in gran conto
dalla giurisprudenza, che quasi mai esclude la responsabilità dell’ente. L’assenza di un vero
raccordo con il diritto societario, l’ampiezza del catalogo dei reati, la peculiarità del sistema
delle misure cautelari e dell’onere della prova (di fatto a carico dell’ente) hanno trasformato
il sistema 231 in un sistema di responsabilità oggettiva dell’impresa.
La sfiducia verso i modelli organizzativi da parte della magistratura può risultare
controproducente, indebolendo l’azione preventiva degli illeciti all’interno delle imprese.
La disciplina 231 richiede qualche intervento di manutenzione per rafforzarne la funzione
7originaria e per raccordarla con l’evoluzione delle regole sui controlli societari dell’ultimo
decennio. Si tratta di un’esigenza molto sentita dal mondo imprenditoriale, che auspica un
maggiore equilibrio tra le esigenze di legalità e quelle di certezza sugli effetti dei modelli
organizzativi.
Occorre anche arrestare la tendenza a creare nuovi presidii di controllo nelle società,
piuttosto che rafforzare e coordinare quelli esistenti. Un recente studio della CONSOB mette
in evidenza che l’eccesso regolatorio del passato decennio ha determinato un irrigidimento
e un sovraccarico delle funzioni e dei costi di compliance, non sempre con l’effetto di limitare
i comportamenti opportunistici o illeciti.
Per le società quotate, un ruolo rilevante nel miglioramento del governo societario è stato
svolto dal Comitato per la Corporate Governance, che ha adeguato il Codice di Autodisciplina
alle migliori pratiche internazionali e ha avviato il monitoraggio dei comportamenti. In
generale, è importante che le imprese adottino una governance moderna e trasparente,
affidando la gestione e il controllo a consigli di amministrazione forti e con elevate
competenze.
Recentemente la Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge volta a rafforzare
l’azione di classe e a estenderne l’ambito di applicazione. La formulazione indebolisce i
filtri per il giudizio di ammissibilità, prevede incentivi alle liti e forme di danno punitivo. È
un’impostazione che si discosta dal modello europeo e suscita serie preoccupazioni tra le
imprese; auspichiamo che possa essere corretta nei successivi passaggi parlamentari.
Le regole sulla crisi d’impresa
Dopo la riforma del 2005-2006 e gli aggiustamenti successivi, il nostro sistema concorsuale
si è avvicinato al modello americano del Chapter 11 e ai sistemi più avanzati dei paesi
europei, che pongono al centro la continuità dell’impresa. Questo obiettivo è preminente
anche nella raccomandazione della Commissione europea del 2014.
Dunque, le nostre regole in materia d’insolvenza sono in linea con le legislazioni migliori dei
paesi avanzati e i principi ispiratori fissati dall’Unione europea. La crisi ha messo alla prova
molti istituti, un ulteriore contributo normativo può essere necessario; ma va mantenuto
l’impianto della disciplina, che si sta oramai affermando nella cultura giuridica del Paese.
8Per rafforzare la tutela dei creditori si possono adottare misure che rendano più celeri
le procedure concorsuali, riconoscendo ai creditori un ruolo proattivo nell’individuazione
di soluzioni non liquidatorie per il recupero del proprio credito, inclusa la possibilità di
conversione del credito in equity, e semplificando l’escussione delle garanzie.
Permangono alcune lacune normative, ad esempio sul fallimento delle società di capitali,
l’assenza di una disciplina per i gruppi, la costituzione di un vero mercato per la smobilitazione
dei crediti incagliati nelle procedure, un moderno diritto penale dell’insolvenza. Inoltre,
l’Italia non ha ratificato lo schema di legge dell’United Nations Commission on International
Trade Law sull’insolvenza transfrontaliera extraeuropea, che essa stessa aveva contribuito
a promuovere.
Ancora immutata, nonostante il disegno di legge delega presentato nel 2010, è rimasta
la disciplina dell’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, regolata da
molteplici norme con diverse procedure. Dobbiamo chiederci se la sua esistenza sia ancora
giustificata, dopo la modernizzazione delle nostre procedure fallimentari secondo i modelli
più avanzati.
A livello europeo, è stato emanato il nuovo regolamento sulle procedure transfrontaliere
d’insolvenza. Una novità importante è l’istituzione di un registro elettronico delle procedure,
che consentirà a creditori e corti nazionali di accedere alle informazioni sulle procedure
transnazionali. Si delinea una nuova disciplina sull’insolvenza dei gruppi. È importante che
l’Italia adegui il suo ordinamento a questi sviluppi.
I numerosi provvedimenti varati dai Governi nel biennio 2013-2014 in materia di
giustizia sono positivi; occorre proseguire rafforzando gli interventi sull’organizzazione
dei tribunali, completandone l’informatizzazione e potenziandone gli organici. Mancano
ottomila cancellieri; la destinazione a queste funzioni del personale delle Province in via di
abolizione garantirebbe il forte aumento della capacità di lavoro dei tribunali. Sarebbe un
segno concreto della determinazione del Governo di usare le nuove norme sulla mobilità
del personale pubblico.
Ulteriori miglioramenti sono possibili per ridurre i tempi dei processi e dare efficacia alla
tutela dei creditori, come indicato dalla Commissione Berruti istituita presso il Ministero della
Giustizia. In particolare va riformato il procedimento esecutivo che ha un peso significativo
nei tempi della giustizia e ha perso contatto con le esigenze dell’economia moderna.
9Una più decisa “de-giurisdizionalizzazione” consentirebbe di accelerare le procedure e
snellire le formalità. Non si tratta di una fuga dai tribunali; anzi, indirizzando in misura
crescente verso i canali alternativi la soluzione delle controversie private, si restituirebbe
centralità ai tribunali nell’accertamento del diritto.
Un ecosistema per il mercato dei capitali
Con la recente consultazione sul mercato unico dei capitali, la Commissione europea si
propone di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari in Europa, rafforzare i flussi di
capitale cross-border, diversificare le fonti di finanziamento per le imprese, in particolare
le piccole e medie. Sarebbe utile accelerare i tempi dell’iniziativa rispetto alla scadenza del
2019.
Nella nostra risposta alla consultazione, abbiamo sottolineato come in alcune aree sia
richiesta una maggiore armonizzazione a livello europeo: in particolare per fissare la
definizione di azionista nelle società quotate e i requisiti di trasparenza per le partecipazioni
rilevanti. Per gli investimenti transfrontalieri serve una definizione comune di strumento
di debito e di capitale, al fine di evitare distorsioni di trattamento di dividendi e interessi e
fenomeni di doppia o mancata imposizione.
In altre aree, invece, le norme comuni dovrebbero arretrare. Ad esempio, si dovrebbe
correggere il regolamento sugli abusi di mercato, che ha esteso gli obblighi informativi
delle società quotate sul mercato regolamentato anche agli emittenti, tipicamente piccole e
medie imprese, i cui titoli sono negoziati solo sui mercati alternativi. Va rispettata l’area di
intervento dell’autodisciplina in materia di corporate governance, frenando la tentazione di
incorporarne le prescrizioni nella legislazione.
Infine, è desiderabile un maggiore accentramento della vigilanza sui mercati dei capitali, in
linea con quanto si è fatto per le banche. In questo senso, abbiamo proposto di attribuire
all’Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari poteri diretti di controllo sulle entità
– mercati, intermediari, emittenti – d’importanza sistemica.
Un aspetto da migliorare nella disciplina europea riguarda il prospetto. La concorrenza tra
regolatori non sta funzionando in quanto per le emissioni azionarie il prospetto è approvato
dall’autorità nazionale del paese in cui l’emittente ha la sede legale. In molti paesi la
10procedura di approvazione del prospetto resta troppo lunga e complessa, con modesti
benefici informativi per gli investitori.
Si dovrebbe lasciare all’emittente la scelta del mercato di emissione, indipendentemente
dalla sede legale; inoltre, il prospetto dovrebbe essere molto più semplice, limitandosi a
fornire poche informazioni standardizzate sull’emittente, lo strumento finanziario e i rischi
connessi, sul modello del Key Information Document utilizzato per i prodotti di investimento
al dettaglio.
Qualche parola va detta anche sulla tassazione degli strumenti finanziari. Non so dire se
il progetto di una cooperazione rafforzata per la Financial Transaction Tax avanzerà; certo,
i progetti in materia paiono mal pensati. Oramai, dopo aver esentato la gran parte delle
transazioni finanziarie, si finirebbe per colpire solo le azioni e i derivati azionari, cioè il
capitale per gli investimenti. Ben sapendo che l’imposta può dare frutti modesti di gettito,
dato che la base imponibile tenderebbe a spostarsi verso piazze esenti. Sarebbe più utile
incoraggiare gli stati membri a introdurre regimi fiscali che favoriscano orizzonti temporali
più lunghi per gli investimenti.
In Italia, con il decreto sulla competitività dello scorso anno (decreto legge n. 91 del 2014)
il nostro ordinamento ha abbandonato il principio “un’azione, un voto”, già scalfito dalla
riforma societaria del 2003, introducendo le azioni a voto plurimo per le società non quotate
e il voto maggiorato per quelle quotate.
Queste innovazioni si collocano in un contesto di misure volte a favorire il finanziamento
diretto dal mercato e l’eventuale quotazione delle imprese. Muovono dall’idea che la
presenza di un socio o di un gruppo di soci stabili interessati alla gestione della società sia
un fattore positivo per il suo sviluppo; che le azioni a voto plurimo o maggiorato possano
facilitare la raccolta di capitale di rischio dal mercato, perché non si indebolisce il controllo
del socio di riferimento. Restano i potenziali svantaggi di proteggere assetti relazionali più
attenti agli equilibri azionari che alla miglior gestione. La disciplina è facoltativa, la sua
concreta attuazione è rimessa alle scelte statutarie.
Le imprese italiane dipendono dal credito bancario anche più largamente che nel resto
d’Europa. Per questo la nostra economia è stata colpita più severamente dalla crisi finanziaria.
La radice del problema sta nella scarsa propensione delle nostre imprese ad aprire il capitale
11al mercato. Troppo spesso ciò si accompagna a una bassa patrimonializzazione. I nuovi
assetti regolamentari indurranno a limitare il credito alle imprese più rischiose.
Con la crisi si è creato un solco fra le imprese più robuste, per le quali l’offerta di credito
eccede la domanda e che hanno trovato sbocco anche sul mercato obbligazionario, e le
imprese più fragili, che stentano a ottenere nuovo credito e in molti casi devono fronteggiare
richieste di rientro.
È dunque importante favorire lo sviluppo di canali alternativi di accesso diretto al mercato
dei capitali, i quali riducono la ciclicità del credito e consentono una ripartizione più diffusa
dei rischi. Numerosi studi empirici confermano che l’aumento della quota di finanziamento
alle imprese proveniente dal mercato dei capitali accresce gli effetti positivi della finanza
sulla crescita.
Dal 2012 si sono susseguiti vari provvedimenti governativi tesi a offrire alle imprese
strumenti alternativi al credito bancario. Nonostante un certo aumento delle emissioni di
obbligazioni, il peso dei finanziamenti diretti alle imprese dal mercato, di debito e di capitale
di rischio, resta limitato.
Vi è spazio per iniziative tese a favorire lo sviluppo di un mercato di titoli cartolarizzati
rappresentativi di crediti alle imprese: ad esempio, rafforzando l’intervento dei fondi di
garanzia anche a favore dei canali di finanziamento non bancario e incoraggiando l’accesso
delle imprese a piattaforme dirette di finanziamento online, che in altri paesi iniziano a
svilupparsi anche con il sostegno degli intermediari tradizionali. Si pone il problema di
sviluppare strumenti informativi standardizzati sulla qualità dei prenditori di credito di
minore dimensione. Le iniziative di sostegno del mercato devono includere anche i fondi
d’investimento disposti ad investire negli strumenti di cartolarizzazione.
La regolamentazione primaria e secondaria sulle società quotate resta troppo complessa
e onerosa; sull’onda dell’emotività scaturita dagli scandali finanziari, non solo non si sono
sufficientemente differenziate le norme per le società minori, ma le regole di accesso al
mercato per le piccole e medie imprese si sono avvicinate a quelle del listino principale.
Da tempo Assonime propone di riorganizzare i mercati borsistici attraverso la creazione
di tre mercati, o regimi, caratterizzati da regole progressivamente più stringenti, in modo
da facilitare l’accesso iniziale alla quotazione di azioni e obbligazioni, in particolare per le
12piccole e medie imprese.
Si tratta di differenziare le regole di ammissione a quotazione su due livelli di mercato
– uno standard e uno premium con requisiti più stringenti – come già accade nel Regno
Unito, mantenendo inoltre piattaforme non regolamentate (Multilateral Trading Facilities)
per la negoziazione di titoli, azionari e obbligazionari, di imprese non quotate. Gli emittenti
potrebbero allora scegliere il regime di governance al quale conformarsi, segnalando in tal
modo agli investitori le caratteristiche di qualità dei titoli emessi.
Anche emittenti non disposti a sopportare gli oneri pieni della quotazione potrebbero
essere indotti ad accedere al mercato, scoprendo più tardi i benefici addizionali di prezzo e
liquidità del titolo ottenibili con la scelta di un segmento con regole più stringenti – come
già mostra l’esperienza del segmento STAR.
Il mercato regolamentato standard, aperto a tutte le società quotate, prevedrebbe
l’applicazione dei soli requisiti imposti dall’applicazione delle normative comunitarie, con
significative semplificazioni rispetto all’attuale disciplina nazionale. Il mercato regolamentato
premium, o di eccellenza, sarebbe caratterizzato da una disciplina più rigorosa sia in tema
di governance che di disclosure di informazioni al mercato.
Le piattaforme di scambio non regolamentate dovrebbero essere affidate ai regolamenti
emanati dai gestori, escludendo interventi della legislazione nazionale diversi da quelli di
attuazione delle direttive europee.
Un fisco semplice e prevedibile
In un saggio del 1946, parlando del sistema fiscale italiano Einaudi scriveva: “La molteplicità,
l’intrico, le sovrapposizioni sono oramai giunte a tale stremo, che nessuno ci si raccapezza
più … il contrario di quel che servirebbe per la ricostruzione economica e sociale del Paese.”
Purtroppo, le cose sono addirittura peggiorate, i contribuenti sono ostaggio di un
fisco che continua a complicarsi. Troppe imposte e troppi adempimenti. Un diluvio di
disposizioni pensate e scritte fuori sistema, solo per esigenze di gettito, che faticano a
trovare sistemazione in un corpo normativo già troppo complesso. Ne scaturisce un volume
abnorme di contenzioso.
13Il sistema sanzionatorio è oppressivo e imprevedibile. Dalla contestazione di violazioni
amministrative minori possono scaturire procedimenti penali ed elevati costi reputazionali;
la certezza del diritto è compromessa dalla durata eccessiva dei processi tributari e dalla
variabilità della giurisprudenza.
Il Governo Renzi sembra determinato a invertire la rotta, portando a compimento la delega
fiscale e avviando una nuova stagione nel rapporto tra fisco e contribuenti, all’insegna della
compliance volontaria e della trasparenza. Il vento del cambiamento viene da fuori, dai
lavori dell’OCSE e del G20 che cercano di definire nuove regole di tassazione dei gruppi
multinazionali per contrastare le operazioni di profit shifting e i regimi di concorrenza fiscale
dannosa. In questo contesto è nato il sistema di scambio automatico multilaterale delle
informazioni sui capitali detenuti all’estero.
Non meno importante, per un rinnovato rapporto tra contribuente e amministrazione
finanziaria, è l’introduzione di una definizione normativa dell’abuso del diritto – da noi sempre
invocata e ora contenuta in uno dei decreti attuativi della delega fiscale. Punti fondamentali
della nuova disciplina sono la precisazione degli elementi costitutivi dell’abuso, che potrà
essere invocato quando, oltre alla mancanza di sostanza economica dell’operazione, sussista
anche una effettiva violazione dei principi o delle finalità delle norme tributarie. È prevista
una netta separazione della fattispecie di simulazione e di frode da quella di abuso, con
conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali per quest’ultimo.
È necessario applicare la sanzione penale alle ipotesi di reale occultamento del reddito,
escludendo le questioni interpretative. Le sanzioni amministrative andrebbero ricalibrate
in funzione della gravità della violazione. Oggi vengono comminate nella medesima misura
per chi compie errori di competenza e per chi occulta il reddito; si applicano sanzioni
proporzionali alle imposte per meri inadempimenti formali.
Gli schemi di decreti attuativi della delega fiscale hanno introdotto opportune innovazioni
per favorire gli investimenti in Italia di soggetti esteri e per rendere più chiara e competitiva
la disciplina fiscale dei gruppi nazionali che si insediano nei mercati esteri, prima tra tutte
la branch exemption.
Per completare l’opera, occorre affrontare due tematiche di grande criticità per le imprese:
quella dei prezzi di trasferimento nelle transazioni intragruppo, già oggetto di un nostro
Rapporto di Giunta inviato al Governo e al Parlamento; e quella dell’esterovestizione, un
14istituto nato per contrastare le costruzioni artificiose insediate in altri paesi per sole ragioni
fiscali, ma che spesso colpisce come fittizie reali attività d’impresa all’estero, solo perché la
capogruppo residente in Italia ne sottopone le attività a direzione e coordinamento.
Abbiamo accolto con sollievo la recente sentenza della Corte costituzionale che, in linea
con le osservazioni più volte da noi espresse, ha censurato l’addizionale sulle imprese del
settore energetico (la c.d. Robin Tax). Questa pronuncia fissa limiti precisi per il legislatore
tributario che intendesse introdurre imposte irragionevolmente gravose per sottosettori di
impresa, o addirittura singole imprese, sostanzialmente per impadronirsi della loro liquidità.
Le addizionali d’imposta applicate ripetutamente a banche e assicurazioni rientrano in
questa fattispecie.
Le proposte di una diversa modulazione dei carichi tributari tra imposte dirette e indirette
faticano ad affermarsi, pur se il Fondo monetario internazionale, l’OCSE e la Commissione
europea ci incoraggiano a muovere in questa direzione. Non si affronta lo smantellamento
delle aliquote ridotte IVA, che pure costituiscono la voce più significativa delle tax
expenditures che ci si chiede di ridurre.
Qualche limitato progresso è stato compiuto nello sgravio dei fattori produttivi, con il
riconoscimento della deduzione dall’IRAP dei costi del lavoro e lo sgravio contributivo
per le assunzioni con il nuovo contratto a protezione crescente, ma la distanza dai nostri
concorrenti europei nel cuneo fiscale sul lavoro resta ancora troppo ampia.
La dimensione europea
L’Europa oggi non è popolare. Le vengono imputate politiche di austerità eccessiva che ci
hanno lasciato con molti debiti e molti disoccupati. L’integrazione dei mercati viene percepita
come fonte di problemi, invece che come opportunità. Si imputa all’Europa l’aumento
dell’incertezza sul futuro e dell’instabilità, che invece è il prodotto della globalizzazione
e del progresso tecnologico. Non riusciamo a regolare i flussi d’immigrazione dal sud del
Mediterraneo, che spaventano l’opinione pubblica, per mancanza d’Europa, non per troppa
Europa. Il Regno Unito chiede di rinegoziare aspetti significativi dei Trattati. La crisi greca
intossica lo spazio pubblico europeo.
Per la crescita, un contributo rilevante viene dalla politica monetaria espansiva della Banca
15centrale europea; ma gli effetti saranno modesti e di breve durata se non sapremo riformare
le nostre strutture economiche, ancora frenate da vincoli e rigidità che schiacciano la
produttività. Il piano Juncker non avrà successo nel rilanciare l’investimento privato, se non
sarà accompagnato dall’integrazione e dalla liberalizzazione dei mercati europei dei servizi
a rete – telecomunicazioni, trasporti, energia.
Le strutture di governo dell’Eurozona devono essere rafforzate: con politiche economiche
capaci di correggere gli enormi squilibri dei pagamenti correnti che albergano al suo
interno e con meccanismi di condivisione dei rischi per fronteggiare eventuali nuovi shock
finanziari. La legittimità democratica non può essere ricostruita senza affidare al Parlamento
europeo e ai Parlamenti nazionali adeguati poteri di indirizzo e controllo nella definizione
delle politiche economiche comuni, oggi affidate solo al Consiglio europeo.
Su questi temi la discussione è avviata, è importante che il prossimo Consiglio europeo
indichi la direzione in maniera convincente. Guidando, invece che inseguendo l’opinione
pubblica. Il nostro futuro, il futuro dei nostri giovani non può costruirsi che in Europa e con
l’Europa.
Vi ringrazio per l’attenzione.
16Puoi anche leggere