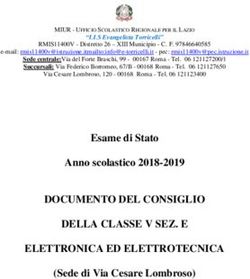Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista - Liberazioni
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
43
territori delle pratiche
Stefania Cappellini e Marco Reggio
Quando i maiali fanno la rivoluzione
Proposte per un movimento antispecista non paternalista
Gli animali hanno sempre fatto parte della nostra storia e delle
nostre storie; ora si tratta di cercare appassionatamente come fare
storia con loro.1
«Il movimento di liberazione animale è lʼunico che agisce per puro altruismo».
Abbiamo sentito così tante volte frasi come questa che ormai ci sembrano ovvie.
Effettivamente, possono essere vere, dipende dai punti di vista e dalla risposta alla
domanda: «Da chi è composto il “movimento di liberazione animale”?» Pensare
allʼanimalismo come lotta altruistica presuppone infatti che gli animali non fac-
ciano parte del movimento di liberazione animale. E questo presupposto poggia
sullʼidea, altrettanto diffusa, che gli animali non siano in grado di protestare, di
ribellarsi, di desiderare la fine del loro sfruttamento. «Siamo la voce dei senza
voce». «Gli animali non possono protestare, noi sì». Anche queste sono afferma-
zioni che abbiamo sentito (e sostenuto) innumerevoli volte, tanto che ci sembrano
costituire lʼunica narrazione possibile della questione animale e della lotta contro
lo sfruttamento dei non umani. Scopo del presente saggio è quello di mettere in di-
scussione lʼinevitabilità di questa narrazione, mostrando che gli animali si ribella-
no, svolgendo il ruolo di soggetti attivi più che di semplici vittime o di beneficiari
passivi della “buona coscienza” animalista. Inoltre, cercheremo di mostrare come
lo sforzo di mettersi in posizione di ascolto delle istanze espresse dai soggetti non
umani possa aprire nuove strade per la lotta di liberazione animale.
Lʼadozione di uno sguardo di questo tipo pone una serie di quesiti di natura
teorica, che non verranno qui approfonditi, ma che sono comunque centrali per
sviluppare un nuovo ambito di ricerca e di azione: qual è la possibilità di comuni-
cazione del dissenso fra specie diverse? Quali modelli è necessario inventare per
rendere possibile lʼespressione del disagio di altre specie come disagio politico?
Come dovrebbero modificarsi alcuni concetti elaborati in ambito umano, come
quelli di “consensoˮ, di “ribellioneˮ, di “organizzazioneˮ, di “atto politicoˮ, di
1 Vinciane Despret, Quando il lupo vivrà con l’agnello. Sguardo umano e comportamenti animali,
trad. it. di G. Regoli, Elèuthera, Milano 2010, p. 213.44 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
agency, e così via2?
Gli animali resistono
Torello abbattuto dopo sei mesi di latitanza [...]. Il vitello aveva ancora al collo il
laccio, incarnito, che ne indicava la provenienza, un allevamento di Castelminio di
Resana. In tanti mesi passati allo stato brado si era inselvatichito e non è stato facile
scovarlo. È stato sorpreso dopo una battuta di ore da parte della Polizia provinciale e
dei vigili. Una fucilata alla testa, sparata da 20 metri lo ha fermato per sempre. Per la
popolazione è come la fine di un incubo. Il fuggitivo era diventato un po’ una leggen-
da metropolitana, per il suo continuo apparire e sparire da una parte all’altra del terri-
torio piombinese. Per tutti questi mesi la povera bestia ha vagato per le campagne del
paese, segnalata dall’intera cittadinanza. Dormiva e mangiava all’interno dei campi
incolti di mais. Parecchi avevano tentato di prenderlo, finché il primo cittadino gio-
vedì ha emesso un’ordinanza di cattura e abbattimento [...]. La carcassa dell’animale
è stata recuperata e portata in un macello, fatto aprire appositamente per riceverla3.
Probabilmente, nelle intenzioni dellʼautrice di questo articolo di cronaca, parole
come «latitanza» hanno un sapore folkloristico. Sarebbero una specie di metafo-
ra di una situazione umana, quella del prigioniero che evade dal carcere o dello
schiavo fuggiasco. In realtà, esse non sono altro che la descrizione letterale degli
avvenimenti, tanto che le autorità locali hanno emesso unʼordinanza di cattura. Ma
perché, ogni volta che un animale evade da uno zoo, da un circo o da un alleva-
mento, le parole che meglio descrivono quanto accaduto suonano folkloristiche?
Sembra quasi che, anziché dei fatti di cronaca, vengano descritti degli aneddoti.
A dispetto delle parole usate, nessuno prende sul serio questi atti di ribellione: del
resto, lʼesito è quasi sempre fallimentare. E non potrebbe essere altrimenti, in un
2 Oltre ai testi citati nel seguito dell'articolo, può essere utile consultare la pagina dei materiali del
blog «Resistenza Animale», http://resistenzanimale.noblogs.org/materiali/, in particolare: Melanie
Bujok, «La resistenza contro lo sfruttamento animale», in Massimo Filippi e Filippo Trasatti (a cura
di), Nell’Albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia, Mimesis, Milano 2010,
pp. 239-261; Matthew Calarco, «Di fronte al volto animale», in M. Filippi e F. Trasatti (a cura di),
Nell’albergo di Adamo, cit. pp. 105-128; M. Filippi e F. Trasatti, «Toc toc», in Crimini in tempo di
pace. La questione animale e l’ideologia del dominio, Elèuthera, Milano 2013, pp. 242-251; Jason C.
Hribal, «Animals Are Part of the Working Class: a Challenge to Labor History», in «Labor History»,
vol. 44, n. 4, 2003, pp. 435-453; Id., «Animal, Agency, and Class», in «Human Ecology Review»,
vol. 14, n. 1, 2007, pp. 101-112; Eva Meijer, «La comunicazione politica con gli animali», in que-
sto stesso numero della rivista; Agnese Pignataro, «La question animale: un débat à ouvrir dans le
mouvement anticapitaliste», in «Contretemps» (http://www.contretemps.eu/interventions/question-
animale-debat-ouvrir-dans-mouvement-anticapitaliste).
3 Giusy Andreoli, «Torello abbattuto dopo sei mesi di latitanza», ne «Il Mattino di Padova», 27
marzo 2010.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 45
contesto in cui gli umani e le loro istituzioni si schierano compatti a sedare ogni
tentativo di ribellione che maturi laddove il controllo sui corpi talvolta si allenta.
Nei grandi allevamenti intensivi, infatti, non cʼè generalmente spazio per l’op-
posizione: i corpi sono disciplinati strettamente sul piano fisico e psicologico, a
partire dalla selezione genetica come mezzo per “promuovereˮ nella produzione
gli individui più docili. La resistenza, come vedremo, si esprime in questi casi
soprattutto come resistenza passiva, come inazione, come non collaborazione: gli
schiavi si lasciano morire, si colpiscono fra loro, talvolta uccidono i propri cuccio-
li. Nei piccoli allevamenti, quando si apre qualche falla, come nel caso citato, è il
contesto generale a incaricarsi di decretare non solo l'insuccesso, ma addirittura la
non esistenza della rivolta animale.
Diversi dispositivi operano in tal senso, al di là delle intenzioni coscienti di noi
umani. Chi, grazie a un incidente, riesce a scappare dal camion che lo sta portando
al macello, trova intorno a sé, per prima cosa, un territorio a misura dʼuomo, ina-
datto alla sua sopravvivenza, un territorio esclusivamente funzionale alla comunità
umana in ogni suo metro quadro, dalle strade asfaltate con tutte le loro barriere e
le automobili lanciate ad alta velocità allʼinacessibilità delle risorse primarie come
le fonti di acqua e di cibo, recintate, privatizzate, cementificate. Dovrà poi fare i
conti con la densità abitativa umana, talmente elevata da implicare un potenziale
di vigilanza e controllo capillare (pressoché assoluto) sui latitanti. Senza contare
la selezione genetica e lʼabitudine alla cattività... Gli animali “da redditoˮ sono di
norma meno adatti dei loro progenitori alla vita selvatica e, al di fuori delle struttu-
re gestite dagli umani, raramente sono in grado di sopravvivere: oltre i loro recinti
non troveranno libere comunità di membri della loro specie, poiché la loro specie
esiste soltanto negli allevamenti; troveranno, anche fuori dalle città, un ambiente
inadatto alle loro caratteristiche motorie, sensoriali, cognitive ed etologiche. Se
questi dispositivi non funzionano o funzionano in modo insufficiente, interviene la
repressione delle istituzioni umane, un meccanismo che si innesca a partire dalla
necessità di tutelare lʼincolumità pubblica nell'immediato (pericoli di incidenti
stradali, danni alle colture, allarme sociale, ecc.), ma che di fatto agisce ricaccian-
do nella sfera dell'inesistenza i tentativi di evasione.
USA: elefantessa confinata allo zoo da 23 anni uccide il suo custode. Si chiama
Patience e ha 41 anni l’elefantessa che alcuni giorni fa ha ucciso il suo custode allo
zoo di Springfield, nel Missouri. Patience era stata catturata in natura nel 1990 e strap-
pata a suo figlio che all’epoca aveva soltanto diciotto mesi di età [...]. Patience ha uc-
ciso il suo trainer mentre questi cercava di spingerla lungo il corridoio che l’avrebbe
portata all’esterno del suo recinto. L’elefantessa ha dapprima tentato una opposizione
passiva, fermandosi e rifiutandosi di camminare, divenendo infine aggressiva quando
Bradford ha cercato di forzarla. A quel punto, il pachiderma ha colpito l’uomo con46 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
la sua proboscide e lo ha schiacciato al suolo, uccidendolo all’istante prima di essere
allontanata da altri dipendenti della struttura4.
Negli zoo e nei circhi, gli episodi di evasione e di aggressione ai danni di guar-
diani e addestratori sono molto frequenti. La selezione genetica non opera come
negli allevamenti alimentari: qui i reclusi sono spesso nati nel loro habitat e cat-
turati successivamente e pertanto, conservano la loro cultura di selvatici. Anche
quando nascono in cattività non sono stati selezionati per essere docili. Se così non
fosse, circhi e zoo perderebbero il fascino della pornografia e della dominazione
della belva. Non a caso, nei circhi gli animali svolgono i propri compiti dopo uno
specifico addestramento, ed è appunto a questo addestramento, oltre che alla pri-
gionia in sé, che si ribellano.
Alcuni di questi schiavi si ribellano a più riprese, spesso fino allʼabbattimento
da parte dei proprietari o delle autorità. È il caso di Tatiana, una tigre siberiana pri-
gioniera dello zoo di San Francisco che nel 2006 ha aggredito un custode, nel 2007
alcuni visitatori che lʼavevano provocata; dopo essere stata uccisa dalla polizia, è
diventata un simbolo della lotta contro gli zoo. L’artista Jon Engdahl le ha dedicato
una scultura, collocata in città senza il permesso delle autorità, mentre i quattro
ufficiali della squadra di polizia che hanno ucciso Tatiana sono stati premiati per il
coraggio da parte della Commissione di Polizia di San Francisco5.
Un caso altrettanto celebre è quello di Tyke, elefantessa detenuta nel circo in-
ternazionale di Honolulu. Tyke, sottoposta ad addestramento per anni, evade una
prima volta nellʼaprile del 1993. Due mesi dopo si ribella e calpesta il suo adde-
stratore. Nell'agosto del 1994, durante uno spettacolo, lo aggredisce a morte e
ferisce altre due persone mentre si dà alla fuga. Viene giustiziata dalla polizia con
86 colpi: muore dopo due ore di agonia. Anche Tyke è diventata un simbolo dei
diritti animali; in seguito alla sua uccisione, sono state aperte diverse cause legali
contro i proprietari del circo per maltrattamento e al suo caso si sono ispirate di-
verse proposte di regolamentazione delle attività circensi nelle Hawaii e in altri
Stati americani6.
Questi episodi sono quelli che, a volte, raggiungono il grande pubblico, perché
creano pericoli concreti alla popolazione umana o perché presentano dei caratteri
insoliti - folkloristici, appunto - che richiamano lʼinteresse della stampa. Ma è
4 «All4animals», 30 ottobre 2013, http://www.all4animals.it/2013/10/30/usa-elefantessa-confina-
ta-allo-zoo-da-23-anni-uccide-il-suo-custode/.
5 «S.Francisco: tigre fugge da zoo, un morto», in «Corriere.it», 26 dicembre 2007; Jordan Ro-
bertson, «San Francisco Zoo Closed After Tiger Killed Visitor», in «National Geographic», 26 di-
cembre 2007; https://resistenzanimale.noblogs.org/post/2013/12/21/un-falo-in-riva-alloceano-per-
ricordare-tatiana/.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Tyke_(elephant).Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 47
presumibile che queste e altre forme di resistenza si verifichino quotidianamente
allʼinterno dei luoghi di sfruttamento. Ad esempio, mucche e maiali si rifiutano
di essere trascinati verso il mattatoio: tirando nella direzione opposta agli opera-
tori umani attuano non solo quella che viene comunemente chiamata resistenza
passiva, ma comunicano anche in modo inequivocabile la comprensione, almeno
parziale, della situazione, il terrore e lʼopposizione al destino che li attende. È
probabile inoltre che la storia degli allevamenti sia costellata da atti di resistenza
più o meno efficaci alle sue pratiche quotidiane, come la separazione dei figli dalle
madri, la fecondazione (stupro) delle femmine, lʼalimentazione forzata.
[Le mucche] lavoravano e producevano. Resistevano e lottavano. Negoziavano con
gli umani le modalità e i limiti del loro sfruttamento. Gli animali stessi erano una
forza nel processo di cambiamento sociale. Simulare incapacità, disobbedire agli or-
dini, rallentare, trascinare i piedi, rifiutare di lavorare senza ricevere un’adeguata
alimentazione, rifiutarsi di lavorare nelle ore più calde, prendersi delle pause senza
permesso, opporsi agli straordinari, protestare facendo sentire la propria voce, com-
piere apertamente o di nascosto piccoli furti, rifiutare seccamente di eseguire compiti
nuovi, fingere obbedienza, distruggere le macchine del sistema produttivo, fuggire,
scontrarsi apertamente: queste sono tutte azioni che fanno parte di quelle che l’an-
tropologo James C. Scott ha chiamato «le armi dei deboli». Anche se raramente si
trattava di azioni organizzate da un punto di vista progettuale ed esecutivo, tali azioni
erano comunque molto conflittuali e, occasionalmente, potevano avere successo [...].
Storicamente, queste forme quotidiane di resistenza non sono state prerogativa della
specie umana, dato che ciascuno dei metodi di cui si è detto è stato utilizzato anche da
altri animali. Gli asini ignoravano gli ordini. I muli trascinavano gli zoccoli. I buoi ri-
fiutavano di lavorare. I cavalli distruggevano l’equipaggiamento. I polli beccavano le
mani degli addetti. Le mucche prendevano gli allevatori a calci nei denti. I maiali fug-
givano dai recinti. I cani rubavano il cibo. Le pecore saltavano le recinzioni. Inoltre,
tutti questi atti di resistenza sono stati pienamente riconosciuti dagli allevatori, dai
proprietari, dai supervisori o dai gestori come tali: atti di resistenza7.
Nei laboratori, lʼevasione o la ribellione da parte delle cavie sono difficilissime,
ma nonostante questo esistono forme anche molto sofisticate di vero e proprio sa-
botaggio dei dispositivi violenti di ricerca, talvolta persino coronate dal successo:
Qualche anno fa gli skinneriani americani, che avevano vagamente appreso l’esisten-
za di altri uccelli oltre all'eterno piccione, hanno cercato di sostituirlo con il corvo
imperiale. Senza successo. Il corvo imperiale, che trovava la situazione nella scatola
7 J. C. Hribal, «Animals, Agency, and Class», cit., p. 103.48 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
di Skinner profondamente assurda, non voleva assolutamente premere le leve al co-
mando di lampadine che si accendevano o di qualsiasi altro segnale. Invece, con il
suo enorme becco, si dedicava con successo a smantellare lʼapparecchiatura. Questo
comportamento fu giudicato unamerican e tutti tornarono ai piccioni8.
Rivoluzione, fra virgolette
Per anni costretti a terribili sofferenze. Rinchiusi in gabbie strette, senza potersi muo-
vere, tenuti in vita per vedere estratta la propria bile ritenuta utile per la medicina tra-
dizionale locale. È quanto capita in Cina a circa 12mila orsi, anche per ventʼanni, sin
quando la morte non li libera da quell'inferno voluto e gestito dallʼuomo. Una soffe-
renza troppo grande per permettere che accada al proprio cucciolo. Così unʼorsa deci-
de per il gesto estremo: uccidere il proprio piccolo per poi togliersi la vita. Lʼepisodio
è raccontato, in anonimato, da uno degli operai di queste “fabbriche della bileˮ: «Il
cucciolo stava piangendo - riporta il portale cinese Reminbao.com - mentre gli stava-
mo inserendo la cannula da cui estraiamo la bile, quando la madre è riuscita a liberar-
si dalla gabbia in cui era tenuta». Pochi istanti, ma sufficienti allʼorsa per raggiungere
il proprio piccolo e tentare di liberarlo dalla catena. Non riuscendoci, la madre decide
così di soffocarlo con un abbraccio. Dopo quel gesto estremo, lʼanimale adulto si è
scagliato a testa bassa contro un muro ponendo fine anche al suo inferno. Un gesto
dʼamore, un gesto di disperazione, che da solo spiega, meglio di tante immagini,
questa pratica che continua a persistere nonostante le proteste internazionali. Una
battaglia che dura da molto tempo: in passato gli orsi venivano catturati e uccisi, poi,
di fronte a una legge che ne vietava la soppressione, la terribile decisione di tenerli in
vita nelle gabbie. Molti orsi, sottoposti ai terribili dolori, dovuti alle infezioni e ai tu-
mori che derivano dalle condizioni in cui vivono, impazziscono, tentano di uccidersi
o di strapparsi via quel tubo9.
In questo caso, non cʼè molto da aggiungere: persino i giornalisti hanno usato
espressioni adeguate. Di norma, però, nelle “fabbriche della bileˮ non è data agli
orsi neppure l'occasione di togliersi la vita in modo attivo. Lʼunica cosa che resta
loro è quindi scegliere di non mangiare, fino a lasciarsi morire:
«Meglio morire che vivere in gabbia»: e gli animali, costretti in condizioni terribili, si
ribellano come possono. In Cina alcuni orsi hanno iniziato uno “sciopero della fame”
8 Remy Chauvin, Le Modèle animal, Hachette, Parigi 1982, p. 138, cit. in V. Despret, Quando il
lupo vivrà con l’agnello, cit., p. 169 (traduzione lievemente modificata).
9 Fulvio Cerutti, «Cina, una “orsa della bileˮ uccide il proprio cucciolo e poi si suicida», in «La-
stampa.it», 15 agosto 2011.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 49
per protestare contro le torture a cui sono sottoposti ogni giorno. Ne parla il Daily
Mail [...]. Visto le dimensioni della loro prigione, praticamente non si muovono, e
passano quasi tutta la loro esistenza sul dorso. Per questo motivo gli animali hanno
scelto di fare uno “sciopero della fame”. Meglio il suicidio per loro che continuare
con questa esistenza: e così alcuni esemplari, come denunciano gli animalisti, hanno
“deciso” di lasciarsi morire10.
Nonostante la profusione di virgolette, a ricordarci che gli animali non fan-
no scioperi della fame e non prendono decisioni in senso stretto, chiunque può
comprendere il significato di azioni come questa, anche grazie all'analogia con le
forme di lotta più estreme che si verificano nelle carceri o nei centri di permanenza
per migranti. Certamente, in questi ambiti lo sciopero della fame si caratterizza per
la propria natura rivendicativa: è preceduto da richieste esplicite e termina o con il
loro accoglimento o con una negoziazione. La richiesta degli orsi della bile non è
formulata nel linguaggio umano, ma è facilmente comprensibile. Gli orsi chiedono
la liberazione e sono evidentemente pronti a interrompere la lotta qualora questa
venisse loro concessa. Si potrebbe dire che esiste una differenza decisiva fra chie-
dere e "chiedere", fra rivendicare e "rivendicare", fra scioperare e "scioperare".
Ma quanto è decisiva questa differenza? E in che cosa consiste? La differenza più
macroscopica riguarda il linguaggio con cui le richieste sono formulate, ma questo
aspetto, a ben vedere, non è poi così rilevante: almeno in molti casi, è possibile
comprendere chiaramente le richieste formulate anche in linguaggi che non sono
il nostro. Le differenze più significative sono in realtà altre. Quando si pensa a una
rivendicazione politica, si pensa solitamente a un soggetto individuale ben definito
e che sia consapevole di fare una richiesta intenzionale diretta a un interlocutore
preciso. Si pensa anche qualcosa d’altro e cioè che questo soggetto abbia un'idea,
magari vaga, del processo che la sua richiesta attiverà, di alcuni dei suoi possibili
sviluppi ed esiti. Ma la natura rivendicativa di un'azione dovrebbe essere giudicata
dagli effetti che è potenzialmente in grado di produrre sugli interlocutori esistenti,
non solo su quelli che il soggetto è intenzionato a raggiungere. Le proteste umane,
del resto, possono smuovere forze ben al di là degli intenti originari e non per que-
sto cambiamo idea sul loro carattere rivendicativo. Così, anche ammettendo che il
disagio degli orsi della bile non sia coscientemente rivolto a qualcuno, esso costi-
tuisce una richiesta che può essere accolta come tale dai soggetti capaci di porsi in
ascolto, come ad esempio le associazioni per i diritti animali.
A ben vedere, pensiamo sempre al movimento animalista come alla
10 Maghdi Abo Abia, «Gli orsi torturati che fanno lo sciopero della fame», in, «Giornalettismo.
com», 3 febbraio 2012; cfr. Suzannah Hills, «Bears Kept in Tiny Cages by Chinese for their Bile
'Commit Suicide' with Hunger Strikes to Escape Barbaric Torture», in «Daily Mail», 3 febbraio
2012.50 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
manifestazione di una sensibilità che si è sviluppata e cresciuta negli ultimi due
secoli, ignorando però il ruolo giocato dalle proteste degli animali nello sviluppo
di tale sensibilità. Eppure le richieste di mobilitazione formulate dagli animali
vengono continuamente riprodotte e diffuse dalla propaganda animalista. Molti
video e molti siti web mostrano visoni detenuti negli allevamenti da pelliccia che
si procurano lesioni e che girano incessantemente in tondo nelle gabbie. Lasciano
cioè che siano gli stessi animali a raccontarci come si sentono, con lʼunico stru-
mento a disposizione: il loro corpo e in alcuni casi addirittura la malattia. Tuttavia,
nel fare questo, raramente il movimento animalista è consapevole di dare visibilità
alle proteste degli animali; spesso, al contrario, utilizza queste immagini come
semplici elementi di denuncia delle condizioni di vita negli allevamenti.
I detenuti di altre specie, come quelli umani, non si limitano a comunicare la
propria sofferenza e a richiedere ai membri della società umana di attivarsi insieme
a loro. Come abbiamo visto, si ribellano, lottano, evadono. Anche le liberazioni
ALF sono solitamente raccontate come situazioni in cui lʼumano fa la parte del
liberatore attivo mentre lʼanimale è la vittima che, come ha subito passivamente la
tortura, così accetta altrettanto passivamente la libertà. In realtà, il ruolo giocato ad
esempio dai visoni nelle azioni dell’ALF è tuttʼaltro che passivo. Si può dire anzi
che le liberazioni dei visoni altro non sono che la creazione di una situazione favo-
revole alla fuga degli stessi. Il ruolo attivo degli animali può sorprendere, talvolta,
gli stessi membri dell’ALF.
Molto interessante, a tal proposito, è la storia di Birba, un cane che si è tenace-
mente opposta a tutte le situazioni di vita in cui si è trovata (sempre alla catena)
finché non ha indotto alcune persone a liberarla e a trovarle un’adozione. Birba
è molto emotiva, abbaia molto, ma nonostante ciò quando sta per essere liberata
comprende che sta accadendo qualcosa di positivo per lei e collabora:
Birba ci sente, ci vede nel buio. Riconosce Emma e me. Capisce al volo. Anche se
non conosce gli altri due amici sa che può fidarsi (incredibile perché Birba si rivelerà
un cane molto diffidente e tutt’ora abbaia a chiunque: di piacere se conosce bene la
persona, di paura se diffida. È davvero eccessivamente rumorosa). Il signore con un
filo di ferro aveva stretto il suo collare così che non potesse più sfilarselo. Noi ci
avviciniamo a lei, la sleghiamo, e lei, silenziosissima e scodinzolante, come in punta
di piedi e come fosse la cosa più ovvia del mondo seguire quattro sconosciuti alle
quattro di notte, senza un gemito, senza un rumore, ci viene dietro nella neve alta11.
11 «Birba, un cane che ha collaborato alla propria liberazione», in «Resistenzanimale.noblogs.org»,
15 gennaio 2014, http://resistenzanimale.noblogs.org/post/2014/01/15/birba-un-cane-che-ha-colla-
borato-alla-propria-liberazione/.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 51
Ribellione o rivoluzione?
Eppure, gli animali […] resistono. La resistenza animale all’annientamento non con-
siste tanto, o non solo, nelle concrete ribellioni, fughe, o morti per inedia, di cui sono
protagonisti alcuni degli animali a noi sottomessi. Gli animali resistono anche, o
soprattutto, nella loro intatta ed insistente capacità di ispirare in noi - in una società
che ci ha alienati da loro al massimo grado - interesse, sollecitudine nei loro con-
fronti, desiderio di creare spazi di condivisione. Questi animali ci accompagnano
dagli albori della nostra storia in modi e forme che non si limitano all’annullamento
dell’animale in nome di una cieca «volontà di dominio» umana, ma racchiudono
anche un senso di prossimità profondo nel comune essere al mondo, nel respirare,
percepire, tessere legami affettivi con i propri simili; nell’essere infine consegnati
ad un comune destino di caducità. Animali e umani formano insieme una comunità
multispecifica. Inoltre, a quegli umani che sono oppressi da altri umani, gli animali
ispirano solidarietà sulla base di comuni esperienze di sofferenza e costrizione (nel
caso delle donne, ad esempio, la riduzione del Sé al proprio corpo organico operata
dalla società, la denigrazione ontologica, la manipolazione scientifica)12.
Molte persone - anche animaliste - quando si parla degli atti di resistenza ani-
male, tendono a riprodurre alcune dicotomie tipiche della politica umana: insurre-
zione/rivoluzione, spontaneismo/organizzazione, e così via. Solo la specie umana
sembra poter entrare in questa dialettica, poiché le altre paiono essere inchiodate
a una natura immutabile in cui non cʼè spazio per nulla di più di qualche moto di
ribellione individuale ed estemporaneo. Come sempre, la dimensione culturale
è «roba da uomini». Non è corretto, in realtà, parlare di capacità organizzative
degli “animali non umani”, mettendo in un unico calderone tutte le specie diverse
dalla nostra. Le caratteristiche cognitive e comportamentali variano notevolmente
da specie a specie e da individuo a individuo, e così le capacità di organizzare la
resistenza al dominio:
Che gli animali non amino la vita in cattività non è un mistero; che la loro avversione
arrivi al punto di spingerli a pianificare, progettare e organizzare la fuga da uno zoo
è, invece, una novità. Il fatto è accaduto a qualche migliaio di chilometri dal nostro
Paese, in Cina. Come ogni giorno il custode era entrato nella gabbia degli animali per
le pulizie quotidiane mentre una folla di curiosi si accalcava contro i vetri del recin-
to. Scene di ordinaria cattività: gli animali che si aggirano, ciondolanti e sconsolati,
12 A. Pignataro, «Chi sono le donne? Chi sono gli animali? Economie dei corpi e politiche degli
affetti», abstract dell’intervento al Blog feminist camp il 29 ottobre 2011, http://www.womenews.
net/spip3/spip.php?article9336.52 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
tra i pochi metri quadrati del loro box; il vociare confuso e indistinto dei visitatori;
l'incedere guardingo del custode. Poi accade lʼimprevedibile. Un panda lentamente
si avvicina all'uomo, si sdraia sulla schiena e attira lʼattenzione del guardiano che,
intimorito, lo allontana allungando una mano e abbozzando una carezza. Un altro
animale, accortosi della manovra diversiva del suo “compliceˮ, si avvicina allʼentrata
della gabbia, allunga una zampa, apre la porta e si dà alla fuga. Una veloce occhiata
allʼingresso del recinto, un sornione scatto di reni e anche il “compliceˮ guadagna la
via dellʼuscita. Lʼincedere, dapprima lento e goffo, diventa una vera e propria corsa
quando lʼanimale capisce di essere inseguito dal custode. Unʼaltra zampata… e, tra lo
stupore di tutti i presenti, anche il secondo panda esce dalla prigione13.
Con ciò non si deve pensare che si tratti di un mero fatto biologico o di diffe-
renze etologiche fra una specie e l'altra, senza considerare il ruolo giocato dalle
diverse culture allʼinterno della stessa specie:
Pochi giorni dopo che una loro simile era rimasta uccisa dal laccio di un bracconie-
re, due giovani gorilla di montagna si sono coalizzati per individuare e distruggere
le trappole piazzate nella foresta ruandese dove vivono: lo rivelano gli studiosi del
Karisoke Research Center della fondazione Dian Fossey, che hanno assistito alla sce-
na, riferendo un comportamento mai osservato prima [...]. Qualche giorno fa, rac-
conta Vecellio, il battitore John Ndayambaje aveva individuato una trappola molto
vicina al clan di gorilla Kuryama; si è avvicinato per disattivarla ma un silverback
di nome Vubu gli ha fatto capire che era meglio stare alla larga. A un certo punto
due gorilla, Rwema, un maschio, e Dukore, una femmina, entrambi sui quattro anni,
si sono messi a correre verso la trappola. Sotto gli occhi di Ndayambaje e di alcuni
turisti, Rwema è saltato sul ramo piegato e lʼha spezzato, mentre Dukore liberava il
cappio. I due hanno poi individuato nelle vicinanze unʼaltra trappola, sfuggita anche
al battitore, e ci si sono fiondati sopra assieme a un terzo gorilla, un giovane di nome
Tetero, distruggendo anche quella [...]. La rapidità con cui è accaduto il tutto ha fatto
pensare a Vecellio che non fosse la prima volta che i gorilla superavano in astuzia i
bracconieri. «Sembravano molto sicuri del fatto loro», racconta. «Hanno visto cosa
cʼera da fare, lʼhanno fatto e se ne sono andati»14.
Ad ogni modo, non si capisce perché, quando si tratta di animali, contrapposi-
zioni come quella fra pianificazione rivoluzionaria e spontaneismo debbano essere
riproposte in termini ottocenteschi, così dogmatici da risultare superati da tempo
13 ENPA Catania, «Archivio generale notizie 2009», http://www.enpacatania.it/archivio_notizie_
naz09.htm.
14 Ker Than, « Due piccoli gorilla distruggono le trappole dei bracconieri», in «National Geogra-
phic Italia», 23 luglio 2012.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 53
anche nelle pratiche di resistenza umana:
Si crede facilmente che chiedere a delle esperienze, a delle azioni, strategie, progetti
di tener conto dellʼ“insieme della societàˮ sia chiedere loro il minimo; il minimo
richiesto per esistere. Io penso al contrario che sia chiedere loro il massimo; che sia
anzi imporre loro una condizione impossibile: poiché lʼ“insieme della societàˮ fun-
ziona precisamente in modo e perché essi non possano né aver luogo, né riuscire, né
perpetuarsi15.
Le definizioni classiche di cosa sia “rivoluzione”, di cosa sia un “processo ri-
voluzionario” o di cosa sia una “strategia rivoluzionaria” sono formulate in modo
da escludere gli animali e, in realtà, anche in modo da escludere la possibilità di
uno stravolgimento profondo e reale che si affranchi dallʼesigenza di tenere conto
dellʼinsieme monolitico della società. Questo significa partire dalla resistenza ani-
male considerata come atto politico e, al tempo stesso, lavorare per lʼampliamento
dellʼambito della critica al di là delle intenzioni dei singoli ribelli.
Nel concetto stesso di “resistenza” si nasconde una tautologia. Dato che la re-
sistenza viene considerata un fenomeno umano - anzi, di alcune categorie umane
in alcune situazioni -, viene definito in modo da implicare delle precise caratteri-
stiche: intenzionalità, consapevolezza, consapevolezza degli obiettivi della lotta,
consapevolezza di ciò che si va a colpire, individuazione di un interlocutore nel
conflitto e, in molti casi, perfino organizzazione collettiva e pianificazione stra-
tegica. Qualora ci si chiedesse se un atto compiuto da un animale non umano (o
anche da un umano che non fa parte dei potenziali ribelli) sia un atto di resistenza,
mancherebbero sempre alcune di quelle caratteristiche. Siccome certe forme di
sfruttamento hanno raggiunto un tale livello di controllo da non lasciare spazio alla
consapevolezza di ciò che sta accadendo, esistono ambiti di sfruttamento a cui per
definizione non è possibile resistere (si tratta peraltro delle condizioni più dure). In
sostanza, la resistenza è per definizione appannaggio di alcuni e sostenere che gli
animali non possono ribellarsi diventa una mera tautologia. In quanto tautologia,
riveste un interesse prettamente lessicale, ma non ha rilevanza politica: o ci si in-
venta un'altra parola per definire la resistenza - che pure esiste - di tutti coloro che
non sono ammessi nella “resistenza”, oppure si ridefinisce la resistenza in modo
meno ristretto. La prima soluzione ha come unica utilità quella di riconfermare il
nostro posto al centro del mondo.
15 Michel Foucault, «Al di là del bene e del male», in Microfisica del potere, trad. it. di A. Fontana e
P. Pasquino Einaudi, Torino 1977, p. 69.54 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
Ribellione e biopotere
Ogni forma di resistenza genera delle contromosse e questo vale evidentemente
anche per la resistenza che gli animali hanno opposto allo sfruttamento umano.
Lʼaffinarsi delle tecniche di irreggimentazione, di reclusione e di riproduzione
forzata va considerato principalmente come una risposta, o una serie di risposte,
allʼinsubordinazione quotidiana dei non umani, analogamente a quanto è accaduto
nellʼambito della schiavitù e del lavoro salariato16. Secondo Jason Hribal, la nasci-
ta e lo sviluppo del capitalismo si intrecciano strettamente con questa dialettica fra
resistenza animale e progresso della zootecnia:
In risposta a questa resistenza, i proprietari e i gestori degli allevamenti, delle fattorie e
di altre aziende del diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo secolo svilupparo-
no, perfezionarono e standardizzarono diversi strumenti e metodi. Vennero eretti recinti
e siepi per impedire le fughe. Gioghi di legno triangolari vennero posizionati sul collo
per ostacolare il movimento. Vennero legati zoccoli rigidi intorno alle zampe posteriori
per impedire il salto o la corsa. Alcuni allevatori recidevano addirittura i tendini di que-
sti lavoratori. Altri tagliavano le ali dei polli, dei tacchini e delle oche per impedirne il
volo e altri ancora accecavano gli animali con un “ferro da maglia roventeˮ. Se queste
misure fallivano, ce n’erano di ulteriori. Vennero costruiti dei luoghi di detenzione per
gli animali catturati. Le marchiature all'orecchio e i tatuaggi vennero usati sempre più
come mezzi di identificazione e gli anelli al naso impedivano ai fuggiaschi, soprattutto
maiali, di scavare nei campi. È significativo che verso la fine del Settecento la maggior
parte delle circoscrizioni e delle municipalità coloniali approvarono leggi che prescri-
vevano l'uso di molte di queste tecniche. Per controllare comportamenti più perico-
losi, vennero sviluppati ulteriori strumenti preventivi. Vennero migliorati dispositivi
rozzi, come lo sperone, le briglie e il morso, il frustino o la frusta per i buoi. A metà
del Seicento ebbero grande diffusione i manuali di addestramento all’arte di domare
i cavalli. Anche le pratiche del gelding (castrazione) e dello spaying (ovariectomia)
acquisirono popolarità in questo periodo e, a partire dalla metà del diciannovesimo
secolo, sarebbero diventate procedure standard. Significativamente, queste operazioni
chirurgiche non si limitavano a privare gli animali delle loro capacità riproduttive ma,
come sottolineavano sempre i loro promotori, riducevano la forza e il vigore dei lavo-
ratori “problematici”. Analogamente, la rimozione delle corna (o “umiliazione”, come
veniva pubblicizzata) sarebbe diventata un’operazione standard a partire dalla metà
del diciannovesimo secolo. E ancora: se queste misure ulteriori fallivano, esisteva una
16 Anche se, ovviamente, altri fattori hanno giocato un ruolo importante (ad es., la ricerca di una
maggiore produttività).Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 55
soluzione definitiva, e cioè la pena capitale17.
Anche la selezione genetica è stata un mezzo per piegare la propensione alla
fuga o alla ribellione: storicamente, tramite lʼincrocio controllato; più recentemen-
te, tramite le tecniche di ingegneria genetica. Se diamo uno sguardo, ad esempio,
alle caratteristiche delle razze di cavalli commercializzati, troviamo una ricorrente
enfasi sulla loro docilità e affidabilità. Ma questo vale anche per altri animali “da
reddito”, come i bovini e i suini. Per quanto riguarda le razze canine, sembra quasi
una banalità ricordare come siano state selezionate con un occhio, fra le altre cose,
alla loro propensione all'obbedienza. Quello che gli industriali di oggi trovano in
alcuni Paesi in termini di debolezza della forza contrattuale della manodopera, gli
allevatori l'hanno trovato nel DNA.
Lo spettacolo della rivolta
Le loro fughe dal macello non erano solo fughe fisiche, ma anche concettuali, mo-
menti di rottura della routine in un sistema di uccisione altrimenti automatizzato e
normalizzato. Lo sterminio e l’elevazione a celebrità (non dissimile dal rituale della
grazia presidenziale al tacchino del Giorno del Ringraziamento) sono entrambi modi
per contenere la minaccia rappresentata da questi momenti di rottura concettuale18.
Nonostante tutto ciò, gli animali si ribellano ancora oggi, come abbiamo visto.
Per i settori legati alle produzioni animali è importante che nessuno si renda conto
del carattere di resistenza di questi atti. Del dissenso prodotto dagli animali non si
deve parlare.
Quando, però, si è costretti a parlarne pubblicamente è spesso possibile offrire
una descrizione dei fatti in grado di stravolgerne il senso. Lʼuccisione dei propri
cuccioli da parte dei genitori viene trattata come una forma di grave malattia men-
tale, che sfocia nell'infanticidio, mentre in molti casi si tratta di una vera e propria
eutanasia che rappresenta una risposta sana a un trattamento malato. Quando si
dice che un cavallo è «imbizzarrito» si sta dicendo che è diventato bizzarro, strano,
deviante. Anche in questo caso, non cʼè nulla di più sano di questa protesta. A ben
vedere, anche i comportamenti aggressivi e autolesionisti delle galline ovaiole sono
risposte a una situazione patologica. Certamente, si tratta di vere e proprie malattie
17 J. C. Hribal, «Animals are Part of the Working Class», cit., pp. 449-450.
18 Avi Solomon, «Working Undercover in a Slaughterhouse: an Interview with Timothy Pachirat»,
in «Boingboing.net», 8 marzo 2012, trad. it. in «Lavorando in incognito in un macello: un’intervista
con Timothy Pachirat», http://neuroneproteso.wordpress.com/2012/03/10/lavorando-in-incognito-
in-un-macello-un-intervista-con-timothy-pachirat/.56 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
mentali, ma non si vede perché questo debba annullarne il portato di resistenza,
tanto più che nella pratica esse sono spesso antagoniste rispetto alla produttività, al
punto da generare la necessità di tecniche biopolitiche (zootecniche) ad hoc, come,
nel caso specifico, il debeccaggio delle galline. Volendo fare un passo oltre, anche
nelle malattie considerate strettamente fisiche è possibile rintracciare aspetti di re-
sistenza. Ad esempio, le mucche separate dai figli e munte a ritmi serrati tendono,
come è noto, a sviluppare diversi disturbi, anche gravi, come le mastiti, che vanno
a interferire con la produzione stessa. Anche in questo caso, una protesta che non
viene riconosciuta come tale per la mancanza di intenzionalità e di autocoscienza
può nella realtà produrre effetti che sono tipici delle forme di resistenza: la zoo-
tecnia, pur senza ammetterlo esplicitamente, è costretta a negoziare dei limiti a
una produttività che vorrebbe invece illimitata, riducendo i cicli riproduttivi e la
mungitura e, in generale, migliorando le condizioni di reclusione quanto basta per
preservare la vita della “merce”.
Infine, gli episodi di resistenza possono in alcuni casi essere addirittura amplifi-
cati. La sovraesposizione, unita alla spettacolarizzazione degli atti di rivolta, pro-
prio nel momento in cui fornisce loro il massimo della visibilità, li rende invisibili
sul piano del significato politico. Il caso di Yvonne è esemplare:
Continua la fuga della mucca Yvonne scappata a maggio da una piccola fattoria in
Germania. La ricerca del bovino bavarese amante della libertà ha ammaliato i tede-
schi, che seguono la vicenda con passione. Da maggio Yvonne riesce a nascondersi
con successo nelle foreste del sud della Germania e ogni tentativo di catturarla è
finora andato in fumo. Diversi residenti locali hanno detto di averla vista più volte,
ma quando le squadre impegnate a cercarla si recano sul luogo dell'avvistamento il
bovino marrone e bianco è già scomparso. Probabilmente la mucca non avrebbe mai
conquistato le prime pagine dei giornali nazionali se non fosse stato per un incidente
sventato. A pochi giorni dalla fuga, infatti, una macchina della polizia ha rischiato
di investirla su una stradina di campagna [...]. Da quando ha scelto la strada della
libertà [...] la mucca fuggiasca pascola leopardianamente sotto le stelle e si nasconde
di giorno19.
La “sempliceˮ fuga non fa notizia. È necessario un avvenimento bizzarro che
scateni la ricerca della latitante. E ancora non basta: cʼè bisogno di una caccia al
tesoro per far muovere la stampa; e una volta che la stampa si muove non è per
raccontare una storia di ribellione e di repressione, la storia di una lotta dagli esiti
incerti. I giornali parleranno invece di un divertente gioco infantile, in cui le guar-
die cercano rocambolescamente di acciuffare i ladri (solo che non si tratta di un
19 « Lʼincredibile avventura di Yvonne», in «L’unità.it», 22 agosto 2011.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 57 gioco, ma di una fuga per salvarsi la vita). Yvonne verrà catturata dopo tre mesi di latitanza e una strenua resistenza. Anche se la fine della storia sembra positiva, poiché Yvonne viene condotta in un rifugio, la sua fama produce unʼulteriore oc- casione di spettacolarizzazione della vicenda: da mucca evasa diventerà erede del polpo Paul, impiegata nellʼassurda mansione di prevedere lʼesito delle partite dei campionati europei di calcio20. È però intorno agli zoo e, soprattutto, ai circhi, che la resistenza animale diventa più facilmente spettacolo. Alcuni motivi sono abbastanza evidenti, altri forse un po' meno. In molti casi le evasioni e le aggressioni nei circhi e negli zoo hanno come protagonisti animali pericolosi, perché feroci o perché totalmente inadatti allʼambiente urbano. Il grave turbamento dellʼordine pubblico è di per sé una ga- ranzia di far notizia. Vi si aggiunga il fatto che i ribelli sono animali esotici, non per caso, ma perché le stesse regole di ingaggio lo prevedono: lo stesso esotismo che contribuisce a interessare lo spettatore dentro il tendone gioca un ruolo importante nellʼappassionarlo alla vista delle immagini della rivolta. Tuttavia, lʼelemento più importante e degno di riflessione è un altro. Le evasioni, gli sfondamenti delle transenne, gli sbranamenti dei domatori, le corse folli per le strade sono tutti atti di proseguimento dello spettacolo circense al di là del copione previsto. Si tratta, in fondo, di fuori programma che in qualche modo vengono prefigurati allo spet- tatore, come se lʼesibizione di una tigre che salta nel fuoco fosse già inserita in un patto implicito fra lʼaddestratore e il pubblico: «Questa belva è domata, potete sta- re tranquilli, ma non troppo, poiché è necessario che vi sia un brivido, che almeno potenzialmente possa uccidere o manifestare la sua indole selvatica nella fuga». Di fatto, questo si verifica raramente, ma quando accade viene riconfermata la possibilità dellʼevento; anzi, è necessario che talvolta accada. Chi andrebbe ancora a vedere una corrida se ogni tanto un toro non riuscisse a incornare il torero? Ma il circo non si riduce a uno spettacolo generico. È piuttosto la messa in sce- na del controllo dell'umano sul selvatico, che viene domato e dominato. Anche in questo consiste il suo fascino: nel rappresentare la sovranità della nostra specie. Se non ci fosse una resistenza, però, non si tratterebbe di dominio, bensì di semplice utilizzo. Come insegna Foucault, perché si abbia potere deve esserci la possibilità che l’oppresso si ribelli; le sporadiche situazioni in cui il potere fallisce sono lì a ricordarci (e a valorizzare) tutte le volte in cui si esercita in modo efficace. 20 Cfr. http://calciomalato.blogosfere.it/2012/06/euro-2012-mucca-yvonne-ecco-lerede-del-polpo- paul.html.
58 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
Lessico e nuvole
Gli oppressi lottano contro la lingua per riprendere possesso di se stessi, per ricono-
scersi, per riunirsi, per ricominciare. Le nostre parole sono azioni, resistenza21.
Che cosa significa prendere sul serio la resistenza animale? E che cosa significa,
concretamente, per il movimento di liberazione animale, lavorare insieme agli ani-
mali? Questo è, ovviamente, un territorio ancora tutto da esplorare, ma proveremo
comunque a fornire qualche spunto e a formulare qualche esempio a nostro avviso
utili alla prassi politica.
In primo luogo, si tratta di compiere uno sforzo per superare il paternalismo che
finora ha contraddistinto gran parte del movimento antispecista. Tale paternalismo,
come abbiamo visto, si è espresso soprattutto al livello della retorica: è dunque dal
cambiamento del modo di esprimersi che dovremmo iniziare. Ad esempio, anzi-
ché dire che «siamo la voce dei senza voce» dovremmo parlare in termini di «far
sentire la loro voce»; dovremmo fare molta attenzione anche a definire gli animali
come «i più deboli». Quando si parla dei comportamenti stereotipati e autolesio-
nisti dei reclusi dovremmo sottolineare lʼaspetto di resistenza, di dissenso in essi
contenuto. Nelle rivendicazioni ALF è importante che emerga la collaborazione
da parte degli animali, quando è presente. Di più: alcuni atti di ribellione senza il
concorso umano dovrebbero comparire fra le azioni ALF, poiché ne rispettano le
linee guida22.
Un diverso modo di esprimersi dovrebbe portarci a superare quellʼatteggiamento
per cui chi conduce la lotta animalista si sente moralmente superiore a chi si inte-
ressa di altre lotte e altri soggetti, secondo il luogo comune che fa della prima una
lotta completamente altruistica e di tutte le altre delle lotte “interessateˮ, poiché
chi le conduce lo farebbe per se stesso, mentre noi lo faremmo soltanto per loro.
Un linguaggio non paternalista potrebbe inoltre facilitare il riconoscimento delle
intersezioni fra le diverse lotte, aiutandoci a comprendere più profondamente la
nostra animalità e a evidenziare forme di solidarietà basate sul riconoscimento di
una oppressione comune23.
Il paternalismo è però anche unʼincapacità di cogliere i messaggi che arrivano
21 bell hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale, trad. it. di M. Nadotti, Feltri-
nelli, Milano 1998, p. 64.
22 Le linee guida che definiscono unʼazione come riconducibile allʼAnimal Liberation Front non
specificano se il liberatore debba appartenere alla specie umana o meno, né se il soggetto e lʼ“oggettoˮ
della liberazione debbano essere due persone diverse.
23 Un esempio utile può essere quello proposto da Barbara X in «Fuga per la sconfitta», maggio
2011 (http://www.antispecismo.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=89:fugaperlasconfit
ta), circa la possibilità per una donna trans di riconoscere la sofferenza e la ribellione degli animali
da macello a partire dalla propria condizione.Quando i maiali fanno la rivoluzione Proposte per un movimento antispecista non paternalista 59
dagli schiavi e, al tempo stesso, il proposito di mantenere saldamente in mano
lʼagenda politica da parte degli umani. Dal primo dei due aspetti forse derivano
anche alcune caratteristiche deleterie della zoofilia e del protezionismo: è perché
non li si è voluti ascoltare realmente che si è potuto sostenere, come è il caso di
Michela Vittoria Brambilla, che ogni cane ha diritto a un divano.
Il fatto che un movimento a prevalenza femminile esprima una visione paterna-
listica è qualcosa di interessante. La mobilitazione femminile nell’ambito dell’an-
tispecismo si può interpretare almeno in due modi. Il primo fa riferimento alla
visione che vuole le donne martiri, dotate di altruismo e spirito di sacrificio quasi
innati, tutti caratteri che si esprimerebbero in una marcata sensibilità ed emotività,
in una tendenza all'ascolto empatico, in una particolare attenzione ai più deboli e
alle loro sofferenze. Il secondo fa invece riferimento alla capacità di immedesi-
marsi nella condizione di oggetti di sfruttamento vissuta dagli animali, a partire
dalla propria condizione di subalternità. Si tratta di due spiegazioni molto diverse,
ma sembra che sia all'interno del movimento animalista che fra i suoi detrattori
prevalga la prima. Se ci chiediamo il perché di quanto appena detto, unʼipotesi
da approfondire potrebbe essere la seguente: la prima visione si impone perché la
narrazione dominante è connotata in senso maschile, indipendentemente da chi la
elabora. Interpretare la mobilitazione femminile come intrinsecamente altruistica
sostiene proprio una visione paternalistica: agli animali ci si dedica perché si è
votati all'amore disinteressato. La seconda interpretazione invece contrasta aper-
tamente un paternalismo che ha cause più lontane: le difficoltà di comunicazione
fra la specie umana e le altre specie; la volontà degli umani di mantenere una
posizione di privilegio rispetto agli animali anche allʼinterno di una lotta in loro
favore; le condizioni di controllo biopolitico degli animali che come abbiamo visto
ne rendono estremamente difficile la ribellione.
Un progetto politico per la resistenza animale
Se il socialismo scientifico ha preso il via dalle utopie [...], forse la socializzazione
reale emanerà dalle esperienze24.
In ciò che segue proviamo a proporre un progetto concreto che non si limiti a
modificare la retorica che accompagna le importanti attività già messe in campo
dagli attivisti e a suggerire alcuni punti su cui lavorare e mobilitarsi, a partire dalla
realizzazione di un osservatorio sulla resistenza animale, come strumento per ren-
dere evidente che gli animali sono soggetti attivi e che gli atti di rivolta sono molto
24 M. Foucault, «Al di là del bene e del male», in Microfisica del potere, cit., p. 68.60 liberazioni n. 16 | Territori delle pratiche
più frequenti di quanto si pensi.
Un osservatorio permanente permetterebbe di dare a ognuna di queste azioni di
ribellione il significato che merita e di lasciar esprimere gli animali su ciò che li ri-
guarda. L’osservatorio permetterebbe inoltre agli umani che intendono raccogliere
la richiesta di alleanza politica avanzata dagli animali di mobilitarsi a più livelli,
sulla spinta delle loro stesse azioni, sviluppando:
1. una rete di sostegno per dare asilo politico agli evasi;
2. un ambito di mobilitazione per solidarizzare con il singolo ribelle;
3. un’articolazione di rivendicazioni politiche più generali a partire dalle ri-
chieste degli animali.
La costituzione di una rete di sostegno mira a creare piccole sacche di possibilità
per il successo delle evasioni. Si tratta quindi di erodere l’efficacia dei dispositivi
descritti, che di norma impediscono agli animali di scampare alla morte e di ren-
dere visibile la loro volontà di ribellione. L’idea di una rete di sostegno è anche
un appello ai rifugi per animali, agli spazi liberati (come i centri sociali, laddove
compatibile con le esigenze etologiche degli evasi), ai singoli solidali, affinché i
latitanti possano ricevere asilo politico (definitivo o anche solo temporaneo), al-
meno nei casi in cui il “riscatto” può avvenire in modo pubblico e legale.
La solidarietà verso il singolo dovrebbe manifestarsi anche come mobilitazione
pubblica. Diventa necessario scendere in piazza, o attivarsi in altro modo, quando
viene data notizia di una ribellione. Ci rendiamo conto che questa proposta presen-
ta diversi problemi organizzativi, poiché gli atti di rivolta sono continui e numerosi
e poichè spesso vengono resi noti soltanto una volta conclusi o le informazioni che
vengono messe a disposizione sono frammentarie. Tuttavia, se solo lo si volesse,
in molti casi sarebbe possibile mobilitarsi. Scendere in piazza non dovrebbe avere
un significato meramente simbolico, di denuncia o di generica solidarietà, ma do-
vrebbe supportare richieste esplicite, come ad esempio il collocamento del ribelle
presso un rifugio o il suo rilascio in libertà. Anche le azioni dirette, oltre che partire
dalla volontà degli umani che le compiono, possono essere intraprese sulla scorta
di un invito degli animali alla mobilitazione.
Avanzare rivendicazioni a partire dagli animali stessi significa iniziare a costru-
ire insieme l’agenda politica. Il paternalismo si è espresso finora anche come il to-
tale controllo di tale agenda da parte degli animalisti umani, anche se non mancano
i casi in cui si è verificato qualcosa di diverso:
Storicamente, ci sono stati tre tipi di offerta fatte dai proprietari e dai gestori ai propri
animali lavoratori per ottenere produzione e obbedienza. La prima era l’offerta di un
trattamento migliore, di cibo e condizioni migliori, talvolta anche di amicizia [...]. Il
secondo tipo di offerta era l’opposto. Siepi e recinzioni vennero erette per impedire
la fuga. Strumenti crudeli, come i gioghi di legno e gli zoccoli, cercavano ridurre lePuoi anche leggere