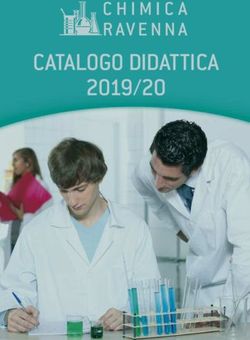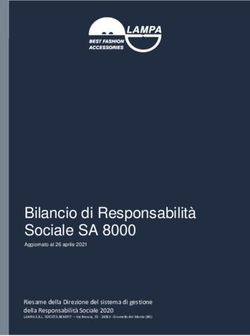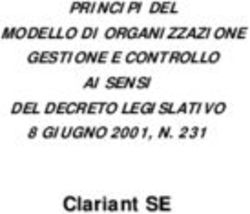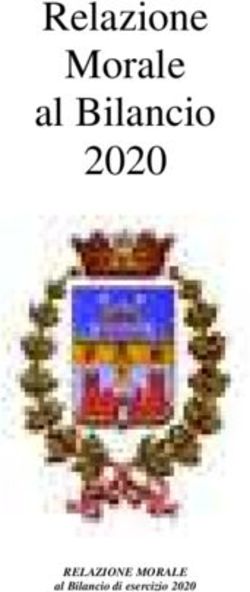Per un uso razionale delle biomasse legnose - Energia Ecologia ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Quale è il problema
Da anni sul monte pisano scoppiano incendi più o meno grandi, di
origine dolosa o colposa
Un altro problema più generale e diffuso è l’inquinamento da polveri
sottili PM10 (particolato di diametro medio inferiore a 10 μm) che si
presenta in modo più acuto nei mesi invernali. La combustione delle
biomasse in campo e per riscaldamento sono secondo alcune stime
la causa principale dell’inquinamento da PM10
L’obiettivo generale di questo documento è valutare alcuni aspetti del
problema e individuare un possibile uso razionale delle biomasse
legnose per evitare la pratica dell’abbruciamento dei residui in
campo.
Il caso del Monte PisanoPM10 episodio del 28 Marzo 2020 http://www.arpat.toscana.it/temi- ambientali/aria/qualita- aria/bollettini/index/regionale/02-04-2020
Medie giornaliere del PM10
Air quality standards for the protection of health,
as given in the EU Ambient Air Quality Directives
PM10
1 day Limit value: 50 μg/m3
Not to be exceeded on more than 35 days per year
Calendar year Limit value: 40 μg/m3
WHO air quality guidelines (AQG)
PM10
1 day 50 μg/m3
99th percentile (3 days per year)
Calendar year 20 μg/m3
La concentrazione delle polveri sottili
nella nostra zona
- supera il valore limite in alcune
stazioni
- è migliorata nel tempo ma non
dappertuttoLa situazione in Europa Nell’Unione Europea il problema è più accentuato negli stati dell’Est, principalmente in Polonia, che usa carbone come fonte energetica principale e nella pianura padana che risente di condizioni climatiche di occlusione/inversione termica per buona parte dell’anno e che ha una concentrazione di industrie molto elevata
Interventi per limitare le emissioni di
PM10 in Europa
In general,
the road transport sector is the largest contributor
to total nitrogen dioxide emissions in the EU, while
fuel combustion in the commercial, institutional and
households sector is the largest contributor to overall
primary particulate matter emissions, particularly in
some eastern European countries (see Chapter 2).
Most reported measures address the road transport
sector (Figure 1.2). The main measures related to traffic
are encouraging a shift among transport modes; land
use planning to ensure sustainable transport facilities;
improving public transport; and public procurement.Inversione termica e PM10 La terra tende a raffreddarsi rapidamente dopo il tramonto del sole. L’adiabaticità dell’atmosfera prevede la diminuzione della temperatura dell’aria di 1 grado per ogni cento metri. Nei periodi di inversione termica la temperatura che è bassa a livello del suolo si innalza per riabbassarsi poi ad altitudini maggiori. Questa situazione, che è assai frequente nei periodi di alta pressione nelle nostre vallate, favorisce l’accumulo di PM10 negli strati bassi dell’atmosfera. Il particolato viene disperso quando il sole riesce a riscaldare il suolo attivando i movimenti convettivi dell’aria. Talvolta queste condizioni avverse permangono anche durante l’intera giornata.
Episodio fine Febbraio inizio Marzo
2019
Mercoledi' 27 Febbraio 2019 La situazione si è protratta invariata fino al
Situazione: un robusto campo di alta 3 Marzo. Il 2 Marzo, pur essendo giornata
pressione con massimi sulla penisola prefestiva in molte stazioni si è superato il
iberica si estende sull'Europa centro- limite di 50 microg/m3
occidentale e favorisce condizioni di
tempo stabile sul centro-nord dell'ItaliaPRQA Piano Regionale Qualità Aria
PRQA Luglio 2018
http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria
2.1 I principali risultati del quadro conoscitivo
• Aree con superamenti del valore limite per l’inquinante materiale particolato fine PM10 nelle aree di fondovalle (fino ad una quota
di 200 metri) della Piana Lucchese e Valdinievole e della Piana di Prato-Pistoia, e per l’inquinante biossido di azoto NO2 lungo le
principali arterie di comunicazione dell’agglomerato di Firenze.
• Zone dove i valori registrati sono vicini, anche se inferiori, ai valori limite e per le quali quindi si dovranno comunque prevedere azioni di
riduzione delle emissioni.
• Esiste un problema diffuso su tutto il territorio regionale per quanto riguarda l’ozono O3 con superamenti del valore obiettivo. Questo
inquinante, che è di natura totalmente secondaria, si prevedono azioni di riduzione dei precursori che sostanzialmente coincidono con i
precursori del PM10 .
• Media annua buona, decisamente(aggettivo più avverbio n.d.r.)) inferiore al limite di 40 µg/m3 (escluso Capannori n.d.r.), (in linea
con i valori registrati in altre aree dove la situazione non presenta alcuna criticità), ma un numero di superamenti del valore limite
giornaliero di 50 µg/m3 superiore ai 35 permessi dalla norma. (allegato 1)
• Dovranno essere attivate importanti azioni di tipo contingibile finalizzate ad abbassare i picchi che si hanno nel periodo critico (da
novembre a marzo).
• Nella scelta degli interventi più importanti, si dovrà tener conto delle principali sorgenti di inquinamento che, come dimostrato dal
progetto regionale PATOS per il PM10, si sono modificate negli ultimi anni. I valori più elevati di inquinamento infatti non si registrano
più nelle centraline di traffico ubicate nei principali centri urbani, ma in quelle di fondo ubicate nelle aree periferiche, anche molto
lontane da centri urbani importanti. Tale circostanza è addebitabile alla combustione da biomassa che, nelle giornate di superamento
del valore limite, rappresenta la principale sorgente di inquinamento. Il traffico invece riveste importanza solo in alcuni centri urbani,
ma comunque non rappresenta più la causa principale dei superamenti del valore limite di PM10 registrati dalle centraline della rete
di monitoraggio della qualità dell’aria. Per quanto riguarda la combustione delle biomasse, al fine di una più precisa specificazione
della sorgente si è fatto riferimento ai dati dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE per l’anno 2010 (ultimo anno
disponibile), dove sono riportati il dettaglio delle emissioni per gli impianti di combustione non industriali suddiviso tra terziario caldaie,
domestico caldaie, domestico caminetti, Domestico Stufe tradizionali, Domestico Stufe a pellet e per tipo di combustibile utilizzato
combustibili vegetali, gasolio, gas naturale e GPL. (Per un dettaglio si vedano le pubblicazioni alla pagina
http://www.regione.toscana.it/-/inventario-regionale-sulle-sorgenti-di-emissione-in-aria-ambiente-irse). Deve esser messo in evidenza
che il maggior contributo deriva dalla combustione di biomassa in caminetti e stufe tradizionali che presentano i fattori di emissione più
elevati, rispettivamente 840 g/GJ e 760 g/GJ contro i 28 g/GJ delle stufe a pellet.Obiettivi PRQA Obiettivo A2 Questo fatto spiega la difficoltà nell’ottenimento di decisivi risultati, nelle aree di superamento, con interventi di risanamento di carattere locale che, agendo solo sulla riduzione delle emissioni della componente primaria del particolato, non riescono ad incidere in via definitiva sui livelli di concentrazione del PM10 misurati. In merito a questo obiettivo specifico, le elaborazioni del quadro conoscitivo ricavato in particolare dai dati IRSE e dal progetto regionale PATOS, indicano che la principale sorgente di emissione del particolato primario sia da ricercarsi nella combustione della biomassa, sia come abbruciamenti all’aperto di sfalci e potature, sia nell’uso di legna e pellet per il riscaldamento domestico. Altri settori quali le emissioni legate alla mobilità, pur essendo minoritarie non possono essere trascurate. Inoltre occorre ricordare che residua anche una componente di PM10 non trascurabile di origine naturale dovuta al trasporto di sabbia sahariana, allo spray marino, etc. Gli interventi devono ovviamente agire prioritariamente verso le emissioni da attività antropiche che rappresentano le principali sorgenti del particolato: combustione delle biomasse e mobilità. In estrema sintesi: Si individua come principale causa dei superamenti del limite per il PM10 la combustione di legna nei caminetti e nelle caldaie alimentate con questo combustibile. Ci si basa per questa affermazione oltre che sulle conclusioni del progetto PATOS sui contributi alle emissioni calcolati e riportati nel datbase IRSE.
Emissioni inquinanti principali Toscana
Stima delle emissioni da combustione
di biomasse
• La base per il calcolo dei contributi alle emissioni è l’INVENTARIO REGIONALE
DELLE SORGENTI DI EMISSIONE IN ARIA AMBIENTE – IRSE
• Dal momento che non esiste nessun censimento degli impianti a pellet, camini etc,
per la stima del consumo regionale di legna e per la differenziazione in base al
sistema in cui viene utilizzata, ci si basa sui dati nazionali rapportati alla regione e
ai comuni.
• Questa stima soffre di molta incertezza. Fra l’altro nel computo non è considerato il
contributo dei fuochi in campo aperto.
• Per il calcolo delle emissioni si utilizzano i fattori di emissione del catalogo
CORINAIR europeo.
• In assenza di un inventario del numero degli impianti (caminetti/caldaie)
realmente funzionanti a legna/pellet nei comuni di fondovalle e nelle città dove
sono stati osservati il maggior numero di superi dei valori di soglia del PM10
avanziamo il serio dubbio che tali impianti contribuiscano nelle proporzioni
dichiarate a tali superi.
• Quanto agli abbruciamenti occorrerebbe fare una stima realistica di questa attività
consci che nel momento che si voglia limitarla occorrerebbe proporre
un’alternativa a questa pratica.Aggiornare e migliorare il quadro
conoscitivo
• Obiettivo specifico D 2 Aggiornare e migliorare il quadro
conoscitivo
• A questo scopo il PRQA prevede:
– la continuazione del progetto PATOS, relativo alla conoscenza
del PM10 e PM2,5, le sue origini e la sua composizione;
– l'aggiornamento dell'IRSE al fine di completare le informazioni
sulle sorgenti di emissione e di costruire solidi scenari di
previsione utili all'individuazione delle strategie future;
– l'utilizzo di modelli di dispersione degli inquinanti, utili anche
per la valutazione ex ante degli effetti sulla qualità dell'aria delle
azioni di riduzione delle emissioni, anche grazie al supporto di
LAMMA e di ARPATProgetto PATOS 2011
Gli obiettivi che il progetto PATOS si è proposto sono:
• determinare la composizione ed origine del PM10 nelle varie aree della
regione(natura primaria, secondaria e terziaria, identificazione delle
sorgenti,…):
• determinare il range dei livelli di concentrazione di fondo (background)
regionali;
• determinare le “possibili” correlazioni tra le condizioni meteoclimatiche
e l’accadimento,la persistenza e la spazialità di episodi con elevate
concentrazionidi PM10;
• ottenere informazioni sul PM10 secondario, la sua formazione ed
origine (es.trasporto e trasformazione da sorgenti puntiformi importanti
per SOx e NOx)
• conoscere la distribuzione spaziale dei livelli di concentrazione di PM10
in aree rappresentative della regione ed in particolare dove si hanno
situazioni disuperamento dei valori limite;
• approfondire, nel limite delle risorse disponibili ed a seguito
dell’ottenimentodelle informazioni precedenti, ovvero in collegamento
con altre iniziative diricerca, le conoscenze circa la frazione ultrafini,
PM2,5 , PM1 e PUF del PM10, inparticolare sulla loro composizione ed
origine.
• https://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Progetto%2
0regionale%20PATOS/058dbb3b-0356-4121-b3dd-9c1d9012696bContributi di sorgente al PM10
- a Capannori è presente una concentrazione molto elevata
(superiore ai 20 μg/m3) di POM;
- il Carbonio Elementare ha concentrazioni maggiori nelle
stazioni classificate come “urbana traffico”(Prato: 3.3 μg/m3 e
Arezzo: 3.6 μg/m3);
- la concentrazione della componente secondaria inorganica
non presenta forti variazioni fra i diversi siti, oscillando tra 5
μg/m3 e 7 μg/m3. Ricordando cheessa è data dalla somma di
solfati, nitrati e ammonio, si osserva che, mentrei solfati
mostrano una dispersione più omogenea su scala regionale, i
nitrati risultano maggiormente condizionati dalle sorgenti
locali di riscaldamento domesticoe traffico, mostrando
concentrazioni atmosferiche più elevate nei siti a più forte
impatto antropico;
- la concentrazione della componente crostale varia da 3
μg/m3 a 7 μg/m3 ;
- il contributo aerosol marino è, come atteso, maggiore nelle
stazioni costiere, con particolare riferimento alla stazione di
Livorno. Tale contributo è, comunque,sempre inferiore 2.0
μg/m3 (valore medio annuo).
L’andamento stagionale delle concentrazioni dei composti
organici del carbonio rispecchia pienamente il trend osservato
per il PM10: i valori più elevati sono registrati nelle stagioni
fredde, quando alle emissioni dovute al traffico veicolare si
aggiungono l’accensione degli impianti di riscaldamento e la
presenza di condizioni meteorologiche di stabilità atmosferica
favorevoli all’accumulo di inquinanti al suolo.Progetto PATOS Cascina 2003
42 variabili 51 campioni
CO Na SC2L08B SB2L07BB
Navacchio NO Mg SC2S06B SB2S05BB
NOx Al SC2L02B SB2F01BB
NO2 K SC2L12B SB2L11BB
NMHC Ca SC2L13BV SB2L04BV
O3 V SC3L15B SB3L16BB
Press Cr SC3L17BN SB3L18BN
UR% Mn SC3L19NB SB3L20NB
T °C Fe SC3L21BV SB3L24VV
Rad Tot Co SC3L23VV SB3S26VV
San Benedetto PM10 Ni SC3S25VV SB3F28VB
OC Cu SC3F27VB SB5L48BVA
EC Zn SC6L47BB SB5L46VAN
Cascina NO3 IC As SC6L45BB SB5S43NB
SO4 IC Sr SC6L44BB SB5F49BB
Na IC Cd SC6S42BB SB5L50BB
NH4 IC Sb SC6F51BB SB5L53BB
K IC Ba SC6L52BB SB5L55BB
Mg IC Tl SC6L54BB SB6L63BB
Ca IC Pb SC6L62BB SB6L60BB
Cl IC Hg SC6S61BB SB6L58BB
SC6F59BB SB6S57BB
SC6L56BB SB6F65BB
SC6L64BB SB6L67BB
SC6L66BB SB6L69BB
SC6L68BB
Individuazione siti di campionamento
La matrice dei risultati daa elaborare è una matrice di 51 righe e 42 colonne. L’informazione
che se ne può ricavare è spesso confusa ed affetta da errore. Si ricorre per questo all’analisi
statistica multivariata, in particolare alla proiezione sui ccomponenti principali, e ai modelli
recettore, che permettono di calcolare il contributo delle emissioni presenti ad ogni singolo
campione di particolato. I modelli più comuni utilizzati sono il CMB (Chemical Mass Balance)
e il PMF (Positive Matrix Factorization)Individuare le sorgenti mediante Analisi dei componenti principali PCA Proiezione sui componenti principali delle variabili e dei campioni
Determinazione dei contributi di
sorgente - Metodo CMB
• Modello basato sul bilancio di massa (CMB) consiste essenzialmente nella soluzione di una serie di
equazioni che esprimono le concentrazioni delle specie chimiche come somma dei prodotti dei
contributi delle singole sorgenti per i loro profili caratteristici di emissione.
• La procedura di modellizazione del CMB richiede:
– L’identificazione dei tipi di sorgente per un determinato sito;
– La scelta delle specie chimiche da includere nel modello;
– La disponibilitá dei profili caratteristici delle sorgenti “probabili”;
– La stima delle incertezze nelle misure e nei profili;
– La soluzione delle equazioni di bilancio di massa delle specie chimiche.
• L’equazione chimica generale di bilancio di massa, per un dato campione sul quale siano state
determinate m specie chimiche come risultante di p sorgenti indipendenti, è la seguente:
p
xij cik s kj
k 1
• dove xij è la concentrazione dell’i-esimo elemento misurata nel j-esimo campione, cik è la
concentrazione dell’i-esimo elemento nel materiale emesso dalla k-esima emissione e skj è la
quantità di materiale emesso dalla k-esima sorgente come contributo al j-esimo campione.Contributi al PM10 – Traffico e aerosol
secondarioIl contributo degli incendi Gli incendi durante i periodi asciutti sono frequenti, ma il loro contributo aal PM10 è molto limitato nel tempo. L’impatto sul PM10 è trascurabile, l’impatto sulle strategie di riqualificazione ambientale è invece molto importante
Toscana – AIB (Anti Incendi Boschivi) L’organizzazione dello spegnimento degli incendi occupa ingenti risorse economiche ed umane. Ma cosa viene fatto per la pulizia del bosco? Poco, interventi sporadici e non inquadrati in un piano generale di valorizzazione della risorsa biomassa e del bosco in generale Gli incendi sono tutti di origine dolosa o colposa. Il servizio di Anti Incendi Boschivi (AIB) è importante ma non basta a contrastare il fenomeno. L’unico modo di contrastare gli incendi è quello di coinvolgere nella cura e conservazione del bosco la comunità che dal bosco trae profitto economico e motivo di coesione sociale
Prescrizioni del PRQA per il contenimento delle
emissioni di PM10
Dal quadro conoscitivo ricavato in particolare dai dati IRSE e dai risultati del progetto
regionale PATOS, si deduce che la principale sorgente di emissione del particolato
primario sia la combustione della biomassa,
Il documento cita gli abbruciamenti di sfalci e potature, ma nel computo del contributo al
Pm10 considera esclusivamente legna e pellet per il riscaldamento domestico.
Il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria prevede:
E6) Ordinanze di limitazione utilizzo biomassa per riscaldamento previste nei PAC
Interventi di divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico che potrà essere ammessa
solo con impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi
alternativi di riscaldamento.PRQA osservazioni e proposte
• Se uno dei problemi principali per la riduzione del PM10 è legato alla combustione
di biomasse per riscaldamento domestico e alla combustione delle potature e degli
sfalci mi sembra opportuno investire risorse in questo campo per individuare le
linee di intervento più opportune. Limitarsi a vietare la combustione delle potature
e a vietare l’uso del caminetto può risultare insufficiente e non accettato
socialmente. Tanto più che l’ENEA e altre istituzioni suggeriscono di incrementare
il ricorso a questa risorsa energetica rinnovabile e diffusa.
• Nel campo degli interventi per la limitazione del traffico sarebbe opportuno
finanziare adeguatamente il potenziamento dei servizi ferroviari, di mobilità
cittadina su rotaia e dei sistemi a sostegno della mobilità dolce, piste ciclabili zone
pedonali.
• Il maggiore investimento finanziato nell’ambito del PRQA 2018 è la sostituzione di
alcuni autobus.
• Quanto all’aggiornamento del database IRSE, ci sembra cosa opportuna ma che
debba essere affiancato da censimenti e verifiche in campo, pena la perdita di
coerenza di questo strumento indispensabile per qualsiasi ipotesi di
programmazioneComunità del bosco del Monte Pisano
Nel momento in cui viene proibita la combustione in campo di potature e sfalci è necessario proporre delle alternative
La CdBMP ha tra i suoi obiettivi generali la promozione, pianificazione e conduzione di percorsi di innovazione e di
gestione condivisa delle risorse del Monte Pisano (boschi, sentieri, oliveti, acqua, patrimonio culturale e immobiliare,
piccole e medie attività economiche collegate alla gestione di tali risorse). La CdBMP vuole valorizzare le risorse del
Monte Pisano e la produzione di beni comuni indispensabili per la vita della comunità, specie in tempi di crisi
climatiche, ambientali, sociali ed economiche. Nello specifico la CDBMP intende conseguire i seguenti 6 obiettivi
specifici:
• 1. Contribuire alla realizzazione di un sentiero narrante capace di legare e collegare le comunità del Monte Pisano
e rafforzarne la capacità di leggere, rendere dialogante e valorizzare la storia e la vita contemporanea del Monte
Pisano e dei suoi attori quotidiani;
• 2. Ripensare e riorganizzare la gestione e la salvaguardia dei sistemi boschivi pubblico e privato aprendolo a
nuove modalità valorizzazione collettiva con finalità di pubblica utilità ambientale (servizi ecosistemici) e di
valorizzazione economica della risorsa;
• 3. Valorizzare la cultura della gestione dell’olivicoltura terrazzata monumentale assicurandone continuità nella
gestione competente e una organizzazione collettiva;
• 4. Innalzare la cultura della prevenzione e della gestione del territorio e delle sue infrastrutture, mediante
comunità antincendio, presidi, sistemi di miglior gestione delle risorse idraulico agrarie;
• 5. Rafforzare i dispositivi di educazione, formazione e creazione di conoscenze in una logica di sostenibilità e
gestione attiva delle risorse ambientali disponibili nel sistema del Monte Pisano.
• 6. Promuovere la cultura dei beni comuni anche nella valorizzazione delle risorse agro-forestali facilitando la
predisposizione di regolamenti capaci di generare una nuova mediazione tra azione pubblica e privata;
https://www.comunitadelboscomontepisano.it/https://www.comunitadelboscomontepisano
.it/abbruciamneto-gestione-ramaglie-oggi/
• Potature stagionali e ramaglie
• La gestione degli oliveti in questa stagione si confronta con le attività di potatura e il relativo smaltimento delle ramaglie. Al di la della difficoltà che
per motivi di sicurezza in questo momento si pongono per il distanziamento sociale e la difficoltà di muoversi per raggiungere gli oliveti, sta
diventando sempre più evidente quanto la tradizionale pratica dell’abbruciamento delle ramaglie stia diventando inadeguata, per motivi sociali,
ambientali e per ragioni climatiche.
• Aspetti sociali dell’abbruciamento
• Per quanto riguarda gli aspetti sociali, la cura degli oliveti è assicurata spesso da persone che da oramai molti anni si dedicano con generosità e
impegno alla loro tenuta. Persone che hanno accumulato grandi conoscenze pratiche e operative ma che, per motivi anagrafici, hanno crescenti
difficoltà fisiche nella gestione di pratiche impegnative e rischiose. In queste condizioni, la possibilità che il fuoco scappi e che finisca per prendere
il sopravvento sul suo gestore è assai facile con implicazioni già viste negli anni recenti.
• Ambiente: polveri sottili
• Dal punto di vista ambientale, poi, appare sempre più evidente la necessità di evitare il cumularsi nell’atmosfera di particolato legato
all’abbruciamento di legno. La qualità dell’aria rappresenta un problema complessivo e la possibilità di limitarne accumuli di sostanze dannose, è
diventata una necessità che riguarda tutti, anche i gestori degli oliveti.
• Clima: rischio incendi
• Infine, non per importanza, le questioni legate al clima. La Regione Toscana, in queste settimane, ha emesso e reiterato il divieto di procedere con le
pratiche di bruciatura delle ramaglie e, questo, per il permanere di tempo asciutto e ventoso che potrebbe facilitare l’innesco di incendi difficili da
controllare. Le pratiche di abbruciamento, purtroppo, sono state spesso agli onori della cronaca per l’innesco di incendi di superfici buscate anche
vaste e se, mentre nel passato la potatura degli oliveti si realizzava in una stagione per lo più umida, oggi non è più così.
• Peraltro, in questi giorni, accanto alle tradizionali difficoltà di assicurare lo spegnimento di incendi, si somma la complessità di organizzare squadre di
intervento in una fase che vede le forze della protezione civile e degli stessi vigili del fuoco impegnati in altre attività a sostegno della popolazione per
l’emergenza COVID-19.
• I motivi che abbiamo ricordato si sommano solitamente nella gestione della ramaglie di potatura.Proposta
• Abbruciamenti
– Puntare alla riduzione e a tendere alla proibizione dell’accensione di fuochi per la
distruzione di ramaglie
– Usare alcuni accorgimenti per limitare l’impatto di questa pratica. Nel periodo dal 1
Dicembre al 31 Marzo i fuochi dovrebbero essere fatti solo nelle ore centrali del
giorno, non prima delle 10 del mattino e non dopo le 16 della sera per evitare i
periodi di inversione. Accensione della pira dall’alto. Spegnimento del fuoco per
produrre del biochar da utilizzare come ammendante del terreno
– Nel comune di Calci esiste uno sportello al quale ci si può rrivolgere per chiedere
consulenze e chiarimenti nel merito
• Biotriturazione. E’ l’alternativa alla termodistruzione più facilmente applicabile. A
seconda della disponibilità le ramaglie di dimensioni minori possono essere triturate
– con una fresa,
– con un biotrituratore per ottenere un materiale per ammendare e pacciamare
– con un trituratore che produca un cippato da utilizzare nelle caldaie per
riscaldamento e in piccccoli impianti per la cogenerazioneBiotriturazione in campo Da un post sul sito WEB della CdB Come vedete dalla foto in vent’anni le ho provate un po’ tutte.In primo piano TRINCIASARMENTI TRAZIONATO, splendida macchina, passa sulle ramaglie a terra e lascia un tappeto di pacciamatura anche bello a vedersi; servono sentieri larghi 80 cm.In secondo piano dulla dx: TRINCIASARMENTI PER MOTOCOLTIVATORE, stessa cosa ma molto meno manovrabile.In terzo piano, la macchina verde sulla destra: BIOTRITURATORE VICKING, bocciato. Ce ne vuole uno ben più potente e comunque sono affari difficili da spostare (si monta sul cingolatino che potete vedere in fondo sulla sinistra, ma sono spostamenti laboriosi e pericolosi soprattutto se in pendenza). Detto questo, dico anche che se si diffondessero macchine simili sul monte in certi periodi non si farebbe vita, perchè sono talmente rumorose da far rimpiangere i fuochi. In particolare il biotrituratore. Per cui ben vengano le fascine.
Cippato in campo
• Se per le potature si può pensare che la
biotriturazione in campo la via migliore di
smaltimento, per il taglio e la pulizia dei boschi e delle
ripe dei fiumi occorre adottare altre strategie.
• Le ditte che intervengono in questo settore utilizzano
grossi macchinari per il taglio, l’esbosco e la cippatura,
non utilizzabili sul monte pisano considerate le forti
pendenze e la fragilità del terreno
• Occcorre mettere in campo strategie diverse per
rendere possibile la coltivazione del bosco e la pulizia
delle ripe. Lagna che deve essere cippata deve essere
trasportata e cippata probabilmente in altro luogo e
ciò influirà sul costo finale del cippato
• Nell’ambito di un progetto in collaboraazzione con
OLT per il ripristino di due aree percorse dalle fiamme
dell’incendio del 2018 si può pensare di mettere a
punto la migliore strategia per ottenere cippato dal
legno tagliato.Utilizzo del cippato per il recupero
energetico
- Il legno di dimensioni maggiori ottenuto per taglio del bosco
può essere cippato in un impianto dedicato oppure conferito
ad una ditta dotata di un cippatore di dimensioni adeguate.
- Utilizzo del cippato per la produzione di energia elettrica
/calore in piccoli impianti di facile gestione
Gassificazione con motore a combustione interna (50 - 500 kW)Conto economico gassificatore
45 kWhe
37,35 kWhe
incerto 7500 h funzionamento
280,125 MWhel/anno
45 kg/h cippato
70 €/t costo cippato
23625 €/anno costo cippato
350000 € costo impianto
incerto 23333 €/anno ammortamento impianto 15 anni
incerto 7000 €/anno costo manutenzione
53958 €/anno costi totali
35000 €/anno rendimento capitale ipotizzato 10%
79438 €/anno ricavi vendita energia elettrica
283,6 €/Mwhel prezzo remunerativo /MWh
99,0 kWhth /h prodotti
9,8 kWhth/h necessari per seccare cippato
9,9 kWhth/h calore perdite
3,2 €/h ricavi vendita calore 0,04 €/kWhth
incerto 9520 €/anno ricavi vendita calore 3000 hConclusioni - Passi futuri
• C’è un’ampia letteratura scientifica che tratta dell’influenza delle polveri sottili
(PM10, PM2.5, PUF) sull’incidenza e la gravità delle malattie dell’apparato
respiratorio. Ne discende la necessità di controllare questo fattore di rischio.
• La combustione di biomasse è stata riconoscciuta come una sorgente importante
dui questo inquinante ed occorre favorirne un utilizzo più razionale
• Si propone
– ottimizzare la pratica di cippatura dei residui legnosi più leggeri in campo per formare
dell’ammendante
– cippare la legna di dimensioni maggiori ottenuta dalla cura degli oliveti e dei boschi e dalla
pulizia delle rive dei torrenti
– utilizzare il cippato ottenuto a fini energetici
• Alcuni aspetti di questa strategia sono noti, ma non è chiaro come possa essere
applicata sul monte pisano che ha sue caratteristiche peculiari. Per questo occorre
definire tutti gli aspetti delle opzioni valutando dal punto di vista della fattibilità e
dell’economicità anche il possibile coinvolgimento di altri soggetti interessati
• La nascita della Comunità del Bosco del Monte Pisano può diventare un elemento
in più per il successo di questa strategia.Puoi anche leggere