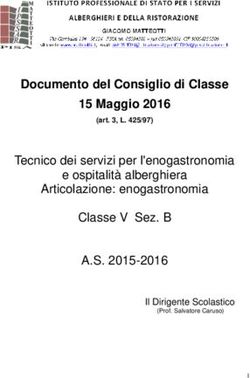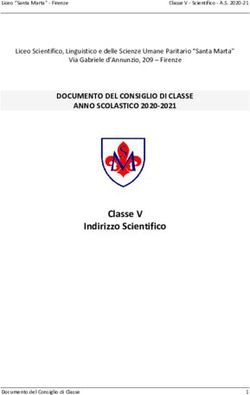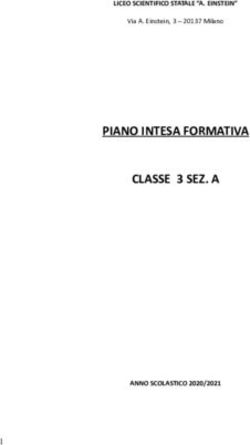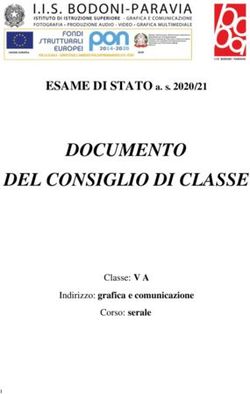"O. Belluzzi - L. da Vinci" - RIMINI Istituto Tecnico Industriale e per Geometri - L ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Istituto Tecnico Industriale e per Geometri
“O. Belluzzi - L. da Vinci”
RIMINI
Anno scolastico 2014/2015
Documento del Consiglio della classe
5a A-CHIMICA
(Ai sensi della legge n° 1 dell’ 11/01/2007)
IL COORDINATORE DI CLASSE
Prof. ssa Cristiana Balducci
Rimini 15/05/2015
1Contenuto:
a) scheda informativa generale comprendente:
Elenco dei candidati
Presentazione della classe
Elenco del Consiglio di Classe
Presentazione Profilo Professionale
b) schede informative analitiche relative alle discipline dell’ultimo anno di corso
c) scheda relativa alle attività integrative ed extracurricolari
d) scheda relativa alla terza prova scritta
e) criteri di valutazione comuni utilizzati per le materie d’indirizzo
f) Allegati
2SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
Elenco dei candidati classe 5a A Chimica
1 ARLOTTI SIRIO
2 BELLI DAVIDE
3 CNEAZOVICI FABIAN
4 CROBU FABIO
5 DE BIAGI LEONE ALBERTO
6 DI SABATINO GARBATI LUCA
7 GIORGI VALERIO
8 GIUNGI FRANCESCO
9 MANENTI JACOPO
10 MIGLIORI ALICE
11 MUCCIOLI LUCA
12 PEDRINI PAOLO
13 TARABORELLI SIMONE
14 VACCA MARIAELENA
Presentazione della classe:
Il gruppo classe è composto di quattordici allievi (12 ragazzi e 2 ragazze), tutti iscritti per la prima volta
alla classe quinta. Uno degli studenti ha una certificazione di DSA, si rimanda al fascicolo allegato per le
informazioni sul Piano Didattico Personalizzato per lui predisposto.
Nell’anno scolastico 2012-13 la classe terza era costituita da 15 studenti. Nelle ore di insegnamento
comune (ad esclusione dell’insegnamento di lingua inglese) la classe era articolata con una classe terza
meccanica, per un totale di 32 studenti.
Il gruppo classe non ha subito cambiamenti di rilievo, salvo due alunni non ammessi in classe quarta ed
uno studente non ammesso in classe quinta. Un nuovo alunno, proveniente da altra provincia, si è
inserito in questo anno scolastico.
Il Consiglio di Classe ha subito diverse modifiche nel corso del triennio: dalla classe terza alla quarta
sono cambiati gli insegnanti di Lingua e Letteratura italiana, Storia e quello di Tecnologie Chimiche
3Industriali; nel passaggio dalla classe quarta alla quinta sono invece cambiati i docenti di Chimica
Organica e Biochimica, Scienze Motorie Sportive e Religione.
L’esiguo numero degli alunni e il loro comportamento tendenzialmente corretto in classe ha permesso
agli insegnanti di inserirsi senza difficoltà nei percorsi didattici già avviati.
La classe si presenta nel complesso omogenea sotto il profilo didattico: la maggior parte degli allievi ha
manifestato competenze e conoscenze essenziali, non approfondite: si orienta negli argomenti
fondamentali delle varie discipline ed ha raggiunto una preparazione sufficiente. Pochi allievi si sono
distinti per impegno e serietà nella preparazione, più diffuso l’approccio allo studio finalizzato alla sola
prova di verifica.
In alcuni casi è mancata, fino alla fine dell’attuale anno scolastico, la consapevolezza dell’impegno per
affrontare adeguatamente l’Esame di Stato. Permangono in alcuni studenti evidenti difficoltà nel
risolvere problemi che non prevedono la sola applicazione di formule standard, ma anche l’utilizzo
simultaneo di più conoscenze o di calcoli matematici più articolati. Inoltre si evidenzia una difficoltà,
nell’ambito delle materie umanistiche, nell’esposizione orale dei contenuti.
Nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha più volte lamentato la mancanza di viva partecipazione e
una generalizzata passività nei confronti delle attività didattiche proposte.
In riferimento alla nota del MIUR n. 4969 del 25 Luglio 2014 relativa all’attivazione di percorsi CLIL si
rimanda all’allegato del programma dell’insegnamento di Tecnologie Chimiche Industriali. In
conformità con quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 16 ottobre 2014, in assenza di docenti
formati secondo la metodologia CLIL, si è definita una collaborazione tra insegnanti di lingua inglese e
quelli delle materie tecniche di indirizzo per l’elaborazione di un modulo in lingua inglese.
4Elenco del Consiglio di Classe 5a A-Chimica
Disciplina del piano di studi Docente Rapporto Ore
di lavoro settimanali
Il Dirigente Scolastico Prof.
Fabio De Angeli
Lingua e lettere italiane Balducci Cristiana T. I. 4
Storia Balducci Cristiana T. I. 2
Lingua Inglese Brozzetti Elisabetta T. I. 3
Matematica Bruschi Andrea T. I. 3
Chimica organica e biochimica Buda Mariacristina T. I. 3
Naldi Arianna T. I.
Chimica analitica e strumentale Zanni Paolo T. I. 8
Bocci Luigi T. I.
Tecnologie chimiche industriali Dante Ivano T. I. 6
Bocci Luigi T. I.
Scienze motorie e sportive Urbinati Rino T.I. 2
Religione Cattolica Morri Emauela T. I. 1
5Commissione d’esame
MATERIA DOCENTE
Lingua e letteratura italiana Cristiana Balducci
Chimica analitica e strumentale Paolo Zanni
Matematica Andrea Bruschi
Inglese Docente esterno
Chimica organica e biochimica Docente esterno
Tecnologie chimiche industriali Docente esterno
Profilo Professionale indirizzo “Chimica e Materiali”
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei
sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei
processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico,
merceologico, biologico e farmaceutico.
- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e
sanitario.
È in grado di:
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella
gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione
delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto
delle normative per la tutela ambientale;
- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei
6processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese;
- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e
nello sviluppo del processo e del prodotto.
In quanto alle competenze acquisite, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato
nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” consegue i risultati di
1 – Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di
un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi
e le loro trasformazioni.
4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in
cui sono applicate.
5 – Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici.
6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla
sicurezza.
7SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)
Anno Scolastico 2014/2015
OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi perseguiti dal Consiglio di Classe si sono posti in linea coerente con le finalità previste dal
nuovo Esame di Stato e pertanto sono stati articolati in:
Conoscenza
Competenza
Capacità
CONOSCENZA
1. Conoscenza specifica dei contenuti delle discipline umanistiche come espressione della civiltà
artistico–letteraria, colti attraverso il simbolico e l’immaginario.
2. Conoscenza diretta dei testi in Lingua italiana più rappresentativi del patrimonio linguistico-
letterario, considerati nella loro varietà interna ed articolati nel loro storico costituirsi.
3. Conoscenza specifica dei contenuti delle discipline scientifico-tecnologiche, colti in connessione
con il dinamismo del mondo produttivo ed articolati in relazione ai processi cui tali discipline
sovrintendono (principali linguaggi tecnici e loro sintassi).
4. Conoscenza dei linguaggi tecnici, scientifico–normativi e dei loro costrutti sintattici e simbolici.
5. Conoscenza delle problematiche giuridiche ed economiche della gestione delle imprese.
6. Conoscenza diretta dei testi in lingua straniera più rappresentativi del patrimonio artistico-
letterario e più significativi della cultura scientifico–tecnologica.
7. Conoscenza dei processi logico-deduttivi.
8. Conoscenza dei processi nel campo fisico e in particolare di quelli elettronici, affrontati in maniera
sistemistica.
COMPETENZA
1. Competenza nell’uso della strumentalità linguistica nella ricezione e nella produzione, orale e
scritta nell’ambito dei linguaggi settoriali.
2. Competenza nell’oggettivare e descrivere in forma orale, scritta o grafica un fenomeno dell’area
letteraria o dell’area scientifico–tecnologica.
3. Competenza nell’affrontare il momento progettuale utilizzando le varie tipologie, rispondenti alle
diverse funzioni produttive, dimostrando inoltre di saper disporre di adeguate tecniche
84. Competenza nell’esaminare risolvere casi concreti e questioni pratiche dell’area chimica
5. Competenza nell’uso di strumenti e apparecchiature tecniche.
CAPACITA’
1. Capacità di organizzare un testo
2. Capacità di elaborare e argomentare proprie opinioni, collegando le conoscenze
3. Capacità di costruire ragionamenti conseguenti e motivati
4. Capacità di cogliere le interconnessioni esistenti tra scuola società e cultura tecnologica
5. Capacità di esprimere fondati giudizi critici e personali
6. Capacità di utilizzare le conoscenze professionali acquisite in contesti progettuali nuovi (rielaborare
autonomamente le conoscenze acquisite per affrontare problematiche nuove)
7. Capacità di utilizzare software per produrre elaborati tecnici.
9ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTE: Balducci Cristiana
Libri di testo: R. Luperini et al., Il nuovo Manuale di letteratura, voll. 3a/ 3b – ed. Palumbo
I principali obiettivi del corso sono stati i seguenti:
A) EDUCAZIONE LINGUISTICA: avanzamento delle competenze linguistiche, sviluppo delle capacità di
lettura e comprensione testuale, nello specifico:
- Comprensione e produzione di discorsi orali
- Percezione delle caratteristiche formali del testo, comprensione del contenuto
- Capacità di cogliere i messaggi e inquadrarli in una generale “tipologia di testi”
- Argomentazione e dimostrazione di tesi
- Capacità di chiarire il proprio pensiero, esprimere sentimenti e stati d’animo
- Competenza necessaria per affrontare i diversi modelli di scrittura contemplati nella prima prova
scritta
- Competenza necessaria per affrontare la trattazione degli argomenti pluridisciplinari previsti dalla
terza prova scritta
B) EDUCAZIONE LETTERARIA: consapevolezza del fenomeno letterario come espressione della civiltà e
come forma di conoscenza del reale
- Conoscenza della biografia dell’Autore, delle sue concezioni e della sua poetica, attraverso la
lettura diretta delle opere, sua collocazione in un contesto ambientale, culturale e storico
- Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica
C) EDUCAZIONE CULTURALE: stimolo ed accrescimento dell’orizzonte delle conoscenze sulle altre
culture, sulle altre arti, sui contesti economici, politici, sociali di altri paesi e di varie epoche
Contenuti
L’ETÁ POSTUNITARIA
Coordinate storico-culturali
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
La Scapigliatura come crocevia culturale
Un’avanguardia mancata
Il naturalismo francese
I fondamenti teorici
I precursori
La poetica di Emile Zola
Il verismo italiano
La diffusione del modello naturalista
L’attività di Luigi Capuana
Giovanni Verga
La vita
I romanzi preveristi
La svolta verista: poetica e tecnica narrativa
10Il verisimo di Verga e il naturalismo zoliano
Vita dei campi
Lo straniamento
Il ciclo dei vinti
Analisi dell’opera maggiore: I Malavoglia (temi, ideologia verghiana, confronto tra modernità e
tradizione, costruzione bipolare del romanzo)
Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana
Il Mastro-don Gesualdo: l’impianto narrativo
IL DECADENTISMO
Caratteri generali: basi culturali e filosofiche del movimento
La lezione di Baudelaire e dei poeti simbolisti francesi
Gabriele D’Annunzio
La vita
Il dannunzianesimo
L’estetismo e la sua crisi
I romanzi del superuomo (panoramica)
Le Laudi: Alcyone
Il periodo “notturno”
Giovanni Pascoli
La vita*
La visione del mondo
La poetica del Fanciullino
I temi della poesia pascoliana e le sue soluzioni formali
Myricae: significato del titolo, caratteri della raccolta
I Canti di Castelvecchio
Confronto con D’Annunzio
*L’aspetto biografico è stato approfondito con la visione del documentario “L’ultima passeggiata”
dedicato alla vicenda umana del poeta
IL PRIMO NOVECENTO
Coordinate storico-culturali
La stagione delle avanguardie: il Futurismo
Italo Svevo
La vita
Le suggestioni culturali dell’opera di Svevo
La figura dell’inetto
Il primo romanzo: Una vita (trama e struttura, lottatori e contemplatori)
Senilità (struttura psicologica del protagonista, l’impostazione narrativa)
La coscienza di Zeno: trama e struttura, il rapporto con la psicanalisi, ironia ed inattendibilità del
narratore, il tempo misto, salute e malattia.
Luigi Pirandello
La vita
La visione del mondo: il contrasto forma-vitalismo, il relativismo conoscitivo, la trappola delle relazioni
La poetica dell’umorismo
Le novelle per un anno
11Il fu Mattia Pascal: la storia, i temi ed i caratteri della narrazione
La produzione teatrale: lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, il
meta teatro
TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
Contesto storico-culturale, in raccordo con il programma di storia
L’Ermetismo
La “letteratura come vita”
Il linguaggio
Salvatore Quasimodo: il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra
Giuseppe Ungaretti
La vita
Le innovazioni stilistico-tematiche de “L’allegria”
Le raccolte successive: Il sentimento del tempo ed Il dolore
La memorialistica: il “caso” Primo Levi
12ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTE: Balducci Cristiana
Testo in adozione: A. Brancati, T. Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia; La Nuova Italia editore
L'insegnamento di storia nel quinto anno ha avuto come obiettivo un percorso formativo al termine del quale
lo studente è in grado di :
- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia,
dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri, nel quadro della storia globale ;
- usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina;
- leggere e valutare le diverse fonti;
- guardare alla Storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente;
- acquisire un metodo di studio che lo pone in grado di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo
di natura storica.
Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica frequente dell'esposizione orale di cui è stata analizzata la
precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spaziotemporali, la coerenza del discorso
e la padronanza terminologica.
CONTENUTI
L’Italia postunitaria
Destra e sinistra storica
L’Italia giolittiana
Politica interna e sociale
L’emigrazione
La guerra di Libia
La prima guerra mondiale
Cause della guerra
L’attentato di Sarajevo ed il meccanismo delle alleanze
Dalla guerra lampo alla guerra di posizione
L’Italia di fronte alla guerra: interventisti e neutralisti
Caduta del fronte russo e intervento degli Stati Uniti
Fine della guerra: la conferenza di pace e il nuovo volto dell’Europa
Panoramica sulla rivoluzione russa (dalla rivoluzione di febbraio alla nascita dell’URSS)
Il fascismo
Le difficoltà della ricostruzione
Nascita dei partiti di massa
Crisi del liberalismo
La questione di Fiume
L’ascesa del fascismo
La costruzione del regime
13 Le leggi fascistissime
Politica interna ed economica
I patti lateranensi
La politica estera
Le leggi razziali
Gli Usa e la crisi del 1929
L’isolazionismo
Dagli “anni ruggenti” alla grande depressione
Il new deal di Roosevelt
Il nazismo
Nascita della repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
Il nazismo al potere
L’ideologia nazista e l’antisemitismo
Politica estera e riarmo
Verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale
Le cause del conflitto
Prima fase della guerra (1939-1940)
1941: la guerra diventa mondiale
Svolta del 1942
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
La vittoria degli alleati
14ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTI: PAOLO ZANNI e LUIGI BOCCI
Conoscenze
o Conoscere i principi teorici fondamentali che sono alla base delle tecniche analitiche
strumentali attualmente più in uso e le applicazioni più diffuse
o Conoscere i metodi di elaborazione statistica dei dati analitici ottenuti
Competenze
o Saper eseguire calcoli stechiometrici di base
o Conoscere i principi generali, le grandezze e i parametri fondamentali delle separazioni
cromatografiche.
o Distinguere e descrivere le varie tecniche cromatografiche.
o Classificare i metodi elettrochimici di analisi.
o Conoscere principi teorici, strumentazione e metodi di analisi dei principali metodi
elettrochimici: potenziometria, conduttimetria.
o Prelevare campioni per le analisi secondo le opportune metodiche.
o Scegliere la tecnica analitica in funzione dei risultati richiesti, in termini di precisione,
accuratezza ed economicità.
o Utilizzare i vari metodi di analisi quantitativa strumentale: retta di taratura, standard interno,
standard esterno, aggiunta singola e multipla.
o Applicare il trattamento statistico ai dati analitici raccolti.
o Utilizzare software applicativi nell’elaborazione dei dati raccolti.
Capacità
o Saper interpretare correttamente le metodiche di laboratorio riportate nei testi per procedere
alla successiva analisi
o Utilizzare in modo corretto la strumentazione
o Eseguire l’analisi nell’ambito delle norme di sicurezza e di rispetto dell’ambiente, oltre che sulla
base delle necessarie operazioni di controllo sugli strumenti utilizzati
o Saper redigere una relazione scientifica
o Conoscere la strategia essenziale per la messa a punto di un metodo di analisi
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione (compresi i tempi per ripassi, verifiche,
approfondimenti, e prove di laboratorio)
Argomento sintetico Sviluppo Tempi
METODI CROMATOGRAFICI PRIMO PERIODO (TRIMESTRE)
GASCROMATOGRAFIA Classificazione delle tecniche gas-cromatografiche.
Grandezze, parametri e prestazioni. Fase mobile e
fase stazionaria: criteri di scelta. Strumentazione:
iniettori, colonne, rivelatori. Trattamenti sui
campioni. Metodi di analisi qualitativa e
quantitativa: retta di taratura, standard esterno,
normalizzazione interna, con e senza fattore di
risposta.
CROMATOGRAFIA IN FASE Principi ed applicazioni; classificazione delle
LIQUIDA AD ELEVATE tecniche. Grandezze, parametri e prestazioni.
15PRESTAZIONI Materiali e tecniche di separazione: fase mobile e
fase stazionaria, criteri di scelta. Cromatografia di
esclusione, cromatografia di scambio ionico,
cromatografia su fasi chirali. La strumentazione.
Metodi di analisi qualitativa e quantitativa.
METODI OTTICI
ASSORBIMENTO ATOMICO Generalità. Strumentazione: sorgenti, sistemi di
atomizzazione a fiamma e a fornetto di grafite;
monocromatori, rivelatori, altri componenti.
Metodi di analisi quantitativa: retta di taratura,
dell’aggiunta e dell’aggiunta multipla.
METODI ELETTROCHIMICI SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE)
ED ELETTROLITICI
Introduzione ai metodi elettrochimici: principi
generali e classificazione.
POTENZIOMETRIA Elettrodi e potenziale di elettrodo; classificazione
degli elettrodi. Potenziali standard di riduzione:
legge di Nernst. Celle galvaniche o pile e calcolo
della tensione teorica e pratica di una cella
galvanica; alcuni tipi di pile. Strumentazione.
Elettrodi di riferimento: a calomelano, ad argento-
cloruro di argento, altri elettrodi. Elettrodo a vetro
per la misura del pH. Elettrodi per la misura del
potenziale redox: al platino, d’oro, ad argento.
Cenni agli elettrodi iono-selettivi, gas-selettivi.
Cenni alla strumentazione. Determinazione della
Keq delle reazioni redox dai valori del potenziale
std e delle pK di elettroliti deboli dai valori di PH a
metà titolazione.
METODI ELETTROLITICI Principi e applicazioni; teoria semplificata, reazioni
all’anodo al catodo e complessiva; previsione della
reazione di cella; la sovratensione. Meccanismi di
trasporto. Le Leggi di Faraday dell’elettrolisi.
Dissoluzione anodica e codeposizione. Applicazioni
dell’elettrolisi: l’elettrogravimetria, principi e
applicazioni, la raffinazione del rame e la
produzione di soda caustica.
CONDUTTOMETRIA Principi teorici e applicazioni. La conducibilità delle
soluzioni. La conducibilità specifica ed equivalente.
La conducibilità a diluizione infinita; legge di
Kohlrausch ed equazione di Onsager. Conduttimetri
e celle conduttimetriche. Metodi di analisi e misure
dirette e indirette. Titolazioni conduttimetriche.
METODI DI ANALISI Titolazioni e determinazione del punto di
QUANTITATIVA equivalenza. Retta di taratura. Metodo dello
STRUMENTALE standard interno e del confronto con singolo
standard. Metodo della normalizzazione interna
con e senza fattore di risposta. Metodo
dell’aggiunta singola e dell’aggiunta multipla.
16Laboratorio di Analisi Chimiche:
Tecnica Competenze Tipologia delle prove
Analitica
Preparazione dello strumento Determinazione di metalli (rame e ferro)
Preparazione dei reattivi nel vino e nell’acqua; determinazione di
Assorbimento Preparazione del campione metalli pesanti (piombo) in campioni di
atomico da analizzare tonno e di piombo e rame nei capelli con
Misura metodo dell’aggiunta multipla.
Preparazione dello strumento Determinazione del metanolo nei distillati e
Preparazione dei reattivi nel vino, metodo della standard esterno e
Gascromatografi Preparazione del campione interno. Determinazione quantitativa di
a da analizzare una miscela di alcoli con metodo della
Misura normalizzazione interna. Determinazione
qualitativa degli IPA nel terreno e sulle
foglie.
HPLC Preparazione dello strumento Determinazione del difenile negli agrumi
Preparazione dei reattivi con metodo dello standard interno.
Preparazione del campione
da analizzare
Misura
Predisposizione dello Determinazione della costante di cella e
Conduttometria strumento della conducibilità a diluizione infinita.
Preparazione dei reattivi Determ. della Ka dell’acido acetico.
Preparazione del campione Determ. della Kps di un sale poco solubile.
da analizzare Titolazioni conduttimetriche. Studio della
Misura cinetica dell’idrolisi alcalina dell’acetato di
etile. Metodi di interpolazione grafica per
l’individuazione del punto di equivalenza.
Preparazione dello strumento Varie titolazioni acido/base con pH-metro e
Preparazione dei reattivi potenziometriche (alogenuri e argento) con
Potenziometria Preparazione del campione elettrodi ad argento e al platino:
da analizzare determinazione della Vit. C;
Misura determinazione del cloro attivo nella
candeggina; determinazione del rame nei
bronzi. Metodi di interpolazione grafica e
matematica per l’individuazione del punto
di equivalenza.
Elettrolisi Preparazione dello strumento Analisi del rame nei bronzi per
Preparazione dei reattivi elettrodeposizione.
Preparazione del campione
da analizzare
Misura
Area di progetto
La classe ha portato a termine in questo anno scolastico un lavoro della durata triennale con a
tema il vino. E’ stato realizzato un vino artigianale, seguendone tutte le fasi della produzione, dalla
vendemmia, all’ottenimento del mosto, alla produzione finale e all’imbottigliamento a scuola,
eseguendo alcune delle determinazioni analitiche principali.
17OBIETTIVI MINIMI
Conoscere i principi teorici delle tecniche analitiche studiate
Conoscere i componenti fondamentali degli strumenti, i relativi schemi di principio e di
funzionamento.
Saper scegliere la tecnica analitica più opportuna in funzione del risultato atteso.
Saper risolvere semplici problemi inerenti le tecniche analitiche studiate.
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo. Elementi di Analisi Chimica Strumentale di R. Cozzi, P. Protti, T.Ruaro, Editore
Zanichelli.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Interrogazioni
Problemi a risposta rapida
Questionari a risposta aperta
Quesiti a risposta multipla
Relazioni di laboratorio
Prove pratiche di esercitazioni di laboratorio
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza specifica della disciplina
Capacità di argomentazione
Capacità logiche e di operare collegamenti
Competenza nell’applicazione delle procedure
Correttezza nell’esposizione ed uso della terminologia specifica
Partecipazione al lavoro in classe, in laboratorio e regolarità nello studio.
Rimini 15/05/2015 Prof. Zanni Paolo Prof. Bocci Luigi
_______________ _______________
18ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTE: ELISABETTA BROZZETTI
Tenuto conto del fatto che il triennio in questo istituto prevede per la lingua inglese il solo voto orale e
alla luce delle future esigenze professionali degli allievi, il docente ha privilegiato la comunicazione
orale di carattere tecnico e nella valutazione ha dato importanza maggiore alla velocità di espressione
e alla conoscenza del vocabolario rispetto all’accuratezza formale.
Quando se ne è ravvisata la necessità, sono stati rivisti alcuni argomenti di carattere grammaticale e
sintattico per recuperare lacune maturate nel corso degli anni precedenti.
Sono state proposte agli studenti alcune verifiche scritte in prospettiva della presenza della lingua
inglese nella terza prova scritta.
MODULO CONTENUTI
HISTORY and LITERATURE
Dal testo The Prose and the Passion (Spiazzi, Tavella)
Da fotocopie varie
The Historical and social context
Britain and America – the Declaration of Independence
Industrial and Agricultural Revolutions
Industrial society
The Romantic Age
The literary Context
Romantic poetry
The gothic novel - Mary Shelley (Frankenstein)
The Historical and social context
The early Victorian Age
The later years of Queen Victoria’s reign
The Victorian Compromise
The Victorian age The literary Context
The Victorian novel – Charles Dickens (Coketown and Facts from Hard times )
Aestheticism and Decadence – Oscar Wilde (brani da The Picture of Dorian
Gray)
The Historical and social context
The Edwardian Age and World War I
From the twenties to World War II
The United States during the World Wars
The Twentieth Century
The Great Depression of the 1930s in the USA
The literary Context
The war poets – Wilfred Owen (Dulce et Decorum est)
19CHEMISTRY
Dal testo: Chemistry and CO. editrice san marco
Unit 1: what is the atom?
Unit 2: Mass number and atomic number
Unit 3: The electrons
Unit 4: Isotopes and ions
Module 3 – Atoms, molecules
The origin of the atomic theory of matter
Unit 5: The periodic table - The making of the periodic table
Unit 6: Bonding –ionic and covalent bonding
Unit 7: The structure of molecules
Unit 1: What is a Chemistry Lab?
Unit 3: Lab equipment: glassware
Module 4 – In the Chemistry
Unit 4: Lab equipment: tools
Laboratory
Unit 5: How to write a lab report
Unit 1: Why are compounds and reactions considered the hearth of
chemistry?
Module 5 – Compounds and
Unit 2: Formulae and Nomenclature
Reactions
Unit 3: Chemical Reactions
Unit 4: Acids, Bases and Salts
Unit 1: What is the scope of Organic Chemistry?
Module 6 – Organic Chemistry Unit 2: Carbon - Polymers
Unit 1: What are the main types of energy sources?
Unit 2: Fossil Fuels – Pollution from fossil fuels
Unit 3: Nuclear Energy
Module 9 – Energy Sources
Unit 4: Renewable Sources of Energy – major types of renewable energy
sources – renewable energy debate
Unit 4: The Atmosphere – air pollution – depletion of the ozone layer – global
Module 10 – The Earth warming – the greenhouse effect
Rimini, Maggio 2015
20ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTI: MARIACRISTINA BUDA e ARIANNA NALDI
LE BASI DELLA BIOCHIMICA ORGANICA
La cellula: le caratteristiche delle cellule procariote ed eucariote. Segnali tra cellule;
movimento cellulare; la membrana cellulare; il citoplasma: i mitocondri, i ribosomi, il
reticolo endoplasmatico, l’apparato del Golgi, il nucleo.
Forma e struttura della cellula batterica; classificazione; la moltiplicazione e le fasi della
crescita batterica; differenziazione; farmaci batteriostatici, battericidi e tecniche di difesa.
Enzimi immobilizzati e Cellule immobilizzate.
Gli acidi nucleici: struttura degli acidi nucleici; il DNA, l’ RNA e le basi azotate; struttura
primaria del DNA e sua sequenziazione: doppia elica . Tipi di RNA, struttura e funzioni. Il
flusso dell’informazione genetica e il codice genetico; le tappe della sintesi proteica. Il
codice genetico; le mutazioni; la ricombinazione genica.
Classificazione dei miceti; le muffe, i lieviti; cenni a: moltiplicazione e riproduzione,
morfologia, fattori di sviluppo e temperatura.
Respirazione aerobica; respirazione anaerobica, fermentazione, fotosintesi clorofilliana, altri
processi energetici; azoto fissazione atmosferica.
Principali famiglie di microrganismi di interesse industriale e alimentare: batteri Gram-
positivi, Gram-negativi, Lieviti, Muffe; procedimenti per prevenire gli inquinamenti
microbici.
Composizione del terreno colturale; preparazione dei terreni colturali; semina isolamento e
incubazione dei microrganismi; identificazione dei microrganismi; determinazione della
concentrazione microbica; conservazione delle cellule.
Alimenti e bevande: vino, aceto, birra, grappa, formaggio. Produzione di acidi, amminoacidi,
alcoli e proteine.
Le bioconversioni microbiche, produzione di antibiotici: insulina e antibiotici.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
Attrezzature e strumenti - panoramica su attrezzature e strumenti per la preparazione e
l’analisi dei terreni; la sterilizzazione e disinfezione del materiale.
L’utilizzo del microscopio ottico – Componenti, funzionamento, cenni ai tipi di microscopio
ed alla manutenzione. Esame microscopico dei microrganismi – esame a fresco,
preparazione dei vetrini, cenni a coloranti e mordenzanti, allestimentoallestimento del
preparato e tecniche di colorazione: colorazione di GRAM, colorazione delle spore con
metodo Shaffer-Fulton.
21Preparazione dei terreni - Fasi preliminari: pesata, dissoluzione, distribuzione,
sterilizzazione, conservazione. Classificazione dei terreni: solidi e liquidi; terreni selettivi.
Determinazione della carica microbica dell’aria: preparazione dei terreni PCA e Sabouraud
Dextrose Agar, osservazione e conta delle colonie di batteri (colorazione monocromatica
con blu di metilene); osservazione e conteggio delle colonie di muffe sviluppate (colorazione
con lattofenolo blu e lattofucsina).
Determinazione della carica microbica totale a 22 e 37°C: preparazione e semina del terreno
PCA, osservazioni ed espressione dei risultati.
Determinazione dei coliformi totali e fecali - Metodo MPN: prova presuntiva con terreno al
brodo lattosato, e test di conferma con terreno VBBB; metodo MF: preparazione, semina e
lettura del terreno Endo-Agar-LES per coliformi totali e del terreno mFc-Agar per quelli
fecali.
Ricerca degli streptococchi fecali - Metodo MPN: prova presuntiva con terreno Azide
Dextrose Broth e prova di conferma con Ethyl Violet Azide Broth; metodo MF: preparazione,
semina e lettura del terreno Slanetz Bartley Agar.
Ricerca dello pseudomonas – Metodo MF: preparazione e semina del terreno Cetrimide
Agar e prova di conferma con terreno Agar Nutriente; prove di conferma all’ossidasi e al
cloroformio.
Ricerca dello Staphilococcus aureus - Metodo MF: preparazione, semina e lettura dei terreni
Baird Parker Agar e Agar sale mannite; test della catalasi, della fermentazione del glucosio
della coagulasi e DNAsi.
Ricerca di clostridi solfito riduttori - Metodo MPN: prova presuntiva con terreno TSN Agar;
metodo MF: preparazione, semina e lettura del terreno SPS Agar; colorazione delle spore
con metodo Schaffer-Fulton.
Vino: dosaggio degli zuccheri riduttori; determinazione dell’acidità totale; dosaggio dell’alcol
etilico.
Realizzazione formaggio e gelato artigianale
METODOLOGIE UTILIZZATE
Lezioni frontali
Lavori individuali e di gruppo
Laboratorio
OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscere la struttura e le proprietà chimiche e biologiche degli amminoacidi e delle proteine.
Saper illustrare la struttura del DNA e RNA e i meccanismi della duplicazione, trasduzione e
traduzione del codice genetico.
Conoscere i microrganismi utilizzati nell’industria biotecnologica.
Distinguere le biotecnologie innovative da quelle tradizionali
Conoscere le principali tecniche utilizzate per la separazione dei prodotti delle fermentazioni
Avere consapevolezza degli aspetti economici relativi alla realizzazione di un processo industriale
biotecnologico
Avere consapevolezza dei problemi legati alla sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Conoscere alcuni processi di produzione quali esempi operativi ed impiantistici.
OBIETTIVI MINIMI
Caratterizzare una cellula procariote da una eucariota
Saper illustrare la struttura delle proteine, del DNA e RNA.
Saper spiegare le funzioni degli acidi nucleici.
22 Saper riconoscere e illustrare i microorganismi di interesse industriale.
Distinguere le biotecnologie innovative da quelle tradizionali.
Saper illustrare alcuni esempi di impiego delle biotecnologie innovative.
Saper illustrare alcuni esempi di impiego delle biotecnologie tradizionali (per es. nel settore
enologico).
Saper illustrare alcuni esempi di impiego delle biotecnologie avanzate.
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo. Chimica delle fermentazioni di G. Sicheri, Editore Hoepli
Visione di documentari didattici
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Interrogazioni
Problemi a risposta rapida
Questionari a risposta aperta
Quesiti a risposta multipla
Relazioni di laboratorio
Prove pratiche di esercitazioni di laboratorio
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza specifica della disciplina
Capacità di argomentazione
Capacità logiche e di operare collegamenti
Competenza nell’applicazione delle procedure
Correttezza nell’esposizione ed uso della terminologia specifica
Partecipazione al lavoro in classe, in laboratorio e regolarità nello studio.
Rimini 15/05/2015
Proff. Buda Mariacristina e Naldi Arianna
23ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTI: IVANO DANTE e LUIGI BOCCI
LIBRI DI TESTO ADOTTATO:
Di Pietro Silvio: Tecnologie Chimiche Industriali – III vol. – Hoepli
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE A. S. 2014/15
167 ore di lezione teoriche alla data del 15/05/2015.
Obiettivi
Conoscenza
Principi teorici delle più significative operazioni della chimica industriale
Criteri – guida nella definizione delle caratteristiche costruttive delle apparecchiature e in scelte di
esercizio
Consolidamento di un linguaggio tecnico appropriato
Alcune significative produzioni industriali
Competenza
Saper impostare e risolvere bilanci di materia e di energia
Saper fare semplici schemi d’impianto, predisponendo le principali regolazioni; saper interpretare gli
stessi
Saper redigere grafici, tabelle e darne corretta interpretazione
Capacità
Individuare ed utilizzare le connessioni interdisciplinari della materia
Acquisire un approccio critico nella individuazione delle scelte d’impianto ed operative più convenienti
Obiettivi minimi
Conoscere gli essenziali aspetti teorici delle operazioni unitarie e dei processi studiati, fare bilanci di
materia ed energia, interpretare correttamente grafici e tabelle, predisporre semplici schemi
d’impianto.
Obiettivi raggiunti
In linea generale la classe non si è accostata alla materia con la necessaria motivazione e curiosità; il
profitto non è sempre stato soddisfacente, frutto di un impegno discontinuo e poco convinto. Verso la
fine del secondo periodo, gli allievi hanno mostrato una certa volontà di recupero, tuttavia il profitto
medio complessivo risente di un impegno ritardato, non scostandosi dalla sufficienza.
Strumenti e metodologie
Lezione frontale
Testo in uso
Disegno di semplici impianti
Verifiche
Verifiche scritte, scritto – grafiche e grafiche
Esercizi ed esempi alla lavagna
Simulazioni della seconda prova scritta dell’esame di stato
Simulazione del colloquio orale
Criteri di valutazione
24Il riferimento è ai criteri di valutazione stabiliti in Consiglio di Classe ad inizio anno scolastico.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
ARGOMENTO SVILUPPO TEMPI
Richiami alla teoria dell’equilibrio liquido-vapore per un componente
puro: equazione di Clausius-Clapeyron ed equazione di Antoine e con
riferimento alle miscele ideali: legge di Raoult; espressione analitica
dell’equilibrio e rappresentazione grafica; deviazioni dal
comportamento ideale.
La rettifica continua in colonna a piatti: bilanci di materia, rette
operative in arricchimento ed in esaurimento, equazione retta di
alimentazione in relazione alle sue caratteristiche termiche;
costruzione del numero di stadi teorici con il metodo di McCabe e
Distillazione Thiele. Rapporto di riflusso e suo effetto sul funzionamento; riflusso Sett./
economicamente più conveniente. Nov.
Caratteristiche costruttive della colonna: tipi di piatti e criteri generali
di scelta; distanza tra i piatti, funzione di discendente e sfioratore per
un corretto regime fluodinamico. Stima di diametro ed altezza della
colonna. Efficienza della colonna e calcolo degli stadi ideali.
Schema semplificato d’impianto con le principali regolazioni.
Distillazione in colonne a corpi di riempimento: criteri generali di
scelta.
Distillazione flash, discontinua, stripping, estrattiva, azeotropica, in
corrente di vapore.
Il controllo di processo nella distillazione.
La solubilità dei gas nei liquidi – legge di Henry; equazioni di
trasferimento di materia – legge di Fick: coefficiente di trasferimento
globale.
Assorbimento e Caratteristiche delle colonne a corpi di riempimento; bilanci di materia, Nov./
stripping rapporto minimo fra le correnti fluide – corretto regime fluodinamico; Dic.
determinazione grafica del numero di stadi teorici nelle colonne a
piatti. Determinazione del diametro e dell’altezza delle colonne a corpi
di riempimento (attraverso numero ed altezza delle unità di
trasferimento).
Principali impieghi dell’estrazione liquido-liquido. Equilibrio di
ripartizione: modalità di conduzione dell’estrazione; coefficiente di
ripartizione e legge di Nernst.
Sistemi a totale immiscibilità tra solvente e diluente: estrazione a
singolo stadio; a stadi multipli a correnti incrociate e i controcorrente.
Sistemi a parziale miscibilità: diagrammi ternari; equilibri tra due fasi
ternarie; estrazione a singolo stadio; a stadi multipli a correnti
Estrazione incrociate e in controcorrente; calcolo del numero teorico di stadi di Dic./
equilibrio. Scelta del solvente. Gennaio
Principali impieghi dell’estrazione solido-liquido. Meccanismo
dell’estrazione solido-liquido: fattori che influenzano il processo.
Diagrammi ternari e bilancio di materia nell’estrazione solido-liquido:
suddivisione del miscuglio d’estrazione; linee di equilibrio.
Determinazione del numero degli stadi ideali: estrazione a singolo
25stadio; a stadi multipli a correnti incrociate e in controcorrente.
L’energia libera e il lavoro utile, condizioni termodinamiche per
l’equilibrio chimico, relazione tra energia libera, entalpia ed entropia;
calcolo della variazione di energia libera di una reazione.
L’affinità chimica delle sostanze; energia libera molare standard di
L’energia libera
formazione, energia libera di una reazione in soluzione; l’energia libera
dei sistemi materiali; coefficiente di attività, sistemi aperti a più Gennaio/
componenti; cenni al potenziale chimico. Febbr.
Variazione dell’energia libera in una reazione, l’equazione di Van’t
L’energia libera Hoff; la costante di equilibrio e i sistemi reali; l’importanza della
e gli equilibri funzione energia libera; l’isobara di Van’t Hoff, diagramma di Francis,
chimici l’energia libera e il mescolamento, diagrammi di Ellingham.
Equazione di Clapeyron, l’equazione di Clausius-Clapeyron; gli equilibri
L’Energia libera e tra fasi condensate, condizioni di stabilità delle fasi.
gli equilibri di
fase
Concetti fondamentali, velocità delle reazioni, legge della velocità delle
reazioni; equazione cinetica delle reazioni del primo ordine, tempo di
Cinetica delle dimezzamento, datazione dei reperti archeologici; equazione cinetica
reazioni delle reazioni del secondo ordine; equazione cinetica delle reazioni del
terzo ordine; reazioni di ordine zero; molecolarità e meccanismo delle
reazioni; cinetica dei sistemi complessi di reazioni.
Teoria della Legge della distribuzione delle velocità molecolari; teoria degli urti
cinetica delle molecolari, velocità di reazione e temperatura, l’equazione di
reazioni Arrhenius; interpretazione cinetico-molecolare della velocità di
reazione; teoria del complesso attivato.
Catalizzatori; caratteristiche generali della catalisi, catalisi omogenea
ed eterogenea, catalisi negativa; catalisi enzimatica, cinetica
Catalisi enzimatica, equazione di Michaelis-Menten; inibizione enzimatica ed
enzimi allosterici.
Caratteristiche fisiche e struttura chimica del petrolio. Classificazione
dei grezzi. Genesi dei petroli: ipotesi passate e teoria presente;
condizioni geologiche di formazione. Ricerca ed estrazione, su terra e
in mare del petrolio: prospezione del sottosuolo; estrazione del
petrolio.
Caratterizzazione del grezzo; caratteristiche e impieghi dei prodotti
Petrolio e petroliferi: prodotti gassosi, distillati leggeri, medi e pesanti.
combustibili Aspetti generali della lavorazione del petrolio; trattamenti preliminari. Marzo /
liquidi Frazionamento del grezzo: distillazione a pressione atmosferica Aprile
(topping); distillazione del residuo del topping a pressione ridotta
(vacuum). Caratteristiche delle benzine: natura e proprietà; potere
antidetonante. Processi petroliferi: cracking catalitico, reforming
catalitico, alchilazione, isomerizzazione.
Processi di raffinazione di combustibili liquidi: desolforazione di gas e
benzine; operazioni di conversione: visbreaking e hydrocracking.
26Processi petrolchimici: produzione di olefine leggere (steam cracking).
Trattamento dei reflui.
Produzione dell’etanolo da etilene.
Classificazione dei polimeri; proprietà; caratteristiche e proprietà dei
polimeri allo stato solido. Preparazione dei polimeri: aspetti
Polimeri e termodinamici e stabilità dei polimeri; cinetica, meccanismi e
materiali catalizzatori usati nelle reazioni di polimerizzazione: reazioni di Maggio
polimerici polimerizzazione a stadi di equilibrio, reazioni di polimerizzazione a
catena. Tecnologie di produzione dei polimeri: polimerizzazione in
massa, in soluzione, in emulsione, in perle. Preparazione industriale di
alcuni polimeri: produzione del polietilene a bassa ed alta densità
(LDPE, HDPE), del polipropilene, del polistirene. Polimeri degradabili.
Lavorazione dei polimeri. Attivazione, Trasformazione dei polimeri e
loro finitura.
Caratteristiche generali e condizioni operative dei processi
biotecnologici: biocatalisi con cellule intere e con enzimi; cinetica di
accrescimento batterico – equazione di Michaelis-Menten.
Bilanci di materia; gli scambi di energia nelle reazioni biologiche.
Cinetica delle reazioni enzimatiche.
Reattori e sistemi di controllo: reattori batch, reattori continui, reattori
che sfruttano le tecniche di immobilizzazione. Recupero dei prodotti.
Processi biotecnologici; produzione di etanolo: microrganismi e vie
metaboliche, materie prime e processi.
Caratteristiche generali e condizioni operative dei processi
biotecnologici: biocatalisi con cellule intere e con enzimi; cinetica di
accrescimento batterico – equazione di Michaelis-Menten.
Successione degli stadi unitari nelle produzioni biotecnologiche. Varie
tipologie di bireattori e relativo sistema di controllo. Produzione di
antibiotici: caratteristiche e fasi del processo; schema semplificato
dell’impianto.
Inquinamento delle acque naturali: problema ambientale; origine ed
effetti sull’ambiente delle acque inquinate. Caratterizzazione delle Aprile/
Biotecno- acque di scarico civili: carico organico e idraulico ; carico in solidi.
logie Maggio
Schema generale degli impianti di depurazione delle acque reflue civili.
Ossidazione biologica a fanghi attivi: caratterizzazione della biomassa.
Parametri per il dimensionamento. Problemi di esercizio. Produzione di
fango di spurgo. Fabbisogno di ossigeno nell’aeratore. Rimozione dei
nutrienti: nitrificazione; denitrificazione; eliminazione dei composti
fosforiti. Trattamento dei fanghi. Digestione anaerobica e produzione
di biogas: microrganismi e reazioni, condizioni operative nella
digestione; produzione di biogas; apparecchiature ed impianti;
dimensionamento.
Produzione dell’etanolo per via fermentativa: materie prime; processo
fermentativo; recupero dell’etanolo dai liquidi di fermentazione.
Produzione degli amminoacidi (L-lisina, D,L-metionina).
Produzione della birra (processo completo).
27Modulo CLIL - Catalysis by enzymes
Dato il carattere sperimentale di questa sezione si è scelto di svolgere il modulo secondo un approccio
innovativo che fa riferimento a contenuti multimediali reperibili in rete.
In modo particolare ci si è riferiti a due video disponibili ai seguenti indirizzi:
https://www.youtube.com/watch?v=A_PhvIktMOw
Produced with Southampton University, this video is designed to introduce the concepts of Catalysis
and how we use Catalysts in everyday scenarios
https://www.youtube.com/watch?v=NdMVRL4oaUo
Mr. W’s Enzyme Song by Science Music Videos
I video utilizzati introducono gli argomenti del modulo l’uno attraverso il testo di una canzone rap, il
secondo propone invece una trattazione più approfondita, facilitata però dalla mediazione
multimediale.
A partire dagli argomenti trattati i ragazzi sono in grado di articolare un’esposizione a partire dalle
seguenti domande
1. What are enzymes?
2. What is a catalyst?
3. What is the suffix used to identify the specificity of certain enzymes?
4. Which is the region where the catalytic activity occur ?
5. Why is it difficult to know the details of the mechanism of enzyme catalysed reactions?
6. What are the kinetic evidences we can study in order to understand the mechanism of those
reactions?
7. What does it mean?
8. Try to explain table 63 and say something about its conclusions
Il testo di riferimento è stato Laider, Chemical Kinetics, TMH Edition
28ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTE: RINO URBINATI
L’attività di Scienze Motorie svolta nel corso dell’anno scolastico nella classe 5° A ha mirato a
soddisfare i bisogni formativi e didattici degli alunni, cercando di far vivere loro esperienze significative
sul piano corporeo (sia collettive sia individuali) in grado di promuovere un miglioramento delle
conoscenze, capacità e competenze motorie per concorrere alla formazione globale dello studente con
piena consapevolezza di sé e del proprio corpo.
L’attività pratica proposta si è articolata principalmente in due momenti:
1°) Attività motoria generale che mirava a consolidare le capacità motorie e le qualità fisiche quali la
resistenza (funzione cardio-respiratoria), la forza (potenza muscolare), la destrezza, la velocità e la
mobilità articolare. Tale attività, prevalentemente svolta a corpo libero, si è espressa attraverso
esercizi di pre-atletismo generale, di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare finalizzati
al benessere psico-fisico al raggiungimento ed alla conservazione della piena efficienza fisica per uno
sviluppo integrale della persona.
2°) Attività sportiva e giochi di squadra che prevedeva la conoscenza e la pratica di alcuni giochi di
squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio 5 e ultimate. Quelli svolti maggiormente sono
stati la pallavolo, il basket e il calcio a cinque, con i loro fondamentali individuali e collettivi
finalizzati alla partita, l’applicazione del regolamento e l’arbitraggio. Nel secondo periodo dell’anno
la classe ha svolto 6 lezioni presso il centro sportivo Garden dove gli alunni hanno potuto provare
discipline quali il beach tennis, beach volley, nuoto, palestra attrezzata e fit boxe. Si sono prediletti
gli sport di squadra in quanto, in genere, consentono di coinvolgere un numero maggiore di alunni
favorendo la socializzazione e richiamano l'attenzione sui diversi ruoli e sulle diverse capacità
individuali; inoltre la competizione collettiva porta a verificare l'impegno, l'applicazione personale e
la necessaria osservanza delle regole da parte di tutti i partecipanti presupposto indispensabile per
la riuscita di qualsiasi gioco sportivo.
In un piano più generale di educazione al benessere e allo sport come abitudine di vita,
parallelamente al lavoro motorio, svolto in palestra, si sono fornite agli alunni nozioni teoriche sulla
tutela della salute, in particolare sull’educazione alimentare (principi e funzioni alimentari) e
soprattutto sull’importanza di un’adeguata attività fisica (conoscenza e allenamento delle capacità
motorie) per la prevenzione delle malattie dell’apparato muscolo-scheletrico e cardiocircolatorio. Si
sono poi trattate le linee fondamentali del primo soccorso e i principi base della sicurezza e
dell’igiene negli ambienti di lavoro che hanno richiamato conoscenze di anatomia, fisiologia e
patologia relative ai vari apparati e sistemi.
29La classe ha partecipato all’incontro con i referenti dell’AVIS (Dottore centro trasfusionale e
operatori) che hanno illustrato l’importanza sociale della donazione. Sono seguite 2 lezioni con i
volontari della Croce Rossa sui principi fondamentali del primo soccorso.
Rimini 14/05/2015 l’insegnante di Sc. Motorie Prof. Rino Urbinati
30ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE 5a A CHIMICA
DOCENTE: MANUELA MORRI
Meta ultima ed obiettivi generali
Utilizzando un'espressione dei “Programmi di Religione per la SMI”, possiamo dire che la meta ultima
dell'Insegnamento della Religione Cattolica è “Lo sviluppo della personalità dell'alunno nella
dimensione religiosa”; che comprende i seguenti obiettivi generali:
L'accostamento critico al fatto religioso, e specificamente a quello cristiano, con il conseguimento
delle informazioni necessarie per una conoscenza adeguata di esso.
L'acquisizione degli atteggiamenti tipici della ricerca religiosa necessari per sviluppare correttamente
tale percorso.
L'apprendimento dell'uso degli strumenti necessari per la questa ricerca, specialmente degli strumenti
di comunicazione.
Obiettivi specifici
Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso gli strumenti propri di un'educazione religiosa realizzata
nella scuola.
Deve essere progressivamente realizzata una conoscenza oggettiva e proporzionalmente esaustiva del
fatto religioso, giungendo alla conoscenza dei contenuti della fede cristiana e di quanto può essere
globalmente chiamato “esperienza cristiana”.
Deve essere sviluppato il confronto e la ricerca sulle altre esperienze religiose e su tutti gli altri
strumenti filosofici di interpretazione della realtà per portare gli allievi ad una conoscenza critica del
“fatto religioso” nella sua globalità
L’analisi oggettiva e sistematica del fatto religioso non può però ignorare le problematiche personali
degli allievi. Ciò esige che l’approfondimento del discorso religioso sia fatto sempre in dialogo con la
loro situazione esistenziale.
Devono essere infine acquisiti gli atteggiamenti giusti per la ricerca religiosa: lealtà nei confronti della
verità, attenzione ai problemi esistenziali più profondi, capacità di ascolto e di riflessione, coraggio e
costanza nella ricerca, apertura alla gratuità, disposizione all'oblatività, senso del proprio
limite/umiltà...
Nuclei tematici (contenuti)
Classi Quinte: “Il problema etico”
Una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell' autorità.
L'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, del primato della
carità.
Il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per una promozione
dell'uomo nella giustizia e nella verità.
Il futuro dell'uomo e della storia verso i "cieli nuovi e la terra nuova".
Strumenti didattici
Gli obiettivi ed i nuclei tematici esposti sono stati sviluppati attraverso la realizzazione di unità
didattiche specifiche. Nella realizzazione di tali itinerari di lavoro sono stati utilizzati vari strumenti
didattici come: lezioni frontali, schemi alla lavagna, cartelloni, giochi didattici di animazione, fotocopie,
discussioni guidate, test, documenti dattiloscritti, sussidi audiovisivi, lettura e studio del libro di testo.
Valutazione
Gli alunni sono stati valutati in base a criteri, quali: la conoscenza dei contenuti affrontati nelle lezioni,
la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse mostrato verso l’attività didattica in generale. Per
tale valutazione vengono utilizzati: test di verifica delle conoscenze, colloqui informali, controllo
periodico dei quaderni, ecc.
31Puoi anche leggere