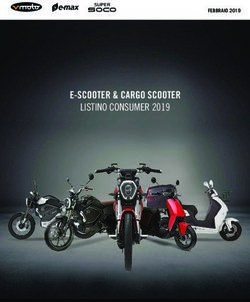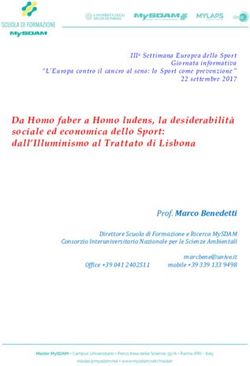LO SPORT PER TUTTI COME POSSIBILE STRATEGIA DI INCLUSIONE SOCIALE - Indagine condotta sulla Provincia di Torino A cura del Prof. Nicola Porro
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LO SPORT PER TUTTI
COME POSSIBILE STRATEGIA
DI INCLUSIONE SOCIALE
Indagine condotta sulla
Provincia di Torino
Novembre 2003
A cura del
Prof. Nicola PorroPresentazione
E' con riconoscenza e con soddisfazione che, in qualità di direttore del progetto di
ricerca, presento questo rapporto conclusivo. Si tratta di un lavoro collettivo, dedicato
a un’analisi non convenzionale del sistema sportivo territoriale come possibile
protagonista di politiche di inclusione.
L'indagine, commissionata dalla Provincia di Torino, è stata realizzata da un gruppo
di ricerca afferente all'Università di Cassino.
La nostra riconoscenza va quindi all'Amministrazione provinciale, e in particolare
agli assessori competenti, dott.ssa Silvana Accossato e dott.ssa Maria Pia Brunato,
che hanno voluto raccogliere l'idea di una rilevazione empirica sul fenomeno, la
prima del genere prodotta nel nostro Paese, e permetterne la realizzazione attraverso
un'indagine condotta sul campo, in stretto contatto con dirigenti, esperti e operatori
del settore. La gratitudine del gruppo di lavoro si estende perciò, e non si tratta di un
riconoscimento protocollare, ai diversi protagonisti dello sport sociale torinese che
hanno messo il loro tempo, la loro pazienza e la loro sensibilità culturale a
disposizione dei nostri ricercatori. Se questo lavoro si dimostrerà capace, come
speriamo, di produrre esiti scientifici e magari di ispirare qualche possibile traduzione
operativa, lo si dovrà principalmente alla loro collaborazione. Mentre solo nostra
sarà, come è giusto, la responsabilità di un'inadeguata o imprecisa recezione degli
input che hanno inteso trasmetterci.
La soddisfazione che voglio esprimere riguarda invece l'approccio metodologico che
con questa ricerca abbiamo cercato di inaugurare. Certo non spetta a noi giudicare la
qualità del prodotto finale, ma mi sia consentito evidenziare il tratto innovativo del
lavoro condotto. Esso è consistito principalmente nel tentativo di integrare e far
interagire due diverse tradizioni di analisi.
Da un lato, si è fatto ricorso agli strumenti della classica sociologia qualitativa -
interviste focalizzate, focus group di valutazione, analisi della cosiddetta letteratura
grigia -, cercando di sottrarre la rilevazione al puro assemblaggio dei pur necessari
dati statistico-descrittivi. L'idea guida è quella, su cui si è fondata l'emancipazione
della sociologia del Novecento dalle discipline strumentali come la statistica e la
demografia, che "i dati non parlano da sé". I fatti emergenti dall'analisi descrittiva dei
fenomeni, al contrario, vanno sistematicamente interrogati, attingendo a quella fonte
primaria che è rappresentata dagli osservatori privilegiati.
Dall'altro, si è provato ad applicare al fenomeno sportivo diffuso i metodi propri di
quel filone di studi - ispirato alla scienza politica - che va sotto il nome di policy
analyis. Con l'obiettivo di individuare, al crocevia fra spontanea espansione della
cultura della pratica e dinamiche di riforma della Pubblica Amministrazione, un
concreto punto di riferimento per possibili politiche di settore.
Sforzandoci di tenere insieme l'interpretazione dei processi e la ricostruzione delle
logiche di governo amministrativo - in una stagione di radicali trasformazioni del
sistema gestionale pubblico - abbiamo così voluto sperimentare una metodologia
assolutamente inedita in Italia.
2Il tentativo, niente affatto accessorio, di sollecitare una riflessione sul tema del
governo della complessità e dei suoi strumenti operativi, va del resto molto al di là
della specifica tematica sportiva. Ai ricercatori non compete interferire nelle opzioni
dei decisori pubblici, del resto sempre più condizionate da costrittivi vincoli di
bilancio. Stimolare una riflessione prospettica, segnalare esperienze e possibili
percorsi per l'innovazione - consapevoli di non poter fornire altro che ipotesi di
lavoro da sottoporre alle impietose verifiche delle compatibilità amministrative - è la
sola ambizione della nostra indagine.
Rinnovando a nome dell'intero staff di ricerca il ringraziamento e l'apprezzamento
per il contributo di tutti gli osservatori privilegiati che abbiamo avuto il piacere di
avvicinare, mi sia permesso conclusivamente ringraziare quanti hanno concorso,
ciascuno per la propria parte, a realizzare il progetto.
Le colleghe professoresse Gabriella Arena e Silvana Casmirri hanno concretamete
sostenuto, per conto del mio Dipartimento universitario, il progetto loro sottoposto e
le sue traduzioni operative, mettendo a disposizione il prezioso supporto
amministrativo della responsabile del settore, dott.ssa Filomena Valente, nonché una
indispensabile integrazione finanziaria al nostro budget.
La professoressa Giovanna Gianturco, dell'Università di Roma La Sapienza, ha
curato la strumentazione metodologica dell'indagine qualitativa e la realizzazione di
non poche interviste focalizzate. A lei si deve anche la nota metodologica che
presentiamo a corredo del lavoro.
Le dottoresse Rosanna d'Iorio, Paola Pappalardo e Dascia Sagoni, con i dottori Eros
Cosentino e Luigi Pietroluongo e con il supporto tecnico-scientifico del Cirsel
(Centro Internazionale per le Ricerche sullo Sport E il Loisir), hanno concretamente
realizzato buona parte del lavoro di raccolta dei materiali empirici e di elaborazione
delle informazioni, nonché la presentazione grafica dei testi.
Un sincero ringraziamento, infine, al personale della Provincia di Torino che ha
fattivamente facilitato il nostro lavoro e accompagnato con simpatia e disponibilità il
nostro tentativo di "immersione" nel contesto locale.
Cassino novembre 2003
Nicola Porro
34
Premessa
Pensare o ripensare le strategie d’intervento dei poteri locali in materia di
inclusione sociale appare concettualmente difficile senza preventivamente affrontare
la necessità di una ridefinizione del contesto di riferimento. In altre parole: possiamo
ancora fare riferimento a nozioni come quelle di città metropolitana, di ente
intermedio, di ambito subregionale e tutte le altre che hanno di volta in volta
aggiornato il lessico amministrativo della politica? E possiamo ancora sforzarci di
analizzare il rapporto fra istituzioni e cittadinanza al di fuori delle trasformazioni
intervenute sul terreno della legislazione territoriale? Trasformazioni, va ricordato,
che hanno interessato la stessa legge fondamentale dello Stato, con la modifica del
titolo V della Carta costituzionale.
L’attenzione allo sport come nuovo, potenziale diritto di cittadinanza va d’altronde
intesa come una concreta e innovativa strategia dell’inclusione. La quale si rivolge,
appunto, a nuovi cittadini della pratica fisico-motoria, cioè a soggetti individuali e
collettivi (anziani, immigrati, disabili, giovani a rischio e tutte quelle aree di
popolazione esposte al pericolo della marginalità) non appartenenti al classico
sistema della prestazione agonistica. Lo sport, cioè, può diventare, come spiega
Silvana Accossato, assessore al turismo e allo sport della Provincia di Torino:
“…elemento di socialità e aggregazione delle diverse fasce di età e anche dei territori; delle
comunità, dei quartieri, attorno a polisportive, piuttosto che all’aperto. Possono nascere
aggregazione sociale, interessi condivisi, volontà di partecipazione dei cittadini alla gestione che
ovviamente, sono l’elemento di miglioramento”.
I due aspetti della questione - la ridefinizione del contesto e delle strategie di
azione dei poteri locali, da un lato, e la sperimentazione dello sport come strategia di
inclusione sociale, dall’altro - appaiono necessariamente connessi e meritevoli di una
preliminare riflessione.
Si tratta, insomma, di inserire a pieno titolo lo sport nella cornice delle politiche
sociali e di definire più precisamente quale tipo di politiche sociali, orientate
all’inclusione, possano rientrare nelle competenze e nel raggio d’azione dei poteri
amministrativi locali. Tenendo d’occhio quella complessa dinamica sociologica che
interessa non solo la dimensione burocratico e funzionale del problema, ma anche il
silenzioso ridisegno dei suoi confini culturali e sociali.
Le conclusioni della ricerca che qui proponiamo non hanno, come è ovvio, la
pretesa di fornire risposte esaustive e perentorie a questioni tanto delicate e persino
controverse, sia sotto il profilo della teoria sociale sia dall’angolo visuale della
politica istituzionale. L’ambizione è piuttosto quella di individuare, circoscrivere ed
esplicitare, sulla base delle informazioni e delle testimonianze raccolte con
complementari metodi di indagine sociologica, le domande che i poteri locali, nella
loro autonoma responsabilità, potrebbero trovarsi di fronte in un breve volgere di
tempo. Domande che richiedono strategie di risposta, flessibilità di analisi e costante
attenzione ai mutamenti. È questo il possibile contributo che è lecito attendersi dal
5lavoro di ricercatori che non hanno, e non possono avere, la pretesa di sostituire le
loro indicazioni alle legittime e sovrane ragioni delle responsabilità politiche. Lo
scopo dell’indagine è piuttosto quello di fornire stimoli e strumenti scientificamente
adeguati all’autonoma elaborazione delle strategie politiche degli attori istituzionali.
Si tratta ora, perciò, di elencare le questioni cruciali sulle quali soffermeremo la
nostra attenzione.
1. Entro quale contesto territoriale di riferimento una strategia pubblica di
inclusione attraverso lo sport può trovare senso e prospettiva? Le tradizionali unità
amministrative (circoscrizioni, comuni, province, regioni ecc.) coincidono con gli
spazi sociali entro i quali possono dispiegarsi efficaci esperienze di attività?
2. A quale configurazione socio-politica è possibile e utile assegnare la pratica
sportiva non identificata nella tradizionale attività agonistica di tipo federale
(discipline di prestazione assoluta, orientate al primato del risultato tecnico e a un
target di potenziali “atleti”), o comunque non riducibile ad essa?
3. Quale rete di attori organizzativi – istituzioni, sistema dell’associazionismo,
circuiti informali di varia natura, media – sono coinvolti in una politica di settore che
aspiri a farsi sistema? Possiamo parlarne come di un terreno privilegiato di
sperimentazione del Welfare Mix?
4. In una logica di regolazione a rete, quali dinamiche di governo partecipato
(Governance) potrebbero e/o dovrebbero sostituire le tradizionali strategie di pura
erogazione di benefici finanziari e strumentali (concessione di impianti, contributi
ecc.), che rientrano nella categoria di Government? E quali competenze, risorse e
poteri d’intervento sono oggi a disposizione degli amministratori chiamati a
cimentarsi con la sfida del federalismo? Possiamo descrivere l’azione amministrativa
rivolta allo sport come espressione di un nuovo approccio, orientato al risultato più
che alle procedure, cioè come una delle possibili politiche di seconda generazione?
1. La dimensione sociale dei sistemi urbani e lo sport.
Alcuni fra i più acuti analisti dei fenomeni urbani hanno da tempo richiamato
l’attenzione sulla rottura di quella che Magnier e Russo (2002) chiamano la filiera
delle istituzioni di governo territoriali. Nella logica della politica e
dell’amministrazione europee di matrice ottocentesca, sopravvissuta pur fra molti e
non irrilevanti assestamenti sino all’ultimo ventennio del XX secolo, le istituzioni
sovranazionali, lo Stato Nazione, le regioni (o le entità subnazionali loro
corrispondenti), le province (o le entità subregionali loro corrispondenti) e le “città”
si collocavano lungo una sequenza strutturale, che configurava di fatto una gerarchia
politico-funzionale. Gerarchia non rigorosamente modellata sullo schema della
piramide. Il vero vertice politico era infatti rappresentato dallo Stato Nazione,
monopolista nella sfera legislativa e detentore non solo dei poteri materiali (la
moneta, il fisco, la forza militare), ma anche delle risorse simboliche capaci di
legittimare l’azione dei governi locali. Allo stesso tempo, però, sistema di relazioni
6strutturate e interdipendenti, capace di plasmare la stessa percezione dell’autorità da
parte dei cittadini.
Con il tempo, e con un’accelerazione crescente a partire dagli anni Ottanta del
secolo scorso, quel paradigma si è incrinato sin quasi a spezzarsi. Importanti, al di là
degli slogan, sono stati gli effetti del processo di globalizzazione, a cominciare dalla
rivoluzione che ha investito il rapporto spazio-tempo con lo sviluppo e la diffusione
di massa delle tecnologie della comunicazione. Conseguenze altrettanto rilevanti ha
avuto lo stress organizzativo che ha colpito tutti i sistemi a elevata (e crescente)
complessità in rapporto al diversificarsi e moltiplicarsi delle domande sociali. Il
combinato disposto di simili dinamiche ha rapidamente destabilizzato quel profilo di
ruoli, gerarchie e responsabilità che aveva seguito e caratterizzato, in Europa
occidentale, l’avvento e il consolidamento dello Stato Nazione. Sopravvivendo
vittoriosamente a due guerre mondiali, a impetuosi processi di democratizzazione, a
trasformazioni significative dei valori e degli stili di vita a livello di massa. A quelle
che, con altre parole, sono state definite le diverse e successive “ondate” della
modernizzazione novecentesca. Scrivevano in proposito Ceri e Rossi (1987) alla fine
degli anni Ottanta:
…le industrie e le attività produttive non hanno più bisogno di concentrarsi in determinati
luoghi: hanno soltanto bisogno di essere collegate, ma a ciò provvedono le vie di comunicazione e,
in misura crescente, le reti informatiche. Anche il potere politico, pur rimanendo localizzato in
istituzioni che hanno sede nelle capitali e nelle altre città, pur traendo da questa localizzazione parte
del suo residuo significato simbolico, non riveste più un carattere specificamente urbano. I mezzi di
comunicazione di massa hanno sostituito il rapporto diretto tra la classe politica e il resto della
popolazione, l’intervista televisiva ha preso il posto del comizio o dell’adunata; mentre
l’informatica provvede alla raccolta e alla trasmissione dei dati necessari al funzionamento
dell’apparato amministrativo. La città sta così cessando di essere il luogo del potere non già perché
si sia trasferito altrove, ma perché il potere non richiede più un centro fisico in cui insediarsi e da
cui espandersi …(pp. 580-581).
A questa rappresentazione del declino della funzione delle città – quella che
Leonardo Benevolo ha descritto, da urbanista, come entropia della metropoli (la città
che non serve più a economizzare tempo concentrando entro uno spazio
topograficamente delimitato i gangli delle attività economiche e del potere politico o
spirituale, come la chiesa, il municipio e il mercato, bensì a disperderlo, causa la
congestione e il collasso indotti dal traffico e dalla pressione antropica) – si
accompagna la tendenza al traboccamento demografico. Nascono costellazioni
urbane e semiurbane nell’hinterland, si smarrisce la distinzione città-campagna, le
aree rurali non urbanizzate sono fagocitate dall’espansione di strutture metropolitane
che, a loro volta, riproducono la campagna in forme artificiali. Trasformazioni che
interessano da vicino, le une come le altre, le opportunità di pratica sportiva e fisico-
motoria. Così come interessano la qualità della vita in senso lato, originando
domande inedite di mobilità alternativa (le piste ciclabili), di pratica salutistica (i
percorsi vita) o di animazione sociale (le domeniche ecologiche in tutte le loro
possibili varianti con il loro contorno di eventi sportivi e parasportivi in ambiente
urbano).
7Al gruppo di ricerca che ha condotto questa indagine pare più corretto ed
euristicamente convincente assumere, in luogo di definizioni più tradizionali ma
meno dotate di potenziale descrittivo (come città o provincia metropolitana), la
nozione di sistema urbano in quanto contesto di riferimento analitico. Ciò soprattutto
in rapporto a quella dimensione culturale e sociale, evidenziata dalla ricerca, che
riguarda lo sport come espressione insieme di antichi bisogni di identità ed
espressività (compreso il municipalismo delle tifoserie dei giochi di squadra più
popolari) e di nuove esigenze, connesse alla diffusione massiccia della pratica e alle
domande di senso – individuali e collettive – che ad essa si indirizza.
Parlare di sistemi urbani, a diversi livelli di interconnessione funzionale con la
filiera istituzionale dei poteri (la regione, la provincia, il comune, le circoscrizioni) e
a differenti livelli di complessità, consente di meglio cogliere e rappresentare i
mutamenti intervenuti in quelle aree del più ampio sistema sociale che la sociologia
classica, edificata sul modello ordinatore dello Stato Nazione, impietosamente e
sbrigativamente liquidava come Periferia. Al punto che proprio sull’opposizione
Centro-Periferia la Scienza politica degli anni Settanta aveva costruito una delle
principali chiavi interpretative della nazionalizzazione (Rokkan, 1970).
Oggi è esattamente il nuovo protagonismo di variegati attori sociali urbani a
rendere non più fungibile quel modello. La Periferia si è fatta Centro, rivendicando e
spesso ottenendo poteri un tempo monopolizzati dallo Stato Nazione. Nello stesso
tempo, però, lo Stato si è fatto Periferia nel contesto di più strutturate e inedite
autorità sovranazionali. Se il governo della moneta e il controllo del fisco e della leva
militare identificavano simbolicamente i poteri del vecchio Stato Nazione, l’Europa
della moneta unica, dei vincoli di Maastricht e degli eserciti professionali, cioè un
continente in via di integrazione, può davvero definirsi - secondo la felice formula
coniata da Jürgen Habermas (1998) - una costellazione postnazionale. Ma nelle
trasformazioni che sono intervenute nella sfera politica e istituzionale hanno giocato
un ruolo decisivo i mutamenti del costume e della cultura. Nessuna Governance è in
grado di sostituirsi efficacemente alle vecchie strutture di Government se la sua
concreta strutturazione formale e operativa non intercetta bisogni diffusi e domande
di rappresentanza. Se non si misura con il nuovo protagonismo di attori collettivi, i
quali non sono necessariamente modellati sui classici paradigmi dell’azione
istituzionale urbana. I cittadini che fanno sport e che, con diverse motivazioni,
attitudini e disponibilità, danno vita a esperienze non solo di pratica, ma di
aggregazione sociale (formale o informale), appartengono a questa tipologia di attori.
Si devono a loro la proliferazione delle società, la consistente espansione – e con essa
la prevedibile istituzionalizzazione – dell’offerta veicolata dalle reti associative,
l’indubbia rilevanza che lo sport ha acquistato nell’agenda politica dei poteri locali, in
Italia come in altri Paesi. In un contesto caratterizzato dal declino del ruolo ordinativo
del sistema federale di prestazione, dal tracollo finanziario dei concorsi pronostici
alla crisi di rappresentatività del Coni. Quelle che si sono modificate, in sostanza,
sono le tradizionali modalità di offerta della pratica sportiva italiana. Le turbolenze
che hanno interessato le serie maggiori del calcio professionistico alla vigilia dei
8campionati 2002/03 e 2003/04, al di là delle specifiche (e in sé poco edificanti)
vicende che hanno evidenziato, costituiscono anche la dimostrazione del collasso di
un ormai anacronistico sistema di organizzazione e gestione del “grande sport”. I cui
effetti critici si riverberano sul sistema sportivo tout court, compreso appunto
l’ambito della pratica amatoriale e dilettantistica.
Analizzare il caso torinese alla luce del sistema sportivo urbano significa perciò
impegnarsi a far interagire attori e processi, così come ci sono consegnati (1) dalle
testimonianze degli opinion leader locali, (2) dall’autoriflessione degli attori
coinvolti, stimolata attraverso il ricorso ai focus group e (3) dall’esame della storia
politico-amministrativa, la cosiddetta letteratura grigia che dovrebbe fare da sfondo a
ogni indagine di questo genere.
Per certi aspetti, ricostruire la storia e le pratiche dello sport locale in un contesto
urbano così ricco di cronache e di memorie e insieme così esposto a dinamiche di
trasformazioni, significa anche individuare un potenziale punto di osservazione per
indagare le più complessive dinamiche socioculturali.
Il caso di Torino, ad esempio, è stato a lungo indagato dalle scienze sociali e dagli
studi demografici come un caso di declino urbano, così come le ricerche degli anni
Settanta e, più tardi, l’importante riflessione di Cheshire e Hay (1989) ce lo hanno
descritto.
Secondo questo approccio, esiste in Europa occidentale una fascia di città di più
antica industrializzazione che da Torino e Genova, procedendo verso nord,
comprende la Francia nord-orientale, le regioni tedesche della Saar e della Ruhr e
l’Inghilterra settentrionale, per spingersi sino a Glascow e Belfast. È quella che viene
chiamata la striscia del malessere demografico, per quel crescente declino della
natalità che, da circa trent’anni a questa parte, si accompagna alla contrazione del
settore manifatturiero, non compensata dallo sviluppo del settore terziario. Torino e la
sua provincia rappresentano però anche un caso che non è del tutto assimilabile a
quello della maggior parte dei sistemi urbani sopra elencati. Perché a Torino è attiva,
malgrado il declino demografico e il crescente ridimensionamento del settore
manifatturiero, una dinamica che andrebbe più propriamente definita di
conurbazione. Un sistema, cioè, in cui l’agglomerazione urbana possiede leggibili
gerarchie interne, come dimostra il fatto che il centro capoluogo conservi un forte
potere direzionale anche nella sofferta transizione a un’economia di servizi.
La città di Torino, in tal senso, assolve virtualmente un ruolo strategico di
collegamento e di collaborazione nell’ambito della filiera istituzionale dei poteri
territoriali. Un importante banco di prova è rappresentato, in tal senso, proprio dalla
preparazione di un evento sportivo di prima grandezza e che interessa l’ambito
provinciale: le Olimpiadi invernali del 2006.
Afferma Patrizia Alfano, presidente provinciale UISP Torino:
“Torino, come dire, ha questa caratteristica di città di riferimento di tutta la regione non solo
della provincia, è come una regione che ha un’unica grande città e tanti paesi. Torino però è anche
un grande punto di riferimento sia dal punto di vista lavorativo sia delle università; […] ogni
9mattina arrivano migliaia e migliaia di pendolari che la sera se ne ritornano. Le attività produttive
sono concentrate prevalentemente nella città, quindi tutto quello che noi riusciamo a produrre a
Torino a livello di progetti di visibilità d’immagine ha una ricaduta sulla provincia. Lo dimostra il
fatto che in provincia ci siano dei comitati che lavorano capillarmente sul territorio”.
Se Torino non è più (se mai lo è stata) riducibile al puro paradigma della one
company town, l’area provinciale si configura come un’unità spaziale urbana
gerarchizzata, ma anche potenzialmente aperta alla sperimentazione di un sistema
reticolare. Ciò smentendo, almeno in parte, la tipologia dei sistemi urbani che - sulla
base di un modello matematico elaborato nel 1991 dal Governo olandese (Ministero
dell’Ambiente) collocava Torino nella “terza fascia” delle metropoli europee. Quella
denominata delle eurocittà, il cui ruolo sulla scena internazionale sarebbe limitato ad
alcune peculiari funzioni. (1)
La diffusione sociale dello sport negli ultimi venti-trent’anni e i mutamenti
culturali che l’hanno caratterizzata rispetto al vecchio paradigma, centrato sul primato
dell’agonismo tradizionale, concorrono a disegnare il profilo di una relazione
sociologicamente significativa fra metropoli e hinterland. Una relazione che presenta,
però, caratteri problematici ancora in parte da approfondire. L’analisi delle politiche
locali è uno strumento prezioso per ricostruire le dinamiche di mutamento che sono
intervenute nel tempo in questo peculiare rapporto fra centro metropolitano e contesto
urbanizzato a perimetro provinciale. Le politiche locali - non necessariamente e non
esclusivamente quelle a sostegno della pratica sportiva - disegnano infatti il profilo e
le gerarchie dell’attenzione che le istituzioni amministrative hanno, o non hanno,
conferito al fenomeno nell’arco temporale che va, grosso modo, dalla metà degli anni
Settanta a oggi. I soggetti organizzati che hanno cercato di interpretare e sviluppare
strategie più o meno orientate alle nuove culture dello sport e della corporeità - dal
circuito profit all’associazionismo di sport per tutti, sino alle strutture tradizionali
afferenti alle istituzioni militari, religiose, aziendali o universitarie costituiscono
attori niente affatto secondari delle trasformazioni sociali proprie dei nuovi sistemi
urbani. È un aspetto che viene ormai sottolineato non solo dagli studiosi del
fenomeno sportivo, ma dagli stessi ricercatori interessati ad aggiornare le categorie di
analisi e le tipologie descrittive dei sistemi territoriali. Sotto il profilo politologico, si
tratta di un’interazione fra mutamento socioculturale, politiche istituzionali e azione
di soggetti specializzati che rinvia alla categoria di Welfare Mix. Cioè a quel
fenomeno di progressiva strutturazione a rete di un sistema di relazioni politiche,
sociali e istituzionali sempre più complesso, in cui le politiche pubbliche sviluppate a
raggio locale divengono il prodotto a responsabilità e gestione condivisa di attori
diversi. Riservando ai poteri amministrativi la funzione nevralgica, ordinamentale e
di indirizzo, delle politiche, ma declinandola sempre più come il prodotto di una
costante e flessibile azione di mediazione culturale.
102. Le nuove tipologie della pratica. Lo sport è una politica di seconda
generazione?
Prima di rapportarci alle indicazioni che emergono dagli allegati di ricerca, occorre
forse richiamare qualche dato complessivo sulla pratica sportiva e l’attività fisico-
motoria in Italia. A evitare una lunga e complicata dissertazione sui controversi criteri
e le metodologie di rilevazione della pratica sportiva diffusa, faremo riferimento
soltanto ai dati più recenti e alla sola fonte ufficiale giudicata in qualche modo supra
partes. Sono i dati ricavabili dall’indagine “I cittadini e il tempo libero”, realizzata
dall’Istat nel dicembre 2000 (report on line, febbraio 2003) intervistando un
campione rappresentativo di famiglie italiane, pari alla ragguardevole cifra di
ventimila unità. L’interesse di tale indagine ai nostri fini consiste nel fatto che l’Istat
ha deliberatamente escluso tutti i soggetti in qualche modo “professionali” - non solo
gli atleti dello sport spettacolo, ma anche docenti e allenatori, tecnici e manager -, per
concentrarsi esclusivamente sulla popolazione di età superiore ai tre anni e sulle
eventuali modalità di esercizio-fruizione dell’attività sportiva e fisico-motoria. In
senso generale, possiamo perciò considerare lo spaccato che l’Istat ci consegna come
un primo, importante tentativo, di disegnare il perimetro sociale dello sport per tutti
italiano.
Gli intervistati che dichiaravano di praticare qualche attività erano invitati ad
autocollocarsi entro una delle due tipologie di pratica proposte: quella dei praticanti
con continuità e quella dei praticanti saltuari.
È interessante sottolineare le implicazioni del metodo della autoclassificazione.
Infatti, non fornendo alcun riferimento descrittivo ai concetti di continuità e
saltuarietà, si è prodotta una radiografia implicita del significato che ciascun
intervistato attribuisce alla propria idea di sport. Significato sociologico e psicologico
che non necessariamente coincide con una definizione procedurale e formale, la quale
è invece essenziale per una rappresentazione statistico-descrittiva. Oppure, viceversa,
per monitorare le esigenze dello sport di prestazione ad alto contenuto tecnico in una
prospettiva puramente empirico-strumentale.
Solo successivamente si chiedeva, infatti, quanti allenamenti a settimana venissero
sostenuti, se l’intervistato prendesse abitualmente parte a competizioni di varia
natura, se fosse affiliato a qualche società e altre informazioni utili come indicatori di
partecipazione strutturata.
L’ipotesi di lavoro che qui si vorrebbe avanzare è che, in qualche modo, i dati
percettivi - o meglio: autopercettivi - posseggano anche in questo caso una forte
valenza ottativa. Registrino, cioè, non solo le soggettive rappresentazioni degli
intervistati, ma anche l’aspirazione dei cittadini non atleti ad attribuire senso e valore
all’impiego del tempo libero. E, con esso, al rapporto con il corpo, alla prassi della
prevenzione sanitaria, alla ricerca del benessere e del relax, alla sperimentazione di
forme originali di socialità. A tutto quello, insomma, che compone l’universo
variegato delle domande collettive e delle aspettative individuali che allo sport per
tutti si rivolgono nelle cosiddette società affluenti.
11Ciò pone sicuramente ai poteri locali, soggetto-oggetto delle strategie di
conversione del Welfare, una sollecitazione a pensare le politiche per lo sport come
vere e proprie politiche di seconda generazione. Formula di derivazione politologica
con cui si indicano strategie orientate al risultato e frutto di una sistematica
concertazione fra soggetti differenziati, come appunto nella filosofia del Welfare Mix
cui sopra si è fatto cenno. Per questo ci pare importante il taglio conferito dall’Istat
alla sua rilevazione. Indirettamente, essa ci disegna il panorama - insieme reale e
virtuale - dello sport dell’inclusione (lo sport dei cittadini), differenziandolo
concettualmente dallo sport della selezione. Quello, cioè, che si fonda sulla
valorizzazione del talento naturale, sull’ottimizzazione ai fini del risultato delle
risorse piscofisiche dell’atleta, sul primato delle esperienze di rendimento
tecnicamente verificabile. Strategie connesse all’agonismo di livello, che non solo
esprime e intercetta i bisogni individuali degli atleti, e con essi formidabili ed estese
passioni popolari, ma che contiene una rispettabile valenza pedagogica. Esperienza,
però, che non sembra più possedere alcuna significativa connessione con l’esperienza
dello sport di prestazione relativa, che abbiamo convenzionalmente identificato come
sport dell’inclusione.
Ai ricercatori dell’Istat l’universo sociale del Paese appare grosso modo diviso in
tre aree di dimensioni comparabili. Il 30,1% della popolazione italiana censita ai fini
della ricerca (16.700.000 cittadini) si considera praticante, in forma continuativa o
saltuaria. I continuativi da soli rappresentano il 20,3% dell’intero universo e i saltuari
il 9,8%.
Poco meno di un terzo del totale - per la precisione il 31,3%, pari a quasi
17.400.000 italiani -, pur non considerandosi praticanti “sportivi” in senso proprio,
dichiarano di partecipare di una qualche forma di cultura del movimento. È il popolo
di chi, quando può, preferisce una sana camminata all’uso dell’automobile. Il popolo
dei ciclisti domenicali, degli appassionati delle settimane bianche o delle escursioni
velistiche. Il popolo delle famiglie che praticano equitazione di campagna, dei
subacquei o dei meno ambiziosi cercatori di funghi.
I sedentari irriducibili, vale a dire quanti per scelta o per necessità (età avanzata,
forme di invalidità o altro) dichiarano di non praticare alcuna modalità di sport e
alcuna forma di attività fisica, sono il 38.6% della popolazione. Corrispondente a
21.400.000 cittadini. Una cifra elevata, anzi fra le più elevate in Europa occidentale,
ma pur sempre una minoranza rispetto all’universo degli attivi, che si avvicina ormai
a rappresentare i due terzi della popolazione italiana. Va anche considerato che i
picchi più alti di inattività si registrano, come prevedibile, fra i bambini di età
compresa fra i tre e i cinque anni e fra gli ultrasessantacinquenni. Dato, quest’ultimo,
che possiede un’incidenza significativa in presenza del continuo aumento dell’età
media.
Interessante è la scomposizione dei dati per genere. I maschi continuano a
prevalere fra gli sportivi in senso stretto. Circa il 37.8% della popolazione maschile
complessiva dichiara di praticare continuativamente o saltuariamente uno o più sport.
12Le donne sportive, in questo ambito, non vanno oltre il 22,7% dell’intero universo
femminile. (2)
Questa relazione, però, si rovescia se consideriamo non più gli sportivi, ma i
semplicemente attivi. Si dichiarano attive il 33.6% delle donne e appena il 28.8%
degli uomini. Cumulando sportivi e attivi, la distanza fra i generi appare
enormemente ridotta rispetto a pochi decenni or sono. A due terzi di maschi
corrisponde un non trascurabile 56.3% di donne in qualche modo attive, anche se le
modalità appaiono differenziate: ancora più inclini i primi all’esperienza agonistica,
che - per scelta o per necessità - coinvolge di meno le donne.
Altrettanto significativo è il divario territoriale: gli sportivi raggiungono il 38% nel
Nord-est e il 34.2% nel Nord-ovest, per attestarsi al 30.7% nelle regioni centrali e
precipitare al 23% di Sud e isole. Aggregando sportivi e attivi, il Nord-est sfiora i tre
quarti della popolazione e il Nord-ovest raggiunge il 70% - valori del tutto
paragonabili a quelli dei Paesi di più antica e diffusa sportivizzazione, come la
Scandinavia -, mentre Sud e isole non superano la metà della popolazione
complessiva.
Può essere utile osservare alcuni riferimenti statistici che riguardano da vicino la
nostra ricerca. Il primo concerne l’area regionale piemontese e l’ampiezza della
pratica sportiva (continuativa o saltuaria). Il valore censito dall’Istat colloca il
Piemonte leggermente sopra la media nazionale: 33% di praticanti - contro il 30,1%
della media nazionale -, ripartiti in un 21.1 di “continuativi” e in un 11,9 di “saltuari”.
La popolazione genericamente attiva si situa anch’essa un po’ sopra la media
nazionale: 33,4% contro 31,3. Ne risulta una minore consistenza percentuale dei
sedentari (33.5% contro 38,6). Leggendo questi dati sinotticamente, colpisce la quasi
perfetta distribuzione in tre aree di pari peso demografico. Il dato va però integrato
con altre due osservazioni: (i) a fronte di una leggera sovrarappresentazione della
popolazione complessivamente attiva rispetto alla media nazionale, l’area piemontese
risulta leggermente più incline alla sedentarietà rispetto al comparto territoriale del
Nord-ovest complessivamente considerato; (ii) comparando i dati relativi ai livelli di
pratica fra quello che l’Istat definisce comune centro (nel caso in esame, Torino città)
e la “periferia”, si manifesta, come ovunque in Italia, uno scarto non trascurabile a
favore di quest’ultima.
Pur esulando dai confini della nostra indagine, anche i dati relativi alla pratica
agonistica strutturata che l’inchiesta demoscopica Istat ci consegna meritano qualche
breve riflessione d’insieme.
Si conferma, intanto, che la sportivizzazione degli italiani - attribuendo a questa
definizione una latitudine sociologica diversa rispetto a quella, più riduttiva, offerta
da storici e politologi (Porro, 2001) - prosegue a ritmi consistenti. In soli cinque anni,
fra il 1995 e il 2000, i praticanti crescono di 3.4 punti percentuali, con un aumento
più netto in quota di composizione dei praticanti continuativi rispetto ai saltuari e
delle donne rispetto agli uomini. Altrettanto interessante è constatare come la
maggiore propensione alla pratica riguardi indistintamente tutte le fasce d’età, con un
picco di crescita particolarmente accentuato nella classe d’età compresa fra i 15 e i 17
anni (addirittura 9.5% in più nel quinquennio considerato). Ancora: la crescita nella
13popolazione maschile si concentra fra i più giovani e nella classe d’età compresa fra i
55 e i 59 anni. Fra le donne la tendenza è a una consistente anticipazione dell’accesso
(bambine) e a un picco nella fascia d’età fra i 15 e i 19 anni. A livello territoriale,
però, l’intero Nord-ovest registra valori di crescita assai inferiori al Nord-est (2%
contro 5.5) e allo stesso Centro-sud (3.5%).
Da approfondire il profilo delle tipologie della pratica. Le attività meno
impegnative (pratica saltuaria o del tempo libero) perdono peso rispetto a quelle più
strutturate in senso agonistico. Disomogeneo risulta, invece, il profilo della
sedentarietà, che nell’arco temporale osservato cresce fra gli uomini e diminuisce fra
le donne. I sedentari aumentano, in particolare, nelle classi d’età centrali (18-54
anni), mentre diminuiscono fra i più giovani e i più anziani.
Osservando poi la frequenza delle attività, risultano essere complessivamente 23
milioni gli italiani che dichiarano di allenarsi, o comunque di esercitare con relativa
continuità qualche attività fisico-motoria, almeno una volta a settimana. Essi
costituiscono il 41.3% della popolazione di riferimento, vale a dire i due terzi del
totale degli sportivi e degli “attivi”, con una persistente prevalenza maschile. Sono
12.330.000 i maschi impegnati (il 45.5% della popolazione maschile considerata)
contro 10.670.000 donne (il 37.2% della popolazione femminile considerata). Il
Piemonte presenta anche in questo caso un valore medio di pratica relativamente
continuativa di poco superiore al dato nazionale (43.5% contro 41.3), ma abbastanza
distante da quello relativo all’area forte del sistema, cioè il Nord-est (il Trentino Alto
Adige si attesta su un valore di 64.6, il Veneto è al 53.2). (3)
Già questa radiografia pone all’agenda delle politiche locali una serie di possibili
priorità e alcuni interrogativi da sciogliere:
1. il minor tasso di pratica sportiva femminile, pur in presenza di una forte
espansione complessiva del tasso di generica attività fisica delle donne, risponde a
una modalità culturale (per esempio una minore propensione per le specialità a più
elevato contenuto agonistico) o non riflette, invece, un persistente svantaggio legato a
condizioni oggettive? Per esempio, a esigenze di cura famigliare non
sufficientemente supportate dalle strutture pubbliche o a un’organizzazione
dell’offerta sportiva (orari e tipologie di funzionamento di impianti e simili) che
continua a svantaggiare l’universo femminile? Spiega a tale proposito Massimo
Sacco Presidente provinciale CSI Torino che:
“Anche l’accesso allo sport riflette, insomma, i problemi più acuti del vivere civile. Penalizzando
soprattutto quei soggetti, come le donne, che sperimentano di necessità una continua intersezione
fra ruoli familiari e professionali”.
2. Come mai bambini e anziani italiani sono, in quota di composizione, meno
rappresentati nel sistema sportivo di quanto non avvenga in altri Paesi sviluppati,
mentre lo scarto fra l’Italia e le esperienze più evolute si è – almeno nelle regioni
centro-settentrionali - quasi completamente annullato nelle classi centrali di età? È
possibile che esistano ancora ragioni strutturali - legate alla quantità e qualità di
14un’offerta specializzata o comunque “dedicata” - cui magari si sommano, nelle fasce
più anziane, eredità culturali non favorenti?
3. Si è posta sufficiente attenzione alla comparazione dei livelli di attività fra
comune capoluogo e hinterland? In particolare, non varrebbe la pena di interrogarsi
sul divario a favore della periferia fra pratica di prestazione relativa (sportivi saltuari)
e attività fisica, da un lato, e totale sedentarietà, dall’altro? Ciò mentre i livelli della
prestazione assoluta (sportivi continuativi) appaiono assolutamente sovrapponibili.
Con il risultato di rappresentarci il sistema sportivo torinese metropolitano -
esattamente come quello romano, milanese ecc. - molto più polarizzato ai due estremi
dello sport di prestazione e della sedentarietà rispetto a quello dell’hinterland. Esiste
forse un “problema metropolitano” legato alla tipologia di offerta, alle distanze e ai
tempi di percorrenza?
4. I dati comparativi per aree territoriali e per fasce d’età segnalano come il Nord-
ovest faccia registrare un minore incremento nei valori 2000 rispetto a quelli di
cinque anni prima. Stimando in dettaglio la pratica continuativa (sia sportiva sia di
puro loisir) abbiamo anche osservato come il Piemonte presenti tassi di pratica
diffusa mediamente elevati, ma ancora lontani da quelli ormai consolidati nelle aree
più sviluppate. Quanto influisce un fattore strutturale, come il declino demografico,
che fa delle aree nord-occidentali del Paese quelle più interessate dagli effetti sociali
dell’invecchiamento della popolazione? E quanto incide, se incide, una
configurazione troppo tradizionale dell’offerta nei contesti regionali - come il Nord-
ovest - che sono stati storicamente considerati i territori incubatrice della
sportivizzazione nazionale? In ogni caso, si pone evidentemente un problema di
adeguamento e forse di riorientamento dell’offerta di pratica.
In questa prospettiva, a Torino, un’associazione di sport per tutti come la UISP si
sforza di ripensare se stessa come alternativa al privato sportivo. Patrizia Alfano,
presidente del comitato provinciale, ci spiega che
“il fenomeno delle palestre private è principalmente rivolto agli adulti. Perché i giovani non le
frequentano sono pochissimi i giovani che vanno nelle palestre private […] le palestre di fitness
hanno obiettivi puramente salutistici ed estetici che aggregano in modo abbastanza, come dire,
superficiale. […] invece quello su cui noi lavoriamo da anni e che dà dei risultati è la continuità,
cioè il creare un senso di appartenenza e di affezione alla pratica sportiva. […] Perché tu offri una
serie di occasioni che creano la continuità il senso di appartenenza, la voglia di praticare sport e di
non smettere mai. C’è un discorso di amore per l’attività […] c’è un gruppo di gente che si ritrova
tutte le volte alla stessa ora allo stesso giorno, chiacchiera con l’istruttore e fa attività cioè proprio
un’altra dimensione che io credo ancora assolutamente valida e importante”.
Un approccio, come si può constatare, che si colloca agli antipodi della filosofia
del personal training o dei programmi individualizzati da eseguire in perfetta
solitudine, seguendo sul display della macchina le istruzioni contenute in una
chiavetta informatizzata.
Bisogna però, contemporaneamente, tener d’occhio la scomposizione interna degli
universi di riferimento. I maschi anziani sembrano più disponibili a cimentarsi con
qualche forma di attività, ma non va dimenticato come fra le donne - che godono di
15una maggiore aspettativa di vita - siano proporzionalmente più incidenti le fasce d’età
molto anziane (sopra gli ottant’anni).
5. Un’altra questione riguarda la valorizzazione, nel generale panorama dell’offerta,
di soggetti organizzati la cui missione sia chiaramente e preferenzialmente connessa
allo sviluppo e alla qualificazione della pratica nei settori sociali e nei contesti
demografici ancora meno rappresentati. Le politiche locali di settore hanno mai
provato a curvare in tale direzione le loro iniziative? A tale proposito, disponiamo di
alcune testimonianze interessanti. Sostiene ancora, ad esempio, Patrizia Alfano:
“Negli anni è successo questo: lo sport è stato affidato a Torino per molti anni a un grande
assessorato, con grandi risorse […] dove lo sport aveva un buon capitolo, aveva un buon budget e
questo ci ha permesso di proporre tantissimi progetti e di vederli approvati e finanziati. Ad un certo
punto della nostra storia lo sport è diventato una delega dell’assessore alla cultura che via via ha
ridotto il suo budget. […] nel modificarsi di questa situazione noi abbiamo iniziato ad avere altri
referenti per cui lavoriamo tantissimo con l’assessorato all’istruzione e al sistema educativo e con
questo assessorato noi realizziamo la maggior parte dei nostri progetti. [Questi vengono finanziati]
il primo anno [e consentono] di farlo partire dal secondo [si deve] trovare il sistema per
autofinanziare il progetto senza il contributo dell’ente pubblico.
E ancora: esiste un ruolo dell’associazionismo di utenza e/o del sistema
commerciale? Nel case study di Torino emerge come ci possa essere una
sovrapposizione tra questi ultimi due termini. Infatti, una parte delle realtà provinciali
sul territorio piemontese presenta un’offerta sportiva simile a quella del sistema
commerciale. Ciò accade grazie al fatto che il surplus di progetti sviluppati dalla
UISP di Torino si riversa sui territori della provincia che, pur avendo le strutture,
mancano di una qualsivoglia progettualità per il loro uso. In tal senso, alcuni dei
progetti sviluppati a livello centrale nell’ambito di politiche sportive a carattere
sociale si convertono in attività che rientrano a pieno titolo nell’offerta commerciale
delle diverse realtà sportive locali. Come afferma la Alfano:
“il fatto che in provincia ci siano dei comitati che lavorano capillarmente sul territorio raccoglie
molti dei nostri progetti che vengono realizzati poi anche in provincia”.
3. Lo sport degli utenti e lo sport dei cittadini. Qual è l’origine del problema?
Il possibile inserimento dello sport fra i temi oggetto di politiche di seconda
generazione non costituisce una questione soltanto accademica. Né rappresenta la
risposta a un pur legittimo problema di adeguamento e aggiornamento delle tipologie
di analisi delle politiche pubbliche. Ovunque, in Europa e nel mondo occidentale, è
dagli anni Settanta che, con la crisi della vecchia sovranità statale e con l’emergere
di una domanda di nuovo protagonismo da parte dei poteri locali, sono venuti
prevalendo i cosiddetti sistemi a rete. In essi, espressione peculiare del cosiddetto
Welfare locale, operano decisori pubblici e privati e convivono missioni istituzionali
diverse e perciò bisognose di livelli di regolazione e integrazione.
16“Le associazioni diventano nodo di una rete che coinvolge i cittadini in tutte le opere di
ristrutturazione li tiene informati li accompagna”, ci dice Patrizia Alfano.
Quelle che abbiamo definito politiche di seconda generazione, a ben vedere, altro
non sono che l’espressione di una nuova configurazione del classico Stato sociale.
Meglio: esse esprimono logiche di azione e di produzione normativa che rimandano
alla categoria di Welfare Mix, come è stata teorizzata, agli inizi degli anni Novanta,
da autori come Everts e Wintersberger (1990). La crisi fiscale dello Stato e
l’affermarsi di modelli di amministrazione pubblica ispirati alle competenze di settore
anziché ai ruoli burocraticamente determinati costituiscono i principali, anche se non
esclusivi, fattori di sviluppo del Welfare Mix.
Contrarre la spesa pubblica e superare la logica di gestione fondata sulla figura dei
funzionari generalisti sono, del resto, due dei principali requisiti per il passaggio a un
sistema a rete. Le politiche di seconda generazione sono il prodotto di questa
trasformazione sia del Welfare sia dell’Amministrazione pubblica. Il Welfare Mix
possiede come fondamentale requisito attuativo la presenza sullo scacchiere del
sistema sociale urbano di attori organizzativi capaci non solo di soddisfare domande
di committenza pubblica, ma anche di concorrere alla produzione delle politiche
locali di settore. Questo significa operare nella logica del governo e/o della gestione
ad hoc. Ovvero elaborare il significato, interpretare – e non solo organizzare con
efficienza sul piano amministrativo, tecnico e gestionale - un complesso e ambizioso
programma olimpico (Torino 2006), cioè un evento connotato per definizione in
chiave agonistico-spettacolare. Ma significa, anche, sperimentare nell’azione
quotidiana l’esercizio di diritti di cittadinanza che lo Stato sociale classico non aveva
in passato mai compiutamente inserito nell’agenda politica. Lo sport per tutti
appartiene a questo ambito di azione ed esige livelli di attenzione specifica da parte di
attori plurimi: sedi amministrative deputate, organizzazioni di Terzo settore,
associazionismo sportivo, movimenti di utenza. Ciò consente di prefigurare, per il
governo e la valorizzazione della domanda di sport orientato alla prestazione relativa,
l’adozione di strategie di azione e implementazione che si rifanno precisamente al
paradigma e alle procedure delle politiche di seconda generazione.
Ancora la Alfano ricostruisce, nello specifico della UISP, la risposta di
un’importante associazione di sport per tutti alla richiesta di collaborazione avanzata
dalle istituzioni:
“…c’è stato un progetto [sull’intera provincia], realizzato dalla provincia per una cooperativa
della Uisp che era la Quadrifoglio, uno dei primi progetti che offriva un percorso formativo di
eventi sportivi per i ragazzi del 2006. [Il progetto successivo] diviso in territori [Ivrea, Pinerolese,
ecc.] [in questo progetto] abbiamo girato tutta le palestre della provincia, il palazzetto dello sport di
Torino per fare un percorso formativo con questi ragazzi, che li ha visti poi protagonisti al Vivicittà.
[…] Hanno imparato come si fa una manifestazione come si organizza come si anima; per un po’ di
mesi hanno lavorato a questo e il giorno di Vivicittà sono arrivati alle 4 del mattino con i nostri
volontari si son divertiti da matti […] e qui noi abbiamo fatto la formazione dei ragazzi di Torino
del 2006, altro sulle Olimpiadi a Torino – almeno in quella fase - non c’era.”
17Ma le pratiche e le strategie di Welfare Mix, con il loro corollario operativo – le
politiche di seconda generazione – non vanno ridotte alla cooperazione, più o meno
strutturata, che gli attori coinvolti istituiscono in occasione di eventi speciali, come le
Olimpiadi. Anche sul terreno della prassi amministrativa corrente, ad esempio, si
sviluppano – a partire dai primi anni Novanta – esperienze inedite per l’ordinamento
amministrativo e la cultura gestionale dell’Amministrazione pubblica italiana. E’ il
caso delle carte dei servizi, che cominciano a dare concretezza all’idea di passare da
amministrazioni di regole – preoccupata di produrre leggi, norme e procedure – ad
amministrazioni di risultato, chiamate a rispondere di qualità e costi del servizio
erogato. È la filosofia che in quegli stessi anni, negli Usa, cerca di applicare
l’amministrazione Clinton, il cui manifesto programmatico può essere contenuto nei
dieci principi del governo imprenditoriale e nell’idea di “reinventare il governo”
suggerita da Osborne e Gaebler (1992).
Alla base della filosofia dell’azione pubblica di Osborne e Gaebler c’è una radicale
riformulazione della questione. Posti di fronte a un dilemma organizzativo o
all’esigenza di far fronte a una situazione critica, non ci si chiede più “qual è il
problema?” - questione di cui ci siamo occupati alla fine del precedente paragrafo -
bensì “qual è la sua origine?”. Anche qui non si tratta di una pura innovazione
teorico-metodologica. L’idea forza è che, nelle questioni connesse
all’amministrazione della cosa pubblica, l’origine del problema consista sempre,
inevitabilmente, nelle resistenze opposte all’innovazione da strutture o vincoli
organizzativi propri della macchina burocratica. Non, cioè, nel consapevole
boicottaggio dei funzionari o in carenze, limiti, errate interpretazioni dei ruoli o delle
mansioni. E neppure principalmente nella ristrettezza delle risorse tecniche,
finanziarie od organizzative. Tutti questi fattori, se presenti, possono concorrere a
produrre la vischiosità del sistema e a compromettere il successo dei tentativi di
cambiamento. Ma il vero nodo della questione sta, per Osborne e Gaebler,
nell’intrinseca rappresentazione del ruolo sociale della sfera pubblica. Prima della
lealtà e la professionalità degli operatori e dell’efficienza della macchina gestionale,
viene l’esigenza di ripensare il sistema in quanto tale. Nella logica della burocrazia
pubblica di Stato, questo sistema era stato ideato per contrastare, inibire o
quantomeno depotenziare l’innovazione. In quanto titolare del potere amministrativo
e soggetto monopolista delle politiche pubbliche, lo Stato Nazione di matrice
ottocentesca si preoccupava di garantire l’imparzialità delle procedure, la stabilità
degli equilibri istituzionali, la riproduzione nel tempo della “prassi consolidata”. La
domanda di innovazione poteva intervenire solo da un ambiente esterno – si trattasse
del mercato o dei movimenti sociali - e tradursi, attraverso le opportune mediazioni
legislative e normative, in adeguamenti (quasi sempre tardivi e parziali) delle routine
operative. L’adozione di una prassi ispirata alle politiche di seconda generazione
sconvolge questo paradigma perché concepisce anche l’amministrazione pubblica
come soggetto, oltre che come oggetto, di sperimentazione orientata all’innovazione.
Di qui il prevedibile prodursi di tensioni, conflitti e stress organizzativo. Domandarsi
quale sia l’origine del problema non significa altro, perciò, che trasferire nell’analisi
dei singoli casi concreti – cioè sottoporre a un processo di contestualizzazione – il
18Puoi anche leggere