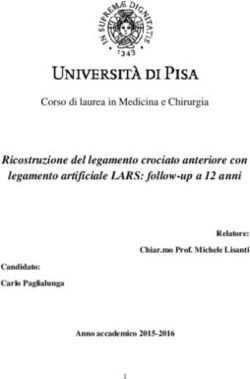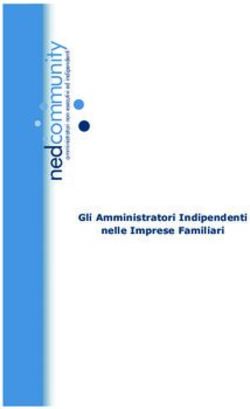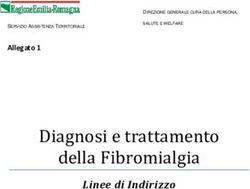UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive
Tesi di Laurea
PARACANOA: GLI EFFETTI DELLA PRATICA DELLA
CANOA SU ATLETI DISABILI
RELATORE:
Prof.ssa Angela Magnanini
CANDIDATO:
Francesco Sirimarco
Matr. L22/03405
Anno accademico 2014/2015INDICE
INTRODUZIONE………………………………………………………………………5
CAPITOLO I
1.1 Lo sport per chi vive in una situazione di disabilità…………………………...8
1.1.1 Cenni storici sullo sport per disabili…………………………………..….10
1.1.2 Il Comitato Italiano Paralimpico……………………………………….….13
1.2 I benefici dello sport per soggetti disabili……………………………………..15
1.2.1 Benefici fisici……………………………………………………………..…16
1.2.2 Benefici psichici…………………………………………………………….18
1.2.3 Benefici socio relazionali…………………………………………………..19
CAPITOLO II
2.1 La paracanoa…………………………………………………………………….22
2.1.1 Adattamenti ai regolamenti e alle imbarcazioni…………………….......26
2.1.2 Manifestazioni ed eventi di paracanoa…………………………………..30
2.2 Forme di disabilità degli atleti di paracanoa…………………………………..32
2.2.1 Lesioni midollari…................................................................................33
2.2.2 Paralisi cerebrale…………………………………………………………...35
2.2.3 Amputazioni…………………………………………………………………37
2.3 Sistema di classificazione………………………………………………………38
2.3.1 Sistema di classificazione Paralimpico………………………………..…40
2.3.2 Sistema di classificazione della paracanoa…………………………..…43
CAPITOLO III
3.1 Scopo dell’indagine……………………………………………………...………46
3.2 Materiali e metodi………………………………………………………..………47
3.2.1 Campione……………………………………………………………………48
3.2.2 Analisi del questionario……………………………………………….……49
3.2.3 Analisi dei dati………………………………………………………………50
3.3 Risultati e discussione……………………………………………………..……51
CAPITOLO IV
4.1 Conclusioni ……………………………………………………….……………...57
4.2 Prospettive future ……………………………………………………………….58
BIBILIOGRAFIA………………………………………………………………….….60
SITOGRAFIA……………………………………………………………………...…61
ALLEGATI……………………………………………………………………………62
4INTRODUZIONE
Per ogni individuo, di qualsiasi età, genere, in tutte le condizioni, con o senza
disabilità, l’attività motoria e sportiva ha un elevato valore educativo e formativo.
Negli ultimi anni ci si è resi conto inoltre che, proprio nelle persone che vivono
in situazione di disabilità, lo sport gioca un ruolo fondamentale sotto il profilo
riabilitativo/funzionale per rimuovere le barriere mentali, architettoniche e sociali
che spesso rendono difficili i normali processi d’inclusione e integrazione.
Grazie al quotidiano lavoro di esperti del settore, è maturata la percezione che
lo sport è una straordinaria fonte di benessere psico-fisico, nonché strumento di
realizzazione personale e soprattutto d’inclusione sociale. Rivestendo una
crescente importanza nella vita delle persone con disabilità, la pratica sportiva
diventa quindi un mezzo per consolidare e acquisire sane abitudini di vita,
migliorare le condizioni di salute e, più in particolare, accrescere gli spazi di
autonomia personale di vitale importanza per coloro che vivono questa
particolare situazione. Si può, in questo caso, parlare di “sport adattato” o
“attività fisica adattata”, anche nota con la sigla APA, dall’inglese “Adapted
Physical Activity” per indicare un’area interdisciplinare che comprende
l’educazione fisica, le discipline sportive, la riabilitazione funzionale e le scienze
motorie al servizio delle persone che vivono in situazione di disabilità, e dove la
pedagogia speciale fornisce un contributo alla formulazione di modelli
educativo-formativi fondati su logiche inclusive e di integrazione. Il presente
elaborato, senza avere alcuna presunzione scientifica, intende esplorare e
analizzare questa vasta area tematica, soffermandosi su come lo sport e la
pratica della canoa si siano rivelati adattabili e praticabili da persone disabili,
conducendone alcune di loro a divenire atleti di elevato livello, in procinto di
partecipare ai giochi Paralimpici di Rio 2016. L’intenzione di esplorare questo
tema nasce dalla mia grande passione per la canoa e principalmente
dall’esperienza vissuta durante il programma Erasmus all’università di Porto,
rivelatasi una preziosa occasione di confronto con la realtà dello sport adattato
in maniera attiva e diretta. Sono lontani gli anni in cui lo sport della canoa
veniva confuso con quello del canottaggio, senza apprezzarne e conoscerne la
5fondamentale differenza, e si può ben sostenere che, con la consacrazione
anche nel programma dei giochi Paralimpici, la specifica identità dello sport
della canoa sia ormai conosciuta e riconosciuta a livello internazionale. Più in
generale, però, si può ritenere scontata l’importanza di qualsiasi sport per le
persone che vivono in situazioni di disabilità, rilevabile in modo concreto dal
crescente interesse sul tema di Istituzioni, professionisti, federazioni e
organizzazioni internazionali, oltre che di tutti noi, prossimi laureati in scienze
delle attività motorie e sportive. Nello specifico, questo elaborato si propone di
indagare come lo sport della paracanoa influenza le condizioni psicofisiche, di
salute e sociali di persone con disabilità. Il lavoro è strutturato in due parti. Nella
prima parte, che corrisponde ai primi due capitoli, sono affrontati il tema dello
sport per i disabili e in particolare lo sport della paracanoa, attraverso una
revisione teorica, avvalendosi della letteratura pedagogica e tecnica su questo
argomento. Il primo capitolo, sul tema dello sport per le persone disabili, tratta
delle condizioni in Italia e dello stato dei vari centri di riferimento. Partendo dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dopo alcuni cenni sulla storia dello sport
per disabili, si valutano i benefici psicofisici e sociali che reca la pratica dello
sport alle persone disabili, riportando le informazioni più attuali che possano
chiarire le dinamiche e l’evoluzione di quest’area. Il secondo capitolo tratta
invece, più in particolare, dell’attuale quadro di situazione riguardante la
disciplina della paracanoa. Inserita per la prima volta nel programma
Paralimpico di Rio 2016, la paracanoa si è evoluta con il passare degli anni,
permettendo a un numero sempre maggiore di persone disabili di avvicinarsi al
mondo della canoa. Come succede per molte discipline sportive di alto livello,
sono intervenuti molteplici adattamenti e adeguamenti che hanno interessato
nel tempo regolamenti, imbarcazioni, programmi di gare e sistema di
classificazione. Proprio sul sistema di classificazione, argomento sempre
attuale e fortemente discusso, completo questo secondo capitolo, trattando
prima del sistema di classificazione Paralimpico e successivamente di quello
della paracanoa. La seconda parte dell’elaborato, corrispondente al terzo
capitolo, è incentrata con un approccio sperimentale sull’analisi delle risposte
agli item di un questionario motivazionale, da me elaborato sulla base delle
6informazioni ottenute dalla letteratura scientifica, che riporta i risultati di
un’indagine effettuata con gli atleti disabili della nazionale italiana di paracanoa,
alcuni dei quali, già qualificati per i giochi Paralimpici di Rio 2016. Il questionario
è teso a indagare le reali condizioni di salute prima e dopo la pratica della
canoa, e più in particolare, le motivazioni che hanno indotto gli stessi atleti alla
pratica della canoa e non di altri sport. Il questionario è stato poi arricchito
anche da un commento personale richiesto su ogni atleta al tecnico/allenatore
che li segue, al fine di completare le informazioni ottenute dal questionario,
offrendo un quadro più completo circa le condizioni di ogni singolo atleta in
maniera più dettagliata. Per ultimo sono riportate le conclusioni dell’elaborato e
alcune considerazioni su possibili piste di ricerca future, evidenziando la
possibilità che la paracanoa assuma sempre più marcatamente i connotati di
uno strumento d’integrazione e d’inclusione sociale, mantenendo comunque
una valenza agonistica di alto livello.
7CAPITOLO I
1.1 Lo sport per chi vive in una situazione di disabilità
Per “sport” s’intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non, “sia orientata al miglioramento della
condizione fisica e psichica, allo sviluppo delle relazioni sociali ovvero al
raggiungimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”1. Lo sport, nelle sue
diverse forme, è un mezzo per la formazione e la crescita della persona e
rappresenta, quindi, una meravigliosa opportunità per dimostrare le proprie
capacità, la propria forza fisica e “d’animo”, ma anche per confrontarsi con se
stessi e gli altri, scoprendo il proprio corpo e i propri limiti e rafforzando la
propria identità. La Carta Internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica
dell’UNESCO, adottata dalla Conferenza Generale del 1978 a Parigi, afferma
che “la pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per
tutti e ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all’educazione
fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità”2
ed a ciò consegue che l’interazione tra sport e disabilità è in realtà molto forte.
Infatti, nonostante la storia dello sport per disabili sia segnata da spiacevoli
episodi in tema di valorizzazione, tutela e integrazione della persona disabile,
che potevano indurre a considerarlo impraticabile per i disabili, le coraggiose
intuizioni di alcuni ed il determinato impegno di organizzazioni mondiali hanno
conferito allo sport la funzione di veicolo di integrazione e riabilitazione, in grado
di permettere alla persona disabile stessa di scegliere di fare sport. Lo sport
diventa quindi uno strumento per agevolare il recupero funzionale e soprattutto
per aumentare concretamente, e non solo in termini di percezione, la misura
dell’autonomia personale nella dimensione fisica e sociale. Tutte le persone in
una situazione di disabilità possono pertanto cimentarsi nella pratica sportiva e,
1 A. Magnanini, Educazione e movimento – Corporeità e integrazione dei diversamente abili,
Del Cerro Ed, 2008, p.127.
2
Cfr. F.A.D.A. Federazione Associazioni Diversamente Abili, Diritto allo sport delle persone con
disabilità, Corso di formazione per operatore Paralimpico, 2014, in www.accademia.edu
(visionato il 20/02/2016)
8se seguite e assistite in maniera corretta, possono superare qualsiasi barriera
e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. In tal senso, nella programmazione di
ogni attività sportiva, è essenziale una precisa ed attenta valutazione di ogni
singolo atleta, funzionale ad impostare programmi il più possibile personalizzati
in termini di durata e tipologia, oltreché adeguati al raggiungimento di obiettivi
individuati correttamente tenendo conto dell’età, del tipo e della gravità del
deficit, delle precedenti esperienze sportive, delle caratteristiche psicologiche,
ma soprattutto delle motivazioni e delle aspettative di ognuno. E’ infatti
fondamentale aiutare l’atleta che si cimenta nello sport, dopo il susseguirsi di un
trauma, a ritarare gli obiettivi motorii in funzione delle proprie possibilità,
stimolandone comunque il raggiungimento così come la capacità di
individuarne di nuovi, aprendosi sempre a ulteriori sfide3. Inoltre, attività all’aria
aperta o in contesti ambientali diversi da quelli comuni, come la pratica della
canoa, possono favorire la variabilità di stimoli generati da un contesto
ambientale sempre differente e unico, velocizzando e migliorando i processi di
integrazione. Eventi e manifestazioni sportive, come i Giochi Paralimpici, hanno
notevolmente aiutato e stimolato la sensibilizzazione e i processi d’integrazione,
e aumentato la consapevolezza dei numerosi benefici che lo sport genera per
le persone che vivono in situazioni di disabilità, dando luce inoltre a molte
discipline sportive poco conosciute, ma sicuramente molto avvincenti. È giusto
quindi sostenere e migliorare le strutture che svolgono attività sportiva per
disabili, o adattata, e seguire gli operatori del settore nel difficile compito
d’integrazione, coinvolgimento e avviamento allo sport, rimanendo al passo con
i tempi sempre in continua evoluzione. Anche il concetto di “salute” è cambiato
con il tempo e si è ampliato da una condizione di assenza di malattia, dove il
rapporto corpo-salute è esclusivamente di natura medica, ad una dimensione di
benessere psico-fisico che integra il rapporto corpo-salute nella globalità della
prospettiva di vita e di realizzazione della persona4. Si è inoltre arrivati a non
parlare più di “persone con disabilità” ma di “persone con limitazioni funzionali”,
3
E. Scanferla, La stimolazione motoria e sensoriale nella disabilità Indicatori di valutazione
dell’attività, Associazione Equilibero Padova, in www.docplayer.it (visionato il 18/02/2016)
4
Cfr. A. Broglia, Strumenti aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive
a servizio della disabilità, Torino, Giappichelli editore, 2012.
9in accordo con la nuova definizione derivante dalla classificazione
dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), che
individua il fenomeno della disabilità nella presenza di restrizioni alla
partecipazione associate a problemi di salute5. Nella più recente classificazione
del 2001 dell’OMS, l’International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), trattando della disabilità non si riferisce più a un disturbo, organico
o funzionale, senza prima rapportarlo a uno stato di salute, e questa
concezione esalta gli aspetti di valorizzazione del singolo nel suo contesto
ambientale e sociale. Ciò che diventa rilevante non è più stabilire la causa della
menomazione, ma intervenire per poterne ridurre la percezione. Un’indagine
svolta dall’Istat riporta che in Italia, nel 2013, le persone con limitazioni
funzionali erano circa 3,2 milioni, di cui 2 milioni e 500 mila anziani. Più alta la
quota tra le donne, 7,1% contro il 3,8% tra gli uomini6. Questi dati non sono stati
analizzati a fondo, ma se si considera che dai numeri riportati dal CONI7 gli
atleti tesserati al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) nell’anno 2014 erano
10.460, ci si può rendere conto che, nonostante sia stato fatto molto fino ad
adesso, ancora comunque si può e si deve fare per valorizzare ed esaltare lo
sport dei disabili. Concludendo, si può affermare che lo sport per persone che
vivono in situazione di disabilità permette il miglioramento della forma fisica,
migliora l’aspetto cognitivo attraverso l’apprendimento motorio, la
socializzazione e l’integrazione, esaltando le capacità e le abilità che si
possiedono8, valorizzando la persona nel suo contesto.
1.1.1 Cenni storici sullo sport per disabili
Le prime forme di attività sportiva per soggetti disabili si ebbero nella prima
metà del ventesimo secolo, quando vennero organizzate le prime
manifestazioni sportive internazionali per sordomuti. “Nel 1924, infatti, si sono
5
Cfr. ISTAT, Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare; XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati
Roma, 2014.
6
Ibidem.
7
Cfr. CONI, Lo sport in Italia – numeri e contesto 2014, Coni Servizi Centro Studi e Osservatori
Statistici per lo Sport
8
Cfr. A. Magnanini, Op. cit.
10svolti a Parigi i primi Giochi Internazionali per sordi”9. Queste manifestazioni
erano comunque saltuarie e avvenivano in un clima ancora fortemente
discriminante. Lo sport per le persone disabili, in particolare disabilità diverse da
quelle sensoriali, prende forma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. È il
neurochirurgo inglese Ludwig Guttmann il pioniere dello sport per i disabili, che
nel National Spinal Injuries Center presso lo Stoke Mandeville Hospital, nei
pressi di Londra, avvia i reduci britannici alla pratica di alcune attività sportive
adattate10. L’inserimento dello sport nella riabilitazione di chi aveva subito delle
menomazioni, diventa quindi uno strumento per esaltare le capacità residue e
recuperare un’accettabile condizione psicologica per raggiungere una buona
autonomia con una dignitosa qualità di vita 11 . Ci si rese subito conto che
l’attività sportiva, oltre ad un miglioramento psicologico, migliorava
notevolmente le capacità muscolari, respiratorie, l’autonomia in carrozzina,
avvenimenti che con i metodi tradizionali di cura tardavano ad arrivare. L’attività
del Dott. Guttmann ottenne molto successo, tanto che nei successivi anni si
svolsero una serie di iniziative sportive destinate alle persone disabili. Il 28
luglio 1948, in concomitanza dei Giochi Olimpici di Londra si tennero i primi
Giochi di Stoke Mandeville. Nel 1952 gli stessi giochi divennero un evento
internazionale. Nel 1960, in concomitanza delle Olimpiadi di Roma, si sono
tenuti i giochi di Stoke Mandeville, ritenuti essere la prima Paraolimpiade, e
contestualmente è stata istituita la Federazione Internazionale dei Giochi di
Stoke Mandeville (ISMGF)12. Questi giochi furono organizzati nella stessa città
che ospitava l’olimpiade, senza tuttavia utilizzare le stesse strutture. Solo nel
1964 a Tokyo, sia i giochi Olimpici sia quelli Paralimpici, vennero svolti nello
stesso stadio. Da qui anche la nuova concezione del termine Paralimpico e del
prefisso “para”, che muta da “paraplegico” a “parallelo ai giochi olimpici”. Inoltre
sempre nel 1964 a Tokyo, si ha la creazione dello stendardo e dell’inno delle
Paraolimpiadi. Da questo momento le Paralimpiadi si terranno con frequenza
quadriennale nella stessa città dei giochi Olimpici. Sempre nel 1964 è stata
9
A. Magnanini, Op. Cit; p.124.
10
Cfr. L. Bertini, Attività Sportive Adattate, Ponte San Giovanni, Calzetti Mariucci Editori, 2005.
11
Ibidem.
12 Ibidem.
11fondata l’International Sport Organization for the Disable (ISOD), l’organismo di
coordinamento degli sport per tutti gli atleti disabili, con l’introduzione di nuove
discipline sportive . “Nel 1976, a Toronto, parteciparono alle Paralimpiadi anche
atleti ciechi ed amputati e nello stesso anno in Norvegia ebbero luogo i primi
Giochi Olimpici Invernali”13. Nel 1980 sono stati fondati la International Blind
Sport Association (IBSA) e la Cerebral Palsy – International Sports and
Recreation Association (CP-ISRA). Nel 1984 le Paralimpiadi si sono tenute in
Inghilterra e vi hanno preso parte più di quattromila atleti. Quelle successive si
sono svolte in Corea del Sud, dove per la prima volta sono comparsi i controlli
antidoping, utilizzando le stesse strutture e gli stessi impianti dei Giochi
Olimpici. “Nel 1982 ISMGF, ISOD, IBSA e CP-ISRA hanno fondato un comitato
internazionale per l’organizzazione e il coordinamento delle manifestazioni
internazionali” 14 , che nel 1989 si è tramutato nel Comitato Paralimpico
Internazionale (IPC), l’organizzazione internazionale degli sport per atleti con
disabilità. Oggi l’IPC raggruppa 160 nazioni, rappresentate attraverso i Comitati
Paralimpici Nazionali (NPCS) e le quattro Federazioni Internazionali fondatrici.
Nel 1992, in occasione dei Giochi Paralimpici invernali di Albertville, l’intera
manifestazione è stata trasmessa in televisione, aumentando così l’interesse
popolare e aiutando a diffondere questa nuova concezione di sport. Per quanto
riguarda le disabilità mentali, dal 1968, grazie alla sociologa americana Shriver,
si svolgono gli Special Olimpics Games, nata come manifestazione non
esclusivamente agonistica ma anche come momento di festa e condivisione15.
Per i Giochi Paralimpici estivi di Rio de Janeiro che si disputeranno dal 7 al 18
settembre 2016, sono previste 22 discipline sportive tra cui anche la canoa e il
triathlon, che faranno la loro prima apparizione nel programma dei giochi.
Prenderanno parte ai Giochi più di quattromila e trecento atleti, provenienti da
oltre centosettanta paesi16.
13
L. Bertini, Op. Cit.; p.19.
14
Ibidem, p.20.
15
Cfr. A. Magnanini, Op. Cit.
16
Pagina ufficiale dei giochi Paralimpici di Rio 2016, in www.rio2016.com (visionato il
21/02/2016).
121.1.2 Il Comitato italiano Paralimpico
In Italia, il padre dello sport per disabili è il Dott. Antonio Manlio, che, grazie ad
un impegno diretto nel lavoro specifico di riabilitazione per persone colpite da
lesioni midollari, ha intravisto “i benefici della pratica di attività sportive nella
terapia riabilitativa”17. Questo impegno, unito ad una straordinaria caparbietà, si
è tradotto nell’organizzazione dei primi Giochi Paralimpici Estivi, in occasione
delle Olimpiadi del 1960 a Roma. Nel Centro Paraplegici Villa Marina di Ostia,
aperto nel giugno del 1957 per volere dell’Istituto Nazionale per l'Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di cui il Dott. Manlio era il direttore18, è
iniziato un lavoro specifico di riabilitazione per le persone colpite da lesione
midollare, basato anche sulla pratica di attività sportive, con nuove metodologie
terapeutiche per i pazienti neurolesi. Grazie al rapporto di amicizia con il Dott.
Guttmann, il Dott. Manlio ha potuto trasferire i metodi utilizzati presso lo Stoke
Mandeville Hospital, riuscendo a consentire anche alle persone disabili di
godere dei benefici di praticare un’attività sportiva. Il Dott. Manlio aveva
compreso che con la pratica di numerose discipline sportive quali nuoto,
pallacanestro, tennis da tavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, tiro con
l’arco, scherma e corsa in carrozzina si potevano non solo a prolungare le
aspettative di vita dei pazienti, garantendo loro una maggior salute,
recuperandone l’identità fisica e favorendone conseguentemente il più alto
possibile livello di inserimento nella società, “in una realtà ancora molto
diffidente nei confronti del disabile”19 . Ovviamente, gli esiti dell’utilizzo dello
sport come strumento riabilitativo non hanno tardato ad arrivare e sono risultati
immediatamente positivi, con una significativa riduzione del tasso di mortalità e
una più che soddisfacente attenuazione degli stati depressivi nelle persone
disabili. Nel 1975, con l’intento di promuovere, sviluppare e disciplinare lo sport
quale strumento di recupero e mezzo di salute, è stata costituita l’Associazione
Nazionale per lo Sport dei Paraplegici ( ANSPI ), di cui è stato presidente
Giovanni Pische, altro pioniere dello sport per disabili in Italia. Si comincia ad
17
L. Bertini, Op. Cit; p.26.
18
Cfr. Claudio Arrigoni, Paralimpici – lo sport per disabili: storie, discipline, personaggi, Milano,
Hoepli, 2006.
19
A. Magnanini, Op. Cit. p.126.
13intravedere una concezione di sport come diritto per tutti i cittadini disabili con
l’effetto che, sia in Italia che nel resto del mondo, lo sport va trasformando da
terapia riabilitativa ad attività ricreativa, fino ad arrivare addirittura attività
agonistica. Nel 1980, l’ANSPI diviene Federazione Italiana Sport Handicappati
(FISHa) che tenta di confrontarsi con il Comitato Olimpico Nazionale, “cercando
di unificare le diverse federazioni sportive per i disabili”20. Nel 1981 la FISHA
ottiene l’adesione al CONI, compiendo il primo significativo passo verso il
riconoscimento dell’attività sportiva svolta da disabili. Sei anni dopo, il Comitato
Olimpico ha riconosciuto giuridicamente la Federazione ed il suo ingresso nelle
Federazioni Sportive Nazionali. Nel 1990, infine, la FISHa ha mutato il nome in
Federazione Italiana Sport Disabili (FISD), che comprende le tre federazioni
sportive FISHA, la Federazione Italiana Ciechi Sportivi (FICS) e la Federazione
Sportiva Silenziosi Italiana (FSSI). “La FISD regola e controlla l’attività sportiva
per sette tipologie di disabilità tra cui paraplegici, tetraplegici, amputati
cerebrolesi, psichici, non vedenti e ipovedenti”21. Con il decreto d’attuazione
della presidenza del consiglio dei ministri dell’8 aprile 2004, “la Federazione
Italiana Sport Disabili è stata individuata come Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), riconoscendone la fondamentale importanza, con lo scopo di garantire il
diritto allo sport in tutte le sue espressioni, promuovendo la massima diffusione
della pratica sportiva per disabili”22. Il CIP è un organismo che è responsabile
della pratica sportiva e della preparazione delle squadre agonistiche,
ricoprendo il ruolo sociale di garantire il diritto allo sport in tutte le sue forme,
permettendo a tutti di migliorare il proprio stato di benessere e utilizzando lo
sport come strumento di recupero, crescita culturale e fisica. Si tratta, in
sostanza, di un organismo garante e gestore della pratica sportiva a qualunque
livello, amatoriale o di alto livello, e per qualunque disabilità, fisica, mentale,
visiva, nel rispetto delle linee guida e in totale accordo con l’IPC e il CIO.
20
L. Bertini, Op. Cit; p.27.
21
Ibidem p. 27.
22
A. Magnanini, Op. Cit; p.127.
141.2 I benefici dello sport per soggetti disabili
La necessità che il corpo ha di esprimersi si può tradurre in una qualsiasi attività
motoria, dato che il movimento è uno dei bisogni primari dell’uomo. Svolgere
attività motorie e/o sportive consente alla persona disabile di migliorare le
proprie qualità fisiche, potenziare gli aspetti cognitivi e psichici e sviluppare
competenze socio-relazionali molto preziose, che si tramutano in una maggiore
autonomia. Il regolare svolgimento di un’attività fisica allenante determina
nell’organismo umano adattamenti cardiovascolari e muscolari in grado di
migliorare la prestazione organica, oltra ad una serie di benefici nelle diverse
dimensioni psicologica e sociale. Lo sport, inoltre, è anche uno strumento di
prevenzione alle principali malattie cardiovascolari e metaboliche, agendo come
mezzo di crescita sociale e di autoaffermazione. Lo svolgimento di un regolare
programma di attività fisica determina una serie di adattamenti vantaggiosi per
l’organismo, che si traducono in un globale miglioramento dello stato di forma
fisica. Lo sport viene spesso intrapreso come momento riabilitativo a seguito
dell’instaurarsi del deficit, da qui la definizione di “sport-terapia”, che comunque
riesce a diventare un forte elemento trainante “orientato ovviamente verso il
recupero di una miglior funzionalità motoria, ma anche verso l’accettazione di
una nuova realtà, diversa nelle sue caratteristiche e potenzialità espressive”23.
Lo sport consente a chi lo pratica di scoprire, o nel caso del disabile di
riscoprire, il proprio corpo, stimolandone la padronanza. L’acquisizione di
esperienze di movimento e di specifiche abilità, “fornisce stimoli allo sviluppo
motorio in concomitanza di eventi divertenti, generando relazioni interpersonali
gratificanti”24. La pratica di attività sportive deve avere per il disabile lo scopo di
permettere un’attività motoria che lo stimoli a sviluppare le proprie potenzialità,
in un ambiente ricco di relazioni significative ed in una dimensione di ludicità. In
tal senso, nel considerare una qualunque attività sportiva, e lo sport per disabili
ne fa ovviamente parte, si devono distinguere due aspetti fondamentali dello
sport: quello ludico e quello agonistico, e l’uno non preclude l’altro, ma anzi
sono in stretta correlazione. Il gioco è riconosciuto di basilare importanza nella
23
L. Bertini, Op. Cit; p.69.
24
Ibidem, p.71.
15vita non solo dell’individuo in età evolutiva, ma anche nell’adulto. Esso si
caratterizza come un’attività piacevole, fine a se stessa, che diventa un tramite
per la liberazione di un eccesso di energie fisiche e nervose attraverso l’attività
motoria. È anche vero che nessuna attività sportiva si può definire tale se non
possiede una minima componente agonistica. L’agonismo è insito nella natura
umana, che si esprime nel desiderio continuo di misurarsi con se stesso e con
gli altri, per essere sostanzialmente rassicurato sulle proprie capacità 25 . Lo
sport però deve essere valorizzato anche per il profilo educativo, ed essere
analizzato con i canoni della scienza dell’educazione, “funzionale a conseguire
una corretta integrazione dell’individuo nella rete sociale”26. Nella persona che
vive in situazione di disabilità, lo sport svolge un ruolo importantissimo nello
sviluppo della persona, sia sul piano fisiologico sia sul piano psicologico. Come
è stato spesso dimostrato, il ruolo che riveste l’attività motoria nel recuperò
della persona disabile è di notevole rilievo, producendo benefici sul piano socio-
educativo e cognitivo, oltre che a livello fisico e psicologico. A seguire sono
riportati gli effetti dell’attività sportiva a livello fisico, sulla psiche e sul piano
socio-relazionale, dando per scontato che questi benefici possono essere
riscontrabili in qualunque persona che pratichi sport, senza distinzione di sesso,
età, stato fisico o mentale e condizione economica.
1.2.1 Benefici fisici
Con riferimento allo “sport”, appare scontato associare l’attività correlata ai
benefici che si riflettono sulle condizioni generali del fisico e sulla salute. E’
ampiamente riconosciuto, ormai, che l’attività motoria è portatrice di effetti
positivi sia a livello fisico che sul piano cognitivo e socio-educativo. A livello
fisico, la pratica di un’attività motoria o sportiva, determina immediatamente un
incremento della forza muscolare e della capacità di equilibrio, aspetti che
assumono una grande rilevanza per le persone disabili. “Un miglioramento della
capacità cinestesica e della coordinazione motoria generale si riscontra anche
25
Cfr. L. Michelini, Handicap e sport – medicina sportiva per atleti disabili; Roma, Società
editrice universo, 1991.
26
A. Magnanini, Op. Cit; p.127.
16come conseguenza di ripetizioni consapevoli e finalizzate degli atti motori”27.
Peraltro, come già detto precedentemente, oltre al miglioramento dell’equilibrio,
aumenta la capacità di rilassamento con notevoli benefici soprattutto per alcuni
tipi di disabilità. Si generano quindi una buona abilità e una maggiore versatilità
nel muoversi, dato che il gesto motorio può essere eseguito dalla persona
disabile in diversi modi. “L’apprendimento e il consolidamento di nuovi schemi
motori, adattati al tipo di disabilità, aumentano la considerazione in sé stessi,
migliorano la percezione del proprio corpo e delle sue possibilità di movimento
nello spazio circostante, arricchendo la conoscenza e la terminologia dei
28
movimenti” . Questo miglioramento e consolidamento delle capacità
coordinative e condizionali, dovuto alla pratica costante di un’attività motoria,
agirà anche sulle capacità percettive e di concentrazione, aumentando
conseguentemente l’autostima e la sicurezza interiore. A livello fisiologico,
l’attività motoria permette all’organismo di produrre endorfine, sostanze
chimiche che, nell’uomo, hanno effetti positivi sull’umore generale e sulla
regolazione del sonno. Chi pratica regolarmente un’attività potrà avere una
diminuzione dell’ansia, dello stress e del nervosismo, e quindi raggiungere uno
stato di benessere emotivo generale. Lo sport inoltre agisce come strumento di
prevenzione, migliorando lo stato fisico ma soprattutto di salute. La prevenzione
di malattie cardiovascolari, respiratorie, stati di ipertensione e obesità, sono solo
alcune patologie sulle quali la pratica di attività motoria ha effetti positivi.
Proprio per quanto riguarda l’alimentazione, una corretta dieta alimentare è
altresì importante per il mantenimento di un buono stato di salute fisica
generale, permettendo il giusto bilanciamento tra massa magra e massa
grassa, che nel caso di disabili in carrozzina potrebbe essere alterato, data la
minor massa magra e la difficolta a fare esercizio fisico. Lo sport produce
nell’uomo, sia normo-dotato che disabile, molteplici benefici, con positive
ripercussioni nei vari aspetti della vita quotidiana, ma è il raggiungimento di un
ottimo livello di autonomia che può essere considerato il fine ultimo della pratica
di un’attività motoria.
27
L. Bertini, Op. Cit; p.72.
28
Ibidem, p.67.
171.2.2 Benefici psichici
Sul piano psicologico, notevoli benefici si hanno quando l’attività motoria e
sportiva genera uno stato di benessere e soddisfazione generale. In una
concezione di sport in cui sono valorizzate ed esaltate le potenzialità, “le
capacità e le abilità che si possiedono, e non quelle che non si possiedono”29,
provare soddisfazione a svolgere un’attività motoria, compiere un gesto tecnico
considerato impossibile o raggiungere un obiettivo prefissato, stimolano
l’interesse, l’impegno e la motivazione, che permettono al disabile di
confrontarsi e relazionarsi con l’ambiente esterno. Se i benefici fisici dovuti alla
pratica di un’attività motoria possono essere facilmente riconosciuti, quelli
psicologici possono essere poco visibili e difficili da percepire. L’attività motoria
consente ad una persona disabile di acquisire maggiore sicurezza nelle proprie
capacità, contribuendo a ripristinare la fiducia nelle proprie potenzialità. Lo sport
e l’acquisizione di nuove forme di movimento favoriscono atteggiamenti di
autonomia e di autocontrollo sempre maggiori, oltre che lo sviluppo di
comportamenti individuali che “migliorano con una piacevole e serena
occupazione del tempo libero” 30 . La conoscenza di sé, altro elemento
fondamentale, può derivare dallo sperimentare le proprie capacità, le proprie
possibilità e i propri limiti. Attraverso una competizione, la persona disabile, lo
sportivo, impara a reagire alla fatica e sfidare i propri limiti, ed a non arrendersi
alle difficoltà. Proprio nella persona disabile, infatti, lo sport e l’attività motoria
abituano alla disciplina e all’allenamento, determinando una profonda
conoscenza di sé e la consapevolezza nelle proprie capacità, attraverso il
passaggio dal mondo del “non posso” al mondo del “posso, riesco”31. Lo sport
può essere inteso anche come valvola di sfogo, in cui poter rilasciare tutte le
energie fisiche e mentali in eccesso. Diventa quindi un mezzo per scaricare
tensioni e aggressività che, se non adeguatamente controllate, potrebbero
invece manifestarsi in reazioni violente e improvvise. Va anche precisato che il
vissuto e lo stato psicologico della persona disabile cambiano notevolmente se
29
A. Magnanini, Op. Cit; p.137.
30
L. Bertini, Op. Cit; p.67.
31
Ibidem, p.72.
18la disabilità è congenita o se è determinata da un trauma o altri eventi. Nelle
persone con disabilità congenita il vissuto psicologico determinerà una
maggiore facilità nel superare gli ostacoli perché noti fin dalla nascita. Coloro
che hanno subito una limitazione o la perdita di una funzione vitale a causa di
un trauma o di malattie occorse dopo la nascita, avranno una maggiore
difficoltà nel superare gli ostacoli della particolare condizione. Da tutto quanto
detto, si desume che l’intervento di allenatori o persone vicine al disabile
durante la pratica sportiva, deve tenere sempre in considerazione una
molteplicità di variabili. Da non trascurare anche l’effetto che la pratica sportiva
produce sulla stimolazione delle facoltà intellettive e delle capacità creative.
Con l’attività motoria si tiene allenata la memoria, prevenendo il suo
invecchiamento, addestrando la concentrazione e imparando a comprendere
nuove informazioni. Il contributo dell’attività motoria e psicomotoria allo sviluppo
della persona e alla sua educazione è ampiamente riconosciuto. In una visione
pedagogica si è rivalutata la valenza sociale, di comunicazione e d’inclusione,
oltre a un ovvia connotazione ludica, della pratica motoria e sportiva32. Si può
affermare quindi che lo sport nelle persone disabili, motivandole costantemente,
“promuove la solidarietà, la socializzazione, fa aumentare l’autostima, rende
l’individuo più autonomo e meno dipendente dalla famiglia” 33 . Il fine ultimo
rimane la riconquista della propria identità e la conoscenza di sé, che attraverso
lo sport possono essere nettamente agevolate e sono indispensabili nei
processi d’integrazione e inclusione,.
1.2.3 Benefici socio relazionali
Proprio in una prospettiva d’inclusione e integrazione, la partecipazione di
persone disabili in attività motorie e sportive agevola l’apertura verso gli altri e
induce a nuovi rapporti sociali, “consente di abbandonare l’isolamento e
l’autocommiserazione che derivano dalla depressione causata dal trauma,
favorendo i processi relazionali nel contesto sociale”34. Lo sport e le attività
motorie sono sempre svolte in relazioni con altre persone e in contesti sociali
32
Cfr. P. Moliterni, Didattica e Scienze motorie, Roma, Armando 2013
33
A. Magnanini, Op. Cit; p.140.
34
L. Bertini, Op. Cit; p.67.
19diversi da quelli abituali, obbligando quindi la persona a relazionarsi in maniera
ogni volta diversa, utilizzando le proprie potenzialità e capacità. Affacciandosi
sul mondo esterno e praticando sport o un’attività motoria, il disabile costruisce
nuove relazioni umane e individua nuovi profili di collaborazione disinteressata.
Nel mondo dello sport, infatti, le interazioni che s’instaurano sono molteplici e di
diverso tipo, giacché si entra in contatto con l’allenatore, con i compagni e con
gli avversari. Questo vasto panorama di situazioni consente al soggetto di
sperimentare diversi stati emotivi, di gestire eventuali conflitti relazionali e di
imparare ad adattare la sua personalità alle persone con cui interagisce. Sono
proprie dello sport, infatti, una serie di relazioni, regole, sanzioni e premi “che
rappresentano uno spaccato esperienziale che costituiranno per la persona
disabile un bagaglio di nuove conoscenze e di strumenti operativi e di pensiero,
da utilizzare per districarsi in molte altre situazioni della vita”35. Nei rapporti
interpersonali, alla persona disabile sono posti degli obiettivi e degli specifici
ruoli, permettendogli di migliorare così il processo di costruzione della sua
identità personale. Un beneficio socio-relazionale che la pratica sportiva
produce è costituito anche dall’acquisizione delle regole. Qualsiasi sport
possiede un insieme di regole che vanno rispettate per garantire la conduzione
di un gioco leale e paritario. La persona disabile, l’atleta, deve quindi sottostare
a queste norme - scritte e non - per giungere alla realizzazione dell’obiettivo.
Accettare le regole che vengono imposte significa anche accettare il giudizio
dell’altro, acconsentire al sacrificio imposto dagli allenamenti ed essere in grado
di confrontarsi con gli altri. Gli sport di squadra, in questo senso, hanno una
forte valenza socio-relazionale. Il gruppo può essere definito come un insieme
non casuale di persone con bisogni, motivazioni e valori condivisi, che si
trovano in una relazione di interdipendenza positiva le une con le altre per il
raggiungimento di uno scopo comune. Nel gruppo si percepisce un forte calore
e un forte senso di appartenenza e si sperimenta in prima persona il significato
dell’aiutarsi reciprocamente per il raggiungimento di un obiettivo. Ogni membro
del gruppo dipende dal compagno, che al tempo stesso costituisce per lui una
risorsa. Il disabile è costretto a relazionarsi e confrontarsi e, inoltre, il fatto di
35
A. Magnanini, Op. Cit; p.139.
20vedere vicino a sé un’altra persona che agisce, può, con il tempo, “maturare
un’importante capacità emulativa, permettendogli di sviluppare un buon grado
di socialità”36 . La persona disabile che pratica sport potrà raggiungere una
maggiore consapevolezza delle proprie possibilità, diventare capace di
finalizzare le attività proposte in comune con i compagni, rendendosi sempre
più disponibile a socializzare37. Completando, i benefici dello sport sul piano
socio-relazionale si possono tradurre in una maggiore autonomia e una
consapevole apertura verso gli altri, sviluppando la capacità di confrontarsi e
relazionarsi con le persone e l’ambiente circostante.
36
L. Bertini, Op. Cit; p.70.
37
Cfr. L. Bertini, Op. Cit.
21CAPITOLO II
2.1 La paracanoa
Paracanoa è il termine utilizzato per indicare lo sport della canoa e del kayak
per persone in situazione di disabilità. Prima che questo termine fosso
introdotto dalla federazione internazionale di canoa che regola l’attività
agonistica, la International Canoe Federation (ICF), per allinearsi nel 2009 alle
direttive del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), la canoa e il kayak per
persone con disabilità era individuata attraverso diverse sigle come Adaptive
Paddling”, “Handykayak”, “Canoeing for All” o anche “PaddleAbility”. Ancora
adesso alcune federazioni nazionali di canoa utilizzano un linguaggio diverso
per indicare il movimento della paracanoa e su vari documenti dell’ICF si può
incontrare il termine “PaddleAbility”38. La paracanoa non differisce dalla canoa e
dal kayak per le persone normo-dotate. Le competizioni consistono in gare di
velocità, che richiedono una grande forza e potenza per accelerare e
mantenere una buona velocità fino al traguardo. Esistono anche altre forme di
competizione, ma ovviamente è possibile utilizzare la canoa e il kayak anche
solo per svago e divertimento. Le competizioni di velocità della paracanoa
comprendono sia le competizioni in kayak sia in canoa ed i kayak utilizzati nella
paracanoa sono gli stessi utilizzati da atleti normo-dotati, con alcuni piccoli
accorgimenti. La canoa è invece sostituita da imbarcazioni chiamate “outrigger”
o “Va’a”, mentre a livello internazionale questa imbarcazione viene identificata
con la lettera “V”. Sono imbarcazioni lunghe e strette, a cui sono connessi,
attraverso due traverse, un bilanciere o “ama”, che incrementa la stabilità.
Queste imbarcazioni sono utilizzate sia da atleti disabili sia da atleti normo-
dotati, ma nelle competizioni ufficiali dell’ICF, l’utilizzo di questo tipo
d’imbarcazione è riconosciuto solo per le competizioni di paracanoa. Il mezzo
con cui si genera la propulsione, la pagaia, è la stessa sia per atleti disabili che
normo-dotati mentre la grandezza delle pale e la lunghezza della pagaia
possono cambiare in base alle caratteristiche fisiche di ogni atleta. Ci sono
38
International Canoe Federation (ICF). ICF Paracanoe Rules 2011. Disponibile in
www.canoeicf.com (visionato il 01/12/2015).
22quindi molte somiglianze nella pratica della canoa e del kayak tra atleti disabili
e normo-dotati, sia per quanto riguarda le competizioni, sia per quanto riguarda
i materiali utilizzati. Ad alto livello, l’imbarcazione e la pagaia possono essere gli
stessi, pur adottando dei mirati accorgimenti per permetterne l’utilizzo in
maniera sicura e controllata. Gli sport della canoa e del kayak sono governati
dall’ICF, e tra questi è ovviamente compresa anche la paracanoa. “Outrigger” e
“Va’a”, invece, sono governate dalla International Va’a Federation (IVF) che sin
dai primi campionati mondiali del 1996 per atleti normo-dotati, ha promosso e
sviluppato un sistema di classificazione riconosciuto e applicato a partire dai
campionati mondiali IVF a Sacramento 39 del 2008. Per regolare a livello
internazionale la paracanoa e permettere a persone in situazione di disabilità di
praticare la canoa e il kayak, l’ICF e l’IVF hanno deciso di lavorare insieme,
formando un comitato di lavoro composto da rappresentati di entrambe le
federazioni, che ha portato nel 2009 a lanciare il programma di sviluppo della
paracanoa riuscendo a inserire questa disciplina nel programma dei campionati
mondiali di canoa e kayak.
Tab.1: Numero delle federazioni internazionali e numero degli atleti partecipanti agli
ultimi campionati mondiali.
WORLD NUMBER OF NUMBER OF
CHAMPIONSHIP FEDERATION ATHLETETS
2009 Dartmouth (CAN) Demonstration in Sprint World Championship
2010 Poznan (POL) 28 67
2011 Szeged (HUG) 26 74
2012 Poznan (POL) 31 97
2013 Duisburg (GER) 33 118
2014 Moscow (RUS) 38 n.d.
Nella tabella 1 è riportato il numero di federazioni nazionali e di atleti che hanno
partecipato ai campionati mondiali. Dalla sua prima apparizione in Canada, nel
2009, come semplice dimostrazione, fino a Milano 2015, il numero di atleti e
39
D.A Hudson, Race-time prediction for the Va’a Paralympic sprint canoe; The 2014 conference
of the International Sports Engineering Association. Disponibile in www.sciencedirect.com
(visionato il 07/12/2015).
23nazioni partecipanti è sempre cresciuto. Atleti dei cinque continenti hanno preso
parte alle ultime edizioni dei campionati mondiali, a dimostrazione che il
movimento della paracanoa sia ormai di interesse mondiale, tanto che, dopo la
candidatura nel 2010, l’IPC ha inserito nel programma dei Giochi Paralimpici di
Rio de Janeiro del 2016 anche la Paracanoa. Si spera che questa prima
apparizione ai Giochi Paralimpici possa essere un’ulteriore consacrazione e
continuare a stimolare la crescita di questa disciplina. Per questo primo grande
appuntamento, sono in programma sei eventi, divisi per uomini e donne e nelle
rispettive classi funzionali40.
Tab.2: Tempi delle medaglie d’oro maschili alle ultime edizioni dei campionati mondiali,
divisi per classe di appartenenza.
MAN
K1 200M V1 200M
LTA TA A LTA TA A
2010 Poznan 44.176 44.617 56.151 54.918
2011 Szeged 43.294 44.055 54.340 57.648 1:02.958 1:30.792
2012 Poznan 43.259 44.614 53.550 54.749 59.024 1:13.143
2013 Duisburg 38.891 40.790 51.330 50.613 56.111 1:01.610
2014 Moscow 39.208 40.928 49.375 50.368 48.596 54.944
2015 Milan 39.270 42.542 50.863 50.656 49.489 57.912
L’attenzione che questa disciplina ha ricevuto e continua a ricevere,
l’innovazione dei materiali utilizzati e soprattutto il miglioramento delle
metodiche di allenamento per atleti disabili, ha permesso agli atleti della
paracanoa di migliorare le proprie performance raggiungendo risultati
straordinari. Nelle tabelle 2 e 2.1 sono riportati i tempi dei primi classificati ai
campionati mondiali, divisi tra kayak e Va’a nelle rispettive classi funzionali ( dal
marzo 2016 le sigle “LTA”, “TA”, “A”, indicatori della classe di appartenenza e
soprattutto del grado di funzionalità residua di ogni atleta, sono stati cambiati
con le sigle KL1, KL2, KL3 per il kayak e VL1, VL2, VL3 per la Va’a41 ). Da una
40
International Paralympic Committee (IPC), Rio 2016 Paralympic Games – Qualification Guide
Canoe, IPC Committee, disponibile in www.paralympic.org (visionato il 03/12/2015).
41
International Canoe Federation (ICF), ICF Paracanoe KAYAK Classification Manual 2015,
disponibile in www.canoeicf.com (visionato il 15/2/2016).
24veloce e superficiale lettura 42 , si può notare come dal primo campionato
mondiale fino all’ultimo che si è disputato, i tempi di gara siano sempre
migliorati.
Tab. 2.1: tempi delle medaglie d’oro femminili alle ultime edizioni dei campionati
mondiali, divisi per classe di appartenenza
WOMEN
K1 200M V1 200M
LTA TA A LTA TA A
2010 Poznan 53.190 1:02.942 x 1:12.096
2011 Szeged 56.425 1:04.139 1:26.561 1:11.882 1:31.682 x
2012 Poznan 57.775 1:04.693 1:05.684 1:08.028 1:08.655
2013 Duisburg 54.317 56.982 59.808 59.967 1:03.243 1:05.628
2014 Moscow 49.700 53.128 55.213 57.948 1:00.358 1:00.016
2015 Milan 50.501 53.023 56.865 1:02.536 59.916 1:15.299
Se pensiamo che agli ultimi campionati mondiali di Milano per atleti normo-
dotati, la medaglia d’oro maschile, sulla stessa distanza della gara di paracanoa
(200 metri), è stata vinta con il tempo di 34.802 secondi rispetto ai 39.270
secondi nella paracanoa, ci si può rendere conto di quanti passi in avanti siano
stati fatti sotto tutti i punti di vista. Grazie al miglioramento dei materiali utilizzati,
alle tecniche e ai metodi di allenamento, ma ovviamente anche al sostegno di
tutto il movimento della paracanoa, gli atleti hanno potuto realizzare prestazioni
sempre migliori. I tempi riportati nella tabella 2 e 2.1 sono riportati nei bollettini
ufficiali di gara. Sicuramente uno studio più approfondito su i tempi di gara,
valutando un modello di prestazione adeguato per gli atleti della paracanoa,
potrebbe fornire informazioni più dettagliate, ma non è lo scopo di queste
pagine.
42
Nell’analizzare i tempi di gara, sarebbe corretto prendere in considerazione una serie di
variabili, come la temperatura dell’acqua, la temperatura atmosferica e la forza del vento.
Queste variabili potrebbero aver condizionato in maniera considerevole i temi di gara, che di
conseguenza non rispecchierebbero le capacità degli atleti, nell’ottica in cui sono stati riportati i
dati.
25Puoi anche leggere