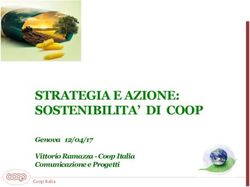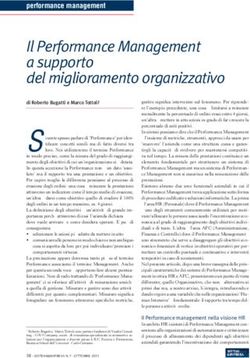LA POLITICA ESTERA DI OBAMA 2.0: COMPLESSITÀ E OPPORTUNITÀ
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA POLITICA ESTERA DI OBAMA 2.0:
COMPLESSITÀ E OPPORTUNITÀ
Roberto Menotti
I l quadro internazionale che la seconda amministrazione Oba-
ma si trova di fronte può essere analizzato alla luce delle dina-
miche della complessità: ciò consente di valutare le principali
scelte che Washington dovrà compiere e le possibili ricadute per
altri paesi e contesti regionali.
Nonostante la grande sfida consistente nel gestire una fase di (re-
lativa) austerità, il presidente rieletto dispone di alcune opportunità
in politica estera, visto che tra il 2009 e il 2012 sono stati realizzati
investimenti con un ritorno necessariamente dilazionato nel tempo.
Si tratta in primo luogo del ritiro delle forze americane dall’Iraq e
di quello più graduale dall’Afghanistan (a seguito però di un netto
aumento temporaneo dello sforzo bellico tra il 2010 e l’estate del
2012), che si configura anche come una scelta di riallocazione di
risorse militari (e finanziarie) verso altri impegni.
C’è stata poi la strategia del “pivot to Asia” che, al di là di questo
sintetico slogan variamente articolato dall’amministrazione, è in so-
stanza un mix di contenimento e cooperazione rispetto alla Cina.
Washington ha puntato infatti su un rafforzamento delle alleanze
militari a raggiera incentrate sulla forza aeronavale americana, per
imbrigliare la potenza cinese, e al tempo stesso su una intensifica-
zione del dialogo strategico a tutto campo con Pechino, nel ten-
tativo di spingere i suoi leader ad assumersi maggiori oneri per la
governance internazionale rispettando le regole esistenti (elaborate di
fatto con una scarsa partecipazione cinese).
L’altro dossier con importanti ramificazioni macro-regionali e in
parte globali è quello del nucleare iraniano: la presidenza Obama
ha perseguito una linea di pressione crescente attraverso sanzioni
internazionali molto dure pur senza mai escludere né il riavvio di un
37Panorama 2013
processo negoziale (a certe condizioni) né il ricorso a imprecisate
opzioni coercitive.
La quarta scelta di investimento che si può identificare è il “reset”
verso la Russia: dopo aver facilitato un primo significativo risultato
sul piano del controllo degli armamenti, l’apertura diplomatica ha
esaurito il suo slancio, ma resta l’interesse americano ad incentiva-
re un atteggiamento cooperativo (o quantomeno non ostativo) di
Mosca su varie questioni di sicurezza, dal Medio Oriente all’Asia
centrale e alla non proliferazione.
Tutte queste iniziative di politica estera hanno in comune tempi
di maturazione non brevi, e dunque richiedono una buona dose
di pazienza e perseveranza. Naturalmente, i ritorni su tali inve-
stimenti realizzati nel primo quadriennio di Obama non sono
garantiti, e dipendono in parte proprio da un’adeguata compren-
sione dei sistemi complessi che caratterizzano i rapporti inter-
nazionali. Da questo punto di vista, il primo mandato è stato
comunque promettente, soprattutto se comparato con le due
presidenze di G.W. Bush.
Le dinamiche della complessità crescente
Un’analisi basata sui concetti della complessità 1 può illuminare
la logica seguita dall’amministrazione Obama in politica estera
sui dossier appena ricordati (e su altri, come le rivolte arabe),
nonchè la sua probabile evoluzione nel secondo. In partico-
lare, una specifica sequenza descritta e studiata dai teorici dei
sistemi sembra essere in azione da alcuni anni nel panorama
politico, economico e strategico globale: si tratta della reazione
ai cosiddetti “gap di complessità”. Un criterio generale è che il
grado di complessità del “controllore” non può essere inferio-
re a quello del sistema controllato; nello specifico, la struttura
dei rapporti internazionali/transnazionali mostra un aumento
di complessità, soprattutto per la diffusione di nuove tecno-
logie della comunicazione e per la forte crescita economica di
alcune grandi economie.
38Roberto Menotti
E’ ben noto che i sistemi complessi, aperti e dinamici – come è
certamente uno Stato moderno, e come è certamente il sistema
dei rapporti internazionali nel suo insieme – devono muoversi
lungo l’equilibrio instabile tra organizzazione e caos, e combina-
re elementi gerarchici con elementi reticolari (o network). Per una
potenza a raggio globale come gli Stati Uniti, l’implicazione più
chiara di questo fenomeno è che uno stretto grado di controllo
sulle dinamiche regionali rischia di avere costi sempre più alti: si
presenta dunque un costante trade-off tra influenza diretta e conte-
nimento dei costi di gestione. Inoltre, i sistemi reticolari che rag-
giungono un livello elevato di interconnessione hanno la capacità
di trasmettere gli impulsi in tutte le direzioni (magari in modo non
simmetrico, ma pur sempre multi-direzionale): in altre parole, una
rete di rapporti molto fitta può anche amplificare gli shock che si
verificano lontano dai “nodi” principali. Almeno due esempi evi-
denti di tale fenomeno sono stati le ramificazioni degli attentanti
del settembre 2001 e quelle della prima crisi finanziaria americana
del 2007-2008; e in entrambi i casi gli Stati Uniti hanno subito
gli effetti di ritorno (feedback) delle loro stesse azioni finalizzate
a ridurre le iniziali conseguenze negative. Gli shock tendono, in
altre parole, a rimbalzare in molte direzioni, finendo a volte per
amplificarsi invece di dissiparsi.
Su questo sfondo, i teorici dei sistemi spiegano che quando un’or-
ganizzazione raggiunge un dato livello di complessità si tende ad
introdurre nuovi livelli gerarchici di gestione; se questi non bastano
comunque a mettere sotto controllo i processi in corso, si ricorre
solitamente a strutture decentrate, cioè reticolari. In sostanza, le
gerarchie cedono un margine di autonomia ai network “locali” – nel
caso del sistema internazionale, la maggiore potenza globale con-
cede autonomia ad alcune potenze (o forze non statuali) regionali.
Questa dinamica viene spesso descritta senza ricorrere direttamente
all’accezione più rigorosa del termine “complessità”2; così facendo,
però, perde una parte della chiarezza concettuale che deriva dal guar-
dare a fenomeni “emergenti” (in cui il sistema si comporta diversa-
mente dalle sue parti) e “transizioni di fase” (mutamenti qualitativi
39Panorama 2013
di una dinamica quando si raggiunge una soglia critica di mutamenti
quantitativi) come i veri meccanismi universali del cambiamento.
La consapevolezza (quantomeno indiretta) di queste dinamiche è
emersa chiaramente nella valutazione che, fin dalla campagna elet-
torale del 2008, la squadra di Obama aveva dato delle “guerre di
Bush” in Afghanistan e in Iraq. In entrambi i casi, si era di fatto
realizzato con relativa facilità un iniziale intervento militare, gra-
zie alla vastissima superiorità degli Stati Uniti sul piano delle risor-
se, su quello tecnologico e su quello organizzativo. A quella prima
fase era però seguito un forte (e stranamente inatteso) aumento di
complessità delle dinamiche locali: un aumento che la diplomazia,
l’intelligence e la macchina militare americana non sono preparate ad
affrontare. In estrema sintesi, era diventato evidente al momento
dell’arrivo di Obama alla Casa Bianca che costruire in Afghanistan e
Iraq un sistema socio-politico inclusivo e rappresentativo, pacifico,
e al contempo favorevole agli interessi americani, è davvero un’im-
presa fuori portata (almeno nell’orizzonte temporale di un mandato
presidenziale). Da tale valutazione generale sono scaturite decisioni
conseguenti, ovviamente diverse nei due casi.
L’impegno in Afghanistan è stato gestito con particolare cautela, se
non altro a causa del legame diretto con il terrorismo “marcato al
Qaeda” e alle ramificazioni della presenza americana (e occidentale)
nel paese anche sul vicino Pakistan; ma il conflitto andava comun-
que chiuso al più presto dal punto di vista militare. Per l’Iraq la scel-
ta era assai più semplice e netta – essendo del resto stata facilitata da
decisioni prese dalla stessa amministrazione Bush nella fase finale
del proprio mandato: il ritiro è dunque risultato più rapido.
Non va dimenticato che una delle motivazioni di fondo fornite uf-
ficialmente per i due “ritiri gemelli” è stata la volontà di spostare
risorse su altri obiettivi strategici, soprattutto nella regione Asia-
Pacifico. E’ stato dunque coerente con questa premessa mantenere
poi un atteggiamento molto riluttante sul possibile impiego di for-
ze americane nella crisi libica e in quella siriana (come anche, con
importanti differenze di contesto, nel caso di una ipotetica azione
militare contro l’Iran).
40Roberto Menotti
Tensioni da gestire e opportunità da cogliere
La scelta di fondo operata dalla prima amministrazione Obama è
stata piuttosto chiaramente di accettare un maggiore tasso di libertà
di manovra di alcuni alleati regionali, in cambio di una riduzione
dei costi immediati incorsi dagli Stati Uniti. Tale scelta verrà con-
fermata, a giudicare dalla campagna elettorale 2012, proprio perché
corrisponde a una visione letteralmente “complessa” del panorama
internazionale e non soltanto a un atteggiamento di “cautela strate-
gica”. Pur in questo quadro di continuità, ci saranno due spinte a un
parziale adattamento a ad alcune innovazioni: anzitutto, l’esigenza
di reagire a crisi acute – come un rapido aumento delle tensioni sul-
le questioni territoriali irrisolte in Asia-Pacifico, o un’accelerazione
della crisi latente tra Iran e Israele sul programma nucleare iraniano
– può certamente causare una presa di iniziativa più diretta da parte
di Washington. In secondo luogo, al di là di situazioni emergenziali
di questo tipo, alcune variabili (regionali e settoriali) in movimen-
to rispetto al quadriennio 2009-2012: la gestione del bilancio della
difesa; l’allocazione delle risorse militari tra Asia-Pacifico e Medio
Oriente/Golfo Persico; il rapido avvicinamento all’obiettivo dell’in-
dipendenza energetica; gli incentivi alla collaborazione con i paesi-
chiave dell’America Latina.
A ben guardare, questi quattro fattori sono in effetti interconnessi,
il che significa che anche un singolo spostamento può produrne
altri, a cascata.
Sul primo fattore, alla luce delle proiezioni l’obiettivo di Obama
è di arrestare la crescita della spesa (che è stata netta negli ultimi
anni), e questa tendenza si rafforzerà sotto la pressione dei difficili
compromessi per evitare il “fiscal cliff”. Il contenimento della spesa
per questa amministrazione è una questione prioritaria che condi-
zionerà anche la politica di sicurezza e difesa.
Sul secondo punto, esiste una inevitabile tensione tra i grandi impe-
gni americani in Asia-Pacifico e l’eredità di “stabilizzatore” in Medio
oriente. Qui una soluzione possibile è di concentrare maggiori risorse
aeronavali (e diplomatiche) nell’Oceano Indiano, che di fatto è il na-
41Panorama 2013
turale collegamento geostrategico tra area del Golfo e Asia orientale.
Un settore di cambiamento che è giunto inatteso (soprattutto per
la rapidità) è quello energetico: gli Stati Uniti sono avviati in una
sorta di marcia di avvicinamento verso l’indipendenza energetica,
grazie allo sfruttamento delle riserve di shale gas (non dunque grazie
alle politiche di Obama per il sostegno alle energie verdi). Questo
passaggio cruciale ha certamente l’effetto di accrescere il grado di
libertà d’azione americana in alcuni teatri difficili: senza dubbio il
Golfo e il Medio oriente, ma anche la Russia e l’Asia centrale, per
finire con i produttori latinoamericani.
Infine, le basi demografiche (forte partecipazione ispanica) della
riconferma elettorale di Barack Obama forniscono condizioni in-
terne più solide per coltivare i rapporti con l’America Latina. Di
fatto, l’amministrazione gode di un consenso potenziale che ricor-
da quello tradizionale dell’America “Wasp” (White, AngloSaxon and
Protestant) verso l’Europa nel secondo dopoguerra. In particolare,
ciò può facilitare il graduale sviluppo di una partnership pragma-
tica con il Brasile – il paese che nella regione è attualmente il più
dinamico e ha di gran lunga il maggiore potenziale. Un altro ovvio
candidato a un rapporto preferenziale più costruttivo che in passa-
to è il Messico, che ha anche una rilevanza diretta per la sicurezza
transnazionale del lungo confine Sud degli Stati Uniti.
Queste considerazioni geopolitiche possono apparire di tipo piutto-
sto classico – non riconducibili cioè necessariamente al paradigma
della complessità. In effetti, tuttavia, possono essere meglio com-
prese in quanto fenomeni tecnicamente (non solo metaforicamente)
complessi di adattamento in corso nella politica estera americana.
L’equilibrio delicato tra complessità,
disordine e adattamento: le sfide per Obama
L’America di Obama ha di fronte una situazione in cui la comples-
sità aumenta, e in cui dunque le alternative sono un maggior con-
trollo gerarchico (che implica ulteriore dispendio di energia) oppure
una cessione di autonomia ai network locali esistenti. L’amministra-
42Roberto Menotti
zione di George W. Bush aveva in sostanza tentato di imporre il
peso gerarchico americano su alcune regioni-chiave in reazione alla
sfida del settembre 2001, e i costi di quella scelta sono stati eviden-
temente elevati.
Anche l’opzione alternativa non è priva di rischi e costi indiretti, come
gli Stati Uniti stanno sperimentando almeno dal 2009: si pensi al ruo-
lo della Turchia come possibile stabilizzatore e mediatore in Medio
oriente (dalla questione palestinese alle iniziali speranze di esercitare
una qualche influenza sul regime di Assad in Siria); o alla volontà
americana di restare nel quadro dell’ONU nel tentativo di contenere
la crisi siriana (lasciando dunque un potere di veto a Russia e Cina); o
ancora all’esigenza di mantenere unito il “fronte delle sanzioni” con-
tro l’Iran. In fondo, la scelta di affidarsi ad intese multilaterali è una
forma di gestione reticolare dei problemi, basata sull’azione di “nodi”
multipli della rete globale – le altre grandi o medie potenze, nel lin-
guaggio delle relazioni internazionali. Una scelta che può generare
una “leva” maggiore moltiplicando le risorse, ma che naturalmente
può anche limitare la libertà di azione degli attori più forti.
Guardando alla situazione nell’ottica apparentemente astratta della
complessità, si chiarisce un doppio problema assai concreto per gli
Stati Uniti: i network hanno la capacità di auto-organizzarsi (il che fa-
cilita la governance, ma riduce il controllo diretto di Washington), e pro-
ducono effetti-contagio (il che costringe comunque anche la potenza
maggiore a prendere dei rischi). Il precedente delle operazioni della
NATO in Libia è illuminante per il futuro: gli Stati Uniti hanno limi-
tato la propria esposizione svolgendo soltanto un’azione di supporto
iniziale degli alleati europei, ma hanno dovuto accettare una tempi-
stica incerta per l’esito finale dell’intervento e hanno poi rinunciato a
un ruolo diretto e predominante nella Libia post-Gheddafi. Inoltre,
hanno finito per pagare comunque un prezzo alto per un coinvolgi-
mento limitato, con la morte del loro ambasciatore e le ripercussioni
di un inusuale attacco contro diplomatici americani.
Date le sue dimensioni e un grado di complessità assai maggio-
re, l’intricata crisi siriana presenta un dilemma analogo che Obama
deve affrontare per non incorrere in costi maggiori in futuro: i ri-
43Panorama 2013
schi di contagio negativo e alcuni effetti feedback sono connaturati
a una forma di intervento diretto (che fino alla rielezione il presi-
dente americano ha evitato), ma d’altro canto un contagio regionale
negativo è già in atto e dunque va incorporato (come un costo che
si sta già pagando) nelle decisioni da assumere d’ora in avanti.
E’ un caso in cui la “cautela strategica” che caratterizza il modus
operandi del presidente rieletto deve fare i conti con i costi – non
solo con i benefici – del non-intervento. Si possono certamente
trovare per la Siria strumenti indiretti di influenza, forme creative di
sostegno all’azione di uno o più partner regionali o, meglio ancora,
interventi concordati a livello multilaterale; ma neppure il “nodo”
principale del sistema globale – gli Stati Uniti – potrà evitare del
tutto ulteriori feedback negativi. Il nuovo team di Obama ne è cer-
tamente cosciente.
Note:
1
La letteratura sulla complessità è molto vasta, e stanno aumentan-
do rapidamente le sue applicazioni alle scienze sociali, sebbene
con un notevole ritardo per quanto riguarda gli studi strategici e
soprattutto le relazioni internazionali. Si veda in proposito Ro-
berto Menotti, Mondo caos. Politica internazionale e nuovi paradigmi
scientifici, Laterza, 2010.
2
Un’ottima esposizione è ad esempio quella di Charles A. Kupchan,
No One’s World. The West, the Rest, and the coming global turn, Oxford
University Press, New York, NY, 2012. Su una linea simile si veda
anche John C. Hulsman “US foreign policy after the election:
caution and austerity”, Aspenia online, 12/11/2012 (www.aspenin-
stitute.it/aspenia-online/).
44Puoi anche leggere