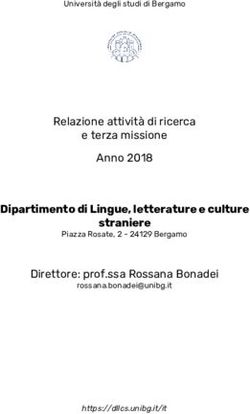Il progetto nella Città Fragile - Henrietta Demma Stefano Di Zazzo Scenari di riappropriazione per l'ex Piazza d'Armi di Milano - IRIS Politecnico ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Henrietta Demma
Stefano Di Zazzo
Il progetto nella Città Fragile
Scenari di riappropriazione per l’ex Piazza d’Armi di Milano
Postfazione di Andrea Di FrancoL’ARCHITETTURA NECESSARIA L’Architettura Necessaria è una collana diretta da Andrea Di Franco, che traduce all’ester- no del mondo accademico gli studi e le ricerche degli architetti del Politecnico di Milano. Il suo obiettivo è quello di raccogliere quei lavori che affrontano temi concreti, urgenti e necessari nell’orizzonte della crisi dell’attuale, multiforme “paesaggio umano”. La redazione di questo libro è frutto di un lavoro di ricerca sviluppato a partire dalla tesi di laurea magistrale “Il progetto nella Città Fragile. Scenari di riappropriazione per abitare l’informale: Piazza d’Armi e l’Ovest milanese” di Henrietta Demma e Stefano Di Zazzo. L’edizione è stata curata dagli autori e successivamente è entrata a far parte della collana l’Architettura Necessaria di cui coglie il senso. Si ringraziano l’Associazione Le Giardiniere, Bianca Bottero, Vincenzo Ferri, Diego Profili, Alberto Secchi e gli ortisti di Piazza d’Armi per il prezioso contributo, e Francesca Cognetti e Andrea Di Franco per il tempo dedicato e l’inestimabile supporto. ISBN 978-88-916-4657-6 © Copyright 2021 Maggioli S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, anche ad uso interno e didattico, non autorizzata. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino, 8 Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595 www.maggiolieditore.it e-mail: clienti.editore@maggioli.it Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. Il catalogo completo è disponibile su www.maggiolieditore.it area università. Finito di stampare nel mese di Marzo 2021 nello stabilimento Maggioli S.p.A. Santarcangelo di Romagna (RN)
Indice
Introduzione 9
Il progetto nella Città Fragile
Parte I
Manifesto della Città Fragile
1. La Città Fragile 21
1.1 La città frammentata 22
1.2 La città in attesa 28
1.3 La città informale 31
2. Fragilità come condizione del contemporaneo 35
2.1 Città dell’incertezza 35
2.2 Città della complessità 37
2.3 Città delle disuguaglianze 40
2.4 Povertà urbane e bidonvillizzazione 44
2.5 Antropocentrismo e perdita di biodiversità 54
3. Categorie della Città Fragile 57
3.1 Il Terzo Paesaggio 57
3.2 Le Rovine 61
3.3 L’Informale 64
Diritto alla terra: la casa costruita in una notte 64
Riappropriazione, occupazione, autocostruzione 67
L’orto informale 734 Indice
4. L’antifragile 77
Categorie fragili e antifragili 78
5. Abitare la Città Fragile 81
Parte II
Teorie del progetto fragile
1. Crisi del progetto: verso un progetto anarchico 87
2. Il progetto fragile 97
Debole e diffuso 98
Partecipato e radicato 99
Temporaneo e di supporto 103
Incerto, aperto 108
Modesto, etico, vernacolare 111
3. Il ruolo dell’architetto oggi 115
Il ruolo sociale: attivatore di politiche 116
Interprete del territorio 120
4. Pratiche di progetto virtuose 123
Lacaton & Vassal 131
Studio Secchi Viganò 134
Urban-Think Tank 137
Studio Albori 140
Raumlabor 142
Assemble 145
Orizzontale 147Il progetto nella Città Fragile 5
Parte III
Una sperimentazione progettuale: Piazza d’Armi e l’Ovest
milanese
1. L’ovest milanese interpretato come territorio fragile 153
1.1 Letture della Città Fragile 155
1.1.1 La città frammentata 156
1.1.2 La città in attesa 156
1.1.3 La città informale 157
1.2 Categorie della Città Fragile 158
1.2.1 Le Rovine 159
1.2.2 Il Terzo Paesaggio 161
1.2.3 L’Informale 162
2. Piazza d’Armi come contesto fragile 165
2.1 Storia di Piazza d’Armi 168
2.2 La biodiversità di Piazza d’Armi 177
2.3 Un’esperienza diretta dell’esistente 180
3. Le voci di Piazza d’Armi 193
Le Giardiniere 194
Diego Profili 200
Vincenzo Ferri 204
Bianca Bottero 207
Alberto Secchi 208
Gli ortisti 211
4. Abitare la Città Fragile: la costruzione di un 215
immaginario6 Indice
5. Progettare per fasi e sperimentazioni 221
5.1 Tempi del progetto 222
5.2 Nodo di progetto: la Città Informale 234
6. Verso sentieri possibili 255
Postfazione 263
Opera Aperta.
Temi per il progetto come processo di modificazione
di Andrea Di Franco
Fonti iconografiche 277
Indice dei nomi 279
Bibliografia 283
Sitografia 292Postfazione
Opera Aperta.
Temi per il progetto come processo di modificazione
di Andrea Di FrancoIl progetto nella Città Fragile 265
Processo
Questo lavoro emerge da una ricerca composta su diversi
fronti e che mette in relazione diversi strumenti e metodologie
di analisi e progetto dello spazio urbano, accomunati e con-
dotti a sinergia dall’intento di praticare il progetto urbano di
modificazione in ambiti fragili e marginali.
Questa disposizione della ricerca mette in tensione – e in pra-
tica –, come carattere imprescindibile, l’idea di progetto ar-
chitettonico in quanto processo, e tenta di comporre la natura
di questo percorso attraverso le sue differenti dimensioni e i
suoi molteplici caratteri. Anzitutto, la dimensione più evidente
dell’ambito processuale, quella del tempo: necessario registro
ma anche inevitabile ostacolo, per via della sua comprensione
di fenomeni endemicamente mutevoli (e spesso contraddittori)
proprio per la loro appartenenza al piano diacronico, ovveros-
sia ad un piano attraversato da tempi differenti che compon-
gono e disfano possibilità e prassi. Poi, la dimensione dello
spazio: la struttura dell’ordine geometrico viene attraversata
anch’essa dalla necessità di scomporre e ricomporre, a secon-
da delle circostanze molteplici e mutevoli che inevitabilmente
costituiscono il processo, gli ordini spaziali, le gerarchie, le mi-
sure, le disposizioni reciproche; un ordine plurale la cui figura
possa dialogare, attraverso la propria geometria variabile, con
la molteplicità delle domande e corrispondere ad esse con la
mutevolezza delle possibili risposte, espresse dagli endemici,
molteplici punti di vista.1
1
La dimensione processuale appare necessaria per poter inquadrare, senza
distorcenti riduzionismi, la complessa realtà del progetto contemporaneo, in
una lettura che chiama in causa, nella ricerca delle ragioni delle modificazioni
passate e future, spazio, tempo, esperienza, sistema delle relazioni: «Forse quel-
la attuale potrebbe essere considerata l’epoca dello spazio. Viviamo nell’epoca
della giustapposizione, nell’epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco e
del disperso. Viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta, credo, più
come grande percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei
punti e che intreccia la sua matassa». FOUCAULT Michel, Spazi altri. I principi
dellíeterotopia, in Lotus International n. 48-49, Electa, Milano, 1985.266 Postfazione Infine, la dimensione disciplinare che lega teoria, prassi e so- cietà. La disciplina della modificazione dello spazio, in quanto pratica teorica, cioè attività che punta a forme concrete attra- verso la regolazione teorica delle tecniche, delle procedure e dei linguaggi, si trova a dover incorporare, nei propri mecca- nismi e tra i propri strumenti di previsione e regolazione, la dimensione relazionale, esprimibile e operabile esclusivamen- te sul piano del processo. Il processo relazionale, l’apertura ‘strutturale’2 agli attori che intervengono nella composizione del progetto, sostanzia la natura di pratica sociale della nostra disciplina. In quanto pratica sociale, le procedure del fare architettonico non possono fare a meno di misurarsi e codificarsi in relazione alla nebulosa dei fenomeni sociali. Tra i fenomeni da conside- rare nell’intreccio che mette in forma la struttura del progetto, oltre ai suoi effetti concreti, cioè le realizzazioni architettoni- che, si raccolgono «l’insieme (di tutte le narrazioni), di tutti i conflitti e le negoziazioni sociali e tecniche che sono stati necessa- ri per la sua costruzione»3: cioè a dire la struttura delle relazioni che lo sottende. Lo stesso impianto metodologico del lavoro che qui è presenta- to fa riferimento ad un processo articolato, condiviso con altri 2 Faccio riferimento al termine ‘struttura’ per evocare gli studi relativi alla strut- tura della comunicazione che si sono sviluppati dagli anni ’30 del Novecento a partire dall’opera di Ferdinand de Saussure, poi declinati nel caleidoscopio de cosiddetto ‘post-strutturalismo’ da autori quali C. Lévi-Strauss, R. Barthes, J. Lacan, U. Eco e altri. Senza entrare nel merito di un argomento troppo ampio rispetto a questo contributo, mi interessa comunque dichiarare la ricerca della natura del progetto in quanto dinamica legata, nelle cause e negli effetti, alle articolate forme d’ordine che sostengono la narrazione dialogica di ‘signifi- canti’ e corrispettivi assetti formalizzati. «L’assunto è che l’uomo sperimenti il mondo – con tutti i sensi ed in tutti i sensi – come una matrice multidimensionale d’informazione e che, in ultima analisi, tutte le forme di comportamento biolo- gico e socioeconomico sono in primo luogo forme e processi di comunicazione». WILDEN Anthony, Comunicazione, Enciclopedia Einaudi, III, Torino, 1978. 3 ARMANDO Alessandro, DURBIANO Giovanni, Teoria del progetto archi- tettonico, Dai disegni agli effetti, Carocci, Roma, 2019.
Il progetto nella Città Fragile 267 ‘autori’, soggetti e discipline che, parimenti alla progettazione architettonica, si interrogano sul ruolo sociale, sugli strumen- ti di comunicazione, sulle finalità della tecnica delle rispettive attività. La precisazione del ruolo e dell’efficacia sociale della disciplina del progetto dello spazio conduce alla necessità dell’amplia- mento del campo. La composizione di reti più ampie entro il corpo delle teorie e delle metodologie del progetto, si trova già negli sviluppi favoriti dalla fase di una nostra ‘contemporanea modernità’ ancora di riferimento, sostanziata dalle riflessioni di autori che hanno dialogato dentro o intorno al progetto culturale che ha attraversato gli ultimi quarant’anni del secolo scorso.4 Casabella esprime già questa tensione alla compren- sione e codificazione della nuova complessità e, seppure fram- mentato, delinea una nuova continuità attraverso i tre momenti di Rogers, Maldonado e Gregotti, se non altro per lo sforzo di rendere corale il discorso intorno al progetto e condurre al ta- volo, oltre a quelli dell’urbanistica nelle sue varie declinazioni, anche i contributi italiani della filosofia che declina nella con- temporaneità i tanti caratteri del ‘post-strutturalismo’ di autori quali Enzo Paci, Gianni Vattimo, Franco Rella, Salvatore Veca, Massimo Cacciari, Giorgio Agamben. Tale articolazione delle dinamiche, dei referenti, delle tecniche e delle competenze determina la ricerca di un dispositivo me- todologico evidentemente ‘corale’, in grado di riconoscere e adattarsi alle condizioni di possibilità, che legge i meccanismi di quella che Lévi-Strauss già definiva operazione di ‘bricola- ge’.5 4 In realtà è sempre la stessa ‘rivoluzionaria’ concezione di ‘progetto moderno’, quella che acquisisce la dimensione del tempo come materia strutturale della costruzione dello spazio, che Tafuri legge già nell’opera di ‘montaggio’ che Leon Battista Alberti fa al Tempio Malatestiano a Rimini (TAFURI Manfre- do, Teorie e storia dell’architettura, Einaudi, Torino, 1970) e che si sostanzia programmaticamente (e figurativamente) nelle simultaneità, nei collage, nelle scomposizioni e ricomposizioni che fanno le avanguardie storiche dai primis- simi anni del Novecento. 5 LÉVI-STRAUSS Claude, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano, 2010.
268 Postfazione
Se il progetto è individuato quale ambito in cui si misura la
responsabilità sociale dell’architettura, la nuova responsabilità
dell’architetto è quella di comprendersi parte di un sistema che
trascende autore e disciplina e di agire, tecnicamente e social-
mente, per attivare e realizzare il processo corale di modifica-
zione, fisica o normativa che sia.
Modificazione
La rimessa in discussione della nozione di progetto per
l’architettura, che lo stesso progetto moderno opera, è ancora
volta a comprendere il rapporto sempre nuovo tra ordine e di-
sordine, vale a dire tra unità e complessità dentro il quale muo-
ve ogni necessità di modificazione. Ciò articola la dimensione
relativa, aperta alle possibilità e non impositiva del progetto di
architettura, e rende necessario recuperare alcune sostanziali
ragioni cui la pratica disciplinare fa riferimento: la ragione della
storia come prima condizione di alterità da cui svolgere una
riflessione sul presente; la ragione critica come strumento di
calcolo della corretta distanza da ogni elemento in gioco e che
solo così può determinare il valore morfologico dei principi
insediativi, dei suoli, delle relazioni tra i materiali dell’architet-
tura; la ragione tecnica implicita nel rappresentare e nel fare,
intesa come strumento di ricerca del valore dell’appropriatezza
al tempo e al luogo; la ragione multidisciplinare, su cui costruire
una relazione necessaria sulle reciproche differenti specificità.
Su questo piano composito si potrebbe assicurare un’auto-
nomia del fare per la nostra pratica artistica senza perdere la
reazione dialettica con quel mondo dell’eteronomia costituito
dalla realtà degli oggetti naturali, dei soggetti sociali, delle pos-
sibilità tecniche.
Modificare presuppone il rispetto di una visione, che pur muo-
vendo nei confronti dello stato delle cose, guarda spesso ad un
lungo rinnovamento di senso, e apre ad un’azione spostata su
una possibilità altra, diversa, quasi sempre incognita. Il modi-Il progetto nella Città Fragile 269
ficare è una prassi che si misura strutturalmente con l’idea di
durata, ma proprio la coscienza della paternità storica e speci-
fica è ciò che non consente il ricorso innocente alla memoria o
alla definizione di una dimensione temporale certa e definita.
Anche lo spazio del tempo viene inserito nella struttura rela-
tiva e relazionale del progetto di modificazione, ed ogni caso
chiama una specifica idea di memoria, di tempo, di durata. La
memoria, com’è noto, non offre modelli ma stabilisce delle di-
vergenze che si possono leggere con attenzione nelle differenze
necessarie alla modificazione specifica di un contesto e secon-
do un ordine dotato di senso.
Davanti ad una visione del possibile misurata su di una scala
temporale e spaziale amplificata, il progetto di architettura può
affermare un principio: il progetto, che non vuole rinunciare
alla dimensione sintetica e morfologica, deve proporre un pro-
getto aperto, cioè un progetto di progetti: sia dal punto di vista
dell’esito formale, sia dal punto di vista dei diversi orizzonti
temporali dei vari ambiti di trasformazione toccati, sia dal pun-
to di vista degli stessi autori che affrontano il lavoro di ricerca.
Intendere il progetto come opera aperta significa praticare un
processo di scomposizione della realtà e ricomposizione in un
tempo successivo, e rendere lo stesso progettista un campo di
possibilità: cioè a dire acquisire i temi cardine della modifica-
zione quali esito di una interlocuzione politica e poetica.
Opera Aperta
Questa programmatica molteplicità dei punti di vista viene
assunta come occasione per orientare verso un obiettivo comu-
ne la ricerca di progetto che, in quanto progetto di uno spazio
comune, sia, necessariamente, al contempo rivolto al corpo
fisico e sociale. Ciò significa che questo lavoro, più che formu-
lare una risposta in merito ad una definizione di forma della
metropoli contemporanea, pone la domanda sul ruolo dell’ar-
chitettura della e nella metropoli contemporanea. Come la for-
ma del progetto può controllare il processo di trasformazione270 Postfazione davanti a orizzonti di questa complessità? Che metamorfosi deve subire il processo progettuale davanti al sostanziale falli- mento disciplinare di ogni forma di controllo delle dinamiche che, alla scala metropolitana e territoriale, investono il piano del reale? La ricerca metodologica coerente con questo doppio problema – futuro della città e del territorio e futuro del loro progetto di architettura –, a partire dai dati specifici messi in campo e dalla pluralità dei riferimenti e degli attori convenuti, conduce a tentare di sperimentare e definire un metodo che potrebbe essere definito come ‘opera aperta’.6 In altre parole, il progetto architettonico, che non intende in quanto tale rinunciare alla propria essenza formale, prova a configurarsi come strumento aperto: cioè in grado di definire una struttura che possa sistematizzare diverse possibilità, sia dal punto di vista dell’esito figurativo, sia dal punto di vista dei diversi orizzonti temporali dei diversi ambiti di trasformazione toccati, sia dal punto di vista degli stessi autori che affrontano il lavoro di ricerca. Immaginare il progetto di architettura come opera aperta non significa lasciarne astratto o generico l’esito, trasferendo l’o- pera di progettazione in un campo pianificatorio che non gli appartiene. Piuttosto significa assumere e formalizzare come propria base un criterio molteplice nella descrizione e cono- scenza della realtà, attraverso l’attivazione di diversi sguardi e interpretazioni collaboranti di cui si ricerca una logica rela- zionale. 6 «Di qui la funzione di un’arte aperta quale metafora epistemologica: in un mondo in cui la discontinuità dei fenomeni ha messo in crisi la possibilità di una immagine unitaria e definitiva, essa suggerisce un modo di vedere ciò in cui si vive, e vedendolo accettarlo, integrarlo alla propria sensibilità. Un’opera aperta affronta appieno il compito di darci una immagine della discontinuità: non la racconta, la è. Mediando l’astratta categoria della metodologia scientifica e la viva materia della nostra sensibilità, essa appare quasi una sorta di schema trascendentale che ci permette di capire nuovi aspetti del mondo». ECO Umberto, Opera Aperta, Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano, 1962.
Il progetto nella Città Fragile 271
Alla base dell’idea di apertura del progetto sta ciò che Edgar
Morin definisce il ruolo del pensiero complesso; l’intreccio at-
tuale delle quantità e delle qualità in gioco non possono che
portare ad un campo di ricerca sistemico. «Un modo di pensare
capace di interconnettere e di solidarizzare delle conoscenze se-
parate è capace di prolungarsi in un’etica di interconnessione e
di solidarietà tra umani. Un pensiero capace di non rinchiudersi
nel locale e nel particolare, ma capace di concepire gli insiemi,
sarebbe adatto a favorire il senso della responsabilità e il senso
della cittadinanza. La riforma del pensiero avrebbe dunque con-
seguenze esistenziali, etiche e civiche»7.
I frammenti che popolano gli insiemi possono attivare, se ri-
conosciuti e agiti nell’ottica del sistema, una possibilità di in-
tegrazione tra persone, cose e idee; a patto che la nostra re-
sponsabilità si traduca operativamente nella apertura dei propri
steccati, nell’autoeducazione all’ascolto, nella responsabilità di
intendere il progetto come un passaggio di consegne a chi prati-
ca il futuro quale tempo proprio.
Dare un contributo oggi al pensiero sul progetto di architettu-
ra nella metropoli contemporanea significa insomma definire
un percorso di tipo strategico che determini una risposta for-
te ed univoca dal punto di vista del diagramma ‘strutturale’ e
allo stesso tempo che sia molteplice dal punto di vista delle
esemplificazioni e delle possibili ricadute architettoniche. In
altre parole, significa che un buon esito strategico del nostro
specifico approccio potrebbe essere un principio che apre a
diverse possibilità attuative, corrispondenti alle occasioni che
via via si realizzeranno.
Da autore a mediatore
Se per ‘opera aperta’ si intende un progetto-processo che sia
in grado di offrire il proprio esito quale registro permanente
7
MORIN Edgar, La testa ben fatta, Riforma dellíinsegnamento e riforma del
pensiero, Raffaello Cortina Editore, 2000.272 Postfazione
per i progetti che si verificheranno nei tempi e per mano di
attori, a vario titolo, successivi, un passaggio di questa ricerca
metodologica è quello della articolazione della figura dell’au-
tore stesso. Lo sguardo multiplo adottato, attraverso la scom-
posizione del piano fenomenico della realtà, si declinerebbe
in una serie di temi, orientati a relativi diagrammi specifici da
porre reciprocamente in relazione; intesi dunque come occa-
sioni critiche: occasioni di confronto, condivisione, opposi-
zione. Ciò significa che la composizione di più sguardi, tra di
loro dialettici, dovrebbe essere programmaticamente acquisita
entro la forma metodologica di questo approccio. Questa cen-
tralità della figura di un autore che agisca da mediatore appare
opportuna rispetto ad un tempo e ad un luogo in cui la com-
plessità e l’incertezza delle condizioni sono evidente materiale
di progetto, anzi ne sono la cifra sostanziale che deve voltarsi
da impedimento a risorsa.
Ma se l’autore architetto rinuncia ad offrire una risposta sin-
tetica in termini di figura stabilizzata, non può declinare la
propria responsabilità a definire un piano su cui possano se-
dimentare, via via lungo il farsi e disfarsi del processo, forme
‘poetiche’ sintetiche. È un piano che traduce il senso del ‘prin-
cipio insediativo’ gregottiano in uno schema diagrammatico,
cioè un campo di possibilità, entro cui produrre e sperimentare
episodi specifici, parziali: sequenze del percorso di progetto
che punteggiano il processo di modificazione8.
Ma come potrebbe determinarsi e figurarsi sinteticamente que-
sto progetto composito, inteso come opera aperta, o ‘progetto
di progetti’, base per successive azioni di indagine, descrizione,
interpretazione e sintesi modificativa?
I temi di riferimento sono condotti a schemi diagrammatici di
progetto; veri e propri diagrammi che, coinvolti nel processo
di relazione della realtà, vengono tentativamente concretizza-
ti sul piano della città. Questi provano a tradurre la struttura
terminologica e narrativa entro una concreta – e materica –
8
GREGOTTI Vittorio, Modificazione, in Casabella n. 498-499, 1984.Il progetto nella Città Fragile 273 grammatica architettonica. Questi diagrammi costituiti di ma- teria concreta, concetti spaziali disseminati nei flussi tempo- rali che attraversano il piano della città, non sono certamente intesi come risposta sintetica unica e neanche come risposte alternative tra loro: essi si dispongono nella forma delle possi- bili domande. Questi schemi cercano cioè la propria efficacia nella loro funzione di prefigurazione di una domanda. Il ruolo di questa metodologia potrebbe essere, rispetto alle condizioni date, orientare ipotesi che conducano gli attori presenti e fu- turi a collaborare al progetto e a immaginare delle risposte di sintesi. In che senso si possono realizzare domande attraverso le for- me? Forse lasciandone aperto l’esito e offrendo con evidenza un principio, un percorso attraverso le ragioni che ne sostan- ziano il campo di possibilità. Ancora ci viene in aiuto l’espe- rienza rivoluzionaria della grande modernità, quella modernità permanente che relativizza il valore della realtà, a partire da sé stessa. Ce lo insegnano da Las Meniñas di Velázquez a quelle di Picasso, dalle figure aperte di Klee – linee che determinano un processo – alle serie cezanniane del Mont Saint-Victoire, alle pulsazioni di Rothko, sino allo Shift di Serra e ai Wrapping di Christo. È l’espressione del principio – su cui si innestano sia concrete che immaginate possibilità figurative – che attiva possibili risposte, che lo stesso fruitore dell’opera è sollecitato a comporre. Va forse sottolineato il lavoro di ricerca di Céz- anne, e la sua celebre attitudine verso una ricerca pittorica non rappresentativa ma effettuale della sostanza e della strutturalità dei fenomeni percettivi e immaginativi. Da qui il contributo di Maurice Merleau-Ponty «Il dubbio di Cézanne»; egli conclude il saggio con queste parole: «Il pittore ha solo potuto costruire un’immagine. Bisogna attendere che quest’immagine si animi per gli altri. Allora l’opera d’arte avrà unito le vie separate, e non esisterà più semplicemente in una di loro come un sogno tenace o un delirio persistente, o nello spazio come una tela colorata, ma abiterà indivisa in parecchi spiriti, presumibilmente in ogni
274 Postfazione spirito possibile, come un’acquisizione per sempre»9. L’autore è il mediatore tra realtà, immaginazione, possibilità, forma. In ambito più propriamente architettonico mi viene in mente il piano per Monte Carasso di Snozzi che conduce il Piano Regolatore ad opera architettonica aperta determinata dalla struttura dei sedimi storici e pochissimi altri elementi; o il piano per le Città d’Olanda, sempre di Snozzi; i potenti dia- grammi dell’Università della Calabria di Gregotti o il suo piano insediativo per Cefalù; oppure, in tempi più recenti, penso a tutte quelle esperienze che consolidano possibilità formali at- traverso un lungo processo di sedimentazione di segni di varia natura, come il progetto per il Tempelhof di Berlino dei Rau- mlabor. È evidente, dunque, come il primo elemento critico, anzi au- to-critico, con cui il metodo di progetto adottato si confronta sono gli autori stessi, i progettisti, mutevoli mediatori a secon- da delle occasioni relazionali, che tuttavia conducono il pro- prio specifico sguardo tematico. Gli autori sono il reagente che legge la crisi, compresa la pro- pria, e innesca la scelta. I temi che esplora il progetto di architettura sono dunque dei capitoli di riferimento che sottendono questioni aperte per qualificare una strategia di progetto del fenomeno urbano con- temporaneo. Il dispositivo di connessione a rete verso cui si tende rivela un principio d’ordine verso l’interno del settore considerato che è, allo stesso tempo, rivolto metodologicamente verso il quadro complessivo, disponibile ad accogliere i progetti che le dina- miche urbane e territoriali esprimeranno nel tempo. Il criterio proposto è condotto su frammenti di un discorso a più voci che lo descrive, lo apre alle diverse interpretazioni e lo precisa grazie alla relazione mutevole tra chi racconta e chi ascolta. Il processo di ricerca così immaginato, e composto in modo esemplificativo, intende imbrigliare questa interlocuzione col- 9 MERLEAU-PONTY Maurice, Il dubbio di Cézanne, in Senso e non senso, Il Saggiatore, Milano, 1962.
Il progetto nella Città Fragile 275 lettiva attraverso un piano sul quale sia possibile scrivere i de- sideri, i temi e le criticità espressi dagli abitanti della città e dagli attori del suo progetto: in breve, un piano sul quale sia possibile esprimere una possibile grammatica architettonica della condivisione.
Fonti iconografiche Pag. 158, al centro: GAGLIARDI Alice, Scuderia de Montel, www. esplorazionedicitta.it/project/scuderia-de-montel/ Pag. 159: PIVA Filippo, Una Milano a emissioni zero, il bando di Reinventing Cities, 2018, www.wired.it/lifestyle/design/2018/01/25/reinventing-cities- milano-bando/ Pag. 160, in alto: SANTUCCI Gianni, Milano, a 14 anni devastano per gioco l’antico ippodromo del trotto, 2017, www.milano.corriere.it/notizie/ cronaca/17_ottobre_08/milano-14-anni-devastano-gioco-l-antico-ippodromo- trotto-114464de-ac63-11e7-b229-0974b7f57cc3.shtml Pag. 162: “Il manuale del buon occupante”, in San Siro Stories, Magazine, Scuola di Giornalismo Università Cattolica, n. 19, aprile 2015, p. 21. Pag. 163, in alto a destra: MARIN Alessandro, Terra e Lievito, ex Piazza d’Armi di Milano, Ri-Formare Milano, Film documentario, 2016, www. workingtitlefilmfestival.it/wtff-ferrovieri/rassegna/terra-e-lievito/ Pag. 174, 175, in alto: www.giorgiouberti.com/storia-baggio/storia-della- piazza-darmi-prima-delle-armi-cascine-fontanili-e-prati-prima-parte/ Pag. 174, 175, in basso: Civiche Raccolte d’Arte “Bertarelli”, Castello Sforzesco, Milano, docplayer.it/2734476-Lo-spazio-urbano-della-piazza-d- armi-di-milano-relazione-storica.html Pag. 176, in alto: Istituto Geografico Militare, Firenze, docplayer.it/2734476- Lo-spazio-urbano-della-piazza-d-armi-di-milano-relazione-storica.html Pag. 176, in basso: geoportale.comune.milano.it Tutte le altre fotografie, le mappe, i fotomontaggi e i disegni sono materiali inediti realizzati dagli autori.
Indice dei nomi
Agamben, Giorgio 267 Cacciari, Massimo 267
Alberti, Leon Battista 267 Caffo, Leonardo 9-10, 25, 30-31, 54-56,
Albori, Studio 140-141 60, 110, 117, 180, 193, 215
Ambrosioni, Annamaria 169 Calabrò, Sara 170
Archigram 124-126 Castel, Robert 53
Archizoom 87, 98 Castiglioni, Maria 199
Argan, Giulio Carlo 104 Castoriadis, Cornelius 11, 87
Aristotele 37 Cézanne, Paul 273-274
Armando, Alessandro 266 Christo 273
Assemble 145-146 Cignini, Paolo 147
Atkinson, Anthony Barnes 50 Cittadini per Piazza d’Armi 173, 196-
Aureli, Pier Vittorio 11, 87-88, 258 197, 200-202, 222, 225
Clarici, Giovanni Battista 174
Bacchelli, Valeria 199 Clément, Gilles 55, 57-59, 60, 79-80, 161,
Banham, Reyner 108-109 166, 194
Barker, Paul 108-109 Cognetti, Francesca 12, 14, 36, 39, 100,
Barthes, Roland 266 106, 117, 119, 180, 120-121
Baudelaire, Charles 121 Constant Anton Nieuwenhuys 124-
Bauman, Zygmunt 32-33 126, 255
Bayat, Asef 48 Correa, Charles 115
Belluschi, Pietro 94 Costa, Francesco 11-12, 25, 162
Bertagna, Alberto 10, 15, 35, 43, 256 Crooke, Pat 70
Bertelli, Guya Grazia 78
Betsky, Aaron 146 Daniel, Guarniero 72, 112
Biraghi, Marco 88-92, 118 Debord, Guy 126
Bishop, Peter 36, 68, 99, 107, 110 De Carlo, Giancarlo 38-39, 87, 102, 110,
Bonisoli, Alberto 203 115-116, 124, 126, 128
Bonomi, Aldo 21 Deleuze, Gilles 46
Borella, Giacomo 92 de Saussure, Ferdinand 266
Borromeo, Carlo 169 De Sica, Vittorio 65
Bottero, Bianca 207 Di Franco, Andrea 264
Bouchain, Patrick 58 Donzelot, Jacques 51
Braghieri, Gianni 141 Dostoevskij, Fëdor 199
Branzi, Andrea 35, 37-38, 61-62, 70, 91, Durbiano, Giovanni 266
98-99, 109, 119, 255
Brenna, Giovanni 174 Eco, Umberto 193, 270
Brillembourg, Alfredo 10, 137-139 Edgerley, Fran 145
Buchanan, Colin Douglas 71 Engels, Friedrich 47
Evi, Eleonora 173280 Indice dei nomi
Farris, Amanzio 128 Klee, Paul 273
Fathy, Hassan 71, 115 Klumpner, Hubert 138
Fava, Federica 97, 104-105, 108
Fava, Ferdinando 36, 39 Lacan, Jacques 266
Ferlenga, Alberto 22 Lacaton, Anne 131-133
Ferrari, Marco 126, 255 Lacaton & Vassal 131-133
Ferraro, Giovanni 121-122, 181 La Cecla, Franco 208
Ferri, Vincenzo 178, 200, 204, 206, Landau, Royston 124-125
222, 225 La Pietra, Ugo 26-27, 64, 71-72, 106, 119-
Fichter, Robert 65 121, 124, 129, 256
Fitter, Richard Sidney Richmond 59 La Varra, Giovanni 68
Foerster-Baldenius, Benjamin 144 Le Corbusier 153
Forlanini, Enrico 170, 213 Lefebvre, Henri 139
Foucault, Michel 265 Legambiente 196
Friedman, Yona 124 Leveratto, Jacopo 40, 126, 129, 143
Fusaro, Diego 47 Lévi-Strauss, Claude 266-267
Lipu 198, 200
Gallino, Luciano 46 London, Jack 44
Gambino, Daniela 222 Lo Ricco, Gabriella 90
Gandin, Michele 65 Lynch, Kevin 23-24, 28-32, 59, 62, 82, 108
Garner, Ray 74
Geddes, Patrick 121-122, 181 Maldonado, Tomás 267
Le Giardiniere 168, 172-173, 179, 192-199, Marin, Alessandro 213
202, 204, 206, 222, 225 Marini, Sara 38-39, 87, 102, 110, 116, 128
Giacometti, Alberto 207 Massey, Doreen 36
Gilbert, Elizabeth 61 McGuirk, Justin 139
Goffredo da Bussero 169 McNamara, Robert 45
Gorz, André 52 Meazza, Giuseppe 156, 207
Gregotti, Vittorio 112, 267, 272, 274 Mele, Elia 179
Guattari, Félix 46 Menon, Krishna 124, 130
Merleau-Ponty, Maurice 273-274
Habraken, N. John 71, 115 Micheli, Silvia 90
Hall, Peter 108-109 Morin, Edgar 271
Hänninen, Giovanni 257 Mussolini, Benito 61
Henderson, Nigel 73 Muzzonigro, Azzurra 9-10, 25, 30, 54-
Hertzberger, Herman 128 56, 110, 117, 180, 193, 215
Hidalgo, Anne 198
Nicolini, Renato 103-104
Ibelings, Hans 88 Nobile, Umberto 170, 213
Italia Nostra 196, 224-225 Nulli, Andrea 140-141
Izenour, Steven 153-154
Omero 78
Jeanton, Gabriel 66 Orizzontale 147-149
Ottaviano Augusto 61
Karpat, Kemal 66
Khanna, Parag 10Il progetto nella Città Fragile 281
Paba, Giancarlo 40-42, 100-101, 103, Soja, Edward 44
117, 181 Stagni, Linda 138
Paci, Enzo 267
Pagani, Gabriele 169 Tafuri, Manfredo 87, 267
Pagano, Giuseppe 72, 112-113 Taleb, Nassim Nicholas 77
Palestra, Ambrogio 169 Tortora, Giuseppe 61
Perrone, Camilla 40-42, 100-101, 103, Touraine, Alain 51
117, 181 Tozzi, Pierluigi 169
Petrillo, Agostino 45-53 Turner, John F. C. 65, 70, 115
Picasso, Pablo 273
Pisapia, Giuliano 172 Uberti, Giorgio 168
Ponti, Gio 95, 117-118 Ulisse, Alberto 29, 68-69
Popper, Karl, 139 Urban-Think Tank 137-138
Price, Cedric 108-109, 123-125
Profili, Diego 173, 200, 203, 225 Vassal, Jean-Philippe 131-133
Protasoni, Sara 77-78 Vattimo, Gianni 267
Veca, Salvatore 267
Rampazzo, Luca 162 Velázquez, Diego 273
Raumlabor 142-144 Venezia, Francesco 63
Recalcati, Massimo 69 Venturi, Lionello 111
Rella, Franco 267 Venturi, Robert 37, 153-154
Retake Milano 192, 225 Vickers, Geoffrey 116
Righter, Rosemary 66, 70 Viganò, Paola 109, 125, 134-135, 153-154,
Roberts, Robert 44 166, 215, 221, 230
Rogers, Ernesto Nathan 267 Viganò, Vittoriano 160
Rossi, Aldo 22, 87-88, 104, 113, 141 Vigotti, Gualberto 169
Rothko, Mark 273
Rudofsky, Bernard 72, 93-94, 111-112, 162 Ward, Colin 25, 64-67, 69-72, 74, 92-94,
Russi, Nicola 104, 106, 116, 118, 120, 133, 115-116, 211
135-136, 139, 143-146 Whitehead, Alfred North 30
Williams, Lesley 36, 68, 99, 107, 110
Sabatino, Michelangelo 113 Wilden, Anthony 266
Sandercock, Leonie 101 Wilsher, Peter 66, 70
Sassen, Saskia 41 Wilson, William Julius 51
Schwägerl, Christian 56 Wood, Denis 28
Scott Brown, Denise 153-154 Woods, Lebbeus 124
Scruton, Roger 66
Secchi, Alberto 208, 210 Zabalbeascoa Anatxu 132
Secchi, Bernardo 10, 23, 25-26, 40, 43- Zedda, Roberto 143
44, 134-135, 258
Secchi-Viganò 134-135
Segal, Walter 115
Sennett, Richard 37, 74-75, 97, 111-112, 121
Serra, Richard 273
Simmel, George 61
Snozzi, Luigi 274Bibliografia
ATKINSON Anthony Barnes, Poverty in Europe, Blackwell, London,
1998.
AURELI Pier Vittorio, Il progetto dell’autonomia: Politica e architettura
dentro e contro il capitalismo, Quodlibet, Macerata, 2016.
BANHAM Reyner, BARKER Paul, HALL Peter, PRICE Cedric,
Non-Plan: an experiment in freedom, New Society, 1969.
BAUMAN Zygmunt, Modernità liquida, Editori Laterza, Roma, 2002.
BAUMAN Zygmunt, Vite di scarto, Editori Laterza, Roma, 2008.
BAYAT Asef, From “Dangerous Classes” to “Quiet Rebels”. Politics
of the Urban Subaltern in the Global South, International
Sociology, 2000.
BERTAGNA Alberto, Il controllo dell’indeterminato. Potemkin
villages e altri nonluoghi, Quodlibet, Macerata, 2010.
BERTELLI Guya Grazia (a cura di), Paesaggi Fragili, Aracne, Roma,
2018.
BIRAGHI Marco, L’architetto come intellettuale, Piccola Biblioteca
Einaudi, Torino, 2019.
BIRAGHI Marco, Storia dell’architettura contemporanea II : 1945-
2008, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 2008
BISHOP Peter, WILLIAMS Lesley, The temporary city, New York:
Routledge, Londra, 2012.
BONOMI Aldo (a cura di), Mettere in mostra la città fragile,
Communitas, Milano, 2009.
BRANZI Andrea, Modernità debole e diffusa: Il mondo del progetto
all’inizio del XXI secolo, Skira, Milano, 2006.
BRILLEMBOURG Alfredo, KLUMPNER Hubert, Torre David,
Informal Community, Area n. 128, 2013.284 Bibliografia
CAFFO Leonardo, Fragile umanità. Il postumano contemporaneo,
Einaudi editore, Torino, 2017.
CAFFO Leonardo, MUZZONIGRO Azzurra, Costruire futuri.
Migrazioni, città, immaginazioni, Bompiani, Milano, 2018.
CASTORIADIS Cornelius, The Retreat from Autonomy:
Postmodernism as Generalized Conformism, in Id., World in
Fragments, Stanford University Press, Stanford, 1997.
CLÉMENT Gilles, Il giardino in movimento: Da la vallée al giardino
planetario, Quodlibet, Macerata, 2011.
CLÉMENT Gilles, Manifesto del Terzo paesaggio, Quodlibet,
Macerata, 2005.
CREMASCHI Marco (a cura di), Tracce di quartieri, Il legame sociale
nelle città che cambia, FrancoAngeli, Milano, 2008.
COGNETTI Francesca, Arte, cultura, creatività nella costruzione
della città pubblica, Critica della razionalità urbanistica, Alinea
Editrice, 2005.
COGNETTI Francesca, Un’idea di arte, un’idea di progetto. Pratiche
artistiche, partecipazione sociale e ruolo dell’artista, Territorio,
2010
COGNETTI Francesca, “Praticare l’interazione in una prospettiva
progettuale”, in CANCELLIERI A., SCANDURRA G. (a
cura di), Tracce urbane. Alla ricerca della città, FrancoAngeli,
Milano, 2012.
COGNETTI Francesca, PADOVANI Liliana, Perché (ancora) i
quartieri pubblici. Un laboratorio di politiche per la casa,
FrancoAngeli, Milano, 2018.
COGNETTI Francesca, FAVA Ferdinando, La città interdisciplinare.
Per itinerari non tracciati tra saperi urbani, Tracce Urbane n.
6, 2019.
DE CARLO Giancarlo, MARINI Sara (a cura di), L’architettura della
partecipazione, Quodlibet, Macerata, 2013.
DE CERTEAU Michel, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro,
Roma, 2001.
DE MASI Domenico, Partecipazione e progetto, in GUCCIONEIl progetto nella Città Fragile 285
Margherita, VITTORINI Alessandra (a cura di), Giancarlo De
Carlo. Le ragioni dell’architettura, Electa-Darc, Milano, 2005.
DONZELOT Jacques, La nouvelle question urbaine, Esprit, Parigi,
2002.
FARRIS Amanzio, Situare l’azione. Uomo, spazio, auspici di
architetture, Alinea Editrice, Firenze, 2012.
FAVA Federica, Estate romana: tempi e pratiche della città effimera,
Quodlibet Studio, Macerata, 2017.
FERRARO Giovanni, Rieducazione alla speranza. Patrick Geddes
planner in India, Jaca Book, 1998.
FIORAVANTI Matteo (a cura di), La città e l’altra città: Racconti
ed esperienze in-disciplinate nella pianificazione anti-fragile,
Palazzo Bonaretti Editore, Novellara, 2013.
FRAMPTON Kenneth, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli,
Bologna, 1982.
GANDIN Michele, Il tetto di Vittorio De Sica, Cappelli Editore, 1956.
GILBERT Elizabeth, Mangia prega ama, Rizzoli, Milano, 2007.
GORZ André, Le metamorfosi del lavoro. Critica della ragione
economica, Bollati Boringhieri, Milano, 1992.
GRAF Franz, TEDESCHI Letizia (a cura di), L’Istituto Marchiondi
Spagliardi di Vittoriano Viganò, Mendrisio Academy Press,
Accademia di Architettura Università della Svizzera Italiana,
Mendrisio, 2009.
GREGOTTI Vittorio, Orientamenti nuovi nell’architettura italiana,
Electa, Milano, 1969.
HERTZBERGER Herman, Lessons for students in Architecture,
Publishers, Rotterdam, 1991.
HUGHES Jonathan, SADLER Simon (a cura di), Non-plan: Essays on
freedom participation and change in modern architecture and
urbanism, Architectural Press, Oxford, 2000.
IBELINGS Hans, Supermodernism: Architecture in the Age of
Globalization, NAI Publishers, 1998.
INFUSSI Francesco, Dal recinto al territorio: Milano, esplorazioni286 Bibliografia
nella città pubblica, Bruno Mondadori, Milano, 2011.
Italia Nostra Onlus, DAStU, Scuola Agraria del Parco di Monza,
DEMM, La città degli orti, 2018.
JEANTON Gabriel, Les maisons construites en une nuit, Revue de
folklore français vol. 10 n. 2, 1939.
LANDAU Royston, Philosophy of enabling: The work of Cedric Price,
AA Files n. 8, 1985.
LA PIETRA Ugo, Abitare la città: Ricerche, interventi, progetti nello
spazio urbano dal 1960 al 2000, Allemandi & C., Torino, 2011.
LA VARRA Giovanni, Post-It City. L’ultimo spazio pubblico della città
contemporanea, Territorio n. 56, 2011.
LEVERATTO Jacopo, Pubblico e personale. Spazi urbani a misura
d’uomo, Tesi di Dottorato, Politecnico di Milano, 2015.
LYNCH Kevin, Deperire: rifiuti e spreco nella vita di uomini e città,
Cuen, Napoli, 1992.
MASSEY Doreen, For Space, Sage Publications, Londra, 2005.
MCGUIRK Justin, Radical cities. Across Latin America in Search of a
New Architecture, Verso, New York, 2014.
Multiplicity.lab (a cura di), Milano: Cronache dell’abitare, Bruno
Mondadori, Milano, 2007.
NERI Raffaella (a cura di), Milano: Caserme e aree militari, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna, 2014.
OSWALT Philipp, OVERMEYER Klaus, MISSELWITZ Philipp,
Urban catalyst: The power of temporary use, DOM, Berlino,
2013.
PABA Giancarlo, PERRONE Camilla, Cittadinanza attiva: Il
coinvolgimento degli abitanti nella costruzione della città,
Alinea, Firenze, 2002.
PAGANO Giuseppe, DANIEL Guarniero, Architettura Rurale
Italiana, Quaderni della Triennale Ulrico Hoepli Editore,
Milano, 1936.
PETRILLO Agostino, Città in Rivolta. Los Angeles, Buenos Aires,
Genova, Ombrecorte, Verona, 2004.Il progetto nella Città Fragile 287
PETRILLO Agostino, Villaggi, città, megalopoli, Carrocci editore,
Roma, 2013.
PONTI Gio, Amate l’architettura: L’architettura è un cristallo, Rizzoli,
Milano, 2008.
ROBERTS Robert, The Classical Slum, Penguins, Harmondsworth-
London, 1972.
ROSSI Aldo, Frammenti, in FERLENGA Alberto (a cura di),
Architetture 1959 - 1987, Electa, Milano, 1987.
RUDOFSKY Bernard, Architettura senza architetti: una breve
introduzione all’architettura non-blasonata, Editoriale
Scientifica, Napoli, 1977.
RUSSI Nicola, Background. Il progetto del vuoto, Quodlibet Studio,
Macerata, 2019.
SABATINO Michelangelo, Orgoglio della modestia: architettura
moderna italiana e tradizione vernacolare, Angeli, Milano,
2013.
SASSEN Saskia, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino,
2008.
SECCHI Bernardo, Progetto di suolo, Casabella n. 520, 1986.
SECCHI Bernardo, La periferia, Casabella n. 583, 1991.
SECCHI Bernardo, La città del ventesimo secolo, Laterza, Roma-Bari,
2005.
SECCHI Bernardo, La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza,
Bari-Roma, 2013.
SENNETT Richard, Costruire e abitare. Etica per la città, Feltrinelli,
Milano, 2018.
TALEB Nassim Nicholas, Antifragile: Prosperare nel disordine, il
Saggiatore, Milano, 2013.
TOESCHI Luisa (a cura di), Un boscoincittà: Analisi di un’esperienza
di forestazione urbana a Milano, FrancoAngeli, Italia Nostra,
Milano, 1984.
TORTORA Giuseppe, Semantica delle rovine, Manifestolibri, Roma,
2006.288 Bibliografia
TOURAINE Alain, Face à l’exclusion, Esprit, 2011.
TURNER John F., FICHTER Robert (a cura di), Freedom to build,
Macmillan, 1972; tr. It. Idem, Libertà di costruire, il Saggiatore,
1979.
ULISSE Alberto, Common spaces: Urban design experience, LIStlab,
Trento, 2018.
UN-Habitat, The Challenge of Slums. Global report on human
settlements, Earthscan Publications, Londra, 2003.
Urban Governance and Urban Poverty: Lessons from a Study of Ten
Cities in the South, The School of Public Policy, University of
Birmingham, 2001.
VATTIMO Gianni, ROVATTI Pier Aldo (a cura di), Il pensiero
debole, Feltrinelli, Milano, 1983.
VENEZIA Francesco, Che cosa è l’architettura. Lezioni, conferenze,
un intervento, Mondadori Electa, Milano, 2013.
VENTURI Lionello, Per la nuova architettura, Casabella, Gennaio,
1933.
VENTURI Robert, SCOTT BROWN Denise, IZENOUR Steven,
Learning from Las Vegas, Cambridge, MIT Press 1972 (trad
it.: Imparando da Las Vegas, Cluva Editrice, Venezia,
1985).
VIGANÒ Paola, I territori dell’urbanistica: Il progetto come produttore
di conoscenza, Officina, Roma, 2010.
WARD Colin, Architettura del dissenso: forme e pratiche alternative
dello spazio urbano, Elèuthera, Milano, 2016.
WILSON William Julius, The Ghetto Underclass. Social Science
Perspectives, Sage, Newbury Park, 1993.
ZABALBEASCOA Anatxu, Bigger, better and still affordable, Domus
1034, 2019
ZEDDA Roberto, Tempi della città. Metodi per l’analisi urbana:
principi e pratiche dell’urbanistica temporale, FrancoAngeli
Editore, Milano, 2009.Bibliografia storica Piazza d’Armi
AMBROSIONI Annamaria, Le pergamene della canonica di
Sant’Ambrogio nel XII secolo, Vita e Pensiero, Milano, 1974.
Archivio Diocesano Milano, Sez. X, Vol. 8, fil. 12 e 14.
Archivio e Biblioteca dell’Istituto Geografico Militare, «Carta
Topografica d’Italia», Foglio 45, Firenze, 1936-1937.
Archivio Storico Civico Milano, Ms. (1346) «Statuti delle acque e delle
strade del contado di Milano. Le compartizione delle strade e
fagie a le comune de li burghi: lochi: cassine: e case de religiosi
del contado de Milano».
CALABRÒ Sara (a cura di), La passione dell’invenzione, Telesma,
Milano, 2004.
Ministero dell’aeronautica, Rivista Aeronautica vol. 55, 1979.
PAGANI Gabriele, Milano e i suoi borghi, Edlin, Milano, 2009.
PALESTRA Ambrogio, Strade romane nella Lombardia Ambrosiana,
Nuove Edizioni Duomo, Milano, 1984.
RIA M., ROGNONI R., 1928 Enrico Forlanini, l’Officina “Leonardo
da Vinci” e Umberto Nobile, Il diciotto, quaderno n. 3, 1998.
TOZZI Pierluigi, Pavia e le vie delle Gallie, Guardamagna, 1998.
VIGOTTI Gualberto, La diocesi di Milano alla fine del Secolo XIII.
Chiese cittadine e pievi forensi nel “Liber Sanctorum” di
Goffredo da Bussero, Edizioni di storia e letteratura, Roma,
1974.Sitografia
BETSKY Aaron, “Assemble and the Culture of Craft”, Architect
Magazine, 22 dicembre 2015, www.architectmagazine.com/
design/culture/assemble-and-the-culture-of-craft_o
BOTTERO Bianca, “A Milano, a San Siro”, www.arcipelagomilano.
org/archives/52918
BOTTERO Bianca, “Dopo la ‘moltitudine del benessere’”, www.
arcipelagomilano.org/archives/55820
BRILLEMBOURG Alfredo, Open webVILLARD 21. From Social
Housing to Social Habitat, webinar, 8 maggio 2020, www.
youtube.com/watch?v=2ruyY8NSkjE
CIGNINI Paolo, “Orizzontale: gli architetti che rigenerano lo spazio
pubblico e creano comunità”, 2020, www.italiachecambia.org
COSTA Francesco, “3. I margini”, Milano, Europa, podcast, www.
pianop.it/2019/03/14/milano-europa/
FERRARI Marco, New Babylon – L’utopia nomade di Constant, 2015,
www.artwort.com/2015/06/23/architettura/new-babylon-
lutopia-nomade-di-constant/
FUSARO Diego, Globalizzazione e sradicamento, l’economia ci
toglie tutto, 2017, www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/01/
globalizzazione-e-sradicamento-leconomia-ci-toglie-
tutto/3424084/
HÄNNINEN Giovanni, cittàinattesa, www.hanninen.it/portfolio_
page/cittainattesa/
MARIN Alessandro, Terra e Lievito, ex Piazza d’Armi di Milano,
Ri-Formare Milano, Film documentario, 2016, www.
workingtitlefilmfestival.it
MELE Elia, L’avifauna di Piazza d’Armi, www.legiardinieremilano.it/
greenweek-settembre-2018/292 Sitografia
NICOLINI Renato, “In viaggio con..” Renato Nicolini,
intervista a Chronicalibri, 2012, www.youtube.com/
watch?v=sEard3ZD6PM
NULLI Andrea, “Osservare, riflettere, bighellonare: tre progetti
dello Studio Albori”, 2011, www.domusweb.it/it/
architettura/2011/03/19/osservare-riflettere-bighellonare-tre-
progetti-dello-studio-albori.html
RAMPAZZO Luca, Tra ratti e scarichi intasati, l’Odissea delle case
popolari di via Fleming, www.milanopost.info/2019/10/12/
tra-ratti-e-scarichi-intasati-lodissea-delle-case-popolari-di-via-
fleming/
SECCHI Alberto, “Nuove architetture e parsimonia urbana”, www.
arcipelagomilano.org/archives/43667
STAGNI Linda, “In Sudafrica con U-TT”, 2016, www.gizmoweb.
org/2016/04/in-sudafrica-con-u-tt/
UBERTI Giorgio, Lo spazio urbano della Piazza d’Armi di Milano:
relazione storica, www.legiardinieremilano.it/la-piazza-d-
armi/
VIGANÒ Paola, Urbs in Horto, www.youtube.com/
watch?v=k5_9LR7jv8Q
albori.it
artwort.com/2015/06/23/architettura/new-babylon-lutopia-nomade-
di-constant/
askanews.it/milano-petizione-su-piazza-darmi-in-discussione-a-
europarlamento
assemblestudio.co.uk
citedelarchitecture.fr/fr/video/studio-09-bernardo-secchi-e-paola-
vigano
comune.milano.it
cultweek.com/vigano/
enricatancioni.com/le-scuderie-de-montel-ecco-il-gioiello-liberty-
abbandonato-al- degradoIl progetto nella Città Fragile 293
fondoambiente.it/piazza-d-armi-di-baggio
geoportale.comune.milano.it
glistatigenerali.com/piazza-darmi-se-un-vincolo-toglie-credibilita-al-
paese-e- blocca-nuovo-parco
giorgiouberti.com/storia-della-piazza-darmi-prima-delle-armi-
cascine-fontanili- e-prati-prima-parte
ilfoglio.it/quelli-che-bloccano-milano-il-m5s-i-nimby-il-mibac-e-
piazza-darmi
ilgiorno.it/piazza-d-armi
ilgiorno.it/baraccopoli-piazza-armi
ilgiorno.it/milano/cronaca/san-siro-cascina-case-nuove-1.1384385
independent.co.uk/news/obituaries/cedric-price-36932.html
legiardinieremilano.it
masterx.iulm.it/la-gloria-distrutta-dellippodromo-del-trotto-di-san-
siro
milanoallnews.it/speciale-municipi-marco-bestetti-municipio-7
milanocittastato.it/featured/terme-scuderie-de-montel/
milano.corriere.it/milano-vincolo-ministero-anche-piazza-d-armi-ira-
comune-bloccano-rilancio-zona
milano.corriere.it/san-siro-l-immobiliare-clandestina-case-popolari-
occupate
milano.corriere.it/scuderie-de-montelun-gioiello-liberty-
abbandonato-degrado
milanoincontemporanea.com/la-piazza-darmi-di-milano-diventa-un-
luogo-del- cuore
milano.repubblica.it/milano_ippodromoricerca.repubblica.it/non-
toccate-piazza- darmi-e-da-tutelare
milanopost.info/piazza-darmi-e-lincapacita-di-gestire-la-citta
milanopost.info/san-siro-come-calcutta-la-baraccopoli-di-milano-e-
il-risultato-del-buonismo294 Sitografia
milanotoday.it/piazza-darmi-degrado
milanotoday.it/piazza-armi
milanotoday.it/morelli-denuncia-baraccopoli-milano
milanox.eu/milano-greenweek-grattacieli-in-piazza-darmi
mi-lorenteggio.com/news/12914
offtopiclab.org/lex-piazza-darmi-nel-contesto-dello-smantellamento-
del- patrimonio-pubblico
orizzontale.org
raumlabor.net
raumlabor.net/floating-university-berlin-an-offshore-campus-for-
cities-in-transformation/
salviamoilpaesaggio.it/milano-piazza-darmi-la-richiesta-di-un-
grande-parco-urbano-raggiunge-le-istituzioni-europee
shareradio.it/difendiamo-la-piazza-darmi- dalledificazione-selvaggia
teknoring.com/news/progettazione/anne-lacaton-bisogna-fare-
molto-con-poco-intelligenza-e-sensibilita/
telecolor.net/scuderie-de-montel-tra-degrado-e-speranze
thesubmarine.it/ancora-non-si-sa-cosa-fare-dellippodromo-del-trotto
trottobenecomune.noblogs.org/il-trotto-di-milano-e-il-suo-storico-
quartiere-ippico-di-san-siro/
voloire.org/le-voloire/la-caserma-s-barbara/Bibliografia Postfazione
ARMANDO Alessandro, DURBIANO Giovanni, Teoria del progetto
architettonico, Dai disegni agli effetti, Carocci, Roma, 2019.
ECO Umberto, Opera Aperta, Forma e indeterminazione nelle poetiche
contemporanee, Bompiani, Milano, 1962.
FOUCAULT Michel, Spazi altri. I principi dell’eterotopia, in Lotus
International n. 48-49, Electa, Milano, 1985.
GREGOTTI Vittorio, Modificazione, in Casabella n. 498-499, 1984.
LÉVI-STRAUSS Claude, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano,
2010.
MERLEAU-PONTY Maurice, Il dubbio di Cézanne, in Senso e non
senso, Il Saggiatore, Milano, 1962.
MORIN Edgar, La testa ben fatta, Riforma dell’insegnamento e riforma
del pensiero, Raffaello Cortina Editore, 2000.
TAFURI Manfredo, Teorie e storia dell’architettura, Einaudi, Torino,
1970.
WILDEN Anthony, Comunicazione, Enciclopedia Einaudi, III,
Torino, 1978.Puoi anche leggere