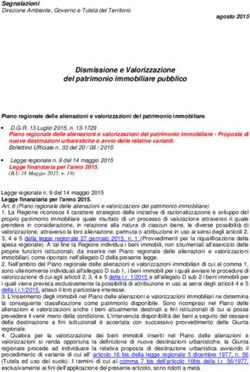I NUOVO STRUMENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE FALLIMENTARE PER IL RILANCIO DELL'IMPRESA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
I
NUOVO
STRUMENTI
INTRODOTTI
DALLA
LEGGE
FALLIMENTARE
PER
IL
RILANCIO
DELL’IMPRESA
-‐
IL
CONCORDATO
PREVENTIVO
-‐
L’ACCORDO
STRAGIUDIZIALE
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI
DEBITI.
-‐
IL
PIANO
DI
RISANAMENTO.
Novità
legisla>ve
D.L.
35/05
–
L.
80/05
Azione
Revocatoria
Concordato
Preven>vo.
Accordo
Stragiudiziale
di
RistruLurazione
del
Debito.
Novità
legisla>ve
D.LGS.
5/06
Imprese
soggeLe
al
fallimento
ed
al
concordato
preven>vo
La
nuova
fase
pre
–
fallimentare
Il
ruolo
del
Giudice
Delegato
Il
Curatore
Il
Comitato
dei
Creditori
Termine
e
Decadenze
per
la
domanda
di
insinuazione
allo
stato
passivo
ordinatoria
e
tardiva
Il
Concordato
Fallimentare
Novità
legisla>ve
D.LGS.
169/07
nuovi
parametri
soggeV
per
individuazione
area
fallibilità.
coord.to
disciplina
concordato
preven>vo
con
quella
del
concordato
fallimentare
Il CONCORDATO PREVENTIVO
Il
“nuovo”
Concordato
Preven>vo
Presuppos>
(Art.160
L.F.)
-‐
l’imprenditore
che
si
trova
in
stato
di
crisi
può
proporre
ai
creditori
un
concordato
prevenGvo
sulla
base
di
un
piano
che
può
prevedere:
A.
la
ristruKurazione
dei
debiG
e
la
soddisfazione
dei
crediG
aKraverso
qualsiasi
forma,
anche
mediante
cessione
dei
beni,
accollo
o
altre
operazioni
straordinarie,
ivi
compresa
l’aKribuzione
ai
creditori
nonché
a
società
da
quesG
partecipate,
di
azioni,
quote,
ovvero
obbligazioni,
anche
converGbili
in
azioni
od
altri
strumenG
finanziari
e
Gtoli
di
credito.
B.
L’aKribuzione
delle
aTvità
delle
imprese
interessate
dalla
proposta
di
concordato
ad
un
assuntore;
possono
cosGtuirsi
come
assuntori
anche
i
creditori
o
società
da
quesG
partecipate
o
da
cosGtuire
nel
corso
della
procedura,
le
azioni
delle
quali
siano
desGnate
ad
essere
aKribuite
ai
creditori
per
effeKo
del
concordato.
C.
La
suddivisione
dei
creditori
in
classi
secondo
posizione
giuridica
ed
interessi
economici
omogenei.
D.
TraKamenG
differenziaG
tra
i
creditori
appartenenG
a
classi
diverse.
Novità 1. stato di crisi come “squilibrio economico e finanziario” quale presupposto oggeTvo rispeKo a quello di “insolvenza” di cui al combinato disposto degli art. 5 e 160 L.F. 2. rimozione preceden> vincoli soggeVvi riguardanG l’imprenditore. 3. Divisione dei creditori in classi per rendere più omogenea l’espressione dei loro diversi interessi nell’ambito della procedura liquidatoria.
La domanda di concordato e la relazione del professionista
Forma
della
domanda
(art.161
L.F.)
-‐
Ricorso
soKoscriKo
dal
debitore
da
depositarsi
pressi
il
Tribunale
in
cui
la
società
ha
la
sede
legale.
Inefficacia
trasferimento
nell’ulGmo
anno.
Documen>:
A.
relazione
aggiornata
sulla
situazione
patrimoniale,
economica
e
finanziaria
dell’impresa.
B.
Stato
anali>co
ed
es>ma>vo
delle
aVvità
e
l’elenco
nominaGvo
dei
creditori
con
indicazione
dei
rispeTvi
crediG
e
della
cause
di
prelazione.
C.
Elenco
dei
Gtolari
di
diriT
reali
o
personali
su
beni
di
proprietà
o
in
possesso
del
debitore.
D.
Il
valore
dei
beni
e
i
creditori
parGcolari
degli
eventuali
soci
illimitatamente
responsabili.
E.
Relazione
di
un
professionista
ex
art.
28
L.F.
che
aKesG
la
veridicità
della
correKezza
e
la
faTbilità
del
piano
medesimo.
Novità -‐ Assenza del previgente potere di controllo del Tribunale e dell’obbligo di deposito della contabilità (abrogato arK. 161 co. III). -‐ AKribuzione di faKo al Professionista del ruolo di garante della fede pubblica ma non sanzionabilità dello stesso. -‐ Residuale e successiva aTvità di controllo in capo al Commissario Giudiziale.
La Giurisprudenza Nell’ambito della procedura di concordato prevenGvo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiG della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli speKanG in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informaGvo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la faVbilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto uGlizzo comporta la inammissibilità della proposta. La aKestazione del professionista deve evidenziare: a) quanto alle risultanze contabili, gli estremi dell’analisi compiuta, i riscontri operaG, i criteri valutaGvi seguiG, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto. b) quanto al giudizio di faTbilità, gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del disseto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternaGve, l’indicazione di obieTvi e risorse che permeKano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani di risanamento e, per le liquidazioni, gli elemenG di certezza che ne concreGzzano nel tempo i valori dedoT a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio.
Ammissione
alla
Procedura
(art.163L.F.)
Il
tribunale,
verificata
la
completezza
e
la
regolarità
della
documentazione,
con
decreto
non
soggeKo
a
reclamo,
dichiara
aperta
la
procedura
di
concordato
prevenGvo;
ove
siano
previste
classi
di
creditori,
il
tribunale
provvede
analogamente
previa
valutazione
della
correKezza
dei
criteri
di
formazione
delle
diversi
classi.
OggeLo
Provvedimento:
1.
delega
un
giudice
alla
procedura
di
concordato.
2.
ordina
la
convocazione
dei
creditori
non
oltre
trenta
giorni
dalla
data
del
provvedimento
e
stabilisce
il
termine
per
la
comunicazione
di
questo
ai
creditori.
3.
nomina
il
commissario
giudiziale
osservate
le
disposizioni
degli
art.
28
e
29.
Novità -‐ Assenza del previgente apprezzamento di merito da parte del Tribunale del concordato proposto. -‐ Rinvio dell’esame della Relazione del professionista all’adunanza dei creditori. -‐ Valutazione correKezza dei criteri di formazione delle eventuali classi di creditori*.
Formazione della maggioranza per l’approvazione del concordato (art.177 L.F.) Il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresenGno la maggioranza dei credi> ammessi al voto. In caso di diverse classi di creditori il concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresenGno la maggioranza dei crediG ammessi al voto nella classe medesima. Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e ritenga che i creditori appartenenG alle classi dissenzienG possano risultare soddisfaT dal concordato in misura non inferiore rispeLo alle alterna>ve concretamente pra>cabili.
Novità -‐ Scompare il riferimento originario alla doppia maggioranza per creditori e per somma. -‐ Valutazione prognosGca e potere discrezionale del Tribunale nella individuazione delle alternaGve praGcabili.
Giudizio di omologazione (art.180 L.F.) -‐ decreto fissazione udienza in camera di consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale. -‐ affissione provvedimento all’albo del tribunale e noGficato a cura al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienG. -‐ deposito memorie difensive entro 10 gironi prima dell’udienza. -‐ aKestata maggioranze di cui all’art. 177 l.f., emissione del decreto moGvato di omologazione reclamabile entro 15 giorni. -‐ emissione del decreto di omologa entro 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 161 L.F. prorogabile una sola volta di 60 giorni.
Disciplina transitoria Le disposizioni modificate degli arK. 160,163,177, 180, 181 si applicano altresì ai procedimenG di concordato prevenGvo penden> e non ancora omologa> alla data di entrata in vigore del DL 35/05 del 17.03.05.
Conclusioni -‐Importanza ed incidenza ai fini del buon esito del concordato della posizione assunta dai creditori portatori di interessi più forG. -‐Concordato prevenGvo per il rilancio dell’impresa e non per la sola liquidazione. -‐Funzione dell’Amministrazione Controllata “assorbita” dal Concordato PrevenGvo*. -‐AutomaGsmo decisionale.
Estensione al Concordato PrevenGvo del pagamento non integrale dei creditori privilegiaG (D.Lgs.169/07)
Accordi
di
ristruLurazione
dei
debi>
(art.
182
bis
L.F.)
OggeLo: Accordo di ristruKurazione sGpulato con i creditori rappresentaG almeno il 60% dei crediG. (novazione obbligazioni)
Forma: -‐ Deposito dell’accordo mediante dichiarazione e documentazione ex art.161 L.F. -‐ Allegazione relazione esperto su aKuabilità dell’accordo e sua idoneità a assicurare il pagamento dei creditori estranei. -‐ Pubblicazione accordo nel Registro delle Imprese.
Opponibilità: -‐ possibilità di opposizione da parte dei creditori e da ogni interessato entro 30 giorni dalla pubblicazione. -‐ omologazione dell’accordo in Camera di Consiglio con decreto moGvato del Tribunale reclamabile in 15 gg. avanG Corte d’Appello. Efficacia: dalla data della pubblicazione nel registro imprese.
I
Creditori
non
aderen>
diriKo
al
pagamento
RISCHIO
Inattuabilità
L’accordo
è
un
contraLo
tra
il
debitore
ed
una
parte
dei
creditori
implicante
una
del piano.
rinegoziazione
del
credito
e
quindi
con
efficacia
limitata
questa
sola
parte
dei
Il pagamento
creditori.
integrale
del 40% dei crediti,
potrebbe risultare
condizione
penalizzante per
l’imprenditoreEstensione del principio dello stato di crisi come presupposto. Divieto azioni esecuGve per 60 gg. dalla pubblicazione del piano al R.I. Novità legisla>ve D.LGS. 169/07
AspeV
di
cri>cità
dell’is>tuto:
1.
ruolo
centrale
del
professionista
d’impresa
alla
quale
è
richiesta
la
relazione
sull’aKuabilità
del
piano
e
l’aKestazione
della
veridicità
dei
daG
aziendali.
2.
assenza
requisiG
esperto
(art.
67
comma
3
leK.
d
o
art.
28
L.F.?).
3.
intervento
marginale
Tribunale.
4.
omesso
riferimento
al
classi
creditori
.
5.
omesso
riferimento
alla
condizione
in
cui
debba
trovarsi
il
debitore.
6.
ruolo
centrale
dei
creditori
portatori
di
interessi
più
forG.
7.
assenza
di
un
obbligo
di
deposito
delle
scriKure
contabili.
8.
no
revocabilità
pagamenG
effeKuaG
in
forza
dell’accordo
(art.
67
comma
3
leK.
e)
successivi
alla
omologa.
9. omessa indicazione delle forme e delle modalità di raccolta delle adesioni all’accordo. 10. assenza di una valutazione del rischio penale (bancaroKa semplice, preferenziale). 11. rischio piano di ristruKurazione scollegato da un piano industriale con ipotesi di riposizionamento strategico dell’impresa.
Applicabilità In assenza di richiamo da parte art. 2 comma 2 D.L. 35/05, l’isGtuto di cui all’art. 182 bis L.F. è entrato in vigore in modo autonomo rispeKo al concordato dal 17.03.05.
Piano di Risanamento ex art 67 3°C. LeK.d
A) FaTspecie e Contenuto. -‐ Il piano prevede il compimento di aV funzionali al risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. -‐ Presupposto oggeTvo: situazione di crisi transitoria che l’imprenditore riGene superabile aKraverso il Piano. -‐ Esenzione dalla revocatoria fallimentare.
B) Condizione esenzione: -‐ Piano idoneo a consenGre il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa. -‐ Piano idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. -‐ Piano aLestato dalla relazione asseverata di un revisore contabile (art. 2501 bis c.c)
C) AspeV Problema>ci: -‐ Requisito di idoneità: momento della redazione del piano o se debba essere sempre valido? -‐ la norma deKa solo i requisiG di idoneità e ragionevolezza senza soffermarsi né sui modi né sui contenu> del piano.
IL
RECUPERO
DELL’IVA
RELATIVA
AI
CREDITI
VERSO
I
CLIENTI
“INSOLVENTI”RiferimenG
normaGvi
(DPR
633/72)
DireTva
comunitaria
388
del
1977
(art.
11
e
20).
L’art.
2,
comma
1,
leKera
c-‐bis),
della
L.
28
febbraio
1997,
n.
30,
di
conversione,
con
modificazioni,
del
D.L.
31
dicembre
1996,
n.
669
e
l’art.
13-‐bis,
commi
1
e
2,
della
L.
28
maggio
1997,
n.
140,
di
conversione,
con
modificazioni,
del
D.L.
28
marzo
1997,
n.
79
RiferimenG
di
prassi:
Circolare
n.
77/E
del
17
aprile
2000
Risoluzione
12
oKobre
2001,
n.
155/E
Risoluzione
17
oKobre
2001,
n.
161/E
Risoluzione
18
marzo
2002,
n.
89/E
MANCATO
PAGAMENTO
IN
TUTTO
O
IN
PARTE
DELL’IMPORTO
INDICATO
IN
FATTURA
A
CAUSA
DI
PROCEDURE
CONSORSUALI
RIMASTE
INFRUTTUOSE
• prevenGvo assoggeKamento del debitore a procedura concorsuale • la necessaria partecipazione del creditore (richiesta di ammissione al passivo).
DOMANDA ORDINARIA -‐ Art. 92 L.F. Il curatore, esaminate le scriKure dell'imprenditore ed altre fonG di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai Gtolari di diriT reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta eleKronica: 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'arGcolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni uGle informazione per agevolare la presentazione della domanda.
-‐ Art. 93 L.F. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di resGtuzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere soKoscriKo anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telema>ca o con altri mezzi di trasmissione purche' sia possibile fornire la prova della ricezione. Il ricorso conGene: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la resGtuzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei faT e degli elemenG di diriKo che cosGtuiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un Gtolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha caraKere speciale; 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta eleLronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di noGficazione e di comunicazione, la trasmissione per posta eleKronica o per telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predeKe modalità.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiG di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario………. I documen> non presenta> con la domanda devono essere deposita>, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo………. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisG ai sensi dell'arGcolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori ……………….
DOMANDA TARDIVA -‐ Art.101 L.F. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di resGtuzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecu>vità dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di parGcolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ulGmo termine fino a dicioLo mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'arGcolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli arGcoli da 93 a 99……… Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tuKe le riparGzioni dell'aTvo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
PRESUPPOSTO EMISSIONE NOTA VARIAZIONE
1. •
Fallimento
-‐
Al
fine
di
individuare
l’infruKuosità
della
procedura
occorre
fare
riferimento
alla
scadenza
del
termine
per
le
osservazioni
al
piano
di
riparto
(trascorsi
10
giorni
dal
decreto),
oppure,
ove
non
vi
sia
stato,
alla
scadenza
del
termine
per
il
reclamo
al
decreto
di
chiusura
del
fallimento
stesso.
2. •
Liquidazione
coaKa
amministraGva
-‐
Occorre
aver
riguardo
al
decorso
dei
termini
(20
giorni)
per
l’approvazione
del
piano
di
riparto.
3. •
Concordato
fallimentare
-‐
Occorre
aKendere
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
di
omologazione
del
concordato
stesso
ed
è
ammessa
per
la
sola
parte
non
incassata.
4. •
Concordato
prevenGvo
-‐
Il
recupero
è
ammesso
solamente
per
i
creditori
chirografari
e
per
la
parte
percentuale
del
loro
credito
che
non
trova
accoglimento
con
la
chiusura
del
concordato.
Occorre
aver
riguardo
oltre
che
alla
sentenza
di
omologazione
divenuta
definiGva,
anche
al
momento
in
cui
il
debitore
concordatario
adempie
agli
obblighi
assun>
in
sede
di
concordato.
Nell’ipotesi
di
dichiarazione
di
fallimento
nel
corso
della
procedura
in
argomento,
in
conseguenza
del
mancato
adempimento
degli
obblighi
assunG
o
alla
luce
di
comportamenG
dolosi
da
parte
del
debitore
concordatario,
la
reTfica
in
diminuzione
va
operata
solo
dopo
che
il
piano
di
riparto
dell’aTvo
sia
divenuto
definiGvo
ovvero,
in
assenza
di
un
piano,
a
chiusura
della
procedura
fallimentare.
5. •
Amministrazione
straordinaria
delle
grandi
imprese
in
crisi
-‐
Anche
tale
procedura
non
rientra
nell’ambito
applicaGvo
della
nuova
disposizione
normaGva.
MANCATO
PAGAMENTO
IN
TUTTO
O
IN
PARTE
A
CAUSA
DI
PROCEDURE
ESECUTIVE
RIMASTE
INFRUTUOSE
1. Il
presupposto
legiTmante
la
variazione
in
diminuzione
viene
ad
esistenza
quando
il
credito
del
cedente
il
bene
o
prestatore
del
servizio
non
trova
soddisfacimento
aKraverso
la
disposizione
delle
somme
ricavate
dalla
vendita
dei
beni
dell’esecutato,
ovvero
quando
sia
stata
accertata
e
documentata
dagli
organi
della
procedura
l’insussistenza
di
beni
da
assoggeLare
all’esecuzione.
2. Mentre
la
variazione
in
diminuzione
cosGtuisce
esercizio
di
una
facoltà
per
il
cedente
o
prestatore
del
servizio,
una
volta
che
quesG
abbia
esercitato
tale
diriKo,
provvedendo
alla
reTfica,
con
l’emissione
della
nota
di
variazione,
sorge
in
capo
alla
controparte
(curatore,
commissario
liquidatore,
esecutato
ecc.)
l’obbligo
di
provvedere
alla
registrazione
della
variazione
in
aumento
nel
registro
delle
faKure
emesse
o
dei
corrispeTvi.
3. Qualora
successivamente
alla
procedura
esecuGva,
colleTva
o
individuale,
il
cedente
del
bene
o
prestatore
del
servizio
recuperi,
in
tuKo
o
in
parte,
il
credito
in
precedenza
insoddisfaKo,
lo
stesso
dovrà
provvedere
ad
effeKuare,in
relazione
all’importo
recuperato,
una
variazione
in
aumento
in
reTfica
di
quella
in
diminuzione
a
suo
tempo
operata.
Momento in cui si realizza l’esito infruKuoso: 1. insussistenza dei beni da soKoporre ad esecuzione accertabile ad opera degli organi adiG già in fase di pignoramento. 2. insufficienza del valore aKribuito dall'organo adito ai beni pignoraG rispeKo all'ammontare del credito preceKato. 3. insufficienza delle somme accertabile in sede di realizzazione del ricavato.
TERMINE EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE
La
circolare
n.77/E
del
2000
ha
precisato
che
non
opera
il
limite
temporale
di
un
anno
dall’effeKuazione
dell’operazione
imponibile,
di
cui
al
comma
3
del
medesimo
art.26,
qualificandosi
la
variazione
come
conseguenza
di
un
evento
che
non
dipende
dal
sopravvenuto
accordo
delle
parG,
o
dalla
inesaKezza
della
precedente
faKurazione.
Al
riguardo,
tuKavia,
l’Agenzia
delle
Entrate,
nel
rispondere
ad
una
istanza
di
interpello
sulla
procedura
fallimentare
(risoluzione
n.89/E
del
2002),ha
espresso
il
principio
di
caraKere
generale
secondo
il
quale
la
disposizione
in
esame
deve
essere
coordinata
con
quella
relaGva
all’esercizio
del
diriKo
alla
detrazione
recata
dall’art.
19
del
D.P.R.
n.633/1972,
nel
senso
che,
come
già
evidenziato,
la
facoltà
può
essere
esercitata
al
più
tardi
con
la
dichiarazione
rela>va
al
secondo
anno
successivo
a
quello
in
cui
il
diriLo
alla
detrazione
è
sorto.
ADEMPIMENTI
Emissione delle note di credito -‐ La variazione in diminuzione deve riguardare sia l’imponibile che l’imposta. -‐ Non comporta per il soggeKo creditore alcuna rinuncia al credito
Facsimile
di
leLera
di
accompagnamento
e
di
nota
di
credito
Le$era
di
trasmissione
Nota di variazione
Applicabilità
della
norma
per
credi>
di
importo
ridoLo
Interpretazione
prudenziale
La
norma
si
rivela
inadeguata
e,
di
fa7o,
inapplicabile
rispe7o
a
quei
credi;
di
modesta
en;tà,
per
i
quali
il
ricorso
alle
procedure
esecu;ve,
siano
esse
individuali
o
concorsuali,
comporterebbe
una
eccessiva
onerosità
non
gius;ficata.
Interpretazione
“aggressiva”
La
possibilità
per
l'azienda
di
emeKere
la
nota
di
credito
ex
art.
26
comma
2
D.P.R.
633/72
relaGvamente
ad
una
posta
di
modesto
valore
sarà
tanto
più
moGvabile
qualora
sia
stata
ad
esempio
accertata
già
in
fase
stragiudiziale:
-‐
l’esistenza
di
protesG
a
carico
del
debitore
-‐
l'esito
negaGvo
della
noGfica
al
debitore
a
mezzo
posta
di
leKere
di
diffida
e
cosGtuzione
in
mora
o
perfezionamento
della
stessa
solo
per
compiuta
giacenza.
Procedura esecu>va esperita per un importo inferiore al credito originario Nella prassi ciò può verificarsi quando al fine di contenere i cosG ed avvalersi di vie processuali più veloci, il creditore azioni solo quella parte minore di credito garanGta e documentata da un Gtolo di credito (cambiale). Dal punto di vista quanGtaGvo, l’enGtà delle note di variazione è streKamente correlata all’esito infruKuoso della procedura posta in essere. Nel caso di specie, quindi, essendo il pignoramento negaGvo esperito per una parte del credito in origine faKurato, la nota di variazione non potrà che assumere un valore pari a quello dell’escussione,giacché soltanto in relazione ad esso è stata dimostrata l’infruKuosità dell’azione intentata.
20122
Milano
Via
Pietro
Cossa
2
Tel:
+
0390236709728
Fax:
+0236709729
www.slacc.it
Puoi anche leggere