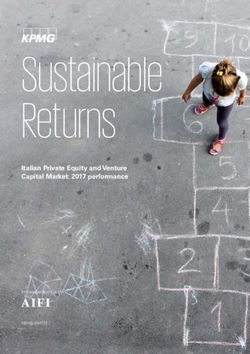Ancora itanglese - Terminologia etc.
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Ancora itanglese Se non l’avete già letto, troverete interessante Itanglese e italiano, alcune considerazioni di Annamaria Testa sugli anglicismi superflui. Ho trovato molto puntuale l’osservazione che i termini inglesi “hanno un vantaggio perché soggettivamente sono percepiti come più precisi e più evocativi, e perché si portano dietro in automatico una connotazione moderna e cosmopolita, quindi positiva”. Alcuni commenti all’articolo e ad altri che l’hanno ispirato sono la conferma che c’è chi conferisce ad alcuni anglicismi accezioni particolari assenti in inglese, ad es. c’è chi pensa che in inglese clown abbia un significato più specifico di pagliaccio. Penso che la percezione soggettiva sia dovuta anche a differenze di registro: alcune parole inglesi hanno un equivalente in parole italiane a cui associamo connotazioni stilistiche o particolari risonanze che ce le fanno percepire come non adeguate per il livello o le finalità della comunicazione. I forestierismi invece non ci appartengono e inizialmente li avvertiamo come parole neutre, quindi possiamo “ridefinirli” caricandoli solo del significato che ci serve: come discutevamo qui, un concorso fa pensare ad aspiranti impiegati statali o all’estrazione degli splendidi premi in palio, e così per artisti e creativi è stato importato il contest. Io però continuo a catalogare contest (e step, feature, deadline, tool, trend, competitor, mission, food, wine lover…) come forestierismi superflui (itanglese) e, come ho ripetuto spesso, sono sempre più convinta che la mania per gli anglicismi sia inversamente proporzionale all’effettiva padronanza dell’inglese (e spesso anche dell’italiano). . Aggiornamento dicembre 2014 – Francesco Sabatini descrive i troppi anglicismi come “un misto di pigrizia, esibizionismo ed elitarismo”: step, feature, feedback, guideline, deadline, policy, ad es. policy aziendali, tool, trend, competition, marketplace, outsourcing, customer service/care, tanto per fare i primi esempi che mi vengono in mente: forse passaggio o passo, caratteristica o funzionalità, commenti e/o suggerimenti, linee guida, scadenza, regole o criteri, strumento, tendenza, concorrenza, mercato, esternalizzazione e assistenza ai clienti non sono abbastanza espressivi? in stile navy, stile British, dondolo old style, rigorosamente white&blue, black&white, se sei blu-addicted [sic], total white, il tuo green party, green & chic, cucinare: blue link, English Mood, scegli il tuo mood, wallpaper anni ‘70, daybed, pattern iper-materico, forma sixties, tre modi di dire outdoor, complementi d’arredo outdoor , tutto mooolto glam, coffee-table iperglam [sic] , soft budget,
nice design, cucina young, ambiente open, temperature hot, decoro easy , apparecchi new generation, case stress-free, il divano è un comodo no-name, mix & match, shopping in & out , bookmaniaci, Face & cook craft room, crafts, soft budget, idee express, news, cult!, city-guide, progetto crafts (con la nota del direttore “non me ne vogliano i patiti dell’italiano-a-tutti i costi ma le craft room hanno già una loro storia”), angolo crafts, stile glossy, tendenza crafts, stickers, scrapbook, la cover della poltrona minimal, atmosfera cottage, idea cool, effetto hand-made, il look tricot è molto craft (?!), animal style, masking tape (suona decisamente più cool di nastro adesivo per mascheratura!), décapé forever, bordo a crochet (francesismo usato anche in inglese; probabilmente “all’uncinetto” non è abbastanza trendy?), comfort, all white, living, stylist, mood, mission possible, cozy (spiegato traducendolo come “coccoloso”)… E anche la pubblicità non scherza: in tre pagine successive si legge more with less, living and cooking, total home design.
L’invasione degli anglicismi Rispondo con un lungo post a diversi commenti di Remo, di cui apprezzo la passione per la lingua italiana. Non condivido invece il suo allarmismo per il presunto disfacimento dell’italiano a causa del proliferare degli anglicismi. Forestierismi insostituibili, utili e superflui Tutte le lingue hanno sempre fatto uso di forestierismi, i cosiddetti prestiti. In italiano la distinzione classica è tra prestiti di necessità e di lusso ma Giovanni Adamo e Valeria Della Valle in Le parole del lessico italiano preferiscono invece una tripartizione: 1 forestierismi insostituibili, ormai radicati nell’uso, soprattutto per la loro concisione, efficacia espressiva e adeguatezza nominativa, come computer; 2 forestierismi utili, che ripropongono espressioni straniere alle quali i parlanti sembrano adeguarsi senza sforzo eccessivo, facilitando l’uso di formule denominative di circolazione internazionale, come autobus; 3 forestierismi superflui, che si affiancano a espressioni italiane già in uso o facilmente ricavabili e sono mossi spesso dalla volontà di ostentare consuetudine con tendenze o conoscenze linguistiche straniere, come nel caso dell’inglese ticket, molto spesso abusato in luogo di ‘biglietto’ o ‘buono’. Per Remo, però, “la distinzione tra anglicismo utile e gratuito è troppo labile: tutti gli anglicismi, se vogliamo, sono gratuiti nel momento del loro ingresso [nella lingua]”. Il mio punto di vista è alquanto diverso, come avevo cercato di spiegare in una risposta precedente, distinguendo tra l’uso degli anglicismi nel lessico comune e nel lessico specialistico, dove spesso possono risultare più utili di eventuali alternative italiane. Lessico comune e concetti generici Sono perplessa dall’uso alquanto disinvolto di anglicismi nel lessico comune per descrivere concetti generici (esempi qui, qui e qui) perché penso che penalizzino la comunicazione. Credo che entrino in gioco una certa pigrizia da parte di chi comunica (soprattutto nei mass media), uno sfoggio della propria presunta conoscenza dell’inglese (ad es. nel marketing e nelle relazioni pubbliche) e, in generale, anche una scarsa sensibilità per le capacità espressive della propria lingua. Lessico specialistico e concetti specifici
Sono invece convinta che in molti linguaggi speciali (linguaggi tecnico-scientifici e settoriali) ci siano casi in cui i prestiti siano la scelta più efficace, grazie al valore monosemico, alla concisione e alla riconoscibilità “globale” del termine (la cosiddetta mutua intelligibilità: in questo senso l’inglese ha il ruolo che aveva una volta il latino). Non sono d’accordo con l’atteggiamento purista* che vorrebbe che anche i forestierismi arrivati dal lessico specialistico per descrivere concetti specifici vadano sostituiti comunque da soluzioni alternative “italiane” (ad es. nessun sostantivo che finisca in consonante, etimologia latina ecc.) perché in molti casi risulterebbero troppo generiche, opache, poco precise e soprattutto non condivise, quindi, paradossalmente, in questi contesti potrebbero essere le parole "autoctone" a penalizzare la comunicazione (cfr. le improbabili alternative per banner e browser qui). Prestiti integrati e non integrati Immagino che Remo ritenga inaccettabili parole come smartphone perché si tratta di prestiti non integrati, che non hanno subito un processo di assimilazione. Va però considerato che la sensibilità linguistica contemporanea fa preferire l’adozione degli anglicismi senza modifiche, anche grazie a una maggiore riconoscibilità delle parole inglesi, ed è il motivo per cui un eventuale prestito integrato come smartofono suonerebbe ridicolo: nessuno ha problemi a pronunciare /ˈzmartfon/ con consonante finale o l’insolita sequenza /rtf/, né tantomeno a scrivere ph. Alternative ai forestierismi Quando si introduce un nuovo concetto nato in un’altra lingua, oltre al prestito si può optare per un calco, ad es. intellifonino, una polirematica, ad es. telefono intelligente, oppure creare un neologismo ad hoc (la scelta meno frequente). Vanno comunque considerate le tendenze della propria lingua e del campo terminologico in cui si opera, ad es. in ambiti tecnici raramente hanno successo soluzioni dal sapore arcaizzante o molto lunghe o, come dicevo sopra, troppo generiche, opache o poco precise. Coesistenza di termini diversi Remo nota che, a differenza dell’italiano che prevede solo smartphone, in francese si potrebbe dire anche ordiphone e in spagnolo teléfono inteligente e trova che in italiano la mancanza di almeno un’alternativa a smartphone sia un campanello di allarme per la salute della lingua. Da un punto di vista terminologico, relativo a un ambito specializzato e non al lessico comune, avere a disposizione più parole per lo stesso concetto è uno svantaggio perché può penalizzare la comunicazione (anche se, nel tempo, le alternative tendono comunque a scomparire, cfr. Radiografia delle parole e relativi
commenti). In questo senso, nel caso di smartphone la situazione italiana è preferibile a quella di altre lingue perché abbiamo un unico termine che identifica il particolare tipo di dispositivo, sia nella comunicazione formale che informale. L’invasione degli anglicismi: reale o percepita? Secondo Remo, “l’attuale avanzamento dei termini inglesi in italiano non ha eguali storici per grandezza e rapidità del fenomeno” e teme “la progressiva sostituzione del vocabolario originario con uno preso pari pari da un’altra lingua”, prospettando che “fra qualche decennio l’italiano (o quello che sarà, visto [che] chiamarlo italiano è sempre più difficile) non sarà altro che un dialetto dell’inglese”. In tutte le generazioni e in tutte le principali lingue europee ci si è sempre lamentati dell’imbarbarimento della propria lingua rispetto al passato (cfr. Integralisti della lingua inglese e Grammatica, variabilità e norme interiorizzate) e anche per questo eviterei il pessimismo: se si fa attenzione a come parlano le persone in situazioni di vita quotidiana, si può notare che la presenza di anglicismi è davvero molto ridotta. I linguisti italiani, per primi, non mostrano particolari preoccupazioni per la presunta invasione degli anglicismi, come confermano vari interventi. Nel Portale Treccani, ad esempio si possono consultare un’intervista a Tullio De Mauro, «Gli anglicismi? No problem, my dear», uno studio riassunto da Silverio Novelli in Il bel Paese dove il weekend suona e, in particolare, i dati forniti da Giuseppe Antonelli in Fare i conti con gli anglicismi I – I dizionari dell’uso, da dove è tratta questa metafora: L’odierna percezione del fenomeno dell’anglicismo potrebbe allora essere paragonata alla “temperatura percepita” di cui così spesso si parla nei telegiornali estivi. Come ci hanno spiegato i meteorologi, a una temperatura obiettiva (misurabile con il termometro) corrisponde – nelle calde giornate d’estate – una temperatura percepita più alta, perché condizionata dal notevole tasso di umidità. Quello che succede per gli anglicismi non è molto diverso: una presenza obiettiva contenuta in percentuali fisiologiche viene avvertita come una preoccupante invasione, perché amplificata dai mezzi di comunicazione di massa. . Concludo ringraziando Remo per gli spunti di discussione e mi auguro che continui a leggermi, sperando soprattutto di convincerlo che i produttori di software non hanno alcun “interesse che l’italiano si eroda” per ridurre i costi di localizzazione. .
Maledizione della conoscenza La “maledizione della conoscenza” è la difficoltà di immaginare che gli altri non sappiano ciò che conosciamo bene. Per Pinker è la causa principale dei testi poco comprensibili anche se scritti da persone molto competenti. Manifestazioni tipiche sono informazioni e riferimenti dati per scontati, l’uso di astrazioni familiari e abituali per chi scrive ma non per i lettori meno esperti, e gergo, abbreviazioni, acronimi e terminologia da addetti ai lavori, senza definizioni o spiegazioni. Esempio: Il ruolo dell’informatica nella società digitale e altre pagine del progetto Programma il futuro, descritto come "per tutti, nessuno escluso" ma che invece presume conoscenze non comuni (cfr. frasi come “la sicurezza di queste transazioni è legata ad una famosa congettura sulla complessità computazionale, secondo la quale P è diverso da NP”). Come evitarla Pinker spiega il problema da prospettive psicologiche e cognitive e dà varie indicazioni per evitarlo. Ritiene valido il classico suggerimento di identificare il lettore tipico di un testo, ma ci avverte che si tende ad avere un’immagine ottimistica di quali possano essere le sue effettive conoscenze, competenze, aspettative ed esigenze: è sempre meglio presumere che sappia meno di quanto si immagina. Per quanto banale possa sembrare, è molto utile sottoporre il testo a lettori reali e rappresentativi del proprio pubblico, per verificare se ci sono problemi di comprensione. Chi scrive dovrebbe inoltre abituarsi a spiegare ogni termine poco noto, ad es. aggiungendo una breve definizione o un esempio, e a evitare esattismi e soprattutto pseudotecnicismi, sostituendoli con parole del lessico comune (cfr. gli esempi di L’antiburocratese e post con tag burocratese). Sono convinta che anche la cultura terminologica possa essere un buon antidoto alla “maledizione della conoscenza” perché abitua a riflettere sui concetti e sulle parole e i termini che li rappresentano, a evidenziare caratteristiche essenziali e distintive e usarle per definizioni concise ma efficaci, e a prestare sempre attenzione all’utente finale: vari esempi nei post sul lavoro terminologico. Altri dettagli in Terminologia e comunicazione (link aggiunto). .
Terminologia e comunicazione Nel mio intervento, Terminologia e comunicazione, ho preso spunto da alcuni esempi istituzionali di “maledizione della conoscenza” per evidenziare aspetti del lavoro terminologico che possono aiutare i comunicatori pubblici a rendere i loro testi più accessibili ai cittadini. Se manca un sistema di gestione della terminologia, o almeno dei glossari di riferimento, diventa ancora più importante sapere individuare i concetti, e quindi i termini che li designano, che più di altri richiedono spiegazioni o esempi per essere comprensibili. Come identificare concetti e termini prioritari I criteri di selezione possono variare in base a diversi fattori, come ad es. tipo e finalità di comunicazione, utente finale, grado di specificità, modalità d’uso. Ne ho descritti alcuni: Novità – Va chiarito ogni concetto nuovo e ogni concetto già noto in altri ambiti ma non in quello in cui appare per la prima volta. Esempio: pensiero computazionale, concetto noto negli Stati Uniti ma fino a un paio di mesi fa quasi sconosciuto in Italia, come rilevato nei commenti a La buona scuola, tra anglicismi e sillabazioni. Visibilità – I concetti strategici e a forte impatto richiedono un’attenzione particolare. Un esempio che faccio spesso riguarda l’accordo sottoscritto da 25 stati membri dell’UE il 2 marzo 2012 e chiamato fiscal compact dai media italiani ma patto di bilancio nei documenti ufficiali UE (e si trovano anche occorrenze di fiscal pact, patto fiscale europeo e trattato sulla stabilità), con grande confusione per i cittadini. I concetti ad alta visibilità vanno individuati quanto prima, in modo da poter diffondere la denominazione ufficiale a tutti i comunicatori prima che ricorrano a soluzioni alternative, come prestiti o calchi dall’inglese, e creino incongruenze (ad es. inclusive growth, concetto chiave della strategia Europa 2020, che in italiano viene chiamato sia crescita inclusiva che crescita solidale) e a volte possano anche fare prevalere terminologia inadeguata o addirittura errata (cfr. paradiso fiscale). Confondibilità – Va evitato che omonimi, accezioni poco note, parole simili o casi di anisomorfismo causino fraintendimenti, come ad es. fiscal in fiscal compact (il significato inglese non corrisponde all’italiano fiscale, cfr. fiscal cuts ≠ tagli fiscali) o compact, difficilmente interpretabile correttamente come “accordo”. Risemantizzazione – È un argomento su cui torno spesso: per chi non ha competenze terminologiche può essere difficile riconoscere i neologismi semantici ed evidenziarli come tali (dettagli in iPad, “flick” e terminologizzazione). Un esempio tipico è crescita, che nel contesto di Europa 2020 non è una parola del lessico
comune ma un termine che identifica un concetto specifico: l’ha sottolineato Daniela Vellutino in Se la crescita è un termine… e nell’intervento che ha dato inizio ai lavori dell’incontro. Specializzazione – Il tipo di utente finale determina quali termini vadano spiegati e quali invece possano essere dati per scontati. Esempio: in una pagina di presentazione del Fondo per la crescita sostenibile è corretto spiegare cosa siano le tecnologie abilitanti, mentre non è necessario se il destinatario è un gruppo di lavoro sulla politica industriale dell’UE, quindi esperti in materia. Ci sono parecchi altri criteri per individuare concetti e termini prioritari (cfr. Quali termini documentare?), ma ritengo che questi siano i più utili e i meno complessi da assimilare per chi fa comunicazione senza una specifica formazione terminologica. Altri aspetti rilevanti Nel mio intervento ho ricordato anche altri aspetti terminologici a cui va data attenzione nelle comunicazioni istituzionali: definizioni adeguate, la differenza tra parole e termini, alcune difficoltà create dagli anglicismi, la coerenza terminologica (ad es. coding e programmazione), la necessità di far prevalere l’approccio un concetto un termine che esclude la variazione privilegiata invece dai giornalisti. . A conclusione di questo lungo post, un ringraziamento a Daniela Vellutino, ai suoi collaboratori e agli altri relatori perché è stato un incontro alquanto stimolante e istruttivo, con contributi davvero interessanti: molto utile il confronto tra professionisti con competenze e punti di vista anche parecchio diversi tra loro. Una bella occasione anche per gli studenti, numerosissimi.
Anglicismi: un piccolo esperimento
L’invasione degli anglicismi ha suscitato molto interesse e parecchi commenti, tra cui
il suggerimento per un piccolo esperimento: consiste nel fare attenzione alle
conversazioni in normali situazioni di vita quotidiana, ad es. in famiglia o tra amici, e
prendere nota dei forestierismi superflui usati dai parlanti.
Ritengo che nell’osservazione vadano considerati alcuni aspetti diacronici e vada
differenziato il lessico comune dal lessico specialistico (dettagli qui):
Per l’esperimento prenderei in esame solo le parole posizionabili nel quadrante in
alto a sinistra del grafico. In particolare:
Analizzerei solo le situazioni di vita quotidiana perché di solito sono
caratterizzate dall’uso di lessico comune e, a differenza di quelle lavorative, le
produzioni verbali sono più spontanee e meno influenzate dai linguaggi
speciali (ad es. informatica, economia, marketing).
Scarterei tutti i prestiti che fanno parte del lessico italiano da vari anni e sono
presenti in tutti i dizionari, come ad es. mouse (1978), check-in (prima del
1974), sport (1829) ecc.
Escluderei tutte le parole, come smartphone, che sono nate in un ambito
specialistico e solo in seguito sono entrate nel lessico comune (frecce nere ➨
nel grafico).
Mi concentrerei sugli anglicismi recenti, arrivati nel lessico comune
direttamente dall’inglese (freccia rossa ➨ nel grafico) e per i quali esiste
anche un’alternativa italiana, quindi solamente prestiti superflui, come gli
esempi in Una casa shabby al punto giusto.
La lingua è in continua evoluzione e alcune parole sono sicuramente difficili da
posizionare, però penso che anche un esperimento rudimentale e del tutto empirico
come questo potrebbe dare qualche indicazione concreta sulla presenza effettiva
degli anglicismi nel lessico comune.Il campione che ho raccolto finora non è affatto rappresentativo (ad es. non comprende tutte le fasce d’età e altri aspetti diastratici) ma mi sta confermando che i prestiti superflui usati attivamente dai parlanti sono decisamente meno numerosi di quelli a cui siamo esposti passivamente ogni giorno attraverso i mezzi di comunicazione di massa* e quindi che le preoccupazioni sulla progressiva scomparsa del lessico italiano sono davvero premature. “etichette”
Occasionalismi o neologismi? Il linguista americano Allan Metcalf in My Mistake? BFD! prende spunto dalla sigla BFD (Big Fucking Deal) per illustrare il suo metodo di valutazione dei neologismi per predire se entreranno nel lessico o rimarranno occasionalismi (parole destinate ad avere vita breve e non rimanere nell’uso perché relative a una situazione particolare e non duratura). Il sistema è conosciuto con l’acronimo FUDGE, dalle iniziali dei cinque criteri di analisi: 1 Frequency of use – un ovvio indicatore di successo è la frequenza d’uso; 2 Unobtrusiveness – le parole che “non si fanno notare”, abbastanza trasparenti per essere assimilate spontaneamente, senza spiegazioni, sono più solide; 3 Diversity of users and situations – viene valutata la varietà d’uso, in particolare gli aspetti diastratici e diamesici (ad esempio, le possibilità di successo di un’abbreviazione sono ridotte se viene usata solo negli SMS da persone di una certa fascia di età, o se in contesti diversi deve competere con significati alternativi già attestati); 4 Generation of other forms and meanings – va considerata anche la produttività della nuova parola, ad es. se da un sostantivo si può far derivare un aggettivo o un verbo (di solito è scarsa nel caso di sigle e acronimi); 5 Endurance of the concept – la nuova parola deve rappresentare un oggetto durevole. Per ciascun attributo viene assegnato un punteggio da 0 a 2; maggiore è il punteggio totale, maggiori sono le possibilità che il neologismo si affermi.
Migranti, emigrati e immigrati Nel Portale Treccani si può leggere un bell’approfondimento sulla differenza tra emigrante, migrante e immigrato. Osserva che “migrante tende a sostituire progressivamente negli usi immigrato, anche se, nell’uso comune, coonestato dai media, migrante viene identificato soltanto con la persona più disperata”, e cioè quella in continuo spostamento da un paese all’altro alla ricerca, spesso vana, di una sistemazione stabile. Un confronto diacronico delle frequenze d’uso nel corpus di libri di Google Books mostra un deciso aumento del sostantivo migrante negli ultimi decenni (dati fino al 2008): Migranti irregolari è la collocazione sostantivo+aggettivo più frequente. Migrante: parola e termine Ieri intanto è stato pubblicato il rapporto Istat su “migrazioni internazionali e interne della popolazione residente” per il 2013 e ho notato che alcuni media hanno dato la notizia usando la parola migranti, altri invece immigrati. Probabilmente chi ha titolato “Quanti nuovi migranti sono arrivati in Italia?” non ha prestato attenzione alla terminologia del rapporto Istat. Si può infatti rilevare che in questo contesto, come in altri contesti istituzionali, migrante è iperonimo di emigrato e di immigrato (e sono iperonimi anche migrazione e migrare). È un esempio di differenza tra parole e termini: l’uso nel linguaggio comune di migrante, con le connotazioni descritte dall’approfondimento citato, non coincide con quello del termine migrante in un ambito specialistico.
Nel Glossario sull’asilo e la migrazione dell’UE, migrante è “persona che lascia il proprio paese o regione per stabilirsi in un altro” e può riguardare “qualsiasi tipo di spostamento qualunque sia la sua durata, composizione e causa”. Sono quindi migranti non solo rifugiati, sfollati e migranti irregolari ma anche manager, dirigenti e professionisti che si spostano per motivi di lavoro (“migranti altamente qualificati”). Il termine migrante ha invece un significato meno ampio per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel cui uso rifugiato non è un tipo di migrante, come per l’Unione europea, ma un concetto coordinato: dettagli in Le differenze tra rifugiati e migranti. È quindi difficile dare una risposta a chi cerca di capire la distinzione tra migrante, immigrante e immigrato: sono parole (e termini) che possono avere accezioni e connotazioni diverse a seconda del loro contesto d’uso. Aggiornamento aprile 2015 – Anche in inglese si discute di differenze lessicali, ad es. There’s A Sad Reason ‘Migrants,’ Not ‘Immigrants,’ Is The Word Being Used osserva che l’uso nei media e in ambiti specialistici (parole ≠ termini) non coincide e fa riferimento a Key Migration Terms, glossario della International Organization for Migration, che ribadisce che a livello internazionale non esiste una definizione condivisa del concetto di migrante.
Aggiornamento giugno 2015 – Nel dibattito politico la parola migrante ha già molte connotazioni: qualche dettaglio in Il gerundio che non era un participio (a proposito di un’affermazione “lessicale” di Matteo Salvini).
Refugee e rifugiato: il lessico della migrazione In diverse lingue europee si discute del lessico della migrazione e nei giorni scorsi vari media italiani hanno dato risalto a una notizia sull’uso delle parole migrant e refugee in inglese, Why Al Jazeera will not say Mediterranean ‘migrants‘. Come spesso succede con i riferimenti linguistici, molti hanno dato per scontato che ci fosse totale equivalenza tra le parole, i loro usi e le loro connotazioni in inglese e italiano. Non hanno considerato che le parole non devono essere isolate dai sistemi concettuali a cui appartengono perché raramente c’è piena corrispondenza tra lingue diverse. Il loro uso è anche influenzato dalle altre parole disponibili in ciascuna lingua. Per l’inglese lo illustra in modo efficace Karl Sharro, libanese che vive a Londra: L’immagine satirica evidenzia parecchie differenze lessicali tra inglese e italiano: Émigré descrive chi è in esilio all’estero, soprattutto autoimposto per motivi politici, come ad es. gli aristocratici europei nel XX secolo. Il francesismo può anche conferire una connotazione di snobismo, come si vede nell’immagine. Non è paragonabile all’italiano emigrato e ha connotazioni diverse da esule e fuoruscito. Global nomad è un neologismo del XXI secolo che descrive chi si sposta da un paese all’altro e ha risorse finanziarie o una carriera che consentono un alto tenore di vita. È una locuzione molto diffusa in inglese, mentre il calco nomade globale ha avuto poca fortuna in italiano. Expat, forma abbreviata di expatriate, è usato in particolare per chi è stato trasferito all’estero per lavoro dalla propria azienda e che, assieme ai propri familiari, gode di particolari privilegi. È una parola molto connotata perché usata quasi esclusivamente per cittadini bianchi occidentali che spesso frequentano solo altri expat. Immigrant ha un corrispondente nell’italiano immigrato ma le connotazioni sono diverse: in Italia nessuno rappresenterebbe un immigrato come nell’illustrazione,
ma per chi vive a Londra è una scelta emblematica perché nel sistema sanitario britannico il 26% dei medici sono stranieri (molti di origine indiana). Asylum seeker ha un equivalente in richiedente asilo ma è un termine che mi sembra molto più frequente nel dibattito pubblico inglese che in quello italiano; si può anche notare che richiedente conferisce una connotazione burocratica assente nell’inglese seeker. Migrant è una parola molto in discussione: anche in inglese, come in italiano, viene usata con un significato diverso nel lessico comune (migrante = persona disperata) e nel lessico delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, ad es. per l’UE migrante è chiunque faccia qualsiasi tipo di spostamento qualunque sia la sua durata, composizione e causa: ne ho discusso in Migranti, emigrati e immigrati. Come già notato da Silverio Novelli, nell’uso dei media italiani la parola migrante è connotata anche dal senso di durata espresso dal participio presente che sta alla base del sostantivo e che sembra sottolineare il continuo spostamento senza requie e senza un approdo definitivo. In inglese questa connotazione “morfologica” non mi pare altrettanto marcata. L’inglese ha a disposizione anche altre parole che non hanno equivalente in italiano: foreign national, non native e alien, usati soprattutto in contesti istituzionali per i cittadini stranieri non naturalizzati che vivono nel paese (quando lavoravo a Dublino noi stranieri scherzavamo molto sull’Aliens Office, dove andavano registrati i cittadini non UE). Una parola italiana che non ha corrispondenza in inglese è extracomunitario. Inoltre, a differenza della coppia immigrant ed emigrant dell’inglese, abbiamo a disposizione le due diverse coppie immigrato ed emigrato ed immigrante ed emigrante, sostantivi con accezioni diverse conferite dalla loro origine (participio passato vs presente). Refugee e rifugiato Credo si possano riscontrare sfumature simili anche paragonando l’inglese refugee e l’italiano rifugiato. In inglese il suffisso –ee deriva da un participio passato francese, quindi formalmente è assimilabile all’italiano –ato, ma appare in parole che identificano chi sta subendo un’azione (employee, trainee, interviewee, antonimi di employer, trainer, interviewer) oppure la sta facendo (referee, absentee), quindi in inglese è sottintesa un’azione in corso. Il participio passato di rifugiato in italiano, invece, suggerisce un’azione già completata. Questa differenza “morfologica” si riscontra anche nelle definizioni dei dizionari: in inglese un refugee è una persona “who has been forced to leave their country” (present perfect: un’azione del passato che si ripercuote nel presente) mentre in italiano è una persona “che ha trovato rifugio” (già avvenuto). Non a caso i media spesso preferiscono profugo, assente dalle terminologie ufficiali sulla
migrazione ma efficace perché suggerisce l’azione della fuga (cfr. tedesco Flüchtling). Credo che queste considerazioni possano essere utili per capire meglio la scelta di Al Jazeera di chiamare refugee chi sta fuggendo sui barconi, e perché la stessa scelta (rifugiato) sarebbe più difficile da giustificare nell’uso non specialistico italiano. Penso anche che i media dovrebbero fare un po’ più di attenzione quando traducono riflessioni sulle parole di un’altra lingua (l’anisomorfismo è sempre in agguato!). Ne ho discusso lo scorso giugno nell’intervento al corso per giornalisti sul tema della migrazione. . Aggiornamento 6 settembre 2015 – Le differenze di percezione tra italiano e inglese sono alla base anche di un appello di Bono (U2) a cui i media italiani hanno dato grande risalto: ospite di un evento a Expo, Bono ha chiesto di non usare più la parola migrant a favore di refugee. Stando a quanto riportato, Bono avrebbe dichiarato, ovviamente in inglese, “queste persone non lasciano le loro case perché vogliono vivere in Italia o in Irlanda. Lasciano i loro Paesi perché non hanno casa. Dunque è sbagliato usare la parola migranti. La parola giusta è ‘rifugiati’”. Il nuovo post Le differenze tra rifugiati e migranti illustra il diverso significato attribuito ai due termini refugee / rifugiato e migrant / migrante da UE e UNHCR (quindi uso specialistico) e lo confronta con l’uso generico nel lessico comune e nei media.
Puoi anche leggere