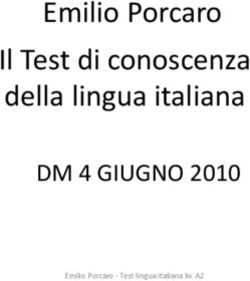2019/2020 GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO - LITERATURA ITALIANA DO SÉCULO XIII - USC
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FACULTADE DE FILOLOXÍA
DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA CLÁSICA,
FRANCESA E ITALIANA
LITERATURA ITALIANA DO SÉCULO XIII
ISABEL GONZÁLEZ
GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO
2019/2020FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA CLÁSICA, FRANCESA E
ITALIANA
AUTORES: Isabel González
Edición electrónica. 2019
ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación
total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico,
mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos
autores.
2INDICE
1. DATI DESCRITTIVI DELLA MATERIA
2. SIGNIFICATO DELLA MATERIA ALL’INTERNO DEL PIANO DI STUDIO
3. OBBIETTIVI
4. COMPETENZE DA ACQUISIRE
5. CONTENUTI
6. BIBLIOGRAFIA
7. METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
8. VALUTAZIONE
1. DATI DESCRITTIVI DELLA MATERIA
1.1. Materia:
Denominazione della materia: Literatura italiana do século XIII
Codice: G5081438
Tipo: Obbligatoria
Corso di Laurea (“grado”): Linguas e Literaturas Modernas: Italiano
Corso: 4º corso
Numero di crediti ECTS: 6
Periodo di svolgimento: Secondo quadrimestre
1.2. Docenza:
Docente del corso: Dott.ssa Isabel González
Lingua impiegata: Italiano. Le lezioni si svolgeranno, fondamentalmente, in
italiano; se necessario, per tradurre e/o chiarire eventuali dubbi, si userà anche il
gallego e lo spagnolo
Area: Filoloxía Italiana
Dipartamento: Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana
Facoltà: Filoloxía
Ufficio: 440 (4º piano)
Telefono: 8818 11865
E-mail: isabel.gonzalez@usc.es
Orario del corso: L, Mt e Mc: 10.00-11.00
Orario di ricevimento: Lunedì, Martedì e Mercoledì: 11.00-13.00
1.3.Requisiti previ e condizioni ottimali:
3È essenziale avere una competenza media dell’italiano orale e scritto.
Trattandosi di una materia obbligatoria dell’ultimo anno, cioè del 4º corso si
suppone, -affinchè si possa studiare con proffito la letteratura del s. XIII-, che lo
studente abbia un livello medio/alto di lingua italiana e che abbia superato le materie
letterarie dei primi corsi (Literatura italiana: Correntes e movimentos (1º), Xéneros
literarios italianos: lírica (2º), Xéneros literarios italianos: narrativa (2º), Xéneros
literarios italianos: teatro (2º), Literatura italiana do século XX (3º), Literatura italiana
do século XIX (3º), e anche la Literatura italiana dos séculos XVII e XVIII (4º primeiro
quadrimestre) e la Literatura italiana dos séculos XV e XVI (4º primeiro quadrimestre),
grazie alle qualli dovrebbe aver imparato a capire, annalizzare e commentare i testi.
2. SIGNIFICATO DELLA MATERIA ALL’INTERNO DEL PIANO DI STUDIO
2.1. Modulo di appartenenza
Nell’ambito del “grado en Linguas e Literaturas Modernas” questa
materia appartiene al Maior e più concretamente al blocco superiore delle
letteratura italiane. Con le altre letterature italiane del Maior, la letteratura
italiana del s. XIII forma un blocco che permette allo studente di acquisire i
mecanismi, gli strumenti e i metodi per l’analisi dei testi che sono fondamentali
per lo studio di qualsiasi letteratura ma molto di più nella letteratura italiana
del duecento che approfondisce lo studio dell’origine tardiva della letteratura
italiana.
2.2. Interesse della materia
Oltre all’importanza e alla necessità dello studio della letteratura italiana
di questo periodo in sé, l’interesse della materia è fondamentale per l’influsso
determinante esercitato sulla letteratura dei secoli successivi.
2.3. Raccomandazioni e osservazioni:
Si raccomanda vivamente l’assistenza regolare alle lezioni teoriche e pratiche e
si consiglia uno studio continuato della materia accompagnato dalla lettura critica e
approfondita dei testi letterari.
3. OBBIETTIVI
Il programma di Letteratura Italiana del secolo XIII intende fornire alcune chiavi
e strumenti per la lettura e l’interpretazione dei testi antichi della tradizione italiana;
quindi, l’obiettivo fondamentale di questa materia è far conoscere all’allievo la
produzione letteraria italiana dalle origini fino a Dante, fondamentalmente il secolo
XIII. Dato che la letteratura italiana del Duecento è così ampia (si pensi soltanto alla
poesia lirica amorosa o all’importanza di certi autori come Guinizelli o Cavalcanti per
non parlare della Vita Nuova di Dante) è impossibile analizzarla nella sua totalità in un
corso di 6 crediti perciò i nostri obiettivi saranno: offrire una panoramica generale
della letteratura italiana del Duecento, studiare in modo approfondito gli autori più
importanti del secolo XIII ed affrontare in forma monografica un aspetto concreto della
Vita Nuova di Dante. Le ragioni di questa scelta sono le seguienti:
41. La panoramica é necessaria per conoscere la letteratura del Duecento e
l’influsso sulla letteratura posteriore (non solo sulla letteratura italiana ma anche sulle
letterature europee).
2. Occorre approfondire lo studio degli autori e delle opere del Duecento
perché data la loro influenza è basilare analizzarla nel dettaglio.
3. Il corso monografico è un modo di conoscere un aspetto concreto di
un'opera rappresentativa del periodo studiato -nel nostro caso la Vita Nuova-
conducendo un'analisi minuziosa che potrà servire agli alunni per acquisire una
maggior competenza nell'analisi dei testi letterari e anche per completare la loro
formazione scientifica e avviarsi così alle successive attività di ricerca. Il corso
monografico sulla Vita Nuova sarà tenuto immediatamente dopo lo studio del Dolce
Stile perché così si potrà capire meglio la poetica amorosa di Dante.
4. COMPETENZE DA ACQUISIRE
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere
l’importanza della letteratura italiana delle origini, fondamentalmente e all’interno
della lirica medioevale il valore della Scuola Poetica Siciliana e del Dolce Stile Nuovo e
l’importanza della Vita Nuova di Dante, dentro della letteratura italiana e universale.
Secondo questa prospettiva, alla fine del corso, il laureando dovrebbe essere in
grado di :
• Leggere e interpretare correttamente un testo letterario antico,
traducendolo, se è necessario, in italiano moderno.
• Individuare gli elementi caratteristici della lingua letteraria (in prosa e
poesia), dalle origini fino a Dante, soprattutto di Guinizzelli e Cavalcanti e della prosa
del Duecento, particolarmente del Novellino.
• Conoscere le principali scuole e movimienti della letteratura italiana del
XIII secolo e avere una conoscenza approfondita della Vita Nuova di Dante.
• Alla fine del corso l’alunno dovrà dimostrare di essere capace di fare un
commento di una poesia della Scuola Poetica Siciliana, per esempio un sonetto di
Jacopo da Lentini, e di una canzone o di un sonetto di un autore del Dolce Stil,
particolarmente di Guido Guinelli, Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia.
• Per quanto riguarda la Vita Nuova, l’allievo dovrà essere in grado di
condurre un’analisi critica, di interpretare e commentare un capitolo, di fare anche un
esame approfondito di un sonetto, o di annalizzare una canzone di quest’opera
dell’Alighieri.
5. CONTENUTI
Le lezioni teoriche saranno sempre accompagnate dalle letture pertinenti
seguendo le diverse impostazioni critiche esistenti e le personali ricerche della
professoressa, per arricchire il lavoro personale dello studente.
5Lo studio dei testi e delle opere si farà in modo tale da comprendere le opere in
sé e anche all’interno del sistema letterario dello scrittore.
Di seguito viene dettagliato il programma del corso, con gli argomenti da
svolgere durante l’anno accademico. Di ogni tema si presenta un elenco degli
argomenti che verranno trattati.
Programma:
Tema 1: Il Duecento: La letteratura italiana dalle origini alla Scuola Poetica
Siciliana
Caratteri generali del Medioevo. Estetica e poetica del Medioevo. La civiltà
medievale in Italia. Impero e Papato: il dibattito politico. La letteratura italiana prima di
Dante. La nascita della letteratura e delle lingue volgari in Italia. Le ragioni del loro
ritardo. I primi documenti del volgare. La poesia religiosa: Francesco d’Assissi. Cantico
di Frate Sole. Jacopone da Todi. Pianto della Madonna.
Tema 2: Poesia lirica amorosa. Scuola Poetica Siciliana
Cultura e poesia dei siciliani. La nascita della lingua letteraria. La corte di
Federico II: premesse culturali per la nascita di una poesia in volgare italiano. I siciliani:
origini e confini di una denominazione. Originalità della poesia. Tematica e poetica. Le
forme metriche: la canzone e il sonetto. La lingua e lo stile. Gli autori e le date.
Continuità e innovazione con la lirica trobadorica. Jacopo da Lentini.
Tema 3: Il Dolce Stil Novo
I due poli culturali : Bologna e Firenze. Il nome della scuola. Caratteristiche.
Originalità. I caratteri distintivi della nuova poetica: Nobilta, gentilezza, Amore. Le linee
essenziali. Il concetto di donna-angelo e l’identità tra amore e cuore gentile. Novità del
Dolce Stil Novo. La ‘dolcezza’ dei nuovi poeti. Il mito stilnovistico. La donna. I poeti e le
date. G. Guinizzelli. G. Cavalcanti. Cino da Pistoia.
Tema 4: La poesia siculo-toscana
La poesia didattica e moraleggiante. La poesia comico-realista.
Tema 5: La prosa del Duecento
La nascita della prosa volgare. Leggende e narrazioni in prosa: Il libro dei sette
savi. Il Novellino. Le cronache. La Rettorica : Brunetto Latini. I viaggiatori: Marco Polo. Il
Milione.
Tema 6: La Vita Nuova.
Nuova lettura della Vita Nuova. Titolo. Il ‘libro’ (della memoria) e il ‘libello’.
Destinatario. Il progetto. Cronologia dell’opera: Genesi. Fonti e modelli. Le rime della
giovinezza e la Vita Nuova. L’influsso della poesia stilnovistica. Il contenuto del libro e
la struttura dell’opera. Definizione, essenza e natura d’amore. Signa Amoris. La Vita
Nuova esempio di prosimetrum medievale. Tipologia. Poetica. Le rime non incluse
nell’opera. La poesia del ‘libello’. Un viaggio autobiografico, sentimentale e letterario.
Argomento: Il primo incontro con Beatrice. Il primo saluto e la ‘meravigliosa visione’.
La donna schermo. La negazione del saluto e gli effetti. La ‘Matera nuova’ e la loda
della gentilissima. La malattia di Dante e la visione della morte di Beatrice. Morte della
donna amata. Il ricordo e il dolore di Dante. La donna pietosa. I pellegrini. L’ultima
6visione di Dante e il proposito di un’altra opera per fare più alta lode della gentilissima.
L’esaltazione di Beatrice. Doppio senso di certi componimenti dell’opera. La Vita
Nuova come opera di prosa. Significato poetico della Vita Nuova dentro del Dolce Stil.
Dante e Guido Cavalcanti: Differente filosofia ma una medesima questione d’Amore.
Eco e fortuna della Vita Nuova.
Di seguito vengono indicati i testi da interpretare, analizzare e commentare.
Tutti di lettura obbligatoria.
Tema 1:
• Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum (o Cantico di Frate Sole)
• Jacopone da Todi, Pianto della Madonna (o Donna de Paradiso)
Tema 2:
• Giacomo Da Lentini: Amor è un desio che ven da core; In Paradiso con
Madonna (o Io m’agio posto in core a Dio servire)
• Rinaldo d’Aquino: Già mai non mi (ri)conforto
• Cielo d’Alcamo: Contrasto tra amante e Madonna (o Rosa fresca
aulentissima)
Tema 3:
• Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io vogli’ del ver
la mia donna laudare
• Guido Cavalcanti: Donna me prega perch’eo voglio dire; Chi è questa che
vèn, ch’ogn’om la mira
• Cino da Pistoia: Una gentil piacevol giovanella
Tema 4:
• Guittone D’Arezzo: Con’ più m’allungo, più m’è prossimana
• Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo
Tema 5:
• Il Novellino: Prologo; Come uno re fece nodrire uno suo figliuolo dieci
anni, in luogo tenebroso, e poi li mostrò tutte le cose, e più li piacque le
femine (XIV); Qui conta d’uomo di corte che cominciò una novella che
non venia meno (LXXXIX)
• Marco Polo, Il Milione: Esordio (cap. 1); Del Veglio de la Montagna e
come fece il paradiso, e gli assessini (capp. 40-42)
Tema 6:
• Vita Nuova
6. BIBLIOGRAFIA
76.1. Come libro di consultazione sarà ovviamente utile qualunque antologia
ampia e completa, qualunque opera di carattere generale o qualsiasi storia della
letteratura italiana come quelle delle case editrici Einaudi, Garzanti, Hoepli, Laterza, Le
Monnier, Mondadori, Marzorati, Mursia, Rizzoli, Vallardi, ecc., o quelle di F. De Sanctis,
G. Contini, F. Flora, N. Sapegno, Asor Rosa, Petronio, Oliveri-Saraso, Gianni- Balestieri-
Pasquali, Fubini-Bonora, A.Budriesi, ecc.
6.2. Per l’impostazione scientifica e didattica saranno particolarmente indicate
storie della letteratura italiana come le seguenti:
AA.VV., L'Italianistica. Introduzione allo studio della letteratura italiana, a cura
di G. Bárberi Squarotti e F. Bruni, Torino, Utet Libreria, 1992
Budriese, Aldo, Letteratura, forme e modelli, v. I: Dalle origini al Quattrocento,
Torino, SEI, 1994
Ferroni, G., Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1991
Guglielmino, S - Grosser, H., Il sistema letterario. Guida alla storia letteraria e
all'analisi testuale, Milano, Principato, 1990
Nencioni, G. - Baldelli, I. - Sabatini, F., Strumenti per lo studio della letteratura
italiana, Firenze, Istituto Geografico De Agostini/Le Monnier, 1992
Pazzaglia, M., Letteratura italiana. Testi e critica con lineamenti di storia
letteraria, Bologna, Bologna, Zanichelli, 1986
Segre, Cesare- Martignoni, Clelia, Guida alla letteratura italiana: testi nella
storia, Milano, Mondadori, 1995-96, 3 vols
Zaccaria, G.- Benussi, C., Per studiare la letteratura italiana. Strumenti e metodi,
Torino, Paravia Scriptorium, 1999
6.3. Sono più recenti, e perciò aggiornate le seguenti:
Brioschi, F. - Di Girolamo, C., Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e
problemi, Torino, Boringhieri, 1995
Bruscagli, R. - Caretti, L. - Luti, G., Letteratura italiana, Milano, Mursia, 1995
Gioanola, E., Storia della letteratura italiana, Milano, Librex Scuola, 1995
Pullega, P., La forma letteraria in Italia, Bologna, Zanichelli, 1995
Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria., Dal testo alla storia. Dalla storia al testo,
Torino, Paravia, 1996
Colombo, A., La letteratura per unità didattiche. Proposte e metodi per
l’educazione letteraria, Firenze, La Nuova Italia, 1996
Mandruzzo, E., Il piacere della letteratura italiana. Per scoprirla, leggerla e
amarla, Milano, Mondadori, 1996
Asor Rosa, A., Storia della letteratura italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1997
Dotti, Ugo., Autori e testi della letteratura italiana, Milano, Laterza, 1997
Gibellini-Oliva-Tesio., Il valore letterario, Brescia, Ed. La Scuola, 1997
Giudici-Bruni: Problemi e scrittori della letteratura italiana, Torino, Paravia,
1997
8Parenti-Vegezzi-Viola., Il tempo storico e le forma, Bologna, Zanichelli, 1997
Pasquini, E., Guida allo studio della letteratura italiana, Bologna, Il Mulino, 1997
Varanini-Marti-Viti-Boldrini., Letteratura italiana, Firenze, Le Monnier, 1997
Pozzi, Mario; Mattioda, Enrico, Introduzione alla letteratura italiana. Istituzioni,
periodizzazioni, strumenti, Torino, UTET, 2002
Luperini, Romano et alii, La scrittura e l'interpretazione. Storia e antologia della
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Firenze, Palumbo, 2002
6.4. Diretta da C. Segre, e perciò molto approfondita e ben curata è l’opera:
Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento, Milano,
Edizioni Scolastiche Mondadori, 1997
6.5. Strutturata in modo “tradizionale” ma con una articolazione interna della
materia diversa dalle altre letterature esistenti –questa studia i fatti letterari entro un
più ampio orizzonte-, considera la storia letteraria non solo in rapporto con la storia
della lingua, dell’arte, del pensiero, della cultura italiana, ma anche in rapporto con le
altre culture europee, è la Storia della letteratura italiana diretta da E. Malato per la
Salerno editrice, Roma, 1995, 20 vv.
6.6. Per la Teoria della letteratura, Critica letteraria e la Teoría della
letteratura comparata, si possono consultare:
Brioschi, F. & Di Girolamo, C., Elementi di teoria letteraria, Milano, Principato,
1996
Garrido, M. A., Nueva introducción a la teoría de la literatura, con la colab. de
A. Garrido y A. García Galiano, Madrid, Síntesis, 2000
Gardini, N., Critica letteraria e letteratura italiana, Milano, Einaudi Scuola,
1999.
Roncaglia, A., Principi e applicazioni di critica testuale, Bulzoni, Roma, 1975
Segre, C., Due lezioni di Ecdotica, Scuola Normale Superiore, Pisa,1991
Gnisci, A., Introduzione alla letteratura comparata, Milano, Bruno Mondadori,
1999
Guillén, C., Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada,
Barcelona, Editorial Crítica, 1985
6.7. Bibliografia di consultazione e approfondimento relativa ai singoli temi:
Tema 1:
Lo spazio letterario del Medioevo, Roma, Salerno editrice, 1996
Casapullo, Rosa, Il Medioevo, Bologna, Il Mulino, 1999
Carrai, S-Inglese, G., La letteratura italiana del Medioevo, Roma, Carocci, 2004
Knowles, D., L’evoluzione del pensiero medievale, Bologna, Il Mulino, 1984
Le Goff, J., Il Basso Medioevo, Milano, Feltrinelli, 1967
9Castellani, A., I più antichi testi italiani. Edizione e commento, Bologna, Pàtron,
1973
G. Petrocchi - I. Di Guardo., Francesco D'Assisi, Gli scritti e la leggenda, Milano,
Rusconi, 1983
Pasero, N., Laudes creaturarum. Il Cantico di Francesco d'Assisi, Parma,
Pratiche, 1992
Contini, G., "Un'ipotesi sulle Laudes creaturarum”, Varianti e altra linguistica,
Torino, Einaudi, 1970, pp. 141-160
Mancini, F., Jacopone da Todi, Laude, a cura di, Roma-Bari, Laterza, 1980
Canettieri, P., "Introducción", Jacopone da Todi e la poesía religiosa del
Duecento, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 5-87.
González, Isabel., Exempla amoris en la poesía italiana del Duecento, Estudios
Románicos dedicados al Prof. Andrés Soria, I, Universidad de Granada, 1985, pp. 349-372.
González, Isabel., “Recursos teatrales en Il Pianto della Madonna”, El teatro
italiano. Actas del VII Congreso Nacional de Italianistas, Valencia, 1998, pp. 271-280.
González, Isabel., Procedimientos analógicos en la poesía amorosa medieval italiana,
Homenaxe ó profesor Camilo Flores, ed. Xosé Luís Couceiro et al., Santiago de Compostela,
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela,
1999, t. II, pp. 379-393.
González, Isabel., Probatio por analogía en la lírica amorosa medieval italiana,
Homenaje al Profesor Trigueros Cano, eds. P.L. Ladrón, A. Pablo y G. Mascali, Murcia, Servicio
de Publicaciones, Universidad de Murcia, 1999, t. I, pp. 193-211.
González, Isabel., Argumenta Amoris en la poesía italiana del Duecento, Actas de la I
Reunión de Italianistas Españoles, Sevilla, 9-11 de diciembre de 1982, Asociación de
Italianistas, Sevilla, 1983, pp. 211-224.
González, Isabel., Exempla amoris en la poesía italiana del Duecento, Estudios
Románicos dedicados al Prof. Andrés Soria, I, Universidad de Granada, 1985, pp. 349-372.
Gutiérrez Carou, Javier, La polisemia simbolica del fiore nella Disputatio rosae
cum viola di Bonvesin da la Riva, in Homenaxe ás profesoras Françoise Jourdan-Pons e
Isolina Sánchez Regueira (ed. de A. Figueroa e J. Lago), Santiago de Compostela,
Universidade de Santiago de Compostela, 1995, pp. 407-414
Tema 2:
Pasquini, E - Quaglio, A.E, Le origini e la scuola siciliana, Roma-Bari, Laterza,
1971
Alvar, Carlos, "Li occhi in prima generan l'amore: consideraciones sobre el
concepto de "amor" en la poesía del siglo XIII", Il Duecento. Actas del IV Congreso
Nacional de Italianistas, Santiago de Compostela, 1989, pp. 9-21
Coletti, Vittorio, "La scuola poetica siciliana", Storia dell'italiano letterario. Dalle
origini al Novecento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 5-17
Folena, G., "Cultura e poesia dei Siciliani", en AA.VV., Storia della letteratura
italiana, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, 1987 (nueva ed.)
10Quaglio, A.E., "I poeti della Magna Curia", en Letteratura italiana. Storia e testi,
diretta da C. Muscetta, Bari, Laterza, 1970, vol. I.
Panvini, B., Poeti italiani della corte di Federico II, Napoli, Liguori, 1994
Antonelli, R., Giacomo da Lentini, Rime, Roma, Bulzoni, 1979
Folena, G., Textus testis: lingua e cultura poetica delle origini, Torino, Bollati
Boringhieri, 2002
Domínguez Ferro, Ana Mª, Manifestaciones del Amor en la lírica siciliana del
siglo XIII, Tesis Doctoral en microficha nº 271, Servicio de Publicaciones de la
Universidade de Santiago de Compostela, 1993
Domínguez Ferro, Ana Mª, “Aproximación al contrasto de Cielo D’Alcamo.
Estudio de los rasgos lingüísticos sicilianos”, Homenaxe ó prof. Constantino García,
Santiago de Compostela, 1991, 133-149
Domínguez Ferro, Ana Mª , “El retrato físico de la dama en la Escuela Poética
Siciliana”, Revista de Literatura Medieval, 9 (1997), pp. 145-172
Domínguez Ferro, Ana Mª , “El retrato moral de la dama en la Escuela Poética
Siciliana”, Revista de Literatura Medieval,10 (1998), pp. 67-81
Domínguez Ferro, Ana Mª “El Apóstrofe Rosa en la Escuela Siciliana del
Duecento”, Il Duecento. Actas del IV Congreso Nacional de Italianistas, Santiago de de
Compostela, 1989, pp. 279-285
Domínguez Ferro, Ana Mª “Las comparaciones con los animales en la Escuela
Poética Siciliana”, Actas del XIX Congreso Internacional de Lingüística y Filoloxía
Románicas, Santiago de Compostela, 1994, vol. II, pp. 629-642
Domínguez Ferro, Ana Mª “El exordio en la canción de la Escuela Poética
Siciliana” Atti del XXI Convegno Internazionale di Lingüística e Filologia Romanza, a
cura di G. Ruffino, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1998, pp. 565-576
Gutiérrez Carou, Javier, Reflexiones sobre la evolución de la rima en el soneto
italiano duecentesco, in Actas del VI Congreso Nacional de Italianistas, vol. I, Madrid,
1994, pp. 331-340.
González, Isabel, El Apóstrofe en la Escuela Poética Siciliana. Parangón con la lírica
gallego-portuguesa, Monografías da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, 1989, 194 páginas (ISBN 84-7191-548-0).
González, Isabel “La expresión de las emociones en la lírica románica medieval”,
M. Brea (ed.), Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2015, pp. 143-160. ISBN: 978-88-6274-
649-6
González, Isabel A voz feminina na "cantiga de amigo" siciliana, Actas do Congreso
Internacional "O Mar das Cantigas", organizado por la Conselleria de Cultura, Comunicación
Social e Turismo de la Xunta de Galicia, Illa de San Simón, 21, 22 y 23 de mayo de 1998, Xunta
de Galicia, Santiago de Compostela, 1998, pp. 179-187.
González, Isabel., Rentabilidad del Apóstrofe en la poesía de Giacomino Pugliese, Actas
del IV Congreso Nacional de Italianistas. Il Duecento, Santiago, 24-26 de mayo de 1988,
Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Santiago de
Compostela, 1989, pp. 381-386.
Tema 3:
11Contini, G., Poeti del Duecento, 2 voll. Milano-Napoli, Ricciardi, 1960
Segre, C. - Ossola, C., Antologia della poesia italiana. Duecento, Torino, Einaudi,
1999
Blanco Valdés, Carmen F., El amor en el Dolce Stil Novo. Fenomenología: teoría
y práctica, Santiago de Compostela, 1996
De Robertis, D., Guido Cavalcanti tra i suoi lettori, Firenze, Cadmo, 2003
González, Isabel., La comparación en la poesía del Dolce Stil Nuovo, Actas del
XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago, 1989.
Fundación "Pedro Barrié de la Maza. Conde de Fenosa", A Coruña, 1994, v. VII. pp. 611-
628.
González, Isabel., “El Apóstrofe en la poesía de Guido Guinizzelli. Semejanzas y
diferencias con la lírica gallego-portuguesa medieval”, Actas del III Congreso de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Salamanca, 1994, pp. 429-436
González, Isabel., “Signa Amoris de dolor en la poesía de Cavalcanti”, Guido
Cavalcanti laico e le origini della poesia europea nel 7º centenario della morte. Poesia,
filosofia, scienze e ricezione, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, pp. 49-62
González, Isabel., “Cavalcanti y Dante: “distinta” filosofía y una “misma”
cuestión de amor”, Con Alonso Zamora Vicente. Actas del Congreso Internacional: La
lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos.., Alicante, 2003, v. II,
pp. 683-691.
Tema 4:
Quaglio, A.E., I poeti siculo-toscani, en AA.VV. Letteratura italiana. Storia e testi,
diretta da C. Muscetta, Bari, Laterza, 1970, vol. I
Leonardi, L., Guittone d'Arezzo, Canzoniere. I sonetti d'amore del codice
Laurenziano, Torino, Einaudi, 1994
Tartaro, A., "Guittone e i rimatori siculo-toscani", en AA.VV., Storia della
letteratura italiana, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, 1987, pp. 375-
452
Picone, M. (a cura di), Guittone d'Arezzo nel settimo centenario della morte,
Firenze, Cesati, 1995
González, Isabel “Caro padre mëo, de vostra laude (Guido Guinizzeli) e Figlio mio
dilettoso, in faccia laude (Guittone d’Arezzo), polemiche letterarie o sirventesi incrociati?”,
Carte Romanze. Rivista di filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento, vol 1,
Nº 1 (2013), Milán, pp. 203-215 (DOI 10.13130/2282-7447/3163).
Tema 5:
AA.VV. Il racconto, a cura di M. Picone, Bologna, Il Mulino, 1985
Il Novellino. Anónimo s. XIII. Traducción de Isabel González. Introducción y
notas de Manuel Gil Esteve), Madrid, Palas Atenea, 2010, 285 pp. (lettura
obbligatoria)
12González, Isabel., “Il prologo del Novellino: guida alla raccolta (di novelle)”,
Actas del X Congreso Nacional de Italianistas Españoles, La Filología Italiana ante el
nuevo milenio, Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 279-289
González, Isabel, « Tipologia del Novellino » , Typologie des formes narratives
brèves au Moyen Age (domaine roman) II, Crisol, Nouvelle Série, nº 4- 2000, Publication
du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro- Americaines de l'Université Paris X-
Nanterre, 2001, pp. 163-177
González, Isabel., “El uso del color en el Novellino”, Actas del VIII Congreso
Nacional de Italianistas. La narrativa, Granada, 30 septiembre-2 de octubre de 1998,
ed. Mª Dolores Valencia, Granada, 2000, pp. 257- 264
Frutos Martínez, Mª Consuelo de, “Introducción al Novelino”, in Novelino,
traduzione e note di Moisés Barcia, Cangas do Morrazo (Pontevedra), Rinoceronte
Editora, 2007, pp. 7-17
Ruggeri, R.M., Marco Polo, Il milione, Firenze, Olschki, 1986
Ponchiroli, D., Marco Polo, Il libro di Marco Polo detto Il milione nella versione
trecentesca dell’Ottimo, Torino, Einaudi, 2000
Tema 6:
González, Isabel., Dante Alighieri, Vita Nuova (nueva lectura), Centro de
Lingüística Aplicada Atenea, Madrid, 2000, 223 páginas (ISBN 84-931844-1-1). Depósito
Legal: M-10554-2001.
González, Isabel., La similitudine nella Vita Nuova, Homenaje a Françoise
Jourdan e Isolina Sánchez, Universidad de Santiago de Compostela, 1995, pp. 401-406.
González, Isabel., “Donne gentili… pure femmine” (Donne ch’avete inteletto
d’amore, Vita Nuova, XIX), Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe
á Profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Secretaría Xeral
de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades,
2009, pp. 253-262.
González, Isabel., La parodia en la literatura italiana medieval: Oncia di carne, libra di
malizia /v/ Ne li occhi porta la mia donna amore, Coloquio Internacional “Parodia e debate
metaliterarios na Idade Media”, Santiago de Compostela, 7-8 de noviembre de 2012 (Santiago
de C., 7 de noviembre de 2012).
González, Isabel., "La Vita Nuova ejemplo de prosimetrum medieval",
Tipología de las formas narrativas breves románicas medievales, eds. Juan Paredes y
Paloma Gracia, Universidad de Granada, 1998, pp. 55-82
González, Isabel., "Doble sentido de algunas composiciones de la Vita Nuova",
Actas del VI Congreso de Italianistas, Universidad Complutense de Madrid, 1994, v. I,
pp. 297-305
González, Isabel., “Donne gentili… pure femmine” (Donne ch’avete inteletto
d’amore, Vita Nuova, XIX)”, Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe
13á Profesora Giulia Lanciani, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia. Secretaría Xeral
de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades,
2009, pp. 253-262.
González, Isabel., "Il lessico emotivo nella prosa della Vita Nuova" en Cantares
de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, edición de Esther Corral, Elvira
Fidalgo Francisco, Pilar Lorenzo Gradín, Santiago de Compostela, Servizo de
Publicacións e Intercambio Científico, 1916, pp. 457-466.
Gorni, G., "Vita Nuova di D. A.", Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Le
Opere. I. Dalle origini al Cinquecento, Einaudi, Torino, 1992, pp. 153-186
Gorni, G., "Per il testo della Vita Nuova, Studi di filologia italiana, 51 (1993),
pp. 5-38
Gorni, G., "Paragrafi e titolo della Vita Nuova, Studi di filologia italiana, 53
(1995), pp. 203-222
Malato, E., "Le Rime della giovinezza e la Vita nuova", Storia della Letteratura
Italiana, Salerno editrice, Roma, 1995, v. I. Dalle origini a Dante, pp. 807-833
Malato, E., Lo fedele consiglio de la ragione. Studi e ricerche di letteratura
italiana, Studi e Saggi, Salerno editrice, Roma, 1997
Malato, E., Dante e Guido Cavalcanti. Il disidio per la Vita Nuova e il
"disdegno" di Guido, Salerno editrice, Roma, 1997
M. Peri, Malato d'amore. La medicina dei poeti e la poesia dei medici,
Rubbettino, Catanzaro, 1996
7. METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le lezioni, che si svolgeranno in lingua italiana, prevedono l'inquadramento
storico delle principali correnti, degli autori e delle opere della letteratura italiana del
Duecento, lo studio della poetica dei principali autori del s. XIII e la lettura, il
commento e l'analisi dei testi più significativi.
7.1. Le lezioni teoriche svolgeranno i seguenti argomenti:
Definizione del periodo: Sussidi e inquadramenti storici. Poetica e ideolgia
dell’autore: profilo e cronogia essenziale. Impostazione dell’opera: disegno generale,
antecedenti, le fonti principali e la cultura. La composizione e la struttura. Stile, temi e
argomenti. Pubblicazione, diffusione e divulgazione del testo. Eco e fortuna critica.
Bibliografia essenziale.
7.2. Le lezioni pratiche sviluperanno un approccio all’analisi testuale, saranno
“grosso modo” uno studio approfondito dei seguenti temi (senza dimenticarci però,
della specificità di ogni testo letterario): Premessa e breve sommario. Lettura attenta
del testo. La trama e la struttura. I contenuti. Le forme. I personaggi: la distanza, le
parole e i pensieri. La dimensione del tempo e dello spazio. Commento linguistico e
stilistico. Il problema del punto di vista e prospettive. L’autore e il lettore.
7.3. Qualche esempio :
14Studio di tre componimenti stilnovistici: Io vogli’ del ver la mia donna laudare
(Guido Guinizzelli), Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira (Guido Cavalcanti) e Amore
e ‘l cor gentil sono una cosa (Dante)
Breve sommario dei tre sonetti: argomento. La loro importanza dentro del
dolce stile. Caratteristiche fondamentali: i caratteri distintivi della nuova poetica. Linee
essenziali: identificazione tra amore e cor gentile, gentilezza e nobiltà /v/ nascita, il
concetto di donna-angelo. La ‘dolcezza’ dei componimenti. Lingua. Stile. Metrica (il
sonetto /v/ la canzone). Paragone riassuntivo e conclusioni finali.
8. VALUTAZIONE
Per accertare la maturità del candidato ed il possesso della conoscenza della
materia nella quale sarà esaminato, si realizzerà un esame scritto (10 punti). L'esame si
svolgerà in lingua italiana.
I criteri di valutazione saranno uguali sia nella prima che nella seconda
opportunità.
15Puoi anche leggere