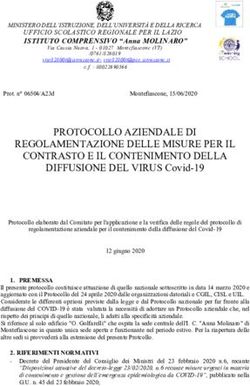Progettazione e Modelli della Qualità della Vita - 24.09.2021 Seconda Lezione
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA “NUOVA” NORMATIVA ● Decreto 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità «decreto inclusione» ● Decreto 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” ● Nota n. 40 del 13 gennaio 2021 [sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio] Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida Adozione del modello nazionale di piano
Decreto 66 del 2017
Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità
«decreto inclusione»Cosa cambia rispetto al passato?...
1. SCUOLA INCLUSIVA (art. 1, comma 1):
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde
ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore
qualità di vita;
b) la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri
soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
- Attenzione ai loro diversi
bisogni educativi speciali
- diritto
all’autodeterminazione
(Del Bianco, 2019)
- migliorare la Qualità
della Vita (Giaconi,
2015; 2020)
- realizzazione di Progetti
di Vita in rete2. PEI parte integrante del PROGETTO INDIVIDUALE (art. 2, comma 2)
LEGGE QUADRO
SERVIZI SOCIALI
n.328/2000
PROGETTO INDIVIDUALE
PROGETTO
EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO3. Nuovo processo di elaborazione del PEI e delle sue componenti.
PRIMA:
redatto sulla base della Diagnosi Funzionale e del
Profilo dinamico-funzionale
“il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali
ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute”
ORA:
redatto sul Profilo di funzionamento (D. Lgs. 66/17, art. 5, commi 3 e 4, e art. 7, comm
«i criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), »4. Vengono istituiti:
- Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica
- il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR);
- i Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
- Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);
- Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)
LIVELLI DI INCLUSIONE: dalle
politiche alle pratiche
Osservatorio
MIUR Livello nazionale
POLITICHE ISTITUZIONALI
permanente
POLITICHE
USR Livello Regionale GLIR GIT
SCOLASTICHE
PRATICHE
Livello
SCUOLA GLI GLO
localeAZIONI STRATEGICHE A LIVELLO DI AZIONI STRATEGICHE A LIVELLO SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA TERRITORIALE PAI = Piano Annuale per l’Inclusività CTI = Centri Territoriali per l’Inclusione GLI = Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (sostituisce il GLHI art. 9, D.Lsg 66/2017) GLO = Gruppo di Lavoro Operativo CTS = Centro Territoriale di Supporto (sostituisce il GLHO) compito di redigere il PEI e indicare una proposta di quantificazione delle ore di sostegno Azioni di monitoraggio e valutazione del SCUOLA POLO per l’INCLUSIONE grado di inclusività della scuola
5. PIANO PER L’INCLUSIONE: documento programmatico-attuativo
della scuola in materia di inclusione
P(a)I
Piano per l’Inclusione (parte del PTOF):
lettura del grado di inclusività della scuola
•
obiettivi di miglioramento
•
ipotesi globale di utilizzo funzionale delle
•
risorse specificheDecreto 96 del 2019
Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità
È in vigore dal 12 settembre 2019Decreto 96 del 2019: luci e ombre Estensione dell’adozione dei criteri 1. dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità (certificazione)
Decreto 96 del 2019: luci e ombre
2. Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente
come “facente parte del progetto individuale”.
Sostegni
nucleo
familiare
PROGETTO
INDIVIDUALE
- AZIONE DI RETE:
VERSO UN SISTEMA
PIU’ INTEGRATO
DEI SERVIZIDecreto 96 del 2019: luci e ombre
2 a. Precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti
per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del
D.Lgs 66/2017, c. 3).
Commissione per redazione del Profilo di Funzionamento da parte di:
3o4
GENITORI DIRIGENTE
PROFESSIONISTI
MASSIMA SCOLASTICO/DOCE
(Neuropsichiatra/
PARTECIPAZIONE NTE DI SOSTEGNO
terapisti della
DELL’ALUNNO
riabilitazione/assiste
nte sociale)Decreto 96 del 2019: luci e ombre
3. Precisazioni funzioni GLO e struttura del PEI:
D.Lgs 96/2019
«Gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione»
D.Lgs 96/2019
Nel PEI vanno esplicitate:
D. Lgs 66/2017 modalità di sostegno didattico;
-
Il PEI tiene conto di: numero di ore di sostegno;
integrato con
-
condizione di disabilità in età
- modalità di verifica;
-
evolutiva [legge 104/1992]; criteri di valutazione;
-
Profilo di funzionamento (facilitatori
-
interventi di inclusione;
-
e barriere) secondo la prospettiva valutazione e programmazione
-
bio-psico-sociale (ICF, OMS, 2001) individualizzata;
interventi di assistenza igienica e di base;
-
risorse professionali per l'assistenza,
-
l'autonomia e la comunicazione.Decreto 66/2017 e Decreto 96/2019
SINTESI DELLE NOVITA’ INTRODOTTE:
PEI come parte
Profilo di Osservatorio permanente, integrante del
funzionamento il Gruppo di lavoro
interistituzionale regionale Progetto di Vita
(GLIR);
i Gruppi per l’inclusione
territoriale (GIT);
Autodeterminazione e MODELLO
Gruppo di lavoro per
‘accomodamento NAZIONALE PEI
ragionevole’, nella l’inclusione (GLI);
prospettiva della migliore Gruppo di Lavoro Operativo
Qualità di Vita (GLO)IL BILANCIO SCIENTIFICO
► ICF COME BASE RICONOSCIUTA PER IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
► COMPARE L’ASPETTO LONGITUDINALE: PENSARE ALL’ALUNNO CON
DISABILITà NEL CORSO DELLA VITA (Giaconi, 2015,2020)
► COMPARE L’AUTODETERMINAZIONE NEI PROGETTI EDUCATIVI E
DIDATTICI
► SI VALORIZZA IL GLO (chi conosce il ragazzo)
► COMPARE LA SOSTENIBILITA’: progetti e percorsi didattici
sostenibili
► VALUTAZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DI UN ISTITUTO
PUNTI CRITICI
► Formazione dell’insegnante specializzato
► Passare dalle Teorie/Leggi alle Pratiche
► Didattica Inclusiva SostenibileNota n. 40 del 13 gennaio
2021
Adozione del modello nazionale di piano educativo
individualizzato e delle correlate linee guida
Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio.Cosa individua il decreto:
MODELLO
NAZIONALE
Vestibulum congue
DI PEI
MODALITA’ DI
LINEE GUIDA ASSEGNAZIONE
Vestibulum congue Vestibulum congue
DELLE MISURE
DI SOSTEGNOMODELLO NAZIONALE DI PEI
1. Prevede una sezione dedicata al raccordo
tra PROFILO DI FUNZIONAMENTO e PEI
2. Prevede una sezione dedicata al raccordo
Formulazione tra PEI e PROGETTO INDIVIDUALE
3. Prevede una sezione di osservazione e
del nuovo Pei progettazione secondo il linguaggio ICF
4. Prevede una sezione dedicata al progetto
di inclusione e utilizzo delle risorseMODELLO NAZIONALE DI PEI
1. PROFILO DI
FUNZIONAMENTO e PEI
I GLO devono prendere visione del PROFILO DI
FUNZIONAMENTO e fornire una SINTESI.
Evidenziare le informazioni relative alle dimensioni che
necessitano di progettazione e di interventi specifici.MODELLO NAZIONALE DI PEI 1. PROFILO DI FUNZIONAMENTO e PEI
MODELLO NAZIONALE DI PEI
2. PEI E PROGETTO
INDIVIDUALE
Nel PEI dovranno essere esplicitate indicazioni
relative al raccordo tra il PEI e il Progetto
Individuale
al fine di garantire
“lo sviluppo della persona e la sua piena
partecipazione alla vita sociale”MODELLO NAZIONALE DI PEI 2. PEI E PROGETTO INDIVIDUALE
MODELLO NAZIONALE DI PEI
QUALITA’ DELLA VITA
Progetto
IndividualeMODELLO NAZIONALE DI PEI
3. OSSERVAZIONE E
PROGETTAZIONE SECONDO IL
LINGUAGGIO ICF
OSSERVAZIONE PROGETTAZIONE
SISTEMATICA CHE TENGA AMBIENTE DI
CONDOTTA SU CONTO DI APPRENDIMENTO
FACILITATORI E FACILITATORI E INCLUSIVO
BARRIERE BARRIEREMODELLO NAZIONALE DI PEI 4. PROGETTO DI INCLUSIONE E’ un prospetto riepilogativo, ovvero una sezione specifica del PEI che è volta ad organizzare le strategie per l’inclusione e la definizione e l’utilizzo delle risorse;
MODELLO NAZIONALE DI PEI 4. PROGETTO DI INCLUSIONE
Il nuovo linguaggio International
Classification of Functioning (OMS,
2001 2007
2001;2007)
https://www.youtube.com/watch?v=w8
kWVxES0SA C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del BiancoLa prospettiva bio-psico-sociale
► PERSONA e le dimensioni del FUNZIONAMENTO
UMANO:
Fisico, psicologico e sociale
SEMPRE
►Negli AMBIENTI DI VITA
C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del BiancoIL MODELLO DI
FUNZIONAMENTO SECONDO
L’ICF
Condizioni di salute
(disturbo/malattia/dotazione
biologica)
Funzioni e strutture Attività Partecipazione
corporee (limitazione) (restrizione)
(menomazione)
Fattori Ambientali Fattori Personali
Politiche; servizi;
tecnologie, ecc.
C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del BiancoESERCITAZIONE
Condizioni di salute
(disturbo/malattia/dotazione biologica)
OGNI VOLTA
CHE NOI
AGIAMO
ADOTTIAMO
UNA LINEA
Funzioni e strutture Attività Partecipazione INTERPRETATIV
corporee (limitazione) (restrizione) A
(menomazione)
Fattori Ambientali Fattori Personali
Politiche; servizi; tecnologie,
ecc.
C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del BiancoCASO 1
► Antonio è un bambino con disabilità motoria, che frequenta la terza elementare.
Antonio riesce a spostarsi solo se spinto da un operatore o da un’altra persona.
Antonio non socializza spesso, soprattutto durante la pausa merenda e nei momenti
ricreativi non partecipa ai giochi che gli altri bambini fanno.
Quali sono le letture che possono essere fatte di questa performance così
descritta?
C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del BiancoCASO 2
► Matteo vive da poco in una struttura residenziale. Fino ad un anno
fa frequentava un centro diurno per persone con disabilità
complessa. Matteo poteva scegliere di partecipare alle attività che
si svolgevano nel centro diurno insieme agli altri, di stendersi sul
suo divano (appositamente inserito nella struttura su suggerimento
dei genitori di Matteo) o di andare nella stanza sensoriale. Matteo,
era abituato ad andare via per ultimo dal centro e a rimanere da
solo con l’operatore dalle 17.00 alle 19.00.
► Matteo, nel corso del tempo, ha cambiato carrozzina. Ora non
riesce più a spostarsi in autonomia e deve essere sempre
affiancato da un operatore per gli spostamenti.
► Nella nuova struttura residenziale, per persone con disabilità
motoria, Matteo viene portato dagli operatori nei laboratori
pomeridiani dove è a contatto con altri dieci ragazzi e due
educatrici, dalle 15.30 alle 19.30.
► Matteo nella nuova struttura ha spesso delle crisi molto intense che
arrivano a comportamenti di autolesionismo.
C. Giaconi – I. D’ Angelo- N. Del Bianco
Quale motivazione attribuiresti alle crisi?CASO 3
► Giovanni è un ragazzo con iperattività che frequenta l’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado. Riesce ancora con difficoltà a controllare il suo
comportamento. Un giorno ritorna a casa con una sospensione perché ha tirato
un pugno ad un suo compagno nel corridoio.
► La mamma di Giovanni, appena viene a conoscenza dell’accaduto dà uno
schiaffo a Giovanni e gli urla contro che è un ragazzo impossibile.
Quale è l’interpretazione che dà la mamma al comportamento di
Giovanni? A quali fattori/componenti attribuisce la causa del
comportamento?
► Giovanni, invece, si sfoga con la sorella e le dice tra le lacrime: «mamma non
capisce che è più forte di me!»
Qual è la motivazione che invece Giovanni si dà del suo comportamento?
Quali sono le cause che gli attribuisce?
► Quali altri componenti possono aver determinato il comportamento di
Giovanni?Codifica delle componenti del
funzionamento
Condizioni di salute
B Funzioni corporee Attività E Partecipazione
S Strutture corporee D
Fattori Ambientali Fattori Personali
EB. FUNZIONI CORPOREE
S. STRUTTURE CORPOREE
D. ATTIVITA’ PARTECIPATIVE Componente
d 1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE Capitolo
d 110 - d 129 ESPERIENZE SENSORIALI INTENZIONALI
- d 110 GUARDARE Dominio
- d 115 ASCOLTARE
- d 120 ALTRE PERCEZIONI SENSORIALI INTENZIONALI
- d 129 ESPERIENZE SENSORIALI INTENZIONALI, ALTRO SPECIFICATO E NON SPECIFICATOSCHEDA PER ESERCITAZIONE
Esercitazione Il caso di Luca (transizione tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) Diagnosi codificata ICD-10: - f70 RITARDO MENTALE LIEVE - f90.0 DISTURBO DELLE ATTIVITA’ E DELL’ATTENZIONE - f.93.9 DISTURBO EMOZIONALE DELL’INFANZIA - f98.5 BALBUZIE
TRADUZIONE IN CODICI ICF
1- Luca è nel periodo della 1- D8 AREE DI VITA PRINCIPALI
transizione tra scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado
2- B1 FUNZIONI MENTALI
2- Luca ha un lieve deficit
intellettivo,
3- D2 COMPITI E RICHIESTE
3- caratterizzato da difficoltà nel
GENERALI
mantenere l’attenzione sia su
compiti semplici e ancor più su
compiti articolati, dove ha
maggiori difficoltà,
4- per le quali riceve aiuto 4- E3 FATTORI AMBIENTALI
dall’insegnante di sostegnoTRADUZIONE IN CODICI ICF 5 - La difficoltà cognitiva e le 5 - B1 FUNZIONI MENTALI sue fragilità emotive 6 - rendono difficoltosa la 6 - D2 COMPITI E RICHIESTE capacità di risolvere GENERALI autonomamente i problemi di vita quotidiana, 7 - fa fatica a gestire e portare a termine le incombenze quotidiane, 7 - D2 COMPITI E RICHIESTE come prepararsi per andare a GENERALI / d6 scuola, riordinare la sua camera, ecc.
TRADUZIONE IN CODICI ICF 8 - parla con grande difficoltà e 8 - D3 COMUNICAZIONE ha moderate difficoltà nella comprensione del linguaggio. 9 - L’aiuto di un’altra persona lo 9 - E3 FATTORE AMBIENTALE aiuta sia nell’espressione che nella comprensione, ma solo in modo limitato 10 - Non ha nessun problema nel 10 - D4 MOBILITA’ movimento 11 - ed è completamente 11 - D5 CURA DELLA PROPRIA autonomo nella cura della PERSONA persona
TRADUZIONE IN CODICI ICF 12 - Durante il percorso 12 - D1 APPRENDIMENTO E scolastico ha fatto solo piccoli APPLICAZIONE CONOSCENZE; miglioramenti E1 FATTORE AMBIENTALE nell’apprendimento della lettura, che avviene attraverso strumenti compensativi 13 - ha ancora difficoltà a 13 - D1 APPRENDIMENTO E scrivere e far di conto APPLICAZIONE CONOSCENZE 14 - in questa attività l’utilizzo 14 - E1 FATTORE AMBIENTALE del pc e di programmi per la didattica determina un parziale miglioramento
Esercitazione M. è un ragazzo di 13 anni frequentante l’ultimo anno della scuola media. La diagnosi di ingresso di M. è di Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, con funzionamento intellettivo borderline, difficoltà di apprendimento e difficoltà emotive relazionali caratterizzate da inibizione. M. presenta difficoltà a mantenere l’attenzione su compiti di natura visiva. Nell’esecuzione dei compiti, riesce ad avviare il compito ma raramente lo porta a termine. Tuttavia, quando l’insegnante di sostegno è presente grazie al richiamo con contatto visivo ritorna sul compito e prosegue l’attività. M. presenta difficoltà anche nella comprensione tramite ascolto, che tuttavia è migliore su lettura autonoma del testo. La competenza ortografica e le abilità numeriche e del calcolo sono molto deficitarie, tuttavia su sollecitazione dell’insegnante all’autocorrezione individua e corregge parte degli errori.
Esercitazione M. tende ad evitare l’interazione verbale, ed è inibito nell’entrare in relazione con gli altri in particolar modo con i pari. Tende ad intraprendere di rado la conversazione e a rispondere alle domande solo in modo telegrafico. Se però sono gli altri ad iniziare la conversazione con lui, si sente più sereno e procede in modo più sicuro. La produzione verbale è caratterizzata da lievi accenti di disfluenza, ed è carente rispetto alla struttura morfosintattica della frase. Quando viene chiesto a M. di esporre un argomento in classe, presenta evidenti stati di ansia che non gli permettono di avere una sicurezza espositiva. Se, invece, lo studente viene interrogato in disparte, lontano dalla classe e in un contesto protetto, ha una prestazione sufficiente e mostra di avere anche una fluenza espositiva migliore.
Puoi anche leggere