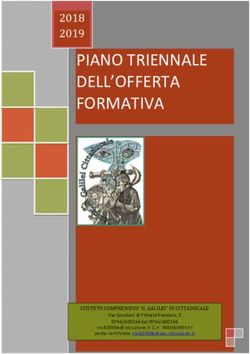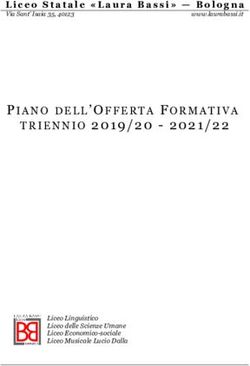LO IUS SOLI A SCUOLA - IRES Veneto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LO IUS SOLI A SCUOLA
Dirigenti e docenti raccontano le “seconde generazioni”
Francesco Cerchiaro
Paper Ires n°77 – marzo 2014
30174 Mestre Venezia Via Peschiera, 5 - Tel. 0415497820-1-2-3 Fax 0415497824 P.IVA 02309080279
http://www.iresveneto.it e-mail: ires@veneto.cgil.it IRES VENETO PAPER N. 77
LO IUS SOLI A SCUOLA
Dirigenti e docenti raccontano le «seconde generazioni»
Francesco Cerchiaro 1
Marzo 2014
1
Dottore di ricerca in Scienze Sociali. Collabora con il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FiSPPA) dell’Università degli Studi
di Padova.
1
IRES VENETO PAPER N. 77
Ringraziamenti
L’Autore ringrazia Salvatore Mazza e Alfiero Boschiero per il confronto in
fase di progettazione della ricerca e scrittura del paper.
Si ringraziano sentitamente i partecipanti alla ricerca, dirigenti e docenti, le
cui testimonianze sono il risultato vivo di questo contributo.
2
IRES VENETO PAPER N. 77
SOMMARIO
INTRODUZIONE 5
Capitolo 1 Lo Ius soli a scuola 8
1.1. Una nuova generazione di «cittadini senza cittadinanza» 8
1.2. Perché la scuola del primo ciclo? 9
Capitolo 2 Contesto demografico e strumenti metodologici della ricerca 11
2.1. La presenza di studenti figli di immigrati in Italia e in Veneto 11
2.2. Strumenti metodologici e campo d’indagine 12
2.2.1. Le interviste in profondità ai dirigenti scolastici 13
2.2.2. I focus group con i docenti 14
Capitolo 3 Ius soli e cittadinanza: la prospettiva della scuola 16
3.1. La scuola come luogo di inclusione e cittadinanza attiva 16
Capitolo 4 Quali criticità? 20
4.1. Dietro lo studente: famiglie migranti e traiettorie biografiche 21
4.2. Dentro la scuola: gli ostacoli tra accoglienza ed inclusione 25
4.2.1. Processi identitari e confronto con il «gruppo dei pari» 25
4.2.2. Alfabetizzazione e risorse 27
Capitolo 5 Autorappresentazioni della e sulla scuola 32
5.1. Dissonanze tra principi e pratiche 32
5.2. Tensioni e sensibilità differenti all’interno del corpo docente 34
5.2.1. Il «toto straniero» e lo «scarica barile» 34
5.2.2. Regola o eccezione? 36
5.3. Primaria e secondaria di primo grado: quali differenze? 38
Capitolo 6 Indicazioni emerse dalle buone pratiche scolastiche 42
6.1. Nuovi modi di «fare rete» 43
6.1.1.Una sensibilità di genere: perché è importante coinvolgere le madri? 44
6.1.2. Insegnanti creativi 46
CONCLUSIONI 48
BIBLIOGRAFIA 51
ALLEGATI 54
3
IRES VENETO PAPER N. 77
4
IRES VENETO PAPER N. 77
Introduzione
Il recente dibattito sullo ius soli ha al centro i minori figli di
immigrati, le cosiddette «seconde generazioni», ragazzi e ragazze che,
dall’inserimento scolastico alle reti affettive, vivono l’intero processo
di socializzazione in un Paese che non li riconosce come cittadini.
Quello dei meccanismi che regolano l’accesso alla cittadinanza è tema
dalle ricadute ampie e complesse che si situa su più ambiti
disciplinari. La presenza di un numero sempre maggiore di «cittadini
senza cittadinanza» nel sistema scolastico italiano impone oggi una
riflessione profonda che riguarda quel patto tra Stato e cittadini su cui
si è sviluppata la moderna concezione di cittadinanza
(Colombo&Domaneschi&Marchetti 2009). La scuola, di questi
processi, è uno degli attori in prima linea, chiamata al contempo non
solo a gestire il cambiamento sociale ma anche a tracciarne la rotta.
L’idea che ha ispirato il progetto di ricerca si fonda sulla convinzione
che la scuola sia non solo agente di socializzazione primario per
guardare la società di domani ma, ancor più oggi, luogo fisico e
simbolico che «fa» la cittadinanza: dal favorire l’integrazione al farsi
promotrice della mobilità sociale di questi giovani. Proprio per questo
essa è investita di una responsabilità storica senza precedenti. Il
presente rapporto è frutto di una ricerca sul campo condotta in Veneto,
che, con 91.867 studenti su un totale di 717.710 (MIUR 2013), è la
seconda regione dopo la Lombardia in quanto a presenze di alunni
figli di immigrati 2. In particolare l’indagine ha riguardato la scuola del
primo ciclo, raggiungendo primarie e secondarie di primo grado, dove
i figli di immigrati sono circa il 14%. L’ipotesi è che proprio nella
scuola del primo ciclo si strutturino processi di inclusione ed
esclusione fondamentali per comprendere criticità e peculiarità di
questa eterogenea generazione di ragazzi. Cinque Istituti scolastici
dislocati in altrettante significative realtà di provincia (Padova,
Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) sono stati coinvolti nella ricerca.
Cinque casi di studio che ci hanno permesso di raccogliere le
rappresentazioni di dirigenti e docenti attraverso interviste in
profondità e focus group che restituiscono la complessità ed
eterogeneità dell’esperienza scolastica, mettendo al centro la parola
2
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono quindi il 12,8% del totale, con
media nazionale che si situa attorno all’8,8%.
5
IRES VENETO PAPER N. 77
come veicolo di significati. Le narrazioni portano alla luce le
rappresentazioni scolastiche sulle seconde generazioni nella loro veste
dinamica: ambivalenze e peculiarità dei processi scolastici di
inclusione, conflitti, tensioni ed eterogeneità all’interno del corpo
docente, buone pratiche e opportunità nel cambiamento. Posta come
un’incudine tra famiglia e società, la scuola appare innanzitutto come
luogo di pratiche, ben distinto dal piano giuridico che divide cittadini
italiani e non. Essa compie di continuo «atti di cittadinanza», pratiche
tese all’inclusione degli studenti come cittadini. «Di che cittadinanza
parliamo?» è stato dunque il nostro interrogativo di fondo per capire la
prospettiva della scuola in questa precisa fase storica. Da qui uno
studio che si è dipanato attraversando i temi emersi dalle narrazioni di
dirigenti e docenti. Il nostro indice traccia così analiticamente una
mappa della nuova geografia scolastica letta attraverso il fenomeno
dei figli degli immigrati. Troviamo, da un lato, la narrazione di
criticità proprie dei percorsi biografici e familiari che caratterizzano il
vissuto del singolo studente e, dall’altro, ciò che egli incontra invece
dentro la scuola e che riguarda i processi scolastici di cui i dirigenti e
docenti sono artefici e testimoni diretti. Su quest’ultimo aspetto
emerge rilevante la narrazione delle difficoltà che lo sforzo per
l’alfabetizzazione incontra a causa del calo di risorse per
implementarla. L’analisi si sofferma quindi sugli effetti della
complessità scolastica sul corpo docente. Il capitolo «Auto
rappresentazioni della e sulla scuola» è parentesi riflessiva dei
docenti sulle pratiche scolastiche inerenti la relazione con gli alunni
figli di immigrati. Questa parte rende conto dello sforzo che sta
facendo la scuola in termini di energie e risorse umane per far fronte a
classi sempre più complesse, con la linea guida di individualizzare la
proposta formativa alle esigenze del singolo alunno. Emergono così
anche narrazioni di conflitti e tensioni interne al corpo docente.
L’alunno figlio di immigrati può diventare così un «peso» che si tende
a delegare;; le espressioni emblematiche di «toto straniero» e «scarica
barile» individuano e decostruiscono queste dinamiche tra docenti.
L’analisi prosegue approfondendo alcune differenze fondamentali
emerse dalle narrazioni riguardanti la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado cercando di individuare le specificità del
cambiamento che riguarda gli studenti nel loro percorso scolastico. Lo
studio si chiude provando a tirare le somme delle principali linee
rintracciate nelle buone pratiche scolastiche, alcune realtà estese e
strutturate nella scuola, altre legate all’inventiva e generosità del
singolo docente. Emerge soprattutto la necessità di posizionare la
6
IRES VENETO PAPER N. 77
scuola come uno, ma non l’unico, vettore di integrazione. Si apre un
discorso ampio sull’importanza di azioni sinergiche che sappiano
«fare rete» con il territorio e con una molteplicità di attori. Sono
messe in evidenza alcune iniziative non convenzionali che tracciano
nuovi modi di fare inclusione. Sono percorsi che mettono al centro la
famiglia immigrata, cercando di farla diventare parte attiva dei
processi scolastici, attraverso percorsi di alfabetizzazione e
partecipazione che mirano ad una maggior attenzione alla realtà
familiare dietro lo studente. Da qui l’importanza di sensibilità e
politiche di genere che migliorino l’interazione con le madri di questi
ragazzi, chiamate, soprattutto nella scuola del primo ciclo, ad un ruolo
fondamentale di supporto allo studio. Ne emerge una scuola per certi
versi «più debole e fragile» di fronte alla complessità, ma anche
generosa e ricca di risorse e professionalità preziose per farvi fronte in
modo efficace. Una scuola che continua, malgrado le difficoltà, ad
essere luogo di cittadinanza attiva. Sono frammenti di un puzzle
complesso da ricostruire, un «sapere pratico» che la scuola ha fatto
proprio e che merita di essere valorizzato e «fatto metodo», da
sistematizzare e, dunque, riprodurre e diffondere.
7
IRES VENETO PAPER N. 77
Capitolo 1
Lo Ius soli a scuola
1.1. Una nuova generazione di «cittadini senza cittadinanza»
La presenza di un numero sempre maggiore di «cittadini senza
cittadinanza», sostiene Colombo (2013), tende ad indebolire il potere
e la legittimità dello Stato stesso, imponendo un ripensamento del
patto di cittadinanza attraverso cui si costruisce una rete che mira ad
assicurare solidarietà ed eguaglianza a chi ne fa parte, escludendo di
fatto da tale comunità il «non» cittadino.
Oggi che si avvicinano al milione, i figli di immigrati in Italia,
offrono una prospettiva nuova per leggere la contemporaneità e
rileggere paradigmi interpretativi e trasformazioni inerenti la
cittadinanza (Colombo&Domaneschi&Marchetti 2009). Definire le
seconde generazioni 3 è di per sé opera controversa, oggetto spesso di
confuse analisi proprio perché «confluiscono in questa categoria
concettuale casi assai diversi che spaziano dai bambini nati e cresciuti
nella società ricevente, agli adolescenti ricongiunti dopo aver
compiuto un ampio processo di socializzazione nel Paese d’origine»
(Ambrosini&Molina 2004: 5). Il recente dibattito sullo ius soli ha al
centro i giovani figli di immigrati, questa generazione di ragazzi e
ragazze socializzati nel nostro Paese da genitori di un’origine
nazionale differente. Essi studiano e parlano la nostra lingua, si
inseriscono nelle reti del nostro Paese in maniera attiva, dalle reti
istituzionali a quelle economiche, a quelle più prettamente relazionali.
In Italia queste ragazze e questi ragazzi non sono però riconosciuti
come cittadini italiani fino a che, al compimento del diciottesimo anno
di età, attraverso un complesso iter burocratico 4, possono accedere ai
3
Dentro l’etichetta «seconde generazioni» confluiscono una molteplicità di casi
assai differenti a testimonianza della complessità di una definizione del fenomeno
(Ambrosini&Molina 2004). Rumbaut (1997) ha infatti colto questa complessità
introducendo il concetto di «generazione 1.5» e poi quelli di generazione 1.25 e
1.75. La generazione 1.5 è quella che ha iniziato il processo di socializzazione e la
scuola primaria nel Paese d’origine e ha completato l’educazione scolastica
all’estero;; la generazione 1,25 è quella che è emigrata tra i 13 e i 17 anni;; la
generazione 1,75 quella che si è trasferita all’estero nell’età prescolare, dai 0-5 anni.
4
Chi nasce in Italia da genitori stranieri può diventare italiano per
“naturalizzazione”, ma al compimento del 18° anno ha un anno di tempo per
chiedere la cittadinanza. Tale passaggio implica innanzitutto l’esser in grado di
8
IRES VENETO PAPER N. 77
diritti e doveri legati all’ottenimento della cittadinanza
(Colombo&Domaneschi&Marchetti 2009). Tale aspetto influenza
dall’alto il loro percorso di crescita e, oltre ad avere ricadute sociali
ampie e complesse, investe direttamente i processi di costruzione della
loro identità (Colombo&Rebughini 2009;; Ambrosini 2001).
L’idea che ha ispirato il progetto di ricerca si fonda sulla
convinzione che la scuola sia non solo, da sempre, agente di
socializzazione primario per guardare la società di domani ma, ancor
di più oggi, luogo fisico e simbolico che dà contenuto alla cittadinanza
formando gli italiani di domani. La presenza nella scuola dei giovani
figli della migrazione diviene sempre più oggetto di analisi soprattutto
da parte della sociologia e della psicologia sociale (Tieghi&Ognissanti
2009;; Casacchia et al. 2008;; Bastianoni 2001;; Mantovani 2008;;
Ambrosini&Molina 2004), proprio perché «la crescita dei figli di
immigrati mette alla prova i dispositivi delle società riceventi, ancora
legati a una presunta omogeneità e coesione “naturale” delle società
nazionali» (Ambrosini 2009: 50). Anche il diritto si interroga oggi su
come formulare una legge basata sullo ius soli che tenga conto della
formazione scolastica avvenuta in territorio italiano 5. La scuola si
vede così sempre più investita, nel discorso pubblico, non solo della
funzione di integrazione strettamente intesa, ma anche della
promozione della mobilità sociale di questi giovani.
Dirigenti scolastici e docenti, raccontando la loro esperienza diretta
con questa «generazione senza cittadinanza», ci restituiscono una
fotografia dal basso di una scuola in prima linea nell’affrontare una
società sempre più plurale, aiutandoci anche ad interpretare, da una
prospettiva privilegiata, il discorso pubblico che oggi ruota attorno
allo ius soli.
1.2. Perché la scuola del primo ciclo?
La scuola, come agente di socializzazione primaria insieme alla
famiglia, è stata chiamata da subito a confrontarsi con il fenomeno
dell’immigrazione e, dunque, ad accogliere nel sistema scolastico i
dimostrare di aver risieduto in Italia legalmente, senza interruzioni, fino al
raggiungimento della maggiore età (Caponio 2007).
5
Per un approfondimento sugli aspetti giuridici della riforma della legge 91/1992
e le sue principali proposte di riforma Cfr., Giovannetti M., Zorzella N, (2013). La
cittadinanza alle seconde generazioni, L’economia dell’immigrazione, Fondazione
Leone Moressa, 3, 8-14.
9
IRES VENETO PAPER N. 77
figli di immigrati. Una legge sullo ius soli cambierebbe infatti lo status
giuridico di molti studenti nati in Italia o arrivati nei primi anni d’età e
inseriti nel ciclo scolastico italiano. Essi sono portatori di diversità con
la quale l’istituzione scolastica si deve misurare a più livelli: nella
gestione del rapporto con i genitori, nell’inserimento scolastico dei
figli, nel rapporto tra principi inclusivi e pratiche scolastiche per
l’integrazione. Per sua natura la scuola è stata chiamata a precedere il
diritto adottando strategie e prassi per rispondere ai cambiamenti di
una società sempre più multietnica, ben prima che il diritto stesso
iniziasse a porsi il problema di «registrare» formalmente tale
cambiamento. L’ipotesi che ci ha spinto a circoscrivere questa ricerca
alla scuola del primo ciclo, dunque, si fonda su due aspetti principali.
In prima istanza vi è un dato statistico significativo 6 che evidenzia
come sia proprio nella scuola del primo ciclo che si concentra oggi il
maggior numero di studenti non cittadini italiani. La seconda
considerazione si basa sull’ipotesi che sia dal loro primo inserimento
nella scuola che si comincino a strutturare le pratiche di inclusione ed
esclusione e si determinino quindi le condizioni per comprendere
l’evoluzione del loro futuro scolastico. Ricerche (Tieghi&Ognissanti
2009) e dati MIUR 7 testimoniano infatti come, dopo la scuola del
primo ciclo, il percorso scolastico dei minori figli di immigrati si
differenzi sostanzialmente rispetto a quello dei loro coetanei autoctoni
sia relativamente alla scelta di indirizzo nella scuola secondaria sia per
le maggiori percentuali di dispersione e abbandono scolastico. Tale
aspetto ci spinge ancor più a considerare la scuola del primo ciclo
come luogo d’elezione in cui comprendere il futuro dei figli
dell’immigrazione.
6
Cfr., Dati MIUR (2013). Vedi a tal proposito le tab.1-2 (allegati).
7
«I dati rilevati nell’anno 2012/2013 mostrano che ben il 38,2% degli alunni
stranieri (di tutti gli ordini di scuola), si trova in una situazione di ritardo scolastico,
a fronte di un ben più contenuto numero di alunni con cittadinanza italiana (11,6%).
La percentuale è più elevata all’innalzarsi della loro età. Nella scuola primaria i
bambini in ritardo rappresentano il 16,3% fra quelli con cittadinanza non italiana e il
2,0% fra quelli con cittadinanza italiana;; nella scuola secondaria di primo grado
sono l’44,1% fra gli stranieri contro il 8,0% di quelli italiani;; nella scuola secondaria
di secondo grado la percentuale di alunni stranieri in ritardo nel percorso scolastico è
molto elevata: 67,1%, contro il 23,9% degli italiani.» Cfr., MIUR – Servizio
Statistico, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano, A.S. 2012-2013,
(Ottobre 2013), p.4.
10
IRES VENETO PAPER N. 77
Capitolo 2
Contesto demografico e strumenti metodologici della ricerca
2.1. La presenza di studenti figli di immigrati in Italia e in
Veneto 8
La presenza degli alunni figli di immigrati nelle scuole italiane,
oltre che eterogenea rispetto all’origine nazionale (sono circa 200 le
nazionalità rappresentate a scuola) registra da anni una crescita
costante. Nell’anno scolastico 2012/2013 il numero degli alunni con
cittadinanza non italiana è stato pari a 786.630 unità, ovvero 30.691
unità in più rispetto all’anno scolastico 2011/2012 9. Nell’anno
scolastico 2012/13 i giovani figli di immigrati iscritti nelle scuole del
Veneto sono stati 91.867. La regione Veneto si attesta così al secondo
posto in Italia (dopo la Lombardia, con 191.526) in quanto a numero
di alunni con cittadinanza non italiana. Quasi 20.492 sono i minori
nella scuola dell’infanzia, 34.335 nella scuola primaria, 19.596 nella
secondaria di primo grado e circa 17.444 nella secondaria di secondo
grado. L’incidenza maggiore si registra quindi nei primi ordini del
sistema scolastico, con gli iscritti nella fascia prescolare che si
attestano al 14,7% che insieme alle scuole primarie si conferma
l’ordine a maggiore incidenza di studenti non italiani (14,7%). Nelle
secondarie di primo grado la percentuale è del 13,6%, valore che
scende all’8,7% nella scuola secondaria di secondo grado 10.
La distribuzione provinciale degli studenti con cittadinanza non
italiana in Veneto riflette le caratteristiche della presenza migratoria
nel territorio, più concentrata nelle province manifatturiere e nei
distretti industriali, dunque, nell’area centrale e pedemontana della
regione. Un’incidenza complessiva superiore alla media si osserva
nelle provincie di Treviso (14,2%), Vicenza (13,6%) e Verona
(13,3%), mentre il valore minimo è quello di Belluno (7,2%). Questa
presenza non varia significativamente tra i diversi ordini scolastici:
solo nella scuola per l’infanzia Vicenza si attesta al primo posto, con
ben 16 bambini stranieri ogni 100 iscritti (15 nella provincia di
8
I dati sopra riportati danno riferimento agli studenti con cittadinanza non
italiana dell’anno scolastico 2012/2013 aggiornati al 29 luglio 2013. Cfr., MIUR -
Ufficio di Statistica (ott.2013).
9
Cfr., Tab.1 – Allegati
10
Cfr., Tab.2 – Allegati
11
IRES VENETO PAPER N. 77
Treviso). La quota in assoluto più elevata si ritrova in corrispondenza
della scuola primaria, che in provincia di Treviso vede gli studenti
figli di immigrati al 16,7% (Gambuzza&Rasera 2013: 65, 68) 11.
2.2. Strumenti metodologici e campo d’indagine12
Visti gli obiettivi esplorativi dello studio ci si è serviti degli
strumenti e delle opportunità offerti dall’indagine qualitativa. Essa ha
infatti il fine di cogliere le peculiarità di processi di attribuzione di
senso, spesso complessi e controversi, integrando dati e statistiche che
danno le dimensioni di un fenomeno, ma non ne sondano in profondità
caratteristiche ed implicazioni. Avvalendosi di interviste 13 e focus
group 14 la ricerca ha perciò messo al centro la parola di dirigenti e
insegnanti della scuola del primo ciclo. Questa emerge come veicolo
che porta alla luce quel «racconto di pratiche» (Bertaux 1999)
intraprese da e nell’istituzione scolastica per affrontare le
trasformazioni in atto nella composizione delle classi.
Non era nostro obiettivo raggiungere l’intero territorio regionale,
quanto piuttosto far emergere una fotografia del fenomeno in alcune
sue realtà significative. Abbiamo, quindi, circoscritto il campo
d’indagine alle cinque province venete di Padova, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza dove, secondo i dati MIUR (2013), vi è la maggiore
concentrazione di studenti di cittadinanza non italiana. Grazie al
supporto e al contributo della rete IRES e Cgil 15 sono stati individuati
cinque Istituti scolastici comprensivi (Tab.3 - Allegati),
rispettivamente dislocati nelle cinque province sopraccitate. Qui si è
articolato un lavoro progressivo, al contempo conoscitivo e di accesso
11
I dati divisi per provincia in questo paragrafo fanno riferimento al Rapporto
2013 (Dati 30 sett. 2013), Immigrazione straniera in Veneto, a cura
dell’Osservatorio Regionale sull’immigrazione. In particolare ci siamo rifatti ai dati
presenti al capitolo 3, (a cura di) Gambuzza e Rasera: “Giovani stranieri nel sistema
scolastico regionale” pp.65-72.
12
All’interno della ricerca sono stati usati pseudonimi per garantire l’anonimato.
13
All’interno della ricca tradizione di ricerca qualitativa si veda a riguardo i
contributi allo sviluppo dell’intervista come metodo di indagine offerti da Cardano
(2011), Kaufmann (2007), La Mendola (2009), Silverman (2000).
14
A questo proposito testi utili ai fini di una trattazione pratica del focus group
sono quelli di Krueger e Casey (2000) e Frisina (2010).
15
A questo proposito fondamentale è stato il lavoro organizzativo di un dirigente
sindacale della Cgil che ha individuato e favorito i contatti con i dirigenti scolastici
dei cinque Istituti.
12
Puoi anche leggere