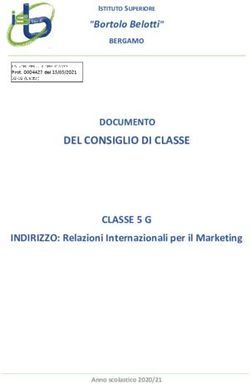Le fiabe nella pratica clinica Carla Narni Mancinelli 1. Premessa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Le fiabe nella pratica clinica Carla Narni Mancinelli 1. Premessa “C’era una volta, tanto tanto tempo fa, in una terra lontana lontana, un minuscolo regno pacifico, prospero e ricco di antiche e poetiche tradizioni. Là, in un maestoso castello, viveva un nobile signore, vedovo, con la sua bambina. Benché egli fosse un padre gentile ed affettuoso, che non faceva mai mancare nulla alla sua figlioletta adorata, tuttavia si rendeva conto che ella avrebbe avuto bisogno delle cure di una mamma. E così, si risposò, scegliendo come seconda moglie una vedova di nobile famiglia che aveva due figliole dell’età di sua figlia, Anastasia e Genoveffa…” Le prime frasi della fiaba di Cenerentola hanno per me una suggestione particolare. Riescono a proiettarmi in una dimensione diversa, facendo riaffiorare vari tipi di ricordi e di emozioni. Emozioni legate alla favola stessa, alla storia della bambina buona, bella e sfortunata che realizza poi tutti i suoi sogni per magia, con l’aiuto della fatina, una storia nella quale è così facile immedesimarsi, con la quale è così facile sognare… I ricordi più remoti, di quando, bambina, ascoltavo il racconto della fiaba, incantandomi e perdendomi nell’immaginare il ballo, il castello, la zucca che si trasforma in un magnifico cocchio, le scarpine di cristallo, il principe azzurro, mentre un’emozione intensa di attesa, di curiosità e di gioia mi riempiva il cuore, ed il ricordo recente dei volti attenti, sognanti e sereni dei miei bambini mentre la racconto loro, che combattono con il sonno per continuare ad ascoltare. La suggestione delle parole di questa fiaba riesce a superare le barriere temporali, restando identica con il passare delle
generazioni, e riesce a superare, anche, le barriere sociali e culturali. Una delle esperienze per me più forti, è quando, a sedici anni, mi trovai a fare l’animatrice in una colonia estiva per bambini con grave disagio sociale, provenienti dall’interland napoletano. E’ superfluo descrivere il loro modo di rapportarsi tra di loro e con gli adulti, e non c’è, credo, bisogno di sottolineare la situazione di carenza affettiva vissuta dai più. La prima sera che passai con loro, ricordo che li accompagnai nella camerata e mi venne l’idea di raccontargli una fiaba. I quindici bambini si fiondarono nei letti e si misero ad ascoltare. I loro volti stupiti, attenti, sognanti e sereni, il silenzio che mi regalarono nell’ascoltare la favola, il loro scivolare, dolcemente, nel sonno, io non l’ho più dimenticato. Per questo, e per altri motivi, credo che le fiabe siano uno strumento eccezionale per mettersi in comunicazione con le altre persone, uno strumento adatto anche ad essere usato per promuovere il cambiamento, nella psicoterapia come nelle attività psico-educative. E’ uno strumento, la fiaba, che io amo molto, e che nella mia personale esperienza clinica ho utilizzato tante e tante volte, sia con i bambini che con gli adulti. 2. Pratica clinica. La psicoterapia come narrazione Parlare di fiabe nella pratica clinica vuol dire aprire il discorso su cosa si intende come pratica clinica e, quindi, su come poter utilizzare le fiabe come strumento terapeutico. Per “pratica clinica” qui intendiamo sia la psicoterapia, con il suo setting individuale, di coppia, familiare, di gruppo, sia altri tipi di intervento volti a modificare delle situazioni esistenziali, quali l’intervento clinico in classe, la conduzione di gruppi di confronto con insegnanti ed alunni, la messa in atto di tecniche di cambiamento, quali il problem solving o il role playing. Ciascuna di queste possibilità presuppone, per poter essere considerata terapeutica, la costituzione, alla base, di un contesto
relazionale che giustifichi e connoti l’intervento come
terapeutico, e, soprattutto, la creazione di una relazione
terapeutica.
L’intervento clinico richiede, per essere considerato tale, un
riconoscimento da entrambe le parti che entrano in gioco,
riconoscimento che dia senso a quello che avviene in quel
contesto, definendone, quindi, i significati.
La definizione del contesto è quindi il primo elemento da
considerare affinché una serie di azioni possano essere
considerate o meno terapia.
Non sono, infatti, le azioni in sé, le tecniche, a definire il
contesto dell’intervento, ma viceversa.
Ai fini della promozione del movimento, e quindi del
cambiamento, possono essere utilizzate svariate metodiche, che
vanno dal gioco alla discussione, dall’espressione di
associazioni libere allo psicodramma, dal colloquio clinico alla
musicoterapia o alla danzaterapia.
Quello che rende terapeutiche le tecniche, utilizzabili peraltro
in mille altre situazioni, sono principalmente due aspetti:
la definizione del contesto come terapeutico
la relazione tra terapeuta e paziente.
La considerazione di questi due aspetti ci consente di stabilire,
quindi, chi è il terapeuta, e quali obiettivi può – e dovrebbe –
perseguire. Il rischio comune, per chi fa questo lavoro, è di
ergersi in cattedra, di porsi su un piedistallo, forte delle teorie
epistemologiche di cui è a conoscenza e delle spiegazioni della
psicopatologia, che somigliano tanto alla verità, ma ne
detengono in realtà solo una parte.
Ma il terapeuta non è un maestro, non è una guida, non è uno
che indica la strada.
Mi è stato insegnato a pensare al terapeuta come ad un tassista,
che guida l’auto che conduce il passeggero a destinazione.
Non è il tassista che stabilisce dove andare, né perché. Il tassista
non giudica, non si intromette con la scelta del passeggero di
andare in un tal posto, ma sceglie per lui il percorso più adatto,
e lo accompagna.Il terapeuta deve quindi “solo traghettare individui, coppie, famiglie, allievi da una sponda all’altra, mettendoci anche noi al “servizio del bambino”, rinunciando “al conforto delle verità ultime e non lasciandoci mai guidare da ciò che possiamo sapere della follia. Nessun concetto della psicopatologia dovrà, anche e soprattutto nel gioco implicito delle retrospezioni, esercitare un ruolo organizzatore. Costitutivo è il gesto che separa la follia e non la scienza che si stabilisce, dopo questa separazione, nella calma ritrovata”(Focault, 1996). Scopriremo che ogni traversata è diversa e che noi l’affrontiamo differentemente, a seconda del “carico”, della pioggia o del sole, del fondo del fiume, del traffico di barche, delle stagioni, delle soste necessarie…” (Di Cesare, 1999) La psicoterapia è una narrazione, è la costruzione di un racconto a più mani. Costituisce nel raccontare a una persona esterna dei fatti, in genere relativi alla propria vita, significativi, quindi lasciare che l’altro li ascolti, ed ascoltarsi mentre si racconta. L’altro, poi, rielabora questo racconto con parole sue, riempiendo i vuoti con dei significati, attinti dalla sua esperienza e dalla pratica acquisita nell’ascoltare storie e rielaborarle, compiendo la cosiddetta “restituzione”. La psicoterapia altro non è che un leggere la storia di una persona, di una coppia, di una famiglia, e riscriverla insieme, per giungere ad una storia uguale alla prima nei fatti, ma più ampia, allargata, nell’attribuzione dei significati. Bateson diceva che due descrizioni sono meglio di una (Bateson, 1999). La psicoterapia è questo, è la costruzione della descrizione della realtà di una persona aggiungendovi un altro punto di vista, che non ha la pretesa di essere più obiettivo, più razionale, più illuminato, ma solo di essere un altro punto di vista. Aprire porte, ampliare lo sguardo, allargare il contesto, creare collegamenti semantici, associare eventi di epoche diverse,
notare le ridondanze nei comportamenti nel tempo, le ripetizioni di modelli e di stili. Comprendere i legami, le trame, che come in un romanzo si snodano, si intrecciano, e creano altri legami, altre trame, altre storie parallele. Questo è reso possibile dal particolare legame che si crea tra terapeuta e paziente, una relazione che ha una sua specificità data dagli obiettivi condivisi, ma soprattutto da quella particolare intesa che si crea, al di là delle parole, per riprendere la metafora, tra il traghettatore ed il passeggero. Un’intesa simile all’amicizia, o all’amore, ma nella quale i sentimenti non vengono alla luce per se stessi, e per essere vissuti come nell’amicizia o nell’amore, ma per essere compresi, elaborati, attribuendoli, poi alle sedi originali. Il terapeuta si fa quindi specchio, ma non è uno specchio inerte. Piuttosto è uno specchio d’acqua, vivo, che si muove non solo grazie all’immagine che accoglie e riflette, ma anche per le sue proprie correnti, e l’immagine riflessa è colorata anche dal riflesso delle piante che crescono attorno al laghetto, dai pesci che vi nuotano, ed è più o meno limpida a seconda, anche, della purezza dell’acqua. Il terapeuta, quindi, ci mette del suo. La relazione terapeutica non è, quindi, un contenitore, ma una relazione altra, diversa, un nuovo contesto in cui si vivono e si rielaborano, insieme, situazioni, emozioni, storie. Al di là dell’illusione dell’obiettività. 3. Pratica clinica e fantasia “Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si
propagano in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso precipita smovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o microeventi, si succedono in un tempo brevissimo. Forse nemmeno ad aver tempo e voglia si potrebbero registrare tutti, senza omissioni. Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie o di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente, per accettare e respingere, collegare e censurare costruire e distruggere.” (Gianni Rodari, 1973, pag.7) Non diversamente avviene nella cosiddetta pratica clinica. Una persona racconta una storia, la sua storia, usando parole, esempi, rappresentazioni. Il terapeuta usa altre parole, per aiutarla nella ricostruzione della storia. Le parole rimbalzano nella mente, risuonano, creano echi, coinvolgono e richiamano alla mente altre parole, altri pensieri. Come e onde concentriche nello stagno, le parole dette nello spazio della terapia richiamano altre parole, altri significati. Così il movimento delle parole stesse produce altro movimento, ed eventi che sembravano lontani, diversi, distanti, vengono loro malgrado coinvolti, avvicinati, collegati. Entrando in rapporto tra loro, gli eventi della vita della persona generano interpretazioni nuove, collegamenti semantici che spesso vanno al di là delle interpunzioni fatte fino a quel momento, superando i legami di causalità semplici, di causa-effetto. Si creano quindi dei movimenti nella mente della persona, e questi movimenti generano cambiamenti, smovendo certezze,
agitando pensieri, alimentando dubbi, causando agitazione, caos. Quando poi le parole toccano corde profonde dell’anima, la smuovono. Non è possibile prevedere le reazioni a catena che verranno prodotte, le analogie e le immagini che saranno richiamate alla mente, riguardate, rielaborate, ripensate. Nel lavoro della persona che produce l’analogia, “l’asse della selezione si proietta sull’asse della combinazione: può essere un suono (una rima) a evocare un significato, un’analogia verbale a suscitare la metafora. Quando il bambino inventa una storia, succede la stessa cosa. Si tratta di un’operazione creativa che ha anche un aspetto estetico: qui ci interessa in relazione alla creatività, non all’arte.” (Gianni Rodari, 1973, p.14) La fantasia e la memoria si incontrano, stimolate dalle parole, e la visione della storia che ne emerge non è più lineare, ma circolare. La ricostruzione è più complessa, le esperienze, gli influssi esterni, le storie intrecciate vengono fuori, contribuiscono a allargare il cerchio. Non è più solo la storia di una persona, ma la sua storia in un contesto storico, culturale, sociale; la sua storia in un contesto relazionale, fatto di legami presenti e passati, di storie di rapporti semplici e complessi. Non c’è più solo la storia di un problema, il motivo che ha portato la persona in terapia. Il problema, il sintomo, acquista significato, parla, all’interno della storia della persona che lo porta, all’interno del complesso delle sue relazioni significative, le spiega. Freud diceva che il sogno è la via regia per l’inconscio (Freud, 1977), ed ha utilizzato, nella sua pratica clinica, le fantasie prodotte dai suoi pazienti per aiutarli nell’interpretazione della loro realtà. Loro realtà, non semplicemente realtà. E’ conoscenza comune, infatti, che ciascuno di noi costruisce una propria interpretazione del mondo che lo circonda, e gli dà significato partendo dai propri parametri e dalle proprie esperienze.
I bambini nascono con la capacità di interpretare, di dare significato alle esperienze che vivono, e lo svolgersi della nostra esistenza richiede lo sviluppo di questa innata capacità. Gli adulti spesso sorridono nell’ascoltare le spiegazioni dei fenomeni della vita quotidiana prodotte dai bambini. E’ divertente ascoltare le loro interpretazioni, le loro attribuzioni di significato. “I dinosauri sono estinti, cioè sono tutti morti, quindi stanno da Gesù. I dinosauri sono il terrore di Gesù” (Gabriele, 3 anni). Molto si è scritto circa l’utilità della metafora in psicoterapia. L’uso della metafora in psicoterapia permette di superare le barriere poste dalla razionalità, che con la crescita aumenta, e consente di andare oltre le censure ai pensieri più segreti e/o inaccettabili. La metafora, così come il gioco, pone una distanza tra gli eventi raccontati, rappresentati, e il giudizio su di loro, consentendo, quindi, un’espressione più libera. La fantasia è uno strumento, una risorsa, una possibilità. Così come il terapeuta, per poter essere utile, deve entrare ed uscire dalla storia del suo paziente, così il paziente può entrare ed uscire dalla sua storia, riuscendo in un certo senso a prenderne le distanze ed a guardarla da fuori. 4. Cosa sono le fiabe? Le fiabe sono racconti fantastici. Racconti più o meno brevi in cui, utilizzando il linguaggio allegorico, possono essere trasmessi dei messaggi. Sono degli spaccati della realtà, delle interpretazioni, dalle quali vengono tratte elaborazioni e conclusioni. Tradizionalmente, le favole venivano tramandate oralmente, per poi essere raccolte e trascritte. Le fiabe parlano della realtà dalla quale sono state generate, dei suoi contesti, delle sue abitudini.
La struttura del racconto è semplice, prevede un inizio, con il delinearsi del personaggio principale, il protagonista, al quale si contrappone l’antagonista; c’è quindi un evento o una serie di eventi che modificano lo status, l’azione del personaggio principale o di un altro, l’aiutante, che lo affianca, la conclusione, di solito a lieto fine ed accompagnata da una morale. In genere, il tutto è condito da un pizzico di magia. I personaggi sono di due tipi, buoni e cattivi, ed in genere non c’è sfumatura nella struttura della loro personalità. C’è la principessa, buona, bella, brava, dolce, sfortunata, che subisce pazientemente le angherie del destino e non si ribella “…ma Cenerentola non si lamentava mai perché ad ogni levar del sole ella sentiva rinascere in cuore la speranza che un giorno il suo sogno di felicità si sarebbe avverato…” E intorno a lei ci sono i suoi amici, di solito miti e delicati come lei, che la confortano, ma non hanno la forza di ribellarsi al destino. C’è la strega, cattivissima, terribile, spietata, senza cuore, che è di solito invidiosa delle qualità della principessa e vuole liberarsene, con l’aiuto dei suoi servitori, cattivi come lei e, in più, timorosi della sua possibile vendetta su di loro “… conducila nel bosco, in un luogo appartato,dove possa cogliere fiori selvatici e là, mio cacciatore e fedele amico, tu l’ucciderai…” e lui risponde “ma maestà, la principessa…” e lei, ancora più cattiva “silenzio, tu sai che ti accadrà se non mi obbedirai”… I personaggi gregari, poi, fanno la loro parte, avallando e rinforzando le qualità dei personaggi principali. E’, ad esempio, il caso del cacciatore nella fiaba di Biancaneve, obbediente e timoroso, che però all’ultimo momento “non ebbe il cuore” di uccidere la bambina e la lasciò andare, mettendo, così, ancora più in risalto la perfidia della regina che glielo aveva ordinato.
L’eroe che salva, infine, è come la principessa, immacolato, buono, retto, perfetto e coraggioso: il principe che affronta il drago per salvare la principessa rinchiusa nella torre, incurante del pericolo, o il principe che sfida la morte, baciando Biancaneve e risvegliandola con il primo bacio d’amore, o, ancora, il principe che riconosce e sposa Cenerentola, salvandola dal suo destino di tristezza nella casa della matrigna e delle sorellastre. Questi eroi, i principi azzurri, utilizzano le armi del coraggio e della rettitudine, forti del loro valore ma anche del loro rango, del coraggio dato dall’appartenenza alla stirpe reale. Ma in ogni caso viene fuori che nella struttura narrativa della fiaba c’è sempre, e comunque, una morale, che non consente al cattivo di trionfare o, se questo trionfa, è perché c’era un motivo, qualcosa da scontare. Ciò che emerge, nella delineazione della personalità dell’eroe, nelle favole, è che le qualità personali possono avere una forza, una potenza salvifica, sconfiggendo, così, le forze del male, che, nel corso dei secoli, si sono concretizzate in modi diversi. Così, ad esempio, Pollicino salva i suoi fratelli grazie al coraggio ed alla furbizia, che riescono a conquistare anche la moglie dell’orco cattivo, che si commuove, mentre Gretel tira fuori la forza della disperazione per cacciare la strega nel forno e liberare il fratello. E se non ci riescono da soli, ecco giungere l’aiuto della magia, la fatina buona, gli stivali delle sette leghe, il fagiolo magico… Il messaggio originale viene comunque veicolato attraverso la fiaba, e giunge a destinazione, in genere, in maniera univoca e comprensibile. Anche le versioni più moderne e apparentemente dissacranti, come la storia di Shreck, presentata come “favola al contrario”,
riprendono, seppure in chiave ironica e divertente, lo schema classico bene/male. L’orco, Shreck, è bruttissimo, orrendo, ma buono, e si trova a dover affrontare un’impresa eroica, salvare la principessa Fiona dalla terribile fortezza difesa dal drago. La storia è un susseguirsi di colpi di scena, di personaggi che nella tradizione delle favole sono buoni e che, invece, qui sono presentati come cattivissimi. Le fiabe sono uno strumento terapeutico da sempre. Qui terapeutico non vuol essere inteso in senso necessariamente positivo, ma nel senso della promozione del cambiamento. Venivano – e vengono – usate per fare paura ai bambini, inducendoli a modificare il loro comportamento, a fare i buoni. Pinocchio, ad esempio, è una fiaba molto pedagogicamente corretta, che insegna ai bambini che se non obbediscono ai genitori saranno guai…” Io non me e anderò di qui, - rispose il Grillo -se prima non ti avrò detto una gran verità. - Dimmela e spicciati. -- Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna!Non avranno mai bene in questo mondo;e prima o poi dovranno pentirsene amaramente…” (Collodi, 2004) Certo, nell’era dell’automazione è strano parlare di fiabe, di fate, streghe, dragoni, principesse incantate. A uno sguardo superficiale, può apparire che questi personaggi appartengano a generazioni precedenti. A ben guardare, però, i videogiochi sono popolati di mostri, di personaggi cattivi da uccidere con il joestick, mentre i cartoni animati più seguiti ancora parlano di fatine (le Winx, ad esempio, o le Witch), così come ancora sono amate le serie fantastiche di Harry Potter, o le Cronache di Narnia. Gli elementi fondamentali ci sono ancora tutti, l’eroe, il cattivo, la magia, il sortilegio…e l’elemento fantastico aiuta, ancora oggi, ad affrontare, e ad esorcizzare le proprie paure e a sperimentarsi immaginandosi come eroe, o come principessa, per vivere emozioni, altrimenti, precluse.
5. Perché leggere le fiabe ai bambini La lettura di fiabe ai bambini li aiuta nello sviluppo del linguaggio. Aumenta il loro repertorio di parole, alimenta la capacità di espressione. La lettura di fiabe in terapia aiuta nello sviluppo del linguaggio della terapia. Aumenta il repertorio di parole, alimenta la capacità di espressione dei contenuti emotivi, dei significati. Scrivere insieme fiabe e racconti aiuta certamente a ricostruire visioni della realtà alternative, a dare respiro ai pensieri, a creare nuove possibili interpunzioni. La lettura ad alta voce di favole è una fondamentale pratica di avvicinamento alla lettura, una pratica che dovrebbe incominciare quando i bambini sono ancora piccolissimi e non dovrebbe interrompersi fino a che i bambini, poi ragazzi, poi adulti, mostrano di accogliere la proposta come un dono, un’affettuosa, divertita, partecipata condivisione di un momento di straordinaria intensità comunicativa. La lettura di fiabe in famiglia e lo scambio, il confronto verbale che ne segue, favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino, portandolo alla scuola dell’infanzia con una migliore capacità di esprimersi, di fare domande, di interessarsi in maniera attiva alle proposte educative che gli verranno fatte. Inoltre, è ampiamente dimostrato che i bambini che hanno esperienza di lettura di fiabe in famiglia sviluppano un repertorio lessicale ed una capacità di mantenere i tempi di attenzione maggiore rispetto ai coetanei. Negli Stati Uniti sono state condotte molte ricerche e sperimentazioni in merito, che hanno verificato l’efficacia dell’esposizione dei bambini alla lettura in età prescolare, strumento utile a colmare le lacune linguistiche e per avviare in modo corretto il rapporto con la lettura. Senza contare, poi, che l’adulto significativo che legge una storia al bambino veicola un ulteriore messaggio, il suo proprio piacere per la lettura, e in
questo, come in altri casi, l’esempio positivo ha un valore
infinitamente maggiore rispetto a qualunque spiegazione,
promovendo spontaneamente l’imitazione.
Ricerche recenti condotte in Italia confermano quanto detto,
aggiungendovi il dato – per la verità abbastanza prevedibile -
che i bambini che statisticamente amano di più la lettura hanno
genitori che leggono molto, e che, quindi, li hanno esposti al
contatto con la cultura fin da piccoli.
Le motivazioni per cui è utile leggere le favole ai bambini sono
tante, principalmente
vengono migliorate le capacità espressive, sia dal punto
di vista linguistico che emotivo;
vengono esercitati e quindi aumentati i tempi di
attenzione;
il bambino viene educato all’ascolto rispettoso, al
silenzio, migliorando, in tal modo, le proprie attitudini
relazionali;
viene promossa la capacità di creare immagini mentali
partendo unicamente dall’ascolto, alimentando, quindi,
il collegamento tra il canale uditivo e quello visivo e la
capacità di fantasticare autonomamente;
viene promosso un rapporto positivo e fecondo con la
lettura, ed il desiderio autonomo di imparare a leggere,
in quanto essa è proposta come attività essenzialmente
piacevole, anche in contrasto con la diffusa
convenzione sociale di collegare la lettura
esclusivamente alla scuola, e quindi di attribuirle una
connotazione negativa, legata più che altro all’obbligo;
viene avviata la conoscenza di generi letterari diversi e
di caratteristiche stilistiche legate anche ai contesti
sociali e culturali: la lettura di fiabe provenienti da
diverse parti del mondo insegna al bambino le diverse
consuetudini dei diversi popoli, favorendo, inoltre, un
pensiero più aperto alla multi-culturalità; vengono poste le premesse per uno sviluppo precoce
del senso della storia, ovvero della capacità di
riconoscere, individuare la struttura narrativa;
viene promossa la creazione di un territorio comune di
idee, emozioni, immagini.
Gli aspetti positivi della lettura di fiabe ai bambini sono
evidenti, quindi, sia per il carico di crescita cognitiva che
quest’esperienza porta con sé, sia, soprattutto, per la possibilità
di creare, utilizzando questo strumento, momenti di crescita e di
comunicazione positiva intergenerazionale, in cui lo scambio
emotivo è pieno e ricco di stimoli per lo sviluppo di relazioni
sociali positive.
6. Funzioni della fiaba
A che servono le favole? Le fiabe servono a fantasticare, a
rilassarsi, ad addormentarsi, ad essere rassicurati, ad esorcizzare
ed affrontare le paure, ad esplorare e conoscere altri mondi, a
migliorare la conoscenza del linguaggio, ad imparare ad
esprimersi.
Le fiabe aiutano nello sviluppo del linguaggio, e consentono, a
chi le ascolta o le legge, di aumentare il proprio repertorio di
parole e di significati.
Dal punto di vista relazionale, le fiabe sono uno strumento
straordinario. Metafore della realtà, consentono la sua scoperta,
la sua conoscenza, ma in maniera per così dire protetta. Possono
essere lette, ascoltate, raccontate, rappresentate graficamente,
musicate, recitate, e si prestano a infinite possibili elaborazioni
e rielaborazioni.
Le fiabe consentono la comunicazione su temi difficili, quali la
morte o l’amore, e su argomenti tabù, permettendo così di
sperimentare le proprie emozioni al riguardo in maniera
controllata.Per approfondire quest’argomento, è utile la lettura della Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, sull’uso delle parolacce e sulle elaborazioni fatte dai bambini delle scuole elementari sui temi “scottanti”, partendo dalle storie inventate dai bimbi dove intervengono “l’inconscio con i suoi conflitti, l’esperienza, la memoria, l’ideologia, la parola in tutte le sue funzioni. Una lettura puramente psicologica, o psicanalitica, non sarebbe bastata a illuminarne tutte le risultanze” (Rodari, 1973, pag.25). Certamente, raccontare una fiaba può servire a comunicare ed a manifestare attenzione, affetto, considerazione. Un bambino che ascolta ogni sera la fiaba della buonanotte imparerà presto a poterci contare, ci farà l’abitudine. Questo piccolo rito quotidiano sarà, per lui e per la mamma o il papà un momento di intima condivisione di un’esperienza, e la sua ripetizione, implicitamente, comunicherà al piccolo che chi si prende cura di lui è affidabile, in un certo senso prevedibile, e ciò è rassicurante. Il linguaggio delle fiabe è analogico, oltre che digitale, e consente di giocare con la storia, di sperimentare sequenze di eventi, di lasciarsi andare, di immergersi per un po’ in un mondo diverso, di vivere, per un po’, in un’altra dimensione. I bambini, di solito, sono istintivamente bravi nel passare da una dimensione all’altra, come quando passano dalla finzione del gioco alla realtà. Con la crescita, se non alimentata, questa capacità diminuisce, senza però mai svanire del tutto. La dimensione “altra”, il cosiddetto pensiero magico, è comune ai bambini ed agli psicotici, ma è una capacità, oserei dire una possibilità, che può tornare utile anche da adulti. 7. Imparare ad ascoltare le fiabe: un percorso educativo da iniziare il più presto possibile – dalle immagini alle storie
Non tutti i bambini hanno la possibilità di essere educati all’ascolto delle fiabe. Nella cultura attuale, che predilige le immagini, le comunicazioni immediate, l’uso del racconto della fiaba è in costante diminuzione. Anche i programmi per bambini, attualmente proposti, danno la precedenza a modalità più veloci ed immediate, ed i cartoni più visti mostrano immagini senza sfumature, in cui gli avvenimenti si susseguono in fretta, e non c’è tempo di attesa. Ascoltare le favole, invece, richiede pazienza. Richiede tempo, sia a chi legge, o racconta, che a chi ascolta. E la pazienza, che poi può tradursi in aumento dei tempi di attenzione, va esercitata. Già durante il primo anno di vita è possibile porre le basi per l’educazione all’ascolto ed alla lettura delle favole. I bambini molto piccoli sono alla ricerca costante di stimoli, e l’adulto che li accudisce può guidare questa ricerca, proponendo al bambino immagini, suoni, parole che alimentino la sua fantasia. Perché ciò avvenga, è importante non partire da situazioni già strutturate, ma proporre al bambino un’esposizione graduale, consentendogli, così, di aumentare la sua capacità di attenzione insieme con l’interesse per l’oggetto. Il bambino, così, sperimenterà il piacere dato dal racconto e, insieme, avrà la sensazione di essere padrone di quella situazione, che non gli genererà frustrazione. Per fare un esempio, per avvicinare un bambino alla lettura delle fiabe si può partire da un libro illustrato, in cui immagini di oggetti comuni siano presentate in maniera piacevolmente colorata ma chiara e riconoscibile. Si può sfogliare il libro insieme al bambino, nominando le immagini ed indicandole con il dito. Quindi, una volta che il bambino abbia preso confidenza con l’oggetto-libro, le immagini possono essere commentate, al nome si possono aggiungere degli aggettivi, e poi si possono inventare e raccontare brevissime storielle ispirate alle immagini.
Il passaggio successivo può prevedere libri di fiabe illustrati, in
cui, però, ancora le parole siano poche, e la preferenza viene
data all’immagine.
La gradualità è importante. Il bambino, piano piano, imparerà
ad ascoltare l’altro raccontare e, sempre piano piano, potrà
appassionarsi a quei racconti.
Una cosa importante è creare l’atmosfera. Raccontare una fiaba
richiede una preparazione, che consiste in movimenti ed
aggiustamenti fisici e psicologici, che possano connotare la
situazione. Trovare la posizione adatta, la distanza ottimale,
scegliere la luminosità dell’ambiente, stabilire il contatto visivo
e fisico, porsi in una situazione di tranquillità.
L’atmosfera, poi, viene creata anche dalle parole usate per
introdurre l’attività, e soprattutto dal tono della voce. Un po’
come nella musica, anche nel racconto delle favole è essenziale
la preparazione, il silenzio, e la modulazione dei toni, della
velocità dei suoni, delle parole, ed anche dei gesti.
Tutte queste cose definiscono un rapporto, una situazione
comunicativa molto intima e particolare.
Non esiste un tempo uguale per ogni bambino per imparare ad
ascoltare le storie (nel mio piccolo, posso dire che i miei tre
hanno avuto tempi diversi), e neanche un tempo uguale per ogni
genitore per imparare a raccontarle; a ciascuno va lasciato il
tempo necessario per appassionarsi alla storia, per
padroneggiarla.
E pazienza se il bambino chiede che gli si racconti sempre la
stessa storia, vuol dire che essa per lui ha una funzione
rassicurante, costituisce una sorta di rituale.
E i bambini hanno bisogno dei rituali, un po’ come i popoli.
8. Funzioni della fiaba nella pratica clinica
“Solo più tardi cominciò a farsi strada la verità:
non era il paziente ad avere bisogno di quella tecnica,
ma il terapeuta.”(Whitaker, 1990) La scelta della tecnica da utilizzare nella pratica clinica è condizionata di solito, da una serie di fattori. Principalmente, dalle tecniche conosciute dal terapeuta. Gli altri fattori che orientano la scelta sono legati alle caratteristiche degli utenti e dal contesto in cui avviene l’intervento. L’ utente può essere un adulto, presentare difficoltà personali ed il contesto può essere un colloquio clinico individuale. Può essere una coppia, e la terapia può essere, appunto, di coppia, relativa a difficoltà comunicative, relazionali, sessuali tra i due, ma può anche vertere principalmente sui problemi e sulle difficoltà di uno dei due; con una coppia si può ragionare anche dei figli senza portarli in terapia, o compiere una mediazione familiare, sostenendoli nel percorso della separazione o orientandoli riguardo a difficoltà genitoriali. L’utente può essere una famiglia, che si mette in discussione per risolvere i problemi emersi e manifestati da uno dei suoi membri, il cosiddetto “paziente designato”, o per risolvere situazioni di conflitto intergenerazionale, difficoltà di comunicazione tra i membri e così via. L’utente può essere un bambino, ed il contesto uno sportello di ascolto e consulenza all’interno della scuola. L’utente può essere una classe, ed il contesto dell’intervento può essere un progetto di sensibilizzazione su una determinata tematica, o un’attività di prevenzione o di intervento per casi di pedofilia, bullismo, difficoltà scolastiche, di gruppo, e così via. I contesti degli interventi sono gli studi privati degli psicologi, le sedi delle associazioni, i servizi pubblici, le scuole. Ed ogni contesto viene definito da una serie di ulteriori fattori quali la disposizione dell’ambiente, la luminosità e l’ampiezza degli spazi, la silenziosità oppure la rumorosità della situazione e, non ultime, le altre persone presenti durante l’intervento, presenti per partecipare o per caso.
Le caratteristiche fisiche e sociali della situazione, unite alle individualità delle persone che entrano in gioco, ed ai loro contesti di apprendimento, contribuiscono a caratterizzare l’intervento. Perché un contesto diventi terapeutico, però, è essenziale che si crei la relazione. Il tipo di tecnica utilizzata ha un’importanza relativa. E’ infatti oggi ampiamente dimostrato che le percentuali di successo in termini di “guarigione” sono più o meno le stesse per le diverse scuole di psicoterapia, dalla psicoanalisi all’indirizzo cognitivo- comportamentale. Ciò che importa è la relazione, oltre alla chiarezza nel perseguire gli obiettivi della psicoterapia. Durante le sedute di psicoterapia, e durante le diverse fasi di un intervento psicologico con delle persone, non è tanto importante cosa si fa, quale tecnica venga utilizzata, se il colloquio individuale su un determinato tema, la “scultura familiare”, il “genogramma”, ma quello che conta è che il terapeuta abbia ben chiaro in mente l’obiettivo, e che sappia perché sta facendo o dicendo una determinata cosa con quel determinato paziente o gruppo. L’uso delle fiabe nella pratica clinica, quindi, è una delle possibili tecniche, che può rivelarsi molto utile e proficua in determinate situazioni e con determinati tipi di utenti. Personalmente, ho utilizzato spesso questa tecnica nella mia esperienza clinica, in quanto la trovo particolarmente interessante e utile, e con diverse tipologie di utenti. Con i bambini, l’utilizzo della fiaba è un mezzo che favorisce l’instaurarsi di un linguaggio comune, l’espressione mediata di contenuti anche complessi ed anche il racconto di esperienze vissute e difficili da esternare altrimenti. Spesso i bambini che hanno subito abusi sessuali, ad esempio, riescono con questa tecnica a esprimere le loro emozioni e vissuti, compiendo dei passi verso l’elaborazione dell’esperienza in maniera graduale e più semplice.
Possono essere sollecitati ad inventare favole con protagonisti che abbiano caratteristiche simili alle loro, elaborando però diversi finali per la stessa storia, o anche raccontare la propria vicenda attribuendola ad altri, per esempio ad animali. E’ un po’ il concetto dei test proiettivi, comunemente utilizzati nella pratica clinica, e che partono al presupposto che nel parlare di una situazione, nel raccontare una storia, una persona parla di sé, e racconta la sua storia, proiettandola nella storia dei personaggi che descrive. Ad esempio, il test T.A.T. (Thematic Apperception Test) di Henry A. Murray, universalmente riconosciuto come uno degli strumenti più efficaci per l'indagine della personalità e per la comprensione delle sue manifestazioni problematiche, consiste nel presentare all’utente delle immagini stimolo, chiedendo poi di inventare una storia per ogni tavola. In particolare, il T.A.T. consente di giungere a conoscenza di emozioni, sentimenti, complessi e conflitti della personalità, rivelando inoltre tendenze rimosse o inibite, che la persona non vuole o non può ammettere, in quanto non ne è cosciente. Proprio in relazione alla necessità di comprendere le tendenze ed emozioni nascoste del soggetto in questione, viene scelta questa particolare metodica, che consente di individuare con una buona attendibilità i bisogni ed i sentimenti consci ed inconsci, espressi in conformità con le esperienze vissute dall’analizzato, senza che quest’ultimo ne sia consapevole. Anche con gli adulti le fiabe possono essere un utile strumento terapeutico, per le loro caratteristiche, cioè per la loro struttura narrativa, formale, per i contenuti delle storie utilizzate, ma anche, e soprattutto, quando sia utile il ricorso alla metafora 9. Racconto di un’esperienza di psicoterapia di coppia Questa è una storia a lieto fine.
E’ la storia di una terapia di coppia iniziata sei mesi dopo il matrimonio dei protagonisti e finita quindici giorni prima della nascita della loro bambina. Renato ed Emilia sono stati inviati al mio studio privato da una pediatra amica comune che, frequentandoli, aveva rilevato un forte disagio legato alla nascita imminente della prima figlia della coppia. Preoccupata soprattutto per la bambina, ha insistito perché si facessero aiutare. A chiamare è stato lui, ed abbiamo preso il primo appuntamento, nel febbraio del 2003. Renato ha 29 anni, è ingegnere elettronico e sta per presentare la tesi del suo dottorato di ricerca al Politecnico di Milano. Unico figlio maschio nato parecchi anni dopo tre femmine, è cresciuto in una famiglia molto tradizionale. E’ un ragazzone alto ed allampanato, con spessi occhiali da vista, il sorriso facile e l’aria un po’ distratta. Passa la maggior parte del tempo all’università o al computer. Emilia ha 27 anni, una laurea in Lettere classiche ed una in Conservazione dei beni culturali, oltre ad un master in economia ed una serie interminabile di specializzazioni. E’ una bella ragazza, alta e bruna, e se non ci si facesse caso, non sembrerebbe neanche incinta. Lavora part time presso un archivio storico. E’ orfana di padre da dieci anni ed ha una mamma molto presente, alla quale è molto legata e con cui passa la maggior parte del suo tempo. Ha due sorelle, una più grande di tre anni ed una più piccola, entrambe sposate e con un bambino. La sorella minore si è sposata un mese prima di Emilia, con un “matrimonio riparatore”, cosa che ha fatto arrabbiare Emilia, che pensava di poter affidare a lei la mamma sposandosi, e invece… Emilia e Renato provengono da famiglie tradizionali, di ambiente cattolico, ed entrambi hanno trascorso l’infanzia e l’adolescenza negli oratori salesiani. E’ lì che si sono conosciuti, circa dodici anni prima di sposarsi.
Sono caratterizzati dalla conversazione brillante e dalla
tendenza ad intellettualizzare e “psicologizzare” tutto,
specialmente lei.
Il motivo che li spinge a chiedere aiuto è il forte disagio vissuto
da Emilia in relazione al loro matrimonio, disagio che li mette
in discussione come coppia e li fa vivere in una tensione
continua.
“Il matrimonio è una cosa assurda. Aiuta a crescere nella
misura in cui è anticonformista. E’ un’esperienza che minaccia
l’integrità di un individuo, il suo proprio essere, e che
sconvolge fin nel profondo. E’ uno stato di coscienza alterato,
come l’ipnosi: più si va in profondità, più è facile che accada
qualcosa.
Una nota di avvertimento: se non sopportate la solitudine, non
sposatevi.
La maggior parte delle persone ragiona in questo modo: “è
una donnaccia, pover’uomo, mi dispiace per lui”, oppure: “lui
è un maledetto bastardo, povera donna”. Credo che le mie
prime scoperte in questo campo siano universalmente valide:
l’accoppiamento tra due partner è perfetto, non solo perché
uno completa l’altro nel presente, ma anche perché ciascuno
sceglie l’altro in funzione della crescita di coppia. La scelta del
partner tiene conto dell’altalena coniugale: l’adattabilità
dell’altro alla tua depressione o al tuo sadismo. Non credete a
nessuno che dica che il suo è stato un matrimonio di
convenienza o che affermi “dovevo essere ubriaco”.
I dieci miliardi di cellule contenute in quell’elaboratore che è il
nostro cervello, si accoppiano esattamente con l’altro
elaboratore con il quale ci colleghiamo.”
(Whi
taker, 1990, pag. 111)Il giorno del matrimonio Emilia entrò in chiesa al braccio dello zio, commossa ed emozionata, nel suo splendido abito bianco da principessa delle favole. Man mano che si avvicinava all’altare, però, cresceva in lei un senso di smarrimento, che all’arrivo si trasformò in una cocente delusione: perché mai Renato non si commuove? Perché non sviene? La visione di cotanta grazia e bellezza non stravolge i suoi sentimenti, non turba i suoi sensi? L’ignaro sposo la bacia ed ha inizio la cerimonia, condita dalle copiose lacrime delle mamme degli sposi, inconsolabili. Poi c’è il ricevimento, infine Renato ed Emilia si ritirano nella loro meritata intimità. La prima notte fu un disastro. Emilia pianse tutto il tempo, sia per il rimorso di aver lasciato sola la mamma, a casa, sia perché Renato, vedendola arrivare in chiesa, non aveva avuto nessuna manifestazione emotiva forte ed eclatante che potesse consolarla e rassicurarla nella sua dolorosa scelta. In più, l’ignaro sposo ha avuto i modi soliti, pacati e dolci, nel loro primo incontro coniugale, dandole così l’impressione tanto sgradevole della “minestra riscaldata”. La prima notte di nozze. Per inciso, quando ne abbiamo parlato, Emilia ha detto di essere rimasta profondamente delusa da lui, dal quale avrebbe desiderato un gesto inconsulto; lui ha ribattuto: “se lo avessi fatto, non me lo avresti mai perdonato”. Emilia questa non gliel’ha perdonata, ha messo il muso e l’ha tenuto per tutto il viaggio di nozze Emilia e Renato si sono conosciuti che avevano 16 e 17 anni e sono stati fidanzati undici anni prima di sposarsi. Il loro rapporto è stato movimentato dalle periodiche crisi di Emilia, e dai suoi frequenti sbalzi di umore. Renato è una persona molto lineare, solida, squadrata (anche fisicamente); Emilia lo definisce un tetragono. Fin dal giorno in cui si sono conosciuti aveva già immaginato, deciso e pianificato il loro futuro insieme.
Emilia invece ha un carattere molto instabile, inquieto e tormentato, che la porta ad analizzare ed a mettere in discussione ogni attimo della vita, sia la sua personale che la loro di coppia. Afferma di aver impiegato anni ad innamorarsi di Renato e che per lei una decisione non è mai definitiva, tutto va vagliato ed analizzato decine e decine di volte. Tutto questo pensare ed analizzare, unito ad una forte sensibilità, la porta ad amplificare la percezione di ogni emozione, perdendo facilmente il controllo dei propri impulsi ed assumendo atteggiamenti e mettendo in atto comportamenti dei quali poi si pente. Le emozioni di Emilia prendono spesso corpo, con somatizzazioni e malori, che la costringono a letto anche per giorni. La tanto apprezzata solidità di Renato, in questi casi viene considerata mancanza di attenzione, la sua stabilità diventa assenza di capacità emotiva o, negli ultimi tempi, incapacità ad esprimere le emozioni. Emilia afferma di provare molta difficoltà di fronte ai cambiamenti, che la scombussolano e la mandano in crisi; Renato evidenzia la coincidenza temporale delle crisi di Emilia con periodi di forte stress. Il desiderio di lei di tenere gli eventi sotto controllo e di guidare le emozioni nella direzione da lei desiderata ha un duro colpo con la scoperta di essere rimasta incinta praticamente la prima notte di nozze, durante il loro primo, deludentissimo, rapporto completo. Emilia prova un rifiuto deciso verso la creatura che porta in grembo, tanto che, inizialmente, prende in considerazione la possibilità di non riconoscerla e darla in adozione. I sensi di colpa per i sentimenti provati sono profondi, accentuati tra l’altro dal suo senso morale, per il quale sono inaccettabili. Ma ha paura di crescere, di perdere di colpo la sua indipendenza, di non avere più tempo per sé. E piange.
Mentre Emilia piange, la sua pancia cresce, e con essa il rifiuto per la nascitura. A questo rifiuto si aggiunge sempre più il risentimento ed aumenta l’ostilità verso Renato, che tanto ha deluso le sue aspettative ed i suoi sogni. Decido di partire da questi per aiutarli a superare l’empasse. La terapia è durata circa tre mesi, con sedute a cadenza quindicinale. Gli obiettivi fissati dall’inizio hanno riguardato la conoscenza della coppia, la sua storia, la conoscenza di quello che l’ha unita. La storia ed i contesti di apprendimento dei singoli nella coppia e della coppia come sistema, avrebbero potuto dare un’idea di quello che c’era dietro l’attuale situazione di stallo. Decisi di partire dalla storia personale e della coppia, facendo leva sulle risorse, le affinità, le ricchezze e le peculiarità che rendevano possibile l’esistenza della coppia stessa. Il sistema terapeutico avrebbe dovuto introdurre confusione, introdurre elementi di differenza, che potessero portare a nuove possibili interpunzioni, per favorire una visione circolare (Bateson, 1987). Avrei quindi cercato di individuare le caratteristiche delle persone che avevo di fronte, e metterle in luce, sostenerle, valorizzarle. L’obiettivo principale era di aiutarli a vedere le proprie vie alternative, lavorando ad un livello di comportamento piuttosto che ad un livello profondo (Haley, 1974). Il sistema terapeutico, quindi, aveva il compito di rompere la ridondanza di modelli di comportamento nella coppia, introducendo nuovi elementi nella relazione, dando luogo ad una descrizione nuova, diversa, di livello logico superiore. Una descrizione che andasse al di là della linearità, e che avesse almeno due punti di vista differenti (due descrizioni sono meglio di una).
Un po’ per aiutarli a ripercorrere la loro storia senza perdersi troppo in elucubrazioni mentali inutili e noiose, un po’ perché è un mezzo a me congeniale, mi sono divertita facendogli inventare e raccontare storie metaforiche ed a fargliele commentare. Con mia grande sorpresa e soddisfazione, dopo un’iniziale concentrazione sugli aspetti stilistici delle storie, Renato ed Emilia si sono divertiti insieme a me a tirare fuori le loro emozioni ed i pensieri, sdrammatizzando le isterie di Emilia e prendendo in giro l’eccessiva “tetragonicità” di Renato. Per farli parlare della loro storia di coppia ed in particolare dei sogni e delle aspettative che avevano reciprocamente, anche in rapporto al matrimonio, ho chiesto loro di inventare separatamente una storia metaforica, una fiaba. La storia raccontata da Renato parla di un pollo e una pollastra che si incontrano nell’aia e partono insieme “alla ricerca di un cortile dove razzolare sereni e farsi compagnia”. Pensando di conoscere la strada, cammina cammina arrivano in un grande prato verde; felici di aver trovato il posto dei loro sogni, si fermano lì, ma… all’improvviso iniziano a piovere schioppettate: non si erano accorti di essersi accampati in un poligono di tiro! Il commento di Emilia a questa favola verte inizialmente sull’aspetto stilistico: si meraviglia della capacità inventiva e di astrazione di Renato; dietro mia insistenza, sottolinea poi altri aspetti che la colpiscono: il fatto che dicano “questo è il posto dei nostri sogni, anche se non se lo erano detto” (Renato interviene: “come no, se lo erano detto!), il fatto che i due polli erano accomunati dalla meta comune. Emilia evidenzia l’essenzialità dei desideri di Renato, la sua linearità, il suo desiderio di condividere una vita comune con lei, la sua capacità di adattamento. Lui risponde che lei scambia questa adattabilità con passiva accettazione degli eventi, ma non è così, se no non ci sarebbe felicità.
La storia di Emilia parla di un principe ed una fatina che si incontrano, si innamorano “perdendosi uno nell’altra” e si sposano (descrizione del matrimonio con dovizia di particolari stile Cenerentola) perché “non riuscivano ad immaginare altro”. Il commento di Renato evidenzia la corrispondenza della metafora con le aspettative di Emilia riguardo il matrimonio e dice che gli è piaciuto il fatto che il principe e la fatina si capiscono guardandosi negli occhi, cosa che piacerebbe anche a lui, ma che non sempre è possibile. Dice che lui si aspettava di essere felice, spensierato, e di poter finalmente approfittare dell’intimità, mentre nei primi mesi era una continuità la crisi: “vorrei capire di che cosa ha bisogno, leggerle nella mente sarebbe un dono divino”. Gli ho fatto poi inventare il seguito delle storie. Renato racconta dei due pollastri che, pur trovandosi all’interno del poligono di tiro, non vengono colpiti e continuano felici a razzolare; Emilia contesta: “per tutta la vita?!” e lui ribatte: “ma lo sai quanto è grande un poligono di tiro?!" Nacquero poi tanti pulcini e vissero felici e contenti, come ogni fiaba che si rispetti. Emilia continua invece la fiaba del marito dicendo che i polli vengono colpiti entrambi dalla stessa freccia, la freccia dell’amore, e dopo si bastano l’uno all’altra…ma come mangiano, commenta Renato? Il seguito della storia di Emilia, per Renato è uguale alla sua: nascono tanti bambini e tutti vissero felici e contenti, mentre per Emilia il seguito non c’è. Emilia, infatti, mette in evidenza che le sue aspettative vengono deluse perché non si concretizzano in qualcosa, sono indefinite. “Non è un fare, è un essere. Io non riesco a pensare ad un seguito, penso che restino lì a guardarsi…ho aspettative su cose impalpabili, per questo è difficile che io le individui”.
Nella seduta successiva al seguito delle storie, l’attenzione è
stata spostata sulla gravidanza di Emilia, turbata per
l’avvicinarsi della data prevista per il parto, che sarebbe stato
probabilmente un cesareo.
Ne parlammo a lungo e con serenità, ripercorrendo la storia
della gravidanza dall’inizio ed affrontando uno per uno i motivi
del rifiuto:
1. la paura di perdere la libertà di gestire la propria vita;
2. la paura di essere inadeguata, di non essere in grado di
amare questa bambina in maniera sufficiente, quindi il
pensiero all’adozione;
3. il vincolo che la bambina rappresenta tra i genitori, il
dubbio sui sentimenti provati per Renato;
4. la paura di crescere.
Mettendo in gioco la mia esperienza, allora, risposi punto per
punto alle paure di Emilia, pensando che affrontarle insieme
potesse renderle concrete, quindi magari superarle:
1. E’ vero che quando nasce un bambino si perde in parte
la libertà di gestire la propria vita, si perde anche la
libertà di dormire quando si vuole…
2. la paura di essere inadeguati è una paura “sana”, che
credo abbiano tutte le persone consapevoli del passo
che stanno facendo quando mettono al mondo un figlio
(chi lo insegna?); il desiderio di darla in adozione l’ho
riletto come un atto di estremo sacrificio, la bambina
donata a chi può darle di più… ma chi può darle di più
di chi la ama a tal punto?
Emilia disse che era una lettura “poetica” della
situazione, ma non ha negato e mi è sembrato che le
piacesse pensarlo.
3. Il vincolo è reale, per cui forse vale la pena, per una
volta, didecidere se ci si ama o no, mantenendo la possibilità di
rimettersi in discussione come coppia ma senza iniziare
da capo ad ogni occasione.
4. Crescere fa paura, è vero, ma a volte non si può
scegliere se
farlo o meno, quando ci si trova di fronte ad eventi
definitivi (nascita, morte…)
Ho quindi fatto un intervento contrario alle mie abitudini e un
po’ fuori dal mio stile: un intervento di responsabilizzazione
verso la maternità, che metteva in forte evidenza l’importanza
per questa bambina di nascere in un ambiente accogliente, tra
genitori che fossero pronti ad amarla senza perdersi in
chiacchiere. Il succo era che si può essere buoni genitori anche
se come coppia non si è perfetti, e che un bambino in genere
non chiede una mamma ed un papà perfetti, ma solo genitori
sufficientemente buoni, che gli vogliano bene a modo loro. Se
poi si vogliono bene anche tra loro, tanto meglio per tutti.
L’ultima seduta, quindici giorni prima del parto, fu molto
serena.
Emilia, quando le chiesi come andasse, mi disse di aver
superato perlopiù la fase del rifiuto, e di “temere ora
soprattutto di non essere capace di amarla come una madre
dovrebbe, in modo totale, spostando l’attenzione da me a lei”.
Le chiesi se amasse suo marito, disse si.
Mi dissero che le cose andavano meglio tra loro, e che le crisi
erano diventate più rare.
Inizialmente, l’obiettivo è stato di mettere gli argini alla terapia:
stabilire un termine, dei tempi, dei modi.
La cornice, e l’attenzione al suo mantenimento e rispetto, è
stato il punto centrale dell’avvio dell’intervento terapeutico.Puoi anche leggere