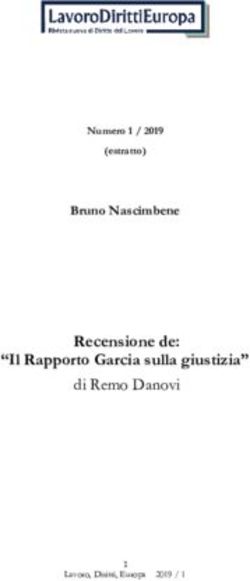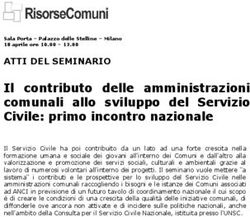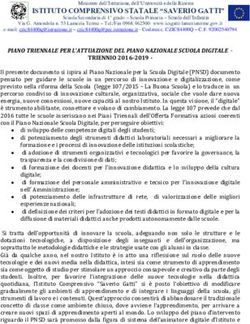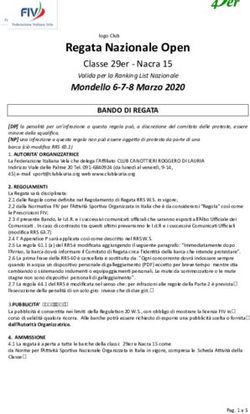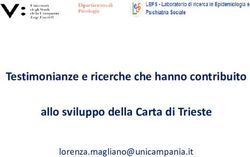L'istituto della cittadinanza dalle origini all'età moderna - LA PROSPETTIVA STORICA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’istituto della cittadinanza dalle origini all’età moderna LA PROSPETTIVA STORICA Fabio Baggio Scalabrini International Migration Institute
Introduzione
Cittadinanza: dal latino “civilitas", a sua volta
da “civis” = persona con stabile dimora in un
territorio, opposto a “peregrinus”
Due accezioni di civilitas in seno alla civiltà
romana
Complesso dei cittadini
Titolo di appartenenza a un gruppo o territorio
Ma il concetto di cittadinanza come titolo di
appartenenza ha radici più anticheIntroduzione
Il mio contributo
Rapido excursus sull’evoluzione storica del
concetto di cittadinanza
Accento su alcuni elementi che ritengo importantiLe prime civiltà
Mesopotamia e Egitto: città e cittadinanza dal
3500 AC
Appartenenza a un territorio circoscritto (mura),
spesso in contrapposizione con gli “altri”
(cittadinanza esclusiva)
Libertà: sudditi di un sovrano, ma persone libere
India: appartenenza cosmica induista e
buddhista
Il concetto di cittadinanza è molto blando:
appartenenza a classi sociali (caste) o territori
come status contingente
La vera appartenenza/identità è a livello cosmico
e si acquista attraverso il superamento delle
contingenzeLe prime civiltà
Cina: Confucio e la cittadinanza “morale”
Individuo non pre-esistente alla società o gruppo: è
l’appartenenza/relazione che lo fa essere
Cittadinanza = serie di doveri che impone la volontà
di continuare a esistere e far esistere la società di
appartenenza
Civiltà precolombiane in America
Civiltà Inca e Azteca: “cittadino” = persona che
risiede stabilmente nel territorio (= uomo/donna), in
opposizione al nomade
Civiltà Maya: “cittadino” = partecipe della vita della
comunità (diritti e doveri) in opposizione alle
persone isolate o indifferentiLe prime civiltà
Il popolo d’Israele: appartenenza e proprietà
Appartenenza religiosa, ma intimamente legata
alla discendenza (legami di sangue) e al possesso
della terra (dono di Dio)
Legge del Giubileo (ogni 50 anni)
Diritti legati alla cittadinanza-appartenenza al
popolo (diritti mediati per minori e donne), non
riconoscimento dei diritti agli schiavi e ai forestieri
(neppure dopo 10 generazioni)
Dimensione ontologica dell’appartenenza non
legata al territorio (Egitto, Babilonia, ecc.)
Diaspora (dal 70 DC) e mito del ritorno e di
riconquista della terraLa nascita del concetto
La cittadinanza nella Grecia antica
Cittadinanza = appartenenza a una comunità e
partecipazione alla vita “politica” nell’ambito
della “polis” (città stato, autocratica)
Status di “cittadino” riconosciuto a maschio libero,
figlio di un cittadino libero, proprietario di terra o
casa, residente
Due accezioni fondamentali:
Platone: cittadinanza dirigente (élite) governa
cittadinanza passiva: rapporto affettivo
Aristotele: tutti i cittadini chiamati a partecipare alla
gestione del potere (diritto e dovere), attraverso
assemblee = esercizio di virtùLa nascita del concetto
“Doppia” cittadinanza “federale” in caso di
alleanze tra “polis” greche (lega acarnana,
achea, beotica, licia ecc.)
Cittadinanza = privilegio revocabile in caso di
gravi trasgressioni (atimia o esilio)
Il cosmopolitismo ellenico
Il concetto nasce nel V secolo AC, con la crisi
della polis e la diffusione del pensiero sofista
Cittadinanza come appartenenza comune a tutto
il mondo conosciuto (fondamentale uguaglianza
tra le persone)
Parte del programma politico di Alessandro
MagnoL’evoluzione del concetto
Dalla Repubblica all’Impero Romano
Epoca repubblicana
“Cives” = concetto molto simile a quello greco;
“civilitas” = appartenenza alla “civitas”
Cives = patrizi e plebei (liberi), cui vengono
riconosciuti diritti politici
Per nascita da padre cittadino (e da madre) o per
adozione da parte di pater cittadino, o per volontà
collettiva di chi già possedeva la cittadinanza
Civilitas come status giuridico privilegiato (voto,
possesso, esilio invece di condanna a morte)
Inizialmente legato alla residenza a Roma, poi estesa
ad altre città federate (“foedus equum”)L’evoluzione del concetto
Si perdeva per morte, alienazione (se sotto
potestas), solenne esclusione, servitù acquisita e
migrazione ad altre città con acquisizione di nuova
cittadinanza
Nell’89 AC venne concessa a tutti gli uomini liberi
d’Italia (guerra sociale). Nel 43 AC concessa anche
ai Transpadani
Epoca imperiale
Espansione dell’impero, codificazione delle leggi e
“istituzionalizzazione” del concetto di cittadinanza
Nel 212 la “Constitutio Antoniana” di Caracalla:
cittadinanza romana estesa a tutti i sudditi liberi
dell’impero
Cittadinanza come simbolo onorifico, non corredata
da reale partecipazione politicaL’evoluzione del concetto
Basso Medioevo: fase di declino
Invasioni barbariche e situazione di cittadinanza
“confusa”
Barbai invasori e cittadini romani come categoria
speciale (non schiavi)
Cittadinanza universale cristiana
Regno longobardo: l’editto di Rotari riconosce tutte
le persone libere come “sudditi” sottoposti a
un’unica legge
Il feudalesimo: potere decentralizzato e
diritti/doveri determinati dai rapporti feudali (ceto e
dipendenza)L’evoluzione del concetto
L’espansione di “El Islam”
Visione teocratica: cittadinanza/appartenenza al El
Islam (territorio fedele alla religione di Allah)
dettata dalla fede religiosa
Espansione di El Islam y costituzione della “Umma
Islamia” (mondo islamico) dove tutti i fedeli hanno
diritto di cittadinanza
La conversione alla vera fede dà cittadinanza e
diritti connessi (possesso, cariche pubbliche,
partecipazione alla vita politica)
Fine dei tempi: per i fedeli, paradiso come vera
patria di appartenenza per sempreL’evoluzione del concetto
Epoca dei Comuni e delle Signorie
Ritorno alle realtà di governo circoscritte e
cittadinanza come riconoscimento statale,
necessaria per agire al di fuori dello stato (identità e
protezione)
Cittadini: persone che risiedono e/o operano
all’interno delle “mura cittadine”, contribuiscono
finanziariamente al governo (tasse) e si impegnano
nella sua difesa
Scompare la schiavitù feudale e nascono le
corporazioni dei mestieri: ambiente più consono
alla partecipazione, anche se permangono chiare
discriminazioniL’evoluzione del concetto
Regni moderni e assolutismo
Nei secoli XVI e XVII: in Europa si strutturano i regni
moderni, con confini ben marcati e forte senso di
appartenenza (nazionalismo)
Assolutismo politico: i rapporti feudatari vengono
restaurati nel rapporto sovrano-sudditi
Scismi e riforme religiose: sfide alla unità nazionale
e “strumento” per separatismi (riconoscimento e
esilio)
Jean Bodin e Hobbes: cittadini = sudditi, ma di fatto
non tutti i sudditi son cittadini (schiavi e stranieri) e
non tutti i cittadini sono uguali (classi, donne e
minori)L’evoluzione del concetto
Le Rivoluzioni del XVIII secolo
Illuminismo: valore universale delle idee di libertà,
uguaglianza e fratellanza, ma realizzabili all’interno
di un territorio di appartenenza (essenzialmente per
nascita = ius soli)
Cittadinanza = appartenenza a uno stato
(repubblica) con diritti e doveri uguali per tutti
Il cittadino = depositario della sovranità (potere),
che delega a rappresentanti per il suo esercizio
ordinario
Partecipazione attiva alla vita sociale e politica
della comunità di riferimento = passaggio dal
concetto di stato a quello di nazioneL’evoluzione del concetto
Rivoluzione americana
Liberta e uguaglianza: dall’esperienza degli immigrati,
stato “laico” e tollerante (divisione tra Chiesa e stato)
Costituzione: riconoscimento giuridico, cittadino per
nascita (in uno stato USA) o per concessione
Rivoluzione francese
Cittadino (citoyen) come sinonimo di aderente alla
rivoluzione (terzo stato)
Diritti uguali per tutti, ma di fatto distinzione tra
contribuenti (con diritto di voto) e non contribuenti
(senza diritto di voto)
Cittadinanza = diritto “naturale” positivo, ma espulsione
di persone per devianze ideologicheConclusioni
Alcune parole chiave
Stabilità (residenza territoriale)
Appartenenza (a gruppo o territorio)
Identità (spesso in contrapposizione)
Libertà (condizione previa)
Discendenza (legami di sangue)
Possesso (terra o casa)
Partecipazione (diritti e doveri)
Condizione giuridica (privelgio e protezione)Conclusioni
Alcune riflessioni
Rapporto tra cittadinanza ed estensione del
territorio (cittadino vs. suddito, partecipazione vs.
mera appartenenza)
Cittadinanza spesso legata a discriminazione
(etnocentrismo, ceti, stranieri, donne e minori) …
ma il cammino della civiltà porta al superamento di
ogni discriminazione
Rapporto tra Identità e partecipazione attiva alla
vita sociale e politica
Universalismo cosmico, cosmopolitismo ellenico,
universalismo cristiano e illuminista su dimensione
più ontologica che politicaFINE
Puoi anche leggere