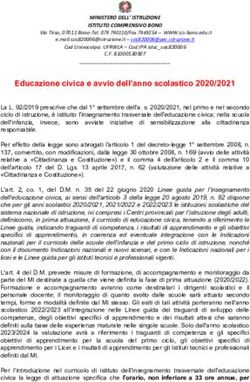L'Iran alle urne a trent'anni dalla rivoluzione - Treccani
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’Iran alle urne a trent’anni dalla rivoluzione
Fu lo Scià Reza Pahlavi nel 1935 a chiedere formalmente alla comunità
internazionale di mutare da Persia in Iran il nome dello stato attualmente conosciuto
come Repubblica Islamica d’Iran. L’allora monarca persiano volle con questa
decisione ispirarsi al nome originario della Persia, il Paese degli Arii. La posizione
geografica favorevole è stata da sempre per l’Iran motivo di grande beneficio.
Un tempo grazie alla ‘Via della Seta’ che l’attraversava per poi passare in
Mesopotamia, la Persia aveva assunto una notevole e invidiabile importanza
commerciale. Oggi il controllo esercitato sullo stretto di Hormuz, all’estremità
meridionale del Golfo Persico, da cui passano il 40% dei trasporti marittimi di
idrocarburi, è per l’Iran una grande fonte di potere strategico.
L’economia è basata su un sistema composito, alla gestione statale dell’industria
petrolifera si aggiunge la privatizzazione di industrie minori, dell’agricoltura e di
altre piccole e medie imprese commerciali. L’industria petrolifera è la principale
risorsa economica che fa dell’Iran un attore chiave nel mercato energetico globale. Il
Paese, secondo al mondo per riserve confermate di oro nero e gas naturale, è
caratterizzato da un alto tasso di inflazione che attualmente si attesta intorno al 19% e
da una disoccupazione pari a circa il 12%. L’Iran è popolato da circa 70 milioni di
persone, due terzi dei quali hanno meno di trent’anni, appartenenti a svariati gruppi
etnici che ne fanno un ricco ‘melting pot’ di culture.
Una repubblica religiosa e rivoluzionaria
“Lo Stato dell’Iran è una Repubblica Islamica che la nazione dell’Iran, sulla base
della fede tradizionale nel governo della verità e della giustizia [rivelato] nel Corano,
in seguito alla vittoria della Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Al-Ozma
Imam Khomeini, ha approvato con il Referendum Nazionale svoltosi il 10 e l’11
Farvardin 1358 (corrispondenti al 30 e 31 Marzo 1979), data coincidente con il 10 e
1
© Copyright 2009 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/percorsiil 2 giorno i Jomad al-oula 1399, esprimendo voto positivo di ratifica con una
maggioranza del 98,22% dei votanti”. Questo l’articolo 1, della prima parte della
Costituzione iraniana, quella dei Principi generali. È la legittimazione dell’ispirazione
religiosa e rivoluzionaria della Repubblica, basata sui principi e sulle norme
dell’Islam e sancita con un voto popolare della comunità islamica.
La sovranità e la legge sono considerati come appartenenti esclusivamente a Dio ed è
imprescindibile l’osservazione dei suoi comandamenti. La rivoluzione islamica ha
rappresentato oltre che il sovvertimento di un ordine esistente, l’avvento di un ordine
sociale e politico fondato sulla Legge divina. Non nacque dal nulla, secondo
Khomeini, ma fu il risultato di una rivoluzione interiore, una piena assimilazione
dell’Islam, della sottomissione a Dio e alla sua visione del mondo. Una visione
geocentrica dell’esistenza, ove la legge è sia dovere sociale che norma religiosa. Una
legge divina nella sua origine, che regola tutta la vita, sia esteriore che interiore,
dell’individuo e dell’intera comunità.
Il diritto, la morale, la filosofia, la teologia, le discipline sociali, tutto è strettamente
unito intorno a un unico centro che è Dio. Nel pensiero dell’Imam la politica diviene
metapolitica, una via di salvezza e un mezzo per la realizzazione delle più alte
possibilità dell’essere umano. La politica è una parte della religione e la separazione
della religione dalla politica, per Khomeini, è stata un operazione portata avanti negli
ultimi secoli dall’imperialismo. Al momento della rivoluzione islamica, il sogno degli
iraniani era trovare una via alternativa alla modernità occidentale e uno stato fondato
sulla religione non poteva che assicurare giustizia e solidarietà. Fu l’assoluta autorità
del Dottore della Legge la teoria fondante della Repubblica Islamica.
Durante la sua permanenza a Najaf, nel suo esilio iracheno, Khomeini tenne una serie
di lezioni sul governo islamico che furono oggetto di una pubblicazione dal titolo
“Vilayat-e Faqih ya Hukumat-e Islami”. Esplicò la teoria che prevedeva l’assunzione
da parte degli ulama più qualificati delle funzioni politiche e giuridiche del
dodicesimo Imam, conseguenza della dottrina sciita dell’imamato. Il 6 gennaio del
2
© Copyright 2009 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/percorsi1988 in una lettera all’allora Presidente della Repubblica Ali Khamenei, attuale
Guida Suprema iraniana, Khomeini definì “assoluta” la figura del Vilayat-e Faqih,
del giureconsulto, che rende teoricamente possibile per la Guida prevalere su tutte le
eventuali obiezioni alle sue politiche.
Il Vilayat-e Faqih deve essere considerato l’unico rappresentante sulla Terra del
Profeta Mohammad e dei dodici Imam suoi successori, dunque l’unica autorità dotata
di assoluti poteri di magistero. Esercita la funzione di guida della vita spirituale
secondo le prescrizioni islamiche, risponde alla necessità di assicurare alla comunità
dei credenti un governo di garanzia e indirizzo secondo gli orientamenti religiosi.
Questo l’articolo 5 della Costituzione, che descrive la stella polare del sistema
politico iraniano, il Leader Supremo: “Durante il tempo in cui il Dodicesimo Imam
(possa Dio accelerare la sua ricomparsa) rimane in occultazione, nella Repubblica
Islamica dell’Iran la tutela degli affari e l’orientamento del popolo sono affidati alla
responsabilità di un giurista giusto e pio, conoscitore della propria epoca, coraggioso,
dotato di energia, di iniziativa e di abilità amministrativa, che la maggioranza della
popolazione riconosca ed accetti come propria Guida”.
La Guida degli sciiti
Il ruolo della Guida è un tratto distintivo dell’Islam sciita rispetto all’Islam sunnita.
Gli sciiti ritengono, distinguendosi in questo dai sunniti, che la scelta dell’Imam non
possa essere di carattere elettivo (cioè provenire dal basso), ma proceda direttamente
da Allah e dal suo Profeta. Partendo da questo principio sostengono che il ruolo di
guida, alla morte di Mohammad, spettasse di diritto a suo genero Ali, in quanto
esplicitamente considerato dal Profeta come il più degno e il più vicino a se stesso. In
seguito il dovere di tutelare il messaggio divino fu trasmesso ad altri undici Imam.
Tutti discendenti della Famiglia del Profeta e condannati al martirio per ordine dei
3
© Copyright 2009 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/percorsicaliffi sunniti, tranne il dodicesimo che per volontà divina entrò in “occultazione” nel
329 (939 d.C.) e di cui si attende tuttora il ritorno come salvatore dell’umanità.
In realtà dalla rivoluzione del 1979 sino alla morte di Khomeini del 1989 il ruolo
della Guida Suprema risultò in modo rilevante identificato con la leadership e il
carisma personale dell’Imam. Dopo la sua morte l’assenza di un possibile adeguato
sostituto nella nomenclatura iraniana, portò alla scelta di modificare nella
Costituzione i requisiti necessari per ricoprire l’importante carica, favorendo in
questo modo la scelta di un candidato debole. Specularmente le istituzioni del
Consiglio dei Guardiani e del Consiglio del Discernimento andarono gradualmente
assumendo un ruolo e un’importanza sempre più rilevante nel sistema iraniano,
rendendo più distribuito il potere nel Paese. L’apparato della Repubblica Islamica
risulta essere un ibrido insieme di istituzioni non scelte dal popolo e controllate dalla
potente autorità della Guida Suprema (Rahbar), contrapposte ad altre, come il
Presidente e il Parlamento, eletti a suffragio universale.
La Guida, scelta dai religiosi che fanno parte dell’Assemblea degli Esperti, controlla
sostanzialmente ogni ramo del potere. Tra i suoi compiti principali: ratificare
l’elezione del Presidente della Repubblica, nominare i sei giuristi religiosi del
Consiglio dei Guardiani, il Capo della Magistratura, i comandanti delle Forze Armate
e delle Guardie della Rivoluzione Islamica (i Pasdaran), i leader delle preghiere del
venerdì e il direttore della radio e Tv di Stato. Ha facoltà di dichiarare lo stato di
guerra, destituire il Presidente, concedere grazie o condonare pene, mentre è
l’Assemblea degli Esperti (la metà dei cui membri sono scelti dalla stessa) che ha il
potere di destituirla in caso di inabilità.
Il Consiglio dei Guardiani
Il Consiglio dei Guardiani (Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi) è l’organo
politico iraniano più influente. Ha la funzione di controllare che le leggi approvate
4
© Copyright 2009 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/percorsidal Parlamento siano in linea con la Costituzione e con la Sharia, oltre che svolgere il
monitoraggio sui candidati alle elezioni presidenziali, parlamentari e di altre
istituzioni, decretandone o meno l’idoneità. Si compone di dodici membri, sei giuristi
islamici appartenenti al clero, sei giuristi laici, eletti dal Parlamento. La Presidenza è
la più alta carica della Repubblica dopo la Guida della Rivoluzione. Il Presidente,
eletto direttamente dal popolo e in carica per quattro anni, è responsabile
dell’esecuzione della legge costituzionale e del coordinamento dei rapporti tra il
potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Ha assunto le funzioni governative dal
1989, quando una modifica della costituzione ha abolito la carica di Primo Ministro e
ha passato le sue funzioni al Presidente. Il Maijlis-e Shora-ye Islami, chiamato
Maijlis per brevità, è il Parlamento unicamerale iraniano.
I 290 deputati dell’Assemblea Nazionale sono eletti direttamente dal popolo a
scrutinio segreto e rimangono in carica per quattro anni. L’Assemblea degli Esperti
(Maijlis –e Khebregan) nacque dopo la Rivoluzione, come Assemblea Costituente,
per l’elaborazione di un testo di Costituzione. Dopo che la prodotta bozza finale fu
approvata da referendum popolare, l’Assemblea fu sciolta per essere rieletta, in
seguito e in più occasioni, a suffragio universale. Nel 1987, l’Imam Khomeini
nominò inoltre il Consiglio per la Determinazione delle Scelte o per il Discernimento
(Shohra-ye Masslehat), organismo il cui compito consiste nel dirimere le eventuali
controversie di carattere legale fra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani. I suoi
membri sono nominati dal Leader Supremo.
Attualmente vi sono in Iran 240 organizzazioni, associazioni e partiti politici
registrati a cui è stata data legittimità ad operare in ottemperanza al sistema religioso
che regge il Paese. Tra questi, gli osservatori e gli elettori riconoscono informalmente
tre grandi correnti: i Conservatori (Osoolgarayan), i Riformisti (Eslahtalaban), e i
Pragmatici o Centristi (Etedaltalaban).
(Francesco De Leo)
5
© Copyright 2009 Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/percorsiPuoi anche leggere