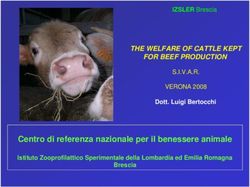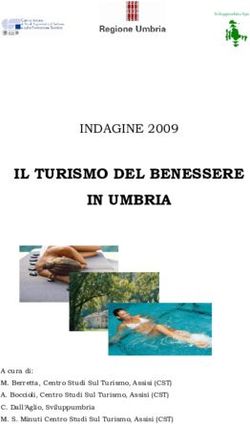Il rapporto tra benessere psicologico, disagio e personalità
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il rapporto tra benessere psicologico, disagio e personalità
The relationship of psychological well-being, distress and personality
CHIARA RUINI*, FEDRA OTTOLINI**, ELIANA TOSSANI*, CARLOTTA BELAISE**
LARA MANGELLI*, GIOVANNI ANDREA FAVA*
*Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
**Dipartimento Misto di Psichiatria e Salute Mentale, Università di Modena e Reggio Emilia
RIASSUNTO. Scopo. Lo scopo di questo lavoro è analizzare il concetto di benessere psicologico in relazione al malessere e
ai tratti di personalità. Risulta essere di fondamentale importanza collocare la valutazione del benessere psicologico rispetto
agli indici sintomatologici e alle dimensioni di personalità. Metodo. Un campione di 450 soggetti appartenenti alla popola-
zione generale ha completato tre questionari: il Symptom Questionnaire (SQ) di Kellner, lo Psychological Well-Being Scales
(PWB) di Ryff e il Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) di Cloninger. Le valutazioni sono state ripetute dopo un
mese. Per analizzare le correlazioni fra i tre questionari è stato utilizzato il coefficiente di correlazione di Pearson. È stata ef-
fettuata un’analisi fattoriale per entrambe le misurazioni; inoltre, sono state calcolate le differenze nei tre indici nel campio-
ne in base alla variabile sesso tramite l’Anova. Risultati. L’analisi fattoriale ha mostrato una struttura a 4 o 5 fattori, in cui
benessere, malessere e personalità sono rappresentati separatamente. Le scale del benessere psicologico sono correlate si-
gnificativamente e negativamente con tutte le scale sintomatologiche, ma solo con una dimensione di personalità, quella del-
l’evitamento del danno. È emerso inoltre che le donne nel nostro campione presentano livelli significativamente inferiori di
benessere psicologico, fatta eccezione per la scala delle Relazioni Positive con gli Altri, e significativamente superiori di di-
sagio e disturbi di personalità. Discussione. I risultati mettono in luce la complessità del rapporto tra benessere, disagio e
personalità. Il benessere psicologico non corrisponde semplicemente all’assenza di sintomi, né a specifici tratti di personalità.
Il PWB di Ryff sembra misurare un atteggiamento nei confronti del benessere e del funzionamento ottimale che è essenzia-
le per una considerazione completa dell’individuo nei contesti clinici.
PAROLE CHIAVE: benessere psicologico, malessere, personalità, valutazione.
SUMMARY. Aim. The aim of the present study was to analyze the concept of psychological well-being and its relationship to
distress and personality traits. It is clinically and empirically important to establish where the measures of well-being are lo-
cated in relation to symptomatology indexes and personality traits. Method. A sample of 450 subjects in the general popula-
tion completed three scales: Kellner’s Symptom Questionnaire (SQ), Ryff’s Psychological Well-Being Scales (PWB), and
Cloninger’s Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ). The assessment was repeated after one month. Pearson’s coef-
ficient was used to analyze correlations between well-being, distress and personality indicators. Exploratory factor analysis
was performed, for both assessments. Differences between the three indexes according to sex were calculated by means of
Anova. Results. Exploratory factor analyses showed a 4 or 5 factor structure, where well-being, distress and personality re-
mained separated. PWB scales were negatively and significantly correlated with all symptom scales, but only with one per-
sonality dimension, TPQ Harm Avoidance. Mean-level differences by gender showed that in general women significantly pre-
sented with lower levels of well-being (except in Positive Relations) and higher levels of distress and personality disturbances.
Discussion. The results suggest that the relationship of well-being to distress and personality is complex. Psychological well-
being could not be equated with the absence of symptomatology, nor with personality traits. PWB scales measure an attitude
toward optimal functioning that is crucial for a comprehensive consideration of individual in clinical settings.
KEY WORDS: psychological well-being, distress, personality, assessment.
E-mail: fava@psibo.unibo.it
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
315Ruini C, et al.
INTRODUZIONE personalità quali l’estroversione e l’apertura verso
nuove esperienze (4).
Il concetto di benessere psicologico è stato per lun- Lo scopo di questo lavoro è quindi analizzare in mo-
go tempo trascurato dalla letteratura scientifica. La ri- do approfondito il concetto di benessere psicologico e
cerca nell’ambito della psicologia, e in particolare i suoi rapporti con il disagio e con vari tratti di perso-
quella clinica, si è focalizzata sulla definizione e sul nalità. A livello clinico è poi di fondamentale impor-
trattamento del disagio e del malessere. Di conseguen- tanza cercare di stabilire dove vengono a collocarsi le
za, la salute è stata spesso identificata semplicemente misurazioni del benessere in relazione agli indici sinto-
come assenza di malattia (1). matici e ai tratti di personalità. La misurazione del be-
Fortunatamente, la costruzione di uno strumento nessere è qualcosa di ben distinto oppure si può so-
psicometrico quale la Scala del Benessere Psicologico vrapporre, in virtù di forti correlazioni, con gli indica-
(Psychological Well-Being Scale, PWB) (2), che misu- tori di disagio e di specifici tratti di personalità? La no-
ra costrutti quali il benessere psicologico e il funziona- stra ipotesi è che il benessere psicologico non corri-
mento ottimale di un individuo, ha permesso di svolge- sponda semplicemente all’assenza di malessere. Quin-
re numerose indagini in questo ambito. Le prime, di ti- di, sebbene ci si possano aspettare correlazioni negati-
po esplorativo, hanno messo in evidenza come vi siano ve con le misurazioni di depressione, ansia, ecc., abbia-
delle differenze nelle sei dimensioni di benessere in mo ipotizzato che alcuni importanti aspetti del benes-
rapporto all’età, al sesso, al livello educativo, alla cul- sere rimangano ben distinti. Allo stesso modo, sebbene
tura di appartenenza (2,3). È stato poi esplorato il rap- il benessere psicologico concettualizzato da Carol Ryff
porto tra benessere psicologico e tratti di personalità rappresenti senz’altro un insieme di potenzialità e ca-
(4), processi di invecchiamento (5), cambiamenti di vi- ratteristiche individuali, si ipotizza che esso non sia
ta (6,7), eventi stressanti e capacità di recupero (8). semplicemente ascrivibile a tratti di personalità pre-
Nell’ambito della psichiatria clinica alcune indagini stabiliti e immutabili, misurati tramite questionari
hanno documentato specifici deficit nelle dimensioni preesistenti.
di benessere psicologico in pazienti con disturbi affet-
tivi (9-11). In tali studi si è visto come i pazienti con di-
sturbi ansiosi e dell’umore, nella fase di remissione del-
METODI
la malattia, continuino a riportare livelli significativa-
mente inferiori di benessere psicologico e significati- Campione
vamente superiori di sintomatologia residua rispetto a
soggetti di controllo bilanciati in base a variabili socio- Il campione raccolto per la ricerca era costituito da
demografiche (9-11). Questi dati hanno suggerito e 450 individui reclutati tramite inserzione in tre città del-
supportato lo sviluppo di una strategia terapeutica vol- l’Emilia-Romagna. Esso era composto da 258 femmine
ta all’aumento del benessere (12). Tale strategia è sta- (57.3%) e 192 maschi (42.7%); l’età variava da un mini-
ta applicata nella fase residua dei disturbi affettivi mo di 15 anni a un massimo di 85 anni (età media=50 an-
(13), nella prevenzione delle ricadute nella depressio- ni). 343 soggetti erano coniugati (76.2%) e 107 non lo
ne maggiore (14) e, recentemente, nel contrastare la erano (23.8%). Le professioni sono state valutate rife-
perdita di efficacia durante terapia di mantenimento rendosi alla classificazione professionale indicata da
con antidepressivi (15). Altri Autori, sempre nell’ambi- Goldthorpe e Hope (17): seguendo questa metodologia,
264 soggetti sono risultati appartenenti alla classe socia-
to della psichiatria clinica, hanno sottolineato l’impor-
le inferiore (58.6%) mentre i rimanenti 186 (41.4%) ap-
tanza di includere le cognizioni positive nella defini- partenevano alla classe media o superiore. 326 soggetti
zione di salute mentale, con particolare riferimento al- (72.4%) avevano un livello di istruzione superiore (di-
la fase di remissione e alle ricadute nel disturbo de- ploma di scuole medie superiori o laurea), gli altri 124
pressivo (16). (27.6%) un livello di scolarità inferiore (scuola dell’ob-
Esaminando tutte queste ricerche, la considerazione bligo).
principale che emerge è che il benessere psicologico è Tutti i soggetti, edotti e informati sulle finalità della ri-
un concetto molto complesso e che altrettanto artico- cerca, hanno accettato spontaneamente di partecipare.
lati sono i suoi rapporti con il disagio, gli stati emotivi
negativi e i vari aspetti della personalità (9,11). Prece-
denti lavori hanno evidenziato, infatti, la correlazione Strumenti psicometrici
negativa tra benessere, depressione, nevroticismo (4) e
A ciascun soggetto è stata consegnata una batteria di
disturbi di personalità (9); mentre alcune dimensioni
questionari composta da:
della Ryff sono correlate positivamente con tratti di
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
316Il rapporto tra benessere psicologico, disagio e personalità
a) La versione italiana del PWB (84 item suddivisi in sei retest (seconda misurazione) 35 soggetti non hanno
scale) è un questionario autovalutativo creato dalla compilato il questionario e quindi i loro dati sono
Ryff (18) in cui ai soggetti viene chiesto di valutare il mancanti.
loro grado di accordo per ogni item, secondo una sca-
la Likert a 6 punti che varia da fortemente d’accordo
Analisi statistica
a fortemente in disaccordo. Le risposte agli item for-
mulati negativamente vengono conteggiate in modo Per valutare a livello empirico se e quanto le dimen-
inverso, cosicché il punteggio finale rappresenta l’au- sioni di benessere, di disagio psicofisico e di personalità
tovalutazione di ciascun soggetto nelle sei dimensioni siano tra loro distinte, è stata condotta un’analisi fatto-
di benessere psicologico. Il range di punteggio varia riale di tipo esplorativo, utilizzando il metodo di rotazio-
da 14 a 84. ne Varimax per l’estrazione delle componenti principali.
b) La versione italiana del TPQ (100 item suddivisi in tre Tale analisi è stata poi ripetuta anche al retest per verifi-
scale) è un questionario di personalità creato da Clo- care la replicabilità dei risultati ottenuti.
ninger (19) con lo scopo di fornire uno strumento di In seguito, per analizzare nel dettaglio il rapporto tra
valutazione per una diagnosi sistematica dei disturbi di dimensioni di benessere, di disagio e di personalità sono
personalità. La validità e l’attendibilità sono già state state calcolate con il coefficiente r di Pearson le correla-
ampiamente provate in studi precedenti (20). Il TPQ è zioni bivariate fra le sei scale del PWB, le tre scale del
costituito da item di tipo Vero/Falso ed è basato su tre TPQ e le otto sottoscale dell’SQ, sia al test che al retest.
dimensioni fondamentali di personalità che sono lega- Infine, sono stati confrontati i punteggi ai questionari
te a specifici sistemi cerebrali e ai relativi assetti neu- autovalutativi in base alla variabile sesso (analisi della
rochimici. Esse sono: ricerca di novità (NS); evitamen- varianza).
to del danno (HA); dipendenza da ricompensa (RD). I
soggetti che ottengono alti punteggi nella dimensione
NS (elevata attività serotoninergica) tendono a essere
curiosi, rapidi, impulsivi e disordinati, mentre quelli RISULTATI
che ottengono punteggi bassi tendono a essere riflessi-
vi, lenti e ordinati. Per la seconda dimensione (HA), gli L’analisi fattoriale alla prima misurazione ha con-
individui che ottengono alti punteggi (bassa attività
fermato la nostra ipotesi di partenza: in effetti, come
dopaminergica) sono affaticabili, apprensivi, timidi e
possiamo vedere dalla Tabella 1, sono emersi quattro
pessimisti; al contrario, quelli che ottengono punteggi
bassi sono ottimisti e vigorosi. Infine, per quanto ri- fattori che cumulativamente spiegano il 64% della va-
guarda l’RD, i soggetti che ottengono alti punteggi rianza. Il primo fattore è saturato positivamente con
(bassa attività basale noradrenergica) sono descritti tutte le dimensioni del benessere e negativamente con
come sensibili a obiettivi sociali e tendenti al senti- la scala della depressione (fattore relativo al benesse-
mentalismo, mentre quelli che ottengono bassi punteg- re). Il secondo fattore mostra un pattern di saturazio-
gi risultano essere poco sensibili, pratici e distaccati. ne con le dimensioni relative al disagio. Tuttavia pos-
c) La versione italiana dell’SQ (92 item suddivisi in otto siamo notare come le scale che si riferiscono propria-
sottoscale) è un questionario autovalutativo (21) ba- mente a un malessere di tipo fisico (somatizzazione e
sato su quattro dimensioni principali: ansia, depressio- benessere fisico) siano più pesantemente saturate in
ne, ostilità, sintomi somatici. Ciascuna delle quattro relazione al terzo fattore. Sembra quindi che il disagio
scale è a sua volta suddivisa in due sottoscale, una re-
possa essere identificato con due fattori: uno più gene-
lativa ai sintomi e l’altra al corrispondente stato di be-
rico (fattore 2) e uno propriamente fisico/somatico
nessere: si ha così un totale di otto sottoscale. L’SQ
prevede risposte del tipo Sì/No o Vero/Falso; dei 92
(fattore 3). L’ultimo fattore, infine, è saturato pesante-
item che lo compongono, 68 indicano sintomi (sotto- mente con le dimensioni di personalità e più legger-
scale dei sintomi) mentre i rimanenti 24 indicano i mente anche con due scale del benessere (crescita per-
contrari dei sintomi (sottoscale di benessere). Per con- sonale e relazioni positive).
teggiare il punteggio si attribuisce il valore 1 per ogni L’analisi fattoriale eseguita sulle stesse dimensioni,
sintomo che è segnato “Sì” o “Vero” e per ogni affer- ma alla seconda misurazione (Tabella 2) replica es-
mazione di benessere segnata come “No” o “Falso” (in senzialmente la struttura descritta in precedenza: ab-
sostanza più il punteggio è alto, più basso è il livello di biamo nuovamente un fattore relativo al benessere
benessere). Il punteggio massimo che si può ottenere (fattore 1), uno relativo al disagio, un terzo relativo al-
per ogni sottoscala dei sintomi è di 17, mentre quello la somatizzazione. In questo caso, tuttavia, le dimen-
per le sottoscale del benessere è di 6. sioni di personalità mostrano saturazioni suddivise in
I questionari sono stati somministrati a distanza di un
due fattori (4 e 5). Tali fattori risultano essere collega-
mese l’uno dall’altro al campione di 450 soggetti. Al
ti anche alla dimensione dell’autonomia, che non trova
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
317Ruini C, et al.
Tabella 1. Analisi Fattoriale delle misure di benessere psicologico, disagio e tratti di personalità (prima misurazione)
Scale Fattori
1 2 3 4
Autonomia (PWB) .706
Padronanza ambientale (PWB) .810
Crescita personale (PWB) .553 .442
Relazioni positive (PWB) .458 .622
Scopo nella vita (PWB) .811
Autoaccettazione (PWB) .786
Ansia (SQ) .570 .493
Depressione (SQ) -.404 .499 .539
Somatizzazione (SQ) .771
Ostilità (SQ) .742
Rilassamento (SQ) .685
Contentezza (SQ) .609
Benessere fisico (SQ) .761
Buona disposizione (SQ) .777
Ricerca di novità (TPQ) .410 .638
Evitamento del danno (TPQ) .421
Dipendenza da ricompensa (TPQ) .730
Metodo di rotazione: Varimax
Tabella 2. Analisi Fattoriale delle misure di benessere psicologico, disagio e tratti di personalità (seconda misurazione)
Scale Fattori
1 2 3 4 5
Autonomia (PWB) -.437 .426
Padronanza ambientale (PWB) .553
Crescita personale (PWB) .644 .404
Relazioni positive (PWB) .558 .560
Scopo nella vita (PWB) .824
Autoaccettazione (PWB) .769 -.393
Ansia (SQ) .709
Depressione (SQ) -.426 .640
Somatizzazione (SQ) .766
Ostilità (SQ) .758
Rilassamento (SQ) .769
Contentezza (SQ) .726
Benessere fisico (SQ) .825
Buona disposizione (SQ) .769
Ricerca di novità (TPQ) .810
Evitamento del danno (TPQ) -.530
Dipendenza da ricompensa (TPQ) .826
Metodo di rotazione: Varimax
saturazione nel primo fattore. Questi 5 fattori spiegano sico e della buona disposizione (seconda misurazione).
cumulativamente il 65% della varianza. In questo lavoro le sottoscale del benessere dell’SQ
Nelle Tabelle 3-6 sono rappresentate le matrici di sono conteggiate all’inverso e i punteggi rappresenta-
correlazione fra gli indici di benessere, sintomatologici no quindi la mancanza di contentezza, rilassamento,
e di personalità. Le sei dimensioni del PWB sono cor- ecc. Ciò fornisce la spiegazione per le correlazioni ne-
relate in modo negativo e significativo con le scale del- gative fra dimensioni di benessere: invertendo il meto-
l’SQ, fatta eccezione per la scala dell’autonomia e del- do di scoring potremmo ottenere correlazioni positive
l’ostilità/buona disposizione e per quella della padro- con le scale del PWB (21).
nanza ambientale e della contentezza, del benessere fi- Per quanto riguarda le correlazioni tra dimensioni
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
318Il rapporto tra benessere psicologico, disagio e personalità
Tabella 3. Matrice di correlazione fra PWB e SQ (prima misurazione)
Ansia Depres- Sintomi Osti- Rilassa- Conten- Benesse- Buona
sione som. lità mento tezza re fisico disp.
Autonomia -.276** -.291** -.188** -.65 -.254** -.153** -.127** -.082
Padronanza ambientale -.454** -.490** -.268** -.28** -391** -.266** -.20** -.231**
Crescita personale -.154** -.194** -.169** -.16** -.132** -.190** -.117* -.143*
Relazioni positive -.237** -.296** -.207** -.269** -.194** -.271** -.118* -.345**
Scopo nella vita -.401** -.454** -.269** -.275** -296** -.235** -.16** -.159**
Accettazione di sé -.536** -.626** -.304** -.34** -.457** -.363** -.247** -.241**
* sign. < 0.05
** sign.Ruini C, et al.
Tabella 7. Differenze nei livelli di benessere, di disagio e di tratti di personalità in base al sesso (prima misurazione)
Scale Media (DS) Media (DS) F p
Maschi (N=192) Femmine (N=285)
Autonomia (PWB) 63.97 (6.4) 62.25 (10.2) 2.96 .086
Padronanza ambientale (PWB) 59.20 (10.7) 56.28 (11) 7.31 .007
Crescita personale (PWB) 63.59 (9.5) 61.51 (10.24) 4.41 .036
Relazioni positive (PWB) 62.92 (11.4) 63.42 (11.4) .19 .662
Scopo nella vita (PWB) 63.83 (10.3) 59.70 (11.1) 14.8 .000
Autoaccettazione (PWB) 62.24 (12) 57.60 (14) 12.35 .000
Ansia (SQ) 3.71 (3) 4.62 (3.6) 7.69 .006
Depressione (SQ) 2.38 (2.5) 3.83 (3.5) 23.55 .000
Somatizzazione (SQ) 2.86 (3) 4.70 (3.8) 30.58 .000
Ostilità (SQ) 3.27 (3.1) 3.80 (3.9) 2.37 .124
Rilassamento (SQ) 2.08 (1.6) 2.62 (1.9) 9.69 .002
Contentezza (SQ) 1.70 (1.8) 1.90 (2) 1.25 .264
Benessere fisico (SQ) 2.11 (1.7) 2.90 (1.9) 20.95 .000
Buona disposizione (SQ) 1.11 (1.4) 1.09 (1.6) .022 .882
Ricerca di novità (TPQ) 14.78 (5.6) 15.33 (5.5) 1.09 .295
Evitamento del danno (TPQ) 13.11 (5.9) 16.36 (6.2) 31.50 .000
Dipendenza da ricompensa (TPQ) 16.98 (4.1) 17.95 (4) 6.2 .013
Tabella 8. Differenze nei livelli di benessere, di disagio e di tratti di personalità in base al sesso (seconda misurazione)
Scale Media (DS) Media (DS) F p
Maschi (N=192) Femmine (N=285)
Autonomia (PWB) 67.34 (37.6) 62.62 (11.1) 3.38 .067
Padronanza ambientale (PWB) 59.25 (12.1) 59.35 (38.8) .001 .975
Crescita personale (PWB) 63.86 (10.1) 62.40 (10.55) 2.02 .158
Relazioni positive (PWB) 62.53 (11.3) 63.2 (12) .323 .57
Scopo nella vita (PWB) 63.59 (9.9) 59.94 (11.7) 11.15 .001
Autoaccettazione (PWB) 63.54 (11.3) 58.36 (13.8) 16.47 .000
Ansia (SQ) 3.41 (3.1) 4.66 (3.9) 13.05 .000
Depressione (SQ) 2.25 (2.6) 3.83 (3.5) 27.32 .000
Somatizzazione (SQ) 2.51 (3.1) 4.44 (3.8) 32.72 .000
Ostilità (SQ) 2.80 (3.1) 3.66 (4) 5.99 .015
Rilassamento (SQ) 1.85 (1.6) 2.64 (2) 19.98 .000
Contentezza (SQ) 1.57 (1.6) 2.10 (2.1) 8.27 .004
Benessere fisico (SQ) 1.95 (1.7) 2.83 (1.9) 24.57 .000
Buona disposizione (SQ) 1.15 (1.5) 1.21 (1.6) .178 .673
Ricerca di novità (TPQ) 12.29 (5.9) 15.71 (6) 33.25 .000
Evitamento del danno (TPQ) 16.54 (4.1) 17.76 (4.1) 9.58 .002
Dipendenza da ricompensa (TPQ) 14.51 (5.4) 15 (5.6) .840 .360
cofisico e caratteristiche di personalità. L’analisi fatto- disagio, benessere e caratteristiche di personalità, ma
riale, in cui è emersa una struttura formata da 4 o 5 fat- se vogliamo analizzare tali rapporti più nel dettaglio,
tori, mostra come queste dimensioni tendano a confi- dobbiamo prendere in considerazione le correlazioni
gurarsi separatamente, ma siano anche collegate fra lo- bivariate fra questi indici.
ro. Possiamo notare come in entrambe le misurazioni, Studi clinici recenti hanno sottolineato che il benes-
le scale del PWB siano saturate in un unico fattore, sere non può corrispondere semplicemente all’assenza
mentre quelle dell’SQ e del TPQ si dividano in due. di disagio psicofisico e che la rimozione dei sintomi
Questo dato replica un precedente studio in cui gli in- non necessariamente implica il ripristino del benesse-
dici sintomatologici, sia in pazienti che in soggetti di re (1,9,10,13,14). Pazienti con disturbi affettivi, trattati
controllo, presentavano saturazioni su due fattori, di efficacemente tramite farmacoterapia o psicoterapia,
cui uno più generico e uno più rappresentativo del ma- continuano infatti a presentare maggiore sintomatolo-
lessere somatico e dell’ostilità (22). L’analisi fattoriale gia residua e livelli significativamente inferiori di be-
fornisce senz’altro una visione globale dei rapporti tra nessere psicologico rispetto a soggetti di controllo. In
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
320Il rapporto tra benessere psicologico, disagio e personalità
queste ricerche le correlazioni fra indici sintomatologi- crescita personale e relazioni positive) (Tabella 2). In-
ci, di benessere, e di personalità hanno mostrato solo troduciamo quindi l’ipotesi che le dimensioni della
alcune sovrapposizioni parziali tra queste dimensioni, Ryff rappresentino una predisposizione individuale
che comunque si configuravano diversamente nel verso il funzionamento ottimale e il benessere psicolo-
gruppo dei pazienti e nel gruppo di controllo (9-11,22). gico. I punteggi al PBW rifletterebbero perciò un pro-
Nel nostro lavoro quasi tutte le correlazioni tra sca- cesso di valutazione soggettiva della propria qualità di
le del benessere e dei sintomi sono significativamente vita e non invece una semplice espressione delle carat-
negative (Tabelle 3 e 5). Questo dato è in linea con al- teristiche di personalità (4,24).
tri della letteratura che documentano correlazioni ne- Inoltre, le caratteristiche psicometriche e clinime-
gative tra i punteggi al PWB e livelli di depressione triche del PWB sollevano il problema della loro collo-
(2,3). Tuttavia, se esaminiamo i risultati con più atten- cazione all’interno del continuum stato-tratto (9). Il
zione, possiamo notare che tali correlazioni non sono questionario ha mostrato in altri lavori (2,18) una
poi così elevate (il valore maggiore è -0.642, Tabella 5) buona attendibilità test-retest: i punteggi, infatti, ten-
e sorprendentemente le correlazioni più deboli si han- dono a rimanere stabili a distanza di un mese. Tuttavia,
no proprio tra le scale del PWB e le sottoscale del be- è altrettanto vero che alcune dimensioni presentano
nessere dell’SQ. Possiamo ipotizzare, quindi, che non aumenti o diminuzioni in base alla variabile età
sia concettualmente e metodologicamente corretto de- (2,3,18). Inoltre, alcune ricerche longitudinali hanno
sumere la presenza di benessere semplicemente in ba- documentato modificazioni nei punteggi in risposta a
se all’assenza di disagio. Le correlazioni moderate o significativi eventi di vita (6,7); mentre anche specifici
addirittura basse tra questi indici mettono in luce come interventi psicoterapeutici si sono rivelati efficaci nel-
i punteggi alle scale sintomatologiche non possano pre- l’indurre incrementi importanti (9,13). Ipotizziamo
dire i livelli di benessere psicologico di una persona. quindi che le dimensioni di benessere postulate da Ca-
Uno studio di qualche anno fa (23) ha rilevato il rol Ryff contengano elementi ascrivibili sia allo stato
rapporto tra alcuni tratti di personalità, quali il nevro- che ai tratti di personalità, cioè che siano dinamiche,
ticismo e l’estroversione, e dimensioni di benessere. senza avere eccessive fluttuazioni nel breve termine.
Più tardi, tuttavia, Schmutte e Ryff (4) hanno eviden- Le Tabelle 3-6, in cui sono illustrate le correlazioni tra
ziato come tale rapporto possa essere molto più com- le scale del benessere e gli indici di stato (sintomi) e di
plesso e come le sei dimensioni della Ryff si collochi- tratto, rappresentano bene questa complessità. Una
no separatamente rispetto alle caratteristiche di perso- precedente ricerca ha evidenziato che il benessere e la
nalità, ma possano subirne l’influenza. Oltre al nevro- felicità, misurati con questionari composti da item for-
ticismo e all’estroversione, infatti, Schmutte e Ryff (4) mulati positivamente, sembrano dipendere maggior-
hanno documentato altre importanti relazioni tra trat- mente dagli eventi di vita di una persona piuttosto che
ti di personalità e dimensioni di benessere, in partico- dalle sue caratteristiche di personalità (25). In questo
lare la gradevolezza correlata fortemente con le rela- lavoro l’analisi fattoriale condotta suggerisce che alcu-
zioni positive; l’apertura all’esperienza, associata alla ne dimensioni del PWB, quali la crescita personale e le
crescita personale e la coscienziosità legata alla padro- relazioni positive, sembrano avvicinarsi maggiormente
nanza ambientale. ai costrutti di tratto, in quanto presentano saturazioni
In questo lavoro replichiamo questi dati con un anche nel “fattore di personalità” (Tabelle 1 e 2);
campione della popolazione italiana: la scala della cre- mentre altre, quali l’autonomia, sembrano essere più
scita personale è correlata positivamente con quella complesse e presentano correlazioni diverse in base al
della ricerca di novità (TPQ); quella delle Relazioni campione, alla situazione o al contesto culturale di ap-
positive con la dipendenza da ricompensa (TPQ); e in- partenenza. Questi dati sembrano sostenere l’ipotesi
fine quella dell’evitamento del danno presenta corre- secondo cui i profili di benessere possano dipendere
lazioni negative con tutte le dimensioni del PWB. dalla tipologia del campione, dalle sue circostanze di
I nostri risultati e quelli precedenti di Schmutte e vita o dalle fasi cliniche in cui viene effettuata la mi-
Ryff (4) sembrano contraddire l’opinione di alcuni ri- surazione (9). La letteratura ha già messo in luce come
cercatori secondo cui la misurazione del benessere ri- la valutazione della personalità, del benessere e del di-
sulta essere ridondante perché troppo collegata alle di- sagio possa variare in un campione clinico e uno di
mensioni di personalità (23). controllo e, all’interno dello stesso campione clinico,
L’analisi fattoriale condotta in questo lavoro docu- anche in base alla fase di sviluppo della patologia
menta la presenza di un singolo fattore legato al be- (9,22,26).
nessere, sia al test che al retest, con solo poche sovrap- Infine, in entrambe le misurazioni, sono emerse dif-
posizioni con le dimensioni di personalità (autonomia, ferenze significative nei punteggi dei questionari in ba-
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
321Ruini C, et al.
se alla variabile sesso. Le donne presentano infatti li- hancing evaluations in a successful life transition. Psychology
velli significativamente inferiori di benessere, fatta ec- and Aging, 2003,18, 3-12.
8. Ryff CD, Singer B, Love GD, Essex MJ: Resilience in adulthood
cezione per la dimensione delle relazioni positive con and later life. In: Lomranz J (ed) Handbook of Aging and Men-
gli altri. Anche nelle ricerche statunitensi le donne mo- tal Health. Springer-Verlag, New York, 1998.
stravano punteggi superiori in questa dimensione, ma 9. Rafanelli C, Park SK, Ruini C, Ottolini F, Cazzaro M, Fava GA:
non emergevano altre differenze significative con gli Rating well-being and distress. Stress Medicine, 2000, 16, 55-61.
10. Fava GA, Rafanelli C, Ottolini F, Ruini C, Cazzaro M, Grandi S:
uomini (2,3). Sembra quindi che le donne italiane in
Psychological well-being and residual symptoms in remitted pa-
questo campione stiano peggio rispetto a quelle ame- tients with panic disorder and agoraphobia. Journal of Affective
ricane. Non è dunque un caso che presentino anche più Disorders, 2001, 31, 899-905.
sintomatologia e disturbi di personalità rispetto agli 11. Ruini C, Rafanelli C, Conti S, Ottolini F, Mangelli L, Tossani E,
uomini. et al.: Benessere psicologico e sintomi residui nei pazienti con
disturbi affettivi. I. Rilevazioni psicometriche. Rivista di psichia-
Questo studio presenta alcuni limiti, in quanto il tria, 2002, 37, 171-178.
campione ha partecipato spontaneamente e non è ne- 12. Fava GA: Well-being therapy. Conceptual and technical issues.
cessariamente rappresentativo della popolazione ita- Psychotherapy and Psychosomatics, 1999, 68, 171-179.
liana. Tuttavia, le misurazioni sono state ripetute dopo 13. Fava GA, Rafanelli C, Cazzaro M, Conti S, Grandi S: Well-being
un intervallo di tempo di un mese e ciò consente di va- therapy. Psychological Medicine, 1998, 28, 475-480.
14. Fava GA, Rafanelli C, Grandi S, Conti S, Belluardo P: Preven-
lutare la stabilità dei fattori emersi nell’analisi fatto- tion of recurrent depression with cognitive behavioral therapy.
riale e l’attendibilità dei risultati ottenuti. Archives of General Psychiatry, 1998, 55, 816-820.
La conclusione maggiormente rilevante di questo 15. Fava GA, Ruini C, Rafanelli C, Grandi S: Cognitive behavior ap-
lavoro potrebbe essere che, da un punto di vista clini- proach to loss of clinical effect during long-term antidepressant
treatment: a pilot study. American Journal of Psychiatry, 2002,
co, è di fondamentale importanza valutare la presenza 159, 2094-2095.
di autonomia, crescita personale, padronanza ambien- 16. MacLeod AK, Moore R: Positive thinking revisited: positive
tale, scopo nella vita, relazioni interpersonali positive, cognitions, well-being and mental health. Clinical Psychology
autoaccettazione, e non semplicemente l’assenza di di- and Psychotherapy, 2000, 7, 1-10.
sagio, per poter affermare che un individuo presenta 17. Goldthorpe JH, Hope K: The Social Grading of Occupations.
Oxford University Press, Oxford, 1974.
una buona qualità di vita. 18. Ruini C, Ottolini F, Rafanelli C, Ryff CD, Fava GA: La vali-
dazione italiana delle Psychological Well-Being Scales (PWB).
Rivista di psichiatria, 2003, 28, 117-129.
19. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR: The Tridimensional
BIBLIOGRAFIA Personality Questionnaire: US normative data. Psychology Re-
port, 1991, 69, 1047-1057.
1. Ryff CD, Singer BH: Psychological well-being: meaning, mea- 20. Saviotti FM, Grandi S, Savron G, Ermentini R, Bartolucci G,
surement, and implications for psychotherapy research. Psy- Conti S, et al.: Characteriological traits of recovered patients
chotherapy and Psychosomatics, 1996, 65, 14-23. with panic disorder and agoraphobia. Journal of Affective Dis-
2. Ryff CD: Happiness is everything, or is it? Explorations on the orders, 1991, 23, 113-117.
meaning of psychological well-being. Journal of Personality and 21. Kellner R: A Symptom Questionnaire. Journal of Clinical Psy-
Social Psychology, 1989, 6, 1069-1081. chiatry, 1987, 48, 269-274.
3. Ryff CD, Keyes CLM: The structure of psychological well-being 22. Fava GA: Neurotic symptoms and major depressive illness.
revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, 69, Psichiatria Clinica, 1982, 15, 231-238.
719-727. 23. Costa PT, McCrae RR, Norris AH: Personal adjustment to ag-
4. Schmutte PS, Ryff CD: Personality and well-being: reexamining ing: longitudinal prediction from neuroticism and extroversion.
methods and meanings. Journal of Personality and Social Psy- Journal of Gerontology, 1981, 36, 78-85.
chology, 1997, 73, 549-559. 24. Keyes CLM, Shmotkin D, Ryff CD: Optimizing well-being: The
5. Heidrich SM, Ryff CD: Physical and mental health in later life: empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and
the self-system as mediator. Psychology and Aging, 1993, 8, 327- Social Psychology, 2002, 82, 1007-1022.
338. 25. Ormel J: Neuroticism and well-being inventories: measuring
6. Kling KC, Ryff CD, Essex MJ: Adaptive changes in self-concept traits or states? Psychological Medicine, 1983, 13, 165-176.
during a life transition. Personality and Social Psychology Bul- 26. Fava GA, Kellner R: Staging: a neglected dimension in psychi-
lettin, 1997,12, 288-295. atric classification. Acta Psichiatrica Scandinavica, 1993, 87, 225-
7. Kwan CML, Love GD, Ryff CD, Essex MJ: The role of self-en- 230.
Rivista di psichiatria, 2004, 39, 5
322Puoi anche leggere