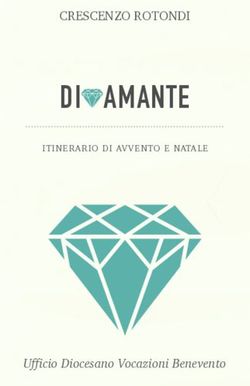Il Fregio della Vita Un confronto tra KLIMT e Munch - Spark (e-learning)
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
1862-1918, Vienna 1863-1944, Oslo
Fondatore e principale esponente della Interprete della stagione
simbolista
Wiener Secession
ed espressionista
Pittura ricca di simbolismo raffinato e letterario Esasperazione e violenza
cromatica
Cerebrale estetismo e acuta sensualità
Sentimento profondo e
Ritmo decorativo ottenuto mediante colore malinconico della natura, senso
e schemi geometrici doloroso dell'amore e della morte- IL PALAZZO DELLA WIENER SECESSION -
AD OGNI EPOCA LA SUA ARTE, ALL’ARTE LA SUA LIBERTÀ
Klimt, presidente della Secessione Viennese, Inaugurazione della XIV mostra della
è attivamente coinvolto nella progettazione, Wiener Secession delle arti unite curata
affidata a Olbrich. Il Palazzo, rivoluzionario da Josef Hoffman.
per il suo spazio interno modificabile, Presso il Palazzo della Secessione
introduce la moderna concezione di dell’architetto Joseph Olbrich, presenti il
allestimento in cui architettura di interni e
Gruppo scultoreo policromo Beethoven Fregio di Beethoven di Gustav Klimt e
arti applicate concorrono alla creazione di un
1902, Max Klinger le opere di Max Klinger. Il maestro
ambiente unitario. La XIV mostra della
Wiener Secession si tenne nel 1902. Il Gustav Mahler dirigerà l’Inno alla Gioia
Palazzo si trasformò in un autentico santuario dalla Nona Sinfonia di Beethoven;
di Beethoven, prototipo del genio artistico. Isidora Duncan eseguirà danze cultuali.Il FREGIO DI BEETHOVEN
Esposizione del 1902 dedicata a Beethoven presso il Palazzo della Secessione di Vienna
LE FORZE OSTILI
PARETE CENTRALE
220x636 cm
PARETE SINISTRA PARETE DESTRA
220x1378 cm 220x1381 cm
TECNICA MISTA SU SFONDO DI TEMATICHE DEL FREGIO
STUCCO • Raffigurazione della Nona Sinfonia di Beethoven nell’interpretazione di
• Colore alla caseina Wagner e dell’Ode alla Gioia di Schiller
• Foglia d’oro • Allusione alla teoria Nietzschiana del superuomo, condensata nella figura
• Pietre semipreziose del Cavaliere
• Intonaco • Lotta per la felicità contro le Forze Ostili e concetto di Ascesi, in relazione
• Carboncino alla filosofia di Schopenhauer
• Pastello • Opposizione tra bene e male e superamento delle tentazioni
• Matita • Riscatto ideale attraverso le arti, trionfo dell’eros e raggiungimento dell’Eden- L’ANELITO ALLA FELICITÀ - CAVALIERE, AMBIZIONE, COMPASSIONE, SUPPLICANTI Le tre figure nude, rappresentanti le Suppliche del Genere Umano, invocano il Cavaliere; alle sue spalle, impersonificate da due giovani donne, l’Ambizione, che regge una corona dall’alloro, e la Compassione, con gli occhi socchiusi. L’Uomo, il cui volto è quello di Mahler, impugnando lo spadone, muove un passo avanti con decisione e concentrazione. Il gusto stilistico, fortemente ornamentale e decorativo, confluisce nell’uso di una linea di contorno marcata e nella polimatericità. Il trionfo dell’oro nell’armatura del Cavaliere contrasta con la delicatezza e la semplicità, tipiche del Simbolismo, delle figure supplicanti.
- LE FORZE OSTILI -
GORGONI, MALATTIA, FOLLIA E MORTE
Le tre figure nude sulla sinistra sono le
Gorgoni, figlie del Gigante Tifeo; caricate di
una prepotente sensualità e delle
caratteristiche di una femminilità fatale,
tentano il cavaliere in un’alternanza di
piacere e angoscia. Nonostante l’anatomia
e la posa richiami l’ideale di bellezza
klimtiano (Nuda Veritas), il colore scuro,
inusuale nelle opere dell’artista, dei capelli,
tra cui si annidano anche dei serpenti,
contribuisce al senso di inquietudine.
Quest’ultima è ben alimentata dalle
personificazioni di Malattia, Follia e Morte,
i corpi scheletrici e pallidi che sovrastano le
giovani donne.
Il biancore delle nudità contrasta con il
colore scuro del resto della parete, che è
riempita in ogni centimetro da dettagli
decorativi.- LE FORZE OSTILI -
VOLUTTA’, LUSSURIA ED ECCESSO
Il Fregio prosegue con le allegorie di
Voluttà, Lussuria ed Eccesso.
Un nudo femminile tanto esplicito e non
solo aggraziato e sensuale, ha valso al
pittore accuse di oscenità e pornografia.
Le bocche rosse socchiuse, le gambe
ritratte verso il petto e i capelli sciolti
rappresentano alcuni dei tratti tipici del
paradigma klimtiano.
La figura dell’Eccesso presenta uno stile
materico molto evidente; infatti, la
decorazione della capigliatura e della
veste è costituita da elementi preziosi
applicati sopra il colore.- LE FORZE OSTILI -
IL GIGANTE TIFEO E ANGOSCIA
La metà destra della parete centrale è
occupata dall’ala e dalle anse del corpo
rettiliano del Gigante Tifeo, chimera la
cui testa richiama quella di un enorme
gorilla.
Dalla macchia di colore oro e rosso
intenso si staglia il corpo scarno di
Angoscia, rannicchiata e avvolta da un
leggero velo nero.- POESIA -
L’ANELITO ALLA FELICITA’ TROVA COMPIMENTO NELLA POESIA
La suonatrice di lira, soggetto già
studiato in Musica (a fianco),
rappresenta il compimento dei desideri
umani, impersonificati dalle figure
sospese.
Simbolo di tutte le arti, in particolare
Poesia e Musica, indica la strada maestra
per l’ottenimento della felicità.- L’INNO ALLA GIOIA -
CORO DEGLI ANGELI DEL PARADISO E BACIO
La scena, tripartita, ritrae,
sulla sinistra, una colonna
di figure femminili su
sfondo dorato, al centro, il
coro degli Angeli e a destra
l’abbraccio di una coppia.
«Gioia meravigliosa scintilla divina» «Questo bacio a tutto il mondo» - Schiller
La fascia centrale è carica di un valore rituale e le figure angeliche sono ritratte come sacerdotesse assorte in
un’estasi mistica.
Il senso di armonia che contraddistingue questa parte del fregio è veicolata dall’omogeneità delle espressioni e
dalla sinuosità della linea.
Il culmine del percorso del Cavaliere è rappresentato dall’abbraccio, dipinto all’interno di una campana,
rappresentante l’Eden stesso, con il Sole, la Luna e lo sgorgare di un corso d’acqua. Tuttavia, i volti degli amanti
sono celati, poiché si vuole elevare questo gesto ad un livello universale. Si tratta quindi della massima
rappresentazione visiva di ciò che Schiller intendeva con gli ultimi versi che chiudono la sua opera Ode alla
Gioia, che viene cantata sopra la Nona Sinfonia.Nel marzo del 1902, mentre a Vienna la Weiner Secession
prepara la sua XIV mostra, Munch espone presso la
Secessione Berlinese una selezione di 22 dipinti, che
IL FREGIO
chiamerà Fregio della Vita. All’interno dell’esposizione è
presente anche una riproduzione di una statua di Max
Klinger, Beethoven, che ci evidenzia l’affinità tra i
DELLA VITA riferimenti culturali di Munch e Klimt.
Le tele vengono presentate all’interno di un’unica cornice
bianca che corre lungo tutte le pareti della sala.
L’organizzazione spaziale in una sequenza continua
amplifica il significato di ogni opera che entra in risonanza
con le altre, venendo incontro all’esigenza tipica di un
pittore simbolista di rappresentare complessivamente il
destino umano attraverso un Fregio unitario, così come fa
l’artista viennese.
Le tele, che abbracciano le tematiche legate a
incomunicabilità, straniamento, solitudine e perdita, sono
suddivise dallo stesso Munch in quattro capitoli, alla
stregua di quelli di un libro pittorico: Seme dell’Amore,
Sviluppo e Dissoluzione dell’Amore, Angoscia, Morte.
L’interesse verso questi temi prende nuovo valore se li si
inquadra nel contesto sociale della Oslo in cui Munch
inizia il proprio percorso artistico: questa città dai freddi e
rigorosi edifici, è pregna di un puritanesimo perbenista,
borghese e protestante. L’artista si propone quindi in
antitesi a questa concezione, valorizzando i temi di vita,
morte, angoscia, malattia, amore.Capitolo 1: Il Seme dell’Amore Il Bacio,
1897
Rosso e Bianco, 1899-1900
Notte stellata, 1893
Danza sulla Spiaggia,
1900-1902
Occhi negli Occhi, Madonna,
1899-1900 1893-1894
Nel primo capitolo, Munch mette in scena l’Amore Nascente. Troviamo qui opere come Il Bacio, in cui i volti
degli amanti si fondono perdendo, tuttavia, la propria identità, e come Madonna, dove la figura femminile
che concede se stessa raggiunge una bellezza dolorosa. Si inizia ad intuire il tema, ripreso dallo stesso
Freud solo qualche anno più tardi, di Eros e Thanatos, Amore e Morte, come indissolubilmente legati.Capitolo 2: Sviluppo e Gelosia,
Dissoluzione dell’Amore 1895
Ceneri,
1894
La Donna
in Tre Fasi,
1894
Vampiro,
1893-1894
La Danza
della Vita, Malinconia,
1899-1900 1894
Il secondo capitolo è il racconto pittorico dell’Amore che Fiorisce e Passa. Ciò è ben rappresentato
ne La Danza della Vita e ne La Donna in Tre Fasi dove i tre momenti della vita, il bianco della
giovinezza fiduciosa, il rosso della maturità appassionata e il nero della vecchiaia amara, mettono
in scena il ciclo esistenziale del sentimento amoroso e della sua fine dolorosa.Capitolo 3: Angoscia Golgota,
1900
Edera Rossa, 1898
Il Grido,
1895
Angoscia, 1894
Sera sul Viale Karl Johan, 1892
Il capitolo terzo è la massima espressione dell’Angoscia. I volti scheletrici e dagli occhi scavati sono in Sera sul
Viale e Angoscia un mezzo di critica sociale verso l’omologazione della borghesia, ma diventano, ne Il Grido,
specchio di uno straniamento e di un’incomprensione vissuti dallo stesso artista. Le linee ondulate e i colori
violenti rispecchiano pienamente l’esasperazione stilistica che diventerà la cifra caratteristica di Munch.Capitolo 4: Morte Metabolismo.
La Vita
Il Letto e la Morte,
di Morte, 1898-1899
1895
Odore
di Morte,
1895
La Madre
Morta e la
Bambina,
Morte nella 1897-1899
Stanza della
Malata,
1895
Il capitolo quarto è completamente intriso del tema del Lutto. I ricordi delle tragedie che hanno segnato
l’infanzia di Munch trovano qui espressione sottoforma di ambienti claustrofobici e senso di
incomunicabilità del dolore. I colori caldi dei pavimenti non cedono il passo a tinte grigie e, anzi, alimentano
la sensazione di una attesa allucinata. Metabolismo rappresenta, dunque, un’eccezione al tema domestico
proponendo un simbolo del ciclo cosmico attraverso lo slancio dei tronchi dalle radici al cielo.Munch: Il Grido, La Madre Morta e la Bambina,
Morte nella Stanza della Malata
La Tecnica di Munch
Se per Klimt l’imperativo è oro e polimatericità, Munch utilizza per la
maggior parte delle opere del suo Fregio colori ad olio applicati su tela;
esistono però delle eccezioni: Il Grido, infatti, uno dei quadri più
rappresentativi della poetica e della tecnica munchiana, è in realtà dipinto
su cartone con olio, tempera e pastelli. Altre piccole eccezioni sono
alcune tele del Quarto Capito: Morte nella Stanza della Malata è dipinta
con tempera e pastello su tela, mentre in Odore di Morte e La Madre
Morta e la Bambina sono state usate tele non impregnate su cui sono
state apportate pennellate di tempera e colori ad olio. E tutto ciò riguarda
solamente le 22 opere del Fregio: sono, infatti, centinaia gli schizzi, i
pastelli, le litografie e le diverse versioni di ogni soggetto.
L’uso del colore in Munch è molto caratteristico e profondamente legato
al significato della sua poetica. Le sue opere più tragiche e sofferte, come
Il Grido, sono quelle che, paradossalmente, hanno la gamma di colori più
accesa e calda: i colori urlano, sono vitali; eppure ciò che comunicano è
un senso di oppressione e soffocamento: le nuvole tendono al rosso
sangue.
L’attitudine di Munch nei confronti dei suoi lavoro è sicuramente
particolare: accatastati per anni nel suo studio a Ekely, vicino a Oslo,
furono rovinati da polvere e umidità, addirittura era non noncurante di
calpestarli. Infatti, diceva: un bel quadro sopporta molte cose, sono i
cattivi quadri che hanno bisogno di molta cura e di belle cornici.KLIMT e Munch Per entrambi gli artisti, il proprio Fregio racchiude il significato dell’esistenza in un’ottica universale, diventa rappresentazione complessiva del destino umano. Inoltre, li accomuna una visione dell’Arte vicina a quella della Musica: le opere sono concepite come sinfonie che concretizzano le idee filosofiche dei loro creatori. Anche il substrato culturale in cui questi maestri si muovono è simile: la filosofia pessimistica e ascetica di Schopenhauer; le influenze nietzschiane, con la teoria dello Übermensch; i primi studi di Freud sull’inconscio; l’appartenenza al movimento simbolista europeo. Tuttavia, sono proprio le visioni di fondo sui grandi temi esistenziali che dividono nettamente i due artisti: se Klimt, attraverso l’Arte, vede una possibilità di salvezza dalle Forze Ostili e di raggiungimento di Felicità e completezza, Munch concepisce la vita come un continuo ritorno ad elementi dolorosi e angoscianti, che coinvolgono anche lo stesso sentimento amoroso, inseparabile dalla Morte; neppure nell’Arte si trova un riscatto. Infine, dal punto di vista stilistico, il gusto raffinato del dettaglio e della decorazione di Klimt impatta con forza contro la concretezza e la violenza cromatica di Munch.
La concezione di Amore
klimtiana anela all’ideale:
l’abbraccio corrisponde a
eros
quell’unione che, come quella di e
Sole e Luna, è universale e eden
genera vita, rappresentata
dall’acqua. La campana dorata
che circonda gli amanti è simbolo
dell’Eden, visto come il Paradiso
Terrestre, luogo di perfezione e
felicità. Il bacio è quindi Amore
perfetto, puro e assoluto.
Munch ribalta diametralmente questa concezione, presentando i
suoi due amanti stretti in un abbraccio che li annulla: i loro volti
sono fusi, ma non in un’unione generatrice, al contrario,
annichilente. La stessa forma a campana, riproposta anche in
questo caso, diventa un involucro soffocante. Il sentimento
amoroso non può essere scisso da dolore e morte.
Anche il riferimento biblico è rovesciato: in Metabolismo, ciò che in
Klimt era vita e fecondità, diventa colpa e monito di morte. E di
nuovo, la tela Occhi negli Occhi, il cui titolo suggerisce la massima
intimità, mostra una distanza insolcabile tra i due; inoltre, si
ripresenta la trasfigurazione del volto dell’uomo in un teschio.
Klimt: L’Abbraccio; Munch: Il Bacio, Occhi negli Occhi, Metabolismo. La vita e la Mortedonna
La rappresentazione del corpo femminile in questi
due artisti tradisce la loro concezione del rapporto tra
i sessi. Per Munch, la bellezza della donna è un
rimando doloroso: molteplice e misteriosa, la
femminilità viene vista come elemento attraente ma,
al contempo, ostile. In Vampiro, questa concezione è
estremizzata: la donna ammalia con una fascino al
limite del demoniaco portando l’uomo
all’annichilimento. Nella tela La Donna in Tre Fasi,
inoltre, si inquadra l’esistenza femminile in tre
passaggi: la speranza giovanile, indicata dal colore
bianco, simbolo di purezza e dell’amore ideale, la
sensualità adulta, identificabile nel nudo, allegoria
della Lussuria, e una maturità amara e piena di
rimpianti, identificabile nel nero, dove la donna è
fedele, ma infelice; l’uomo sulla destra tiene in mano
il fiore del dolore che, benché rosso di amore
passionale, è straziato. In Klimt, invece, si coglie il lato
sensuale del corpo femminile, che è sia elemento di
tentazione che tramite per il raggiungimento di una
perfezione assoluta. Infine, l’artista viennese è anche
capace di ritrarre corpi privi di una marcata vena
Klimt: Le Gorgoni, Suppliche del Genere Umano; seduttiva, al contrario, delicati e naturali.
Munch: Madonna, La Donna in Tre Fasi, Vampiroangoscia
Come spesso accade in Munch, i titoli delle opere
sono concetti astratti che vengono impersonificati
dai personaggi raffigurati e resi attraverso lunghe
pennellate.
Il processo di Klimt è più colto, poiché procede
per allegorie.
Nel confronto tra la resa artistica dei due maestri
si notano divergenze drastiche: in Klimt l’Angoscia
è incarnata da un’esile donna, il cui corpo è
rannicchiato e avvolto da un leggerissimo velo
scuro. La tensione della figura è verso l’interno, i
suoi occhi sono chiusi e il capo chino. Il biancore
pallido contrasta con lo sfondo riccamente
decorato del corpo del gigante Tifeo.
Munch invece propone quadri assordanti: la
spinta verso l’esterno del grido fa vibrare l’aria
circostante in dense onde di colore. Il paesaggio
non è altro che amplificazione dello stato emotivo
del pittore. Le figure sono scheletriche, con gli
occhi spalancati e vestite di pesanti abiti scuri.
Klimt: L’Angoscia; Munch: Angoscia, Il GridoSITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA
▪ Catalogo online del Munch Museet di Oslo: Munch Museet
▪ Video del Canale YouTube «Smarthistory»: Gustav Klimt,
Beethoven Frieze
▪ Documentario Pittori del 900, Edvard Munch di Raffaele
Andreassi ricaricato su YouTube: Edavrd Munch
▪ Catalogo della mostra presso il Museo Correr di Venezia
(24.03_8.07.2012) Klimt: nel segno di Hoffman e della
Secessione
▪ Volume dedicato a Klimt della collana I Classici dell’Arte – Il
Novecento, Skira 2004
▪ Klimt di Gottfried Fliedl, Taschen 2003
▪ Le edizioni di Art Dossier dedicati a Munch e Klimt curati da Eva
di Stefano, Giunti 1994/6
▪ Klimt – L’artista e le opere, Giunti 1999Puoi anche leggere