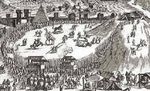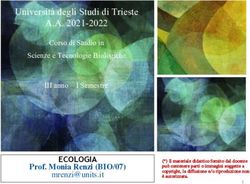Il Carnevale Romano Donatella Cerulli - ARCA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CURIOSITÀ ROMANE
Il Carnevale Romano
Donatella Cerulli
Sigmund Freud, in Totem e Tabù, scrive che la «festa è un eccesso permesso, anzi
offerto…». Goethe, però, in Viaggio in Italia precisa che «Il Carnevale di Roma non è
una festa che si offre al popolo, bensì una festa che il popolo offre a se stesso. (…) Tutti
hanno il permesso di essere pazzi e folli come gli piace, e quasi tutto, tranne i pugni e le
pugnalate, è lecito».
Ripercorrere la storia del Carnevale Romano è come fare un lungo viaggio nel tempo,
sempre in bilico tra follia e gioiosità, sacro, profano e un’oscura ombra di crudeltà.
Ormai è chiaro: molte delle nostre festività hanno origini lontane, in quel variegato
mondo pagano dei nostri antenati. Non fa eccezione il Carnevale Romano, erede dei
Saturnalia e dei Baccanali dell’antica Roma che celebravano un sovvertimento
dell’ordine sociale, un rovesciamento di tutte le gerarchie pubbliche e familiari
all’insegna del semel in anno licet insanire, “una volta l’anno è lecito impazzire”. Ed è
proprio da queste festività religiose che si tramandano molte usanze tipiche del
carnevale dei nostri giorni: maschere, travestimenti, comportamenti spesso sfrenati,
divertimenti pubblici e privati, balli, sfilate di carri allegorici1 e perfino il consumo dei
tipici dolci carnascialeschi, le frappe.Le Frappe di Apicio
Nell’antica Roma, durante i Saturnalia, venivano distribuiti tra la folla per strada i frictilia,
dolci fritti nel grasso di maiale e poi immersi nel miele. Marco Apicio, gastronomo, cuoco e
scrittore romano vissuto a cavallo fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., nel De re coquinaria le
descrive come «frittelle a base di uova e farina di farro tagliate a bocconcini, fritte nello strutto
e poi tuffate nel miele». I frictilia sono sopravvissuti fino ad oggi, con solo piccole modifiche
alla ricetta originale, a seconda delle varie tradizioni regionali. Purtroppo, in nome del
salutismo e delle diete, il miele è sparito sostituito da un velo di zucchero ed è sempre più raro
trovare frappe fritte nello strutto: si preferisce friggerle nell’olio o cotte al forno.
Le prime testimonianze del Carnevale Romano le rintracciamo nel XII secolo quando,
nei giorni precedenti la Quaresima, iniziò a svolgersi una tradizionale cavalcata del
papa fino a Testaccio, in compagnia di patrizi e cavalieri. In quell’occasione i nobili si
cimentavano in duelli, pali, giostre e gare di tauromachia nella piana sotto Testaccio
dove nell’antichità si celebravano le feste dionisiache.
L’evento, ovviamente, richiamava il
popolo a frotte sia per la spettacolarità
sia, soprattutto, perché era l’occasione
di impadronirsi impunemente della
carne degli animali uccisi durante i
combattimenti. In seguito i giochi si
svolsero anche nel centro di Roma: a
Piazza Navona si tenevano i giochi
cavallereschi, mentre Testaccio, al
tempo pressoché disabitato, ospitava i
divertimenti più licenziosi e cruenti,
come la Ruzzica de li porci: dalla sommità della collina si facevano rotolare dei carretti
2
carichi di maiali che arrivavano a valle più morti che vivi con grande gaudio del popolo
che si contendeva furiosamente le carcasse dei malcapitati suini.
Nel Rinascimento, con l’avvento al soglio pontificio di papa Paolo II, il Carnevale
Romano assunse quelle folli caratteristiche di cui scrissero celebri autori stranieri e le
celebrazioni furono spostate in Via Lata, poi ribattezzata Via del Corso in virtù delle
“corse” di uomini e animali che si svolgevano lungo la strada.
A metà del 1400, infatti, papa Paolo II Barbo, già cardinale di Venezia, si fece costruire
a Piazza S. Marco uno splendido palazzo, una parte del quale fu concessa come
ambasciata alla Repubblica di Venezia: Palazzo e Piazza portano così questo nome.
Desideroso di valorizzare l’edificio, il papa spostò i festeggiamenti del Carnevale da
Testaccio a Via Lata.
Come scrisse lo storico Ludvig von Pastor (1854-1928) nella sua Storia dei Papi, Paolo
II inaugurò il “suo” carnevale il 9 febbraio del 1466 con sfilate di «cortei bacchici,
rappresentazioni mitologiche di numi, di eroi, di ninfe e di geni e dalla loggia del suo
palazzo volle essere spettatore delle corse ordinando che se ne fissasse la partenza
sotto l’arco di Dominazione3 e l’arrivo sotto le sue finestre.»L’entusiasmo dei romani fu tanto e tale che papa Barbo emanò addirittura un regolamento che elencava dettagliatamente quando e quali gare si dovevano svolgere: primo lunedì: corsa degli ebrei;4 primo martedì: corsa dei bambini cristiani; mercoledì: corsa dei giovani cristiani; giovedì grasso: corsa dei vecchi ultrasessantenni; secondo lunedì: corsa degli asini; martedì grasso: corsa delle bufale. Nel tempo, a queste corse “regolamentari” se ne aggiunsero altre, frutto dello spirito cinico e a volte crudele dei Romani: la corsa dei nani e quella degli zoppi, la corsa dei deformi e, dal 1501, anche la corsa delle prostitute, istituita da papa Alessandro VI Borgia. Negli anni successivi, per consolarsi dell’abolizione della Corsa degli Ebrei, all’apertura del Carnevale furono riservati eventi ancora più crudeli: l’esecuzione in piazza di condanne a morte o di pene corporali. Durante tutti gli otto giorni di Carnevale si svolgeva, poco prima del tramonto, l’evento più atteso: la violenta Corsa dei Barberi, ovvero la corsa dei cavalli berberi, una razza di piccoli ma muscolosi cavalli di Barberia5. La Corsa dei Barberi Questi piccoli cavalli di Barberia venivano fatti correre senza finimenti e senza fantino, ma stretti sul dorso da un insieme di corde alle quali erano appese delle palle irte di punte acuminate che fungevano da sprone. Incitati dalle urla degli spettatori e inferociti dal dolore, i poveri animali venivano lanciati in una folle corsa lungo via Lata che iniziava a piazza del Popolo e terminava a piazza Venezia. Al traguardo venivano fermati da un lungo telone tirato da una parte all’altra della strada, mentre i barbareschi, impavidi e nerboruti mozzi di stalla, si gettavano fra i cavalli tentando di bloccarli a viva forza. Il proprietario del cavallo vincitore era premiato con un palio, un prezioso drappo di stoffa ricamato, mentre premi speciali venivano assegnati a coloro che nell’ultima parte della gara riuscivano a saltare in groppa ai cavalli. Il tutto, dalla partenza all’arrivo, fra l’entusiasmo generale e una violenta confusione. Per buona pace dei Romani più morigerati si svolgevano anche pacifiche manifestazioni festose: balli in piazza, cene in osterie, sfilate in maschera e di carri allegorici, lancio di dolcetti di zucchero (con al centro un seme di coriandolo) e di sbruffi (pezzetti e palline di carta colorata) e magnifici spettacoli pirotecnici. Il Carnevale si concludeva la sera del martedì grasso con la suggestiva Festa dei Moccoletti che chiudeva un periodo di baldoria generale a cui partecipavano tutti, perfino preti, frati e monache, anche se esclusivamente al chiuso dei loro conventi nei quali erano ammessi musica, balli, sontuosi pranzi e travestimenti. Ma, siccome a tutto
c’è un limite, alle monache di clausura era consentito travestirsi solo con gli abiti dei
loro confessori…
Addio ammascherate e carrettelle,
pranzi, cene, marenne e colazione,
fiori, sbruffi, confetti e carammelle.
Er carnovale è mmorto e sseppellito:
li moccoli hanno chiusa la funzione:
nun ze ne parla ppiú: ttutt’è ffinito.6
La Festa dei Moccoletti
Inaugurata per la prima volta nel 1773, la Festa si svolgeva al tramonto del Martedì
Grasso, lungo via del Corso, e sanciva l'apice e la chiusura del Carnevale in uno
spettacolare tutti contro tutti, ognuno rigorosamente munito di un moccoletto, una
candela che poteva essere grande come un cero pasquale o sottile come la “coda di un
sorcio”. Al grido di Mor’ammazzato chi non porta er mòccolo, «Ognuno dei presenti
sembra animato da un solo proposito e cioè spegnere la candeletta degli altri e
mantenere accesa la propria; e tutti, uomini, donne e ragazzi, signori e signore, principi
e contadini, italiani e stranieri, vociano, strillano e urlano incessantemente ai vinti in
aria di canzonatura: “Senza moccolo! Senza moccolo!”»7
Alle prime luci dell’alba di mercoledì, dopo otto giorni e otto notti di sfrenatezze,
eccessi, follie e violenze, i Romani, contriti e pentiti, si riversavano nelle tante chiese
cittadine, vere e proprie “lavanderie” delle
anime sporche, dove si confessavano, si
battevano il petto e ricevevano le Ceneri…
Insomma, durante il Carnevale a Roma
succedeva davvero di tutto, tanto che Goethe
invitava i turisti ad assistere al Carnevale
Romano «non fosse altro che per togliersi
dalla mente il desiderio di rivederlo»...
Per oltre quattro secoli il Carnevale Romano, celebre in tutta Europa, fu al centro della
vita sociale, politica e culturale della Città coinvolgendo papi, nobili, potenti, celebri
artisti e letterati che prestarono la loro arte come scenografi, pittori, poeti e autori.Nel Carnevale del 1874, durante la Corsa dei Barberi, un giovane morì calpestato dai
cavalli sotto gli occhi dei Reali d’Italia. Il Consiglio Comunale, motivato né da spirito
animalista né, tantomeno, umanitario, abolì la Corsa ritenendola un retaggio della
Roma papalina, troppo popolare e indegna per la nuova capitale d’Italia.
La soppressione della Corsa segnò il declino del Carnevale Romano, a lungo rimpianto
come verseggiò Trilussa nel sonetto Er carnovale de mo’:
Leva er tarappattà, leva la gente
Leva le corze… la bardoria è morta,
Er carnovale s’ariduce a gnente.
Dicheno bene assai li mi’ padroni:
De tutt’er carnovale de ‘na vorta
Che ciarimane mò? ‘N par de… vejoni
Note
1 Le Antesterie, feste dionisiache che si svolgevano all’equinozio di
primavera, erano caratterizzate da un corteo in cui sfilavano i carri
del sole, della luna e dei segni zodiacali: antenati dei nostri carri
allegorici.
2 Ruzzica: «Grosso, massiccio disco di legno, da lanciarsi su un
terreno sgombro da ostacoli, per mezzo di una corda avvolta in più
giri attorno al bordo. Serve a gareggiare tra più giocatori, tra i quali
vince quello che riesce a mandare la “ruzzica” più lontano.»
Fernando Ravaro, Dizionario romanesco, vol. 2.
3Lo scomparso Arco di Portogallo, all’altezza di via della Vite.
4 Prima della gara gli Ebrei erano costretti a rimpinzarsi di cibo per
renderli più goffi e impacciati. Papa Clemente IX nel 1667 mise fine
a questa corsa, ma da allora gli Ebrei dovettero accollarsi buona
parte delle spese di organizzazione del Carnevale e costretti a
subire un’oltraggiosa cerimonia: il Rabbino Capo, in ginocchio in
Campidoglio davanti alle autorità comunali, pronunciava un
discorso di pentimento a cui il Senatore rispondeva con le parole Andate! Per quest’anno vi
soffriamo, rifilando un poderoso calcio nel sedere del Rabbino.
5 Una denominazione un po’ vaga utilizzata in passato per indicare paesi quali Marocco,
Algeria, Tunisia e Tripolitania.
6 Giuseppe Gioacchino Belli, Er primo giorno de quaresima.
7 Charles Dickens, Impressioni d'Italia.Puoi anche leggere