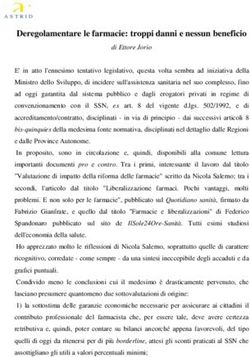Fiat: storia di un management orientato al fallimento
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Fiat: storia di un management orientato al fallimento
di Mario Rosso
Mario Rosso spiega il clamoroso fallimento manageriale della Fiat, ovvero come praticando il
quality management al contrario, l'azienda sia arrivata al fallimento.
(Tratto da: Qualitas 1998: http://www.qualitas1998.net/qualityreport/caso_fiat.htm)
Il cosiddetto «caso Fiat» è stato negli ultimi giorni oggetto di ogni tipo di commento. E
ben lo merita, per la gravità della crisi, le sue dimensioni e l'impatto sull'economia, sugli
equilibri di potere, per la straordinaria complessità di qualsiasi piano di intervento, e per
l'apparente rapidità e imprevedibilità di questo livello di disastro.
Perché di disastro si tratta, come sa chi ha seguito dall'interno dell'azienda, o da
posizioni molto vicine al management e ai meccanismi decisionali, l'incredibile sequenza
di errori, superficialità, mistificazioni, che hanno portato in quattro, cinque anni, la Fiat a
questo punto.
Mi sembra che nei commenti e lamenti che stanno accompagnando questa storia
italiana, quella che continua a mancare sia una serena critica e autocritica di come e
perché questo è accaduto, e almeno una piccola riflessione su come fare per evitare
che accada ancora.
Intanto, gli attori di questo dramma sono diversi: in prima approssimazione almeno la
«proprietà», poi il management, quindi i politici, i giornalisti, e, non ultimo, il sindacato.
Ripercorriamo quindi, senza pretese di scientificità e oggettività, le vicende più recenti.
Con l'uscita di Vittorio Ghidella, e in particolare con quel tipo di uscita violenta, senza
l'onore delle armi, Fiat Auto ha perso una leadership insostituibile, non per qualità o doti
sovrumane di Ghidella (rimasto non a caso «l'ingegnere» per antonomasia nel lessico
dei quadri di Fiat Auto) ma per un raro mix di competenza sul prodotto, di passione, di
determinazione, di carisma specifico per quella fase strategica di quella Fiat.
Eppure, per tutta la successiva gestione Romiti, nonostante evidenti debolezze
commerciali, la Fiat è riuscita a mantenere una struttura relativamente solida,
un'identità operativa che faceva comunque guardare alle difficoltà con preoccupazione,
ma con la consapevolezza di avere le risorse per affrontarle.
Dall'uscita di Romiti, comincia una spaventosa accelerazione del declino. Una serie di
scelte sugli uomini, sbagliate in modo evidente, spesso ambigue e paralizzanti:
Roberto Testore viene nominato amministratore delegato di Fiat Auto e presentato al
costernato consesso degli «alti direttori» del Gruppo: «E' di ottima famiglia, abbiamo
avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di suo padre...».Tuttavia Cantarella, nominato contestualmente amministratore delegato del Gruppo
Fiat, manterrà per sé le deleghe relative alla progettazione e allo sviluppo dei prodotti.
Questo rende monco e delegittimato il ruolo di Testore, ed espone la Progettazione di
Fiat Auto a una totale mancanza di guida, di indirizzi, di sostegno e sicurezza. Stilisti,
tecnici, tecnologi sono esposti alle incursioni di Cantarella, che interviene anche su
aspetti di dettaglio, modifica il disegno delle maniglie e dei bocchettoni per la benzina,
rifiutandosi di ascoltare qualsiasi critica, e intanto si sbagliano alcune delle decisioni
fondamentali: la richiesta del Marketing di fare una vettura per città piccola a quattro
porte viene bollata come «ignorante», perché «ingegneristicamente sbagliata».
Un anno dopo, il mercato viene invaso dai modelli giapponesi a quattro porte,
devastando le quote di mercato Fiat.
Anno dopo anno viene rimandato lo sviluppo di un Suv (Sport utility vehicle), nella
convinzione, più volte ribadita, che il consumatore affluente ed evoluto non potrà mai
accettare auto sostanzialmente scomode, meno veloci e confortevoli delle grandi
berline di lusso (Mercedes, Bmw, Lancia). Si manca totalmente di quel minimo di
apertura al mercato, o di disponibilità a imparare, che consentirebbe al management di
aprirsi ai nuovi modelli di consumo.
Tutti capiscono che il boato che viene dalla folla prelude a una rivolta, e non a un
trionfo. Tranne l'imperatore, che parla di programmi e obiettivi impossibili, che nessuno
gli contesta con i fatti, tantomeno una corte delusa e intimorita. Intanto Rover, Toyota,
Chrysler, Gm si incuneano nel nuovo segmento (ad alta profittabilità), lo fanno
crescere e lo occupano in modo irreversibile.
World car
Ma vogliamo parlare di globalizzazione? Anzitutto, ancora, sul prodotto. Alla prima
dichiarazione sullo sviluppo di una world car, cioè di un modello medio economico
sostanzialmente uguale per il pubblico meno abbiente dei Paesi evoluti e per le nuovi
classi medie delle nazioni in sviluppo (Sud America, India, Cina, Est Europa), i grandi
concorrenti gongolano. E' infatti noto a tutti che i tentativi finora compiuti (principalmente
da General Motors e da Renault) hanno dimostrato che si tratta di un'idea fallimentare
dal punto di vista del marketing. Un'ossessione di ottimizzazione ingegneristica non
vuole o non sa tener conto del fatto che bisogni e percezioni dei consumatori sono
ancora in fasi troppo diverse per poter essere soddisfatte da un'offerta identica e
venduta come identica.
Inoltre la necessità di standardizzare costringe all'allineamento delle soluzioni tecniche
e di design verso il basso, dando vita a uno dei modelli meno riusciti degli ultimi anni, la
Palio, superata in negativo solo dalla Duna, che rialimenta così l'aneddotica deteriore
sulla qualità del prodotto Fiat, cui in gran parte risale la distruzione di valore del
marchio operata negli ultimi anni.
Ma, a parte il prodotto, con quale cultura si vuol fare la globalizzazione? Pochi esempi.In India
Si deve costruire uno stabilimento in India. I manager della società locale
predispongono progetti e piani tramite società di ingegneria e di costruzione indiani;
infatti essi conoscono normativa, prassi, esigenze locali di chi concretamente ci
lavorerà, e sanno come sveltire i lavori e risparmiare.
Ma al momento di partire con la costruzione, arriva un diktat: bisogna utilizzare la
società interna di Fiat, Fiat Engineering, all'interno ribattezzata Fiat Geometring per la
sua burocrazia, costi alti e rigidità di soluzioni. Risultato: ritardo di sei mesi, costi più alti
del 35%, soluzioni organizzative e strutturali che niente hanno a che fare con le
modalità operative locali. A un timido accenno a questi e altri problemi operativi, nel
corso di un incontro di Progress Report, si replica con rabbioso fastidio: «Ma vi rendete
conto della soddisfazione di aver sentito parlare piemontese in India?».
Allo sgomento gruppo di manager che assiste alla scena rimane solo l'amara
consolazione di aver capito, forse prima di altri, uno dei motivi dell'inevitabile insuccesso
Fiat: perché dietro «Gianduja a Bangalore» (come viene immediatamente
soprannominata questa filosofia di globalizzazione), sta non solo una svuotata
riedizione della vecchia teoria della «one best way», ma una sua interpretazione
provinciale e arrogante, installata e radicata su un sistema di potere che non si riesce a
scuotere.
A gestire gli organici della nuova società in India viene inviata una responsabile del
personale piemontese che non parla inglese.
Argentina
Un altro semplice esempio: a metà degli anni '90, improvvisamente, prende corpo la
decisione di investire in un nuovo stabilimento per la produzione di automobili in
Argentina. Non un solo elemento delle analisi conforta questa decisione, anzi. I vecchi
manager Fiat Auto, al solo sentire il nome «Argentina», rabbrividiscono: ricordano
ancora con preoccupazione le storie della precedente avventura argentina di Fiat Auto:
volatilità del mercato, corruzione, problemi sociali, sequestri di persona: un fallimento
ben presente nella memoria.
Inoltre tutti sanno che la capacità produttiva installata in Brasile è più che sufficiente a
soddisfare le necessità dell'Argentina, anche perché il Brasile è ben noto per le sue
accentuate ciclicità, e quindi si presta bene a espansioni e contrazioni della capacità
produttiva. Nonostante tutto - e malgrado gli altri «Capi Settore», che si tenta di
coinvolgere nella avventura, facciano una rabbiosa resistenza e opera di dissuasione
(Giancarlo Boschetti per Iveco e Riccardo Ruggeri per New Holland) - il processo
decisionale va avanti inarrestabile, tra la sfiducia e lo scoraggiamento generale.Oggi le attività argentine sono letteralmente un cumulo di macerie. I veri numeri non si
sapranno mai. Ma come minimo, parlando solo dei costi diretti, si possono
approssimare per difetto a duemila miliardi di vecchie lire di perdite, tra investimento
iniziale (mille miliardi?) e perdite dei successivi tre anni (altri mille?).
Outsourcing
Intanto all'interno di Fiat Auto procede a grandi passi una politica di outsourcing
sbagliata: si spezzetta il ciclo operativo e produttivo in decine di segmenti che vengono
venduti all'esterno, appaltati a specialisti o fornitori. Prima tocca a logistica, trasporti e
manutenzioni. Poi si passa alle fasi del ciclo produttivo: stampaggio, verniciatura. Così
la complessità aumenta invece che diminuire, si perde il controllo della catena del
valore, i dipendenti della Fiat Auto passano da 85.000 a 25.000.
Questo processo, che richiede rigorose procedure sindacali, passa totalmente ignorato
da tutti: il sindacato, ipnotizzato dalla faccia di Gorgone del nome Fiat, o ricattato dalla
logica del male minore, o malamente coinvolto, o semplicemente incapace e
inadeguato (ricordo che gran parte di questo disastro avviene durante il governo del
centrosinistra) si affanna a salvare l'albero mentre si distrugge la foresta; contratta le
«garanzie» ad ogni spin-off, mentre è chiaro a tutti che è l'intero apparato aziendale a
scivolare verso il collasso.
E il management? Viene sistematicamente sottoposto a un processo di
«omologazione», tramite la marginalizzazione del diverso, la criminalizzazione del
dissenso e il controllo/restringimento delle deleghe operative. Si verifica il ben noto
processo di involuzione per cui i problemi nati da errori di eccessivo accentramento
cominciano a richiedere una gestione di emergenza, che a sua volta legittima un
ulteriore accentramento del potere, potere che però finisce nelle stesse mani del gruppo
che ha generato i problemi.
E che dunque non può riconoscerli, ma anzi è portato a ripeterli. Se un gruppo di
manager in qualche modo si distingue, l'intervento è immediato ed esemplare.
Guardate il caso New Holland, il Settore Trattori e Macchine Movimento Terra. Ho il
privilegio di aver fatto parte di un management un po' fuori schema - e anche meno
«sotto controllo» della Corporate perché localizzato a Londra - che si è reso
protagonista di una delle svolte più straordinarie, portando l'azienda da una situazione
pre-fallimentare a una posizione di profitto netto di 600 milioni di dollari in tre anni (sulla
vicenda, che costituisce uno dei casi di studio della Bocconi, è stato scritto un libro).
Ebbene, questo gruppo di manager - realmente internazionale e globale avendo gestito
per sette anni all'estero - invece di essere valorizzato e utilizzato per risanare altre
situazioni critiche, viene brutalmente spazzato via e disperso, per l'unica colpa, in realtà,
di non essere omogeneo, organico, allineato al nuovo vertice. Tre anni dopo la stessa
New Holland, divenuta Cnh Case New Holland dopo la sciagurata acquisizionedell'americana Case, sarà di nuovo sull'orlo del baratro. Quanto altro valore distrutto, tra
denaro, asset, professionalità e motivazione?
Fin qui la storia, alcune storie. Ma perché è successo tutto questo, e come è potuto
succedere? E soprattutto: come possiamo almeno diminuire la possibilità, se non
evitare, che accadano cose simili in futuro?
Non credo che dal caso Fiat si possano derivare insegnamenti e regole astratte, perché
le motivazioni e le diagnosi devono fare riferimento alla specifica storia e alle condizioni
politiche culturali ed economiche in cui la vicenda si è svolta: ma forse qualche
indicazione generale può essere tratta.
Appena nominato, il nuovo presidente Fresco visitò in modo informale varie sedi del
gruppo, incontrando parecchi alti manager. E a tutti usava fare la stessa domanda:
«Quali sono secondo Lei i tre principali punti deboli della Fiat?».
Colpa del cliente
Ebbene, a più di quattro anni, posso ripetere la stessa risposta che gli diedi allora, con
l'amara consapevolezza che nulla è stato fatto e che anzi forse oggi c'è qualcosa da
aggiungere. Ecco, in estrema sintesi:
Una cultura d'azienda abissalmente lontana dal cliente, e di chi lo rappresenta, cioè la
rete commerciale, mai ascoltata e sempre disistimata. La carenza di adeguata
formazione commerciale, marginalizzazione degli uomini di vendita e di marketing nelle
carriere interne, ideologia monopolistica e specialmente la dominanza del «pregiudizio
ingegneristico», cioè la convinzione diffusa e radicata che il «saper fare» il prodotto
risiede nella competenza progettuale e tecnico-produttiva, che sa sempre, prima e
meglio del cliente, come si fa una buona macchina. Se poi il cliente non capisce, e
compra un'auto della concorrenza, peggio per lui, rimarrà ignorante.
Avanti, Savoia
L'esperienza dimostra che molto sovente i fattori di successo di una certa fase possono
rapidamente trasformarsi, al variare delle condizioni di mercato, in zavorre mortali.
Ebbene, il radicamento piemontese di Fiat è stato per anni un elemento straordinario di
forza: laboriosità, frugalità, obbedienza e rispetto per la gerarchia, precisione e talento
per la meccanica, conservatorismo e rifiuto del rischio, pragmatismo e riservatezza,
sono stati gli elementi di forza distintivi su cui si è creata e sviluppata la fortuna del
Gruppo.
Per non parlare dell’eccellenza di un management della cui formazione il Gruppo Fiat è
stato la vera «accademia italiana» negli anni ’70 e ’80, in linea con la locale tradizione
culturale e universitaria.Ma poi, rapidamente, tutto cambia: il mercato si apre, il sistema politico cessa di essere
un riferimento affidabile, è necessario competere all'estero, e le doti si rivoltano nel
proprio contrario. La riservatezza diventa diffidenza, e non aiuta la multiculturalità; il
conservatorismo diventa opposizione al diverso; frugalità e rifiuto del rischio limitano la
visione e la volontà di investire nel futuro; fedeltà e rispetto della gerarchia diventano
subordinazione, acquiescenza, passività e rinuncia.
Lo straordinario asset costituito da una tecnostruttura capace, fedele e laboriosa viene
così, non gestito, lasciato degradare, e quasi ormai dissolversi. Il gruppo di potere,
invece di correggere la deformazione, la accentua. All'inizio del '98 quasi il 70% dei
vertici del Gruppo e dei principali settori erano piemontesi, e di questi l'80% di una
ristretta area della regione, compresa tra le province di Cuneo e Asti.
E pensare che da anni qualcuno dibatteva il tema di un giusto mix intercontinentale di
management!
Poco ascolto
Una delle caratteristiche del «caso Fiat», e che lo rende in un certo senso più
inesplicabile di altre crisi aziendali, è il suo essere, in modo clamoroso, un disastro
annunciato. Se infatti si riguarda l'andamento economico e di mercato della Fiat balza
agli occhi un'alternanza vistosissima tra fasi di successo e profittabilità e momenti di
crisi e perdite. Fatto ancora più significativo, i periodi di alternanza si accorciano sempre
di più, fino alla crisi attuale. Il vertice sembra aver perso ogni capacità (o volontà?) di
leggere e capire ciò che succede, e gestisce «per crisi», cioè affannosamente re-agisce
solo quando i sintomi del problema hanno talmente superato il livello di guardia (e di
dissimulabilità) che sono innegabili.
E allora casse integrazioni, mobilità, outsourcing, rottamazioni, prepensionamenti di
centinaia di dirigenti e migliaia di tecnici e quadri, progetti di riduzione costi, work-out,
campagne d'opinione sul problema della competitività del sistema Italia (come se
all'estero si stessero mietendo chissà quali successi), e specialmente belle campagne
di disinformazione, sostenute dall'allegro e disincantato opinionismo dei giornalisti
amici, succubi di molti fascini, sempre pronti a spiegare alla pubblica opinione perché la
colpa è dei giapponesi, del sistema Italia, del sindacato, qualche volta del governo, ma
mai del vertice del gruppo, del management, e meno che mai della proprietà,
intoccabile icona italiana.
Ma tutto questo succede anzitutto perché nella rocca di Corso Marconi, e poi di Lingotto
(dove si sono ricostruiti, se possibile in modo ancora più oppressivo, i simboli di un
potere imbalsamato nel proprio passato: corridoi marmorei, sale riunioni obitoriali, ferrea
divisione tra reparti e uffici, atmosfera di intimorita rassegnazione...) nulla può essere
detto di ciò che realmente accade all'esterno. La critica non è ammessa,
l'evidenziazione dei problemi è vista, e quindi sanzionata, come aggressione al potere
legittimo, che si circonda sempre più di ex professionisti, trasformati in ciambellanicompiacenti, o, nei casi migliori (e ce ne sono stati tanti) statue silenti impegnate, quasi di nascosto, a salvare il salvabile. Ma non è solo un problema di stile manageriale: è l'intero sistema di funzionamento dell'azienda a scoprirsi improvvisamente, anche se tardivamente, inadeguato a fronte della spaventosa accelerazione dei ritmi di cambiamento e del tasso di complessità nella gestione del settore. Il management Fiat, infatti, ha «mancato» completamente la grande stagione di cambiamento delle tecniche e delle culture manageriali che ha investito, stravolto e rigenerato la grande industria e tutte le migliori aziende mondiali a partire dalla prima metà degli anni '80. Quel «new management system» che - partendo dalle parole d'ordine delega-decentramento, process based company, informatizzazione estrema, ossessione per il cliente, attenzione totale alla qualità e motivazione delle risorse umane, networking, integrazione delle componenti del modello giapponese, miglioramento continuo, logistica integrata, e, specialmente, qualità - è diventato e si è consolidato come il modello di successo di tutti i competitor mondiali, attraverso interventi seri, continui e coerenti, volti a cambiare radicalmente il modo di essere, gestire e competere: un grande cambiamento anzitutto culturale, in Fiat mille volte proclamato e celebrato, ma mai realizzato. Difficile sintetizzare le ragioni di un così totale fallimento, sapendo che molti, all'interno, hanno in buona fede singolarmente creduto a questi piani di cambiamento. I motivi sono complicati, e l'amara verità è che la mancanza di fiducia nella possibilità di fare collettivamente grandi cambiamenti, insomma l’incapacità di «credere», è una delle principali debolezze della cultura manageriale italiana. Comunque alla Fiat, sarà stata mancanza di maturità direzionale del vertice, scarsità di risorse al momento dei grandi investimenti formativi, scetticismo e superficialità. Fatto sta che ci si è trovati ad affrontare una poderosa guerra di battaglie campali con il solito moschetto 91 e le scarpe di cartone. Attuale direttore generale dell'Ansa, Mario Rosso (57 anni), ha gestito persone, ristrutturazioni, affari internazionali per venticinque anni nel Gruppo Fiat dove è stato per dieci anni alla Direzione personale e organizzazione di Gruppo e ha passato la parte più importante della sua vita professionale all’estero. Laureato in Filosofia a Torino, dopo un periodo a Pittsburgh, è stato capo del personale di Fiat Componenti e in seguito ha ricoperto lo stesso incarico alla Rinascente. Dal ’92 al ’98 ha fatto parte del vertice di New Holland (la società di trattori e macchine movimento terra nata dalla fusione di Fiat Trattori e Ford-New Holland), prima come responsabile delle risorse umane e poi nell’ambito della pianificazione strategica. In questo periodo, da Londra, ha gestito direttamente la ristrutturazione della multinazionale (un caso di successo a livello mondiale), la fusione delle strutture e del management e le partnership in Europa, Cina, India e Messico. Per tre anni, dal ’99 al 2001, è stato responsabile delle risorse umane del gruppo Telecom Italia e per un anno è stato direttore generale di Tiscali.
Puoi anche leggere