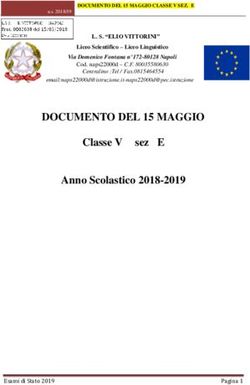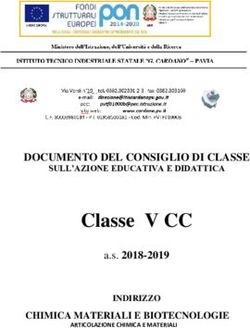ESAME DI STATO Documento del Consiglio di classe
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa
C.M. PIIS00700E C.F. 93089150507
Tel. 050/23230-050/6200431 Fax 050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it
pec piis00700e@pec.istruzione.it
Anno Scolastico 2020/2021
ESAME DI STATO
Documento del Consiglio di classe
ITE PACINOTTI - Classe 5° Sez. B AFM
Pisa, li 15 Maggio 2021
1Composizione del Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Giuliani
IRC Prof. Alessandro Corsi
Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Antonella Iannaccone
Storia Prof.ssa Antonella Iannaccone
Inglese Prof.ssa Valeria Sturniolo
Spagnolo Prof.ssa Maria Carmen Llerena Del Castillo
Matematica Prof.ssa Laura Parenti
Economia Aziendale Prof. Sergio Pierotti
Diritto Prof.ssa Doretta Benelli
Scienza delle Finanze Prof.ssa Doretta Benelli
Scienze Motorie Prof. Massimo Galoppini
CONTINUITA' DIDATTICA
CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°
ITALIANO/STORIA Prof. Giuliana Mazzoni Prof. Giuliana Mazzoni Prof.Antonella
Iannaccone
INGLESE Prof. Annalisa Turrini Prof. Valeria Sturniolo Prof. Valeria Sturniolo
SPAGNOLO Prof. Aurelio Borghini Prof. Patrizia Pesola Prof.ssa Mari Carmen
Llerena Del Castillo
MATEMATICA Prof.ssa Laura Parenti Prof.ssa Laura Parenti Prof.ssa Laura Parenti
ECONOMIA AZIENDALE Prof. Sergio Pierotti Prof. Sergio Pierotti Prof. Sergio Pierotti
DIRITTO/SCIENZA Prof.ssa Doretta Benelli Prof.ssa Doretta Benelli Prof.ssa Doretta Benelli
DELLE FINANZE
INFORMATICA Prof. Domiziano De Prof. Domiziano De /////
Cristofaro Cristofaro
SCIENZE MOTORIE Prof. Massimo Prof. Massimo Prof. Massimo
Galoppini Galoppini Galoppini
IRC Prof. Alessandro Corsi Prof. Alessandro Corsi Prof. Alessandro Corsi
2Contenuto del documento:
Scheda informativa generale del Consiglio di Classe
Obiettivi trasversali
Relazione sulla classe dei singoli docenti; schede informative relative ai
macroargomenti ed agli obiettivi cognitivi disciplinari.
Scheda informativa relativa alle attività di recupero
Scheda informativa relativa alle attività extracurricolari del triennio
Elaborati assegnati agli studenti
Elenco dei testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano
Scheda relativa alle attività di PCTO
Scheda relativa alle attività di EDUCAZIONE CIVICA
Allegati:
Programmi analitici delle singole discipline
SCHEDA INFORMATIVA GENERALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Storia ed analisi della classe nel triennio
L’attuale classe 5° B AFM è costituita da 16 alunni. Di questi, 14 provengono dalla classe quarta; a loro si
sono aggiunti un alunno che si era ritirato dalla classe quinta nell'anno scolastico 2019/20 e un alunno
proveniente da scuola privata (che aveva frequentato il nostro istituto fino alla classe 3°). I movimenti
precisi dell'intero triennio sono riportati nella sottostante tabella "Evoluzione del triennio".
Anche i cambiamenti subiti dal corpo docente sono riportati nella soprastante tabella "continuità
didattica"; per matematica, economia aziendale, diritto/scienza delle finanze, informatica, scienze
motorie e IRC i docenti non sono cambiati per la durata dell'intero triennio; ci sono stati cambiamenti
per Italiano/storia in classe 5°, inglese in classe 4° e spagnolo dove c'è stato un docente diverso per
ognuno dei tre anni scolastici.
Per quasi tutte le materie gli studenti si sono dimostrati abbastanza interessati agli argomenti proposti e
mediamente partecipi al dialogo educativo, anche se non sempre e non tutti hanno lavorato con
puntualità e assiduità. Il comportamento, generalmente corretto, è stato caratterizzato da qualche
eccesso di vivacità in relazione alla componente maschile della classe.
3La didattica a distanza è avvenuta tramite la piattaforma Google Classroom e Meet e utilizzando fogli di
calcolo e di testo per la condivisione dei vari materiali sia da parte dei docenti che degli studenti.
Durante le lezioni a distanza nessuno degli studenti ha comunicato di avere impedimenti tali da
ostacolare la regolare frequenza delle lezioni.
Gli argomenti previsti nelle varie programmazioni iniziali sono stati svolti; gli obiettivi didattici sono stati
mediamente raggiunti, ma in alcune materie il disinteresse e il mancato impegno di alcuni ha impedito
loro di ottenere una preparazione adeguata. Un gruppo di studenti ha invece dimostrato interesse, ha
utilizzato un corretto metodo di studio, ha profuso un impegno costante e ha raggiunto buoni e anche
ottimi livelli di preparazione.
Ad uno studente "atleta professionista" sono state concesse particolari facilitazioni in termini di orario di
frequenza scolastica e programmazione delle verifiche, come risulta dai verbali del Consiglio di classe;
nella classe è presente un alunno DSA.
Evoluzione nel triennio:
5° B AFM
CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°
ISCRITTI 15 ISCRITTI 17 ISCRITTI 16
Ingresso successivo 1 Ingresso successivo 1
RITIRATI/ Passati ad 3 RITIRATI/passati a altri 4 RITIRATI 0
altro indirizzo indirizzi/scuole
PROMOSSI 10 PROMOSSI 9 PROMOSSI
PROMOSSI CON 3 PROMOSSI CON 5 PROMOSSI CON
DEBITO DEBITO DEBITO
NON PROMOSSI 0 NON PROMOSSI 0
4Obiettivi Trasversali
COMPORTAMENTALI
( Valori da 1 a 5; ad un numero più alto corrisponde un avvicinamento maggiore all’obiettivo da
raggiungere )
Partecipazione corretta al lavoro individuale e di 3
gruppo
Flessibilità al cambiamento 3
Correttezza nei rapporti interpersonali 4
Puntualità e precisione nell’esecuzione dei lavori 3
assegnati
COGNITIVI
Leggere, redigere ed interpretare testi e
documenti di diversa complessità
3
5Collegare argomenti della stessa disciplina o di
discipline diverse cogliendone le relazioni
3
Documentare adeguatamente il proprio lavoro 3
Comunicare efficacemente, utilizzando
appropriati linguaggi tecnici
3
Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando
ed assumendo le informazioni opportune
3
RELAZIONI SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO e STORIA - Prof.ssa Antonella Iannaccone
Relazione finale
La classe, che ho preso in consegna a partire da questo anno scolastico per entrambe le discipline di Italiano
e Storia, ha dimostrato di posseder fin da subito una non sempre sufficiente impostazione didattica e
disciplinare.
Le studentesse e gli studenti, durante quest’ultimo anno, si sono mostrati abbastanza interessati agli
argomenti proposti, mediamente attenti e partecipi al lavoro svolto in classe, anche se non sempre (e non
tutti) hanno dimostrato assiduità e puntualità nello studio individuale. Seppur quest’ ultimo anno scolastico
(con il relativo ‘strascico’ dell’anno precedente) non sia stato regolare dal punto di vista della
partecipazione alle lezioni a causa della Dad, gli studenti di questa classe hanno affrontato l’andamento
instabile degli interventi didattici con una sufficiente partecipazione alle lezioni in presenza: non sempre
essi hanno affrontato, altresì, questi impegni didattici con entusiasmo e senso di responsabilità. Nella classe
si possono individuare, per quanto concerne le discipline di Italiano e Storia, due gruppi di studenti e
relativo impegno per le discipline umanistiche: un gruppo composto da quattro/cinque alunni ha affrontato
lo studio con un impegno tale da riuscire ad ottenere anche ottimi voti; il restante della classe ha affrontato
lo studio in maniera più essenziale, facendo l’ indispensabile per poter ottenere la sufficienza. Pochi alunni
hanno dimostrato la volontà di approfondire gli argomenti e le tematiche trattate. Nell’ultimo
quadrimestre, comunque, segnalo un miglioramento da parte della maggioranza degli studenti
6nell’effettuare l’analisi del testo letterario: sia le verifiche scritte che quelle orali hanno dimostrato una
capacità analitica maggiore rispetto all’inizio dell’anno scolastico.
ITALIANO
Metodologie didattiche e verifiche
Ho guidato lo studio della letteratura privilegiando la lettura del testo, quando possibile integrale, e la sua
analisi critica. Da questo esame, gradualmente, sono stati formulati, con il coinvolgimento delle
studentesse e degli studenti, i caratteri generali della poetica di un autore, di una corrente letteraria, di un
periodo storico. Ho fornito a tutti gli alunni delle dispense autoprodotte (a corredo del libro di testo) sui
nodi tematici principali per facilitare loro il recupero delle informazioni necessarie e caratterizzanti i
movimenti culturali e le più autorevoli e peculiari espressioni letterarie dell’Ottocento e Novecento.
Il tratto comune di questa classe è stato la diffidenza, soprattutto durante la prima parte dell’anno, verso
una disciplina (la letteratura italiana) concepita, cause abitudine e retaggio culturale pregresse, spesso
come una disciplina mnemonica, teorica, anacronistica, inattuabile nella vita di tutti i giorni e scarsamente
utile nell’acquisizione di competenze professionali. Le singole attitudini, combinate con lacune pregresse, di
tipo eminentemente espositivo-espressivo, hanno determinato risultati conclusivi variegati, ma
generalmente sufficienti e a volta più che buoni. Per quanto riguarda i traguardi raggiunti, un discreto
gruppo di studentesse e studenti ha maturato una conoscenza soddisfacente della storia della letteratura e
più che sufficienticompetenze di analisi del testo. Un gruppo numericamente minoritario, causa di un
impegno scarsamente profuso, ha stentatamente colmato carenze pregresse, riuscendo a raggiungere
risultati sufficienti al termine dell’anno scolastico.
Per quanto riguarda l’attività di elaborazione scritta, durante il primo e il secondo quadrimestre di questo
anno ho proposto esercitazioni in classe e come lavoro domestico numerose analisi del testo (tipologia A);
in classe sono state sostenute prove scritte di tipologia A, B e C.
In seguito alla modalità mista delle attività didattiche in presenza finalizzata al contenimento del contagio
da COVID-19, ho proseguito l’attività didattica (sia di intervento, che di valutazione)mediante le video
lezioni. Durante la Dad gli studenti hanno partecipato alle lezioni con maggiore distacco rispetto al lavoro
svolto in presenza: nonostante i continui richiami, molti alunni hanno reiterato il comportamento poco
corretto di tenere la telecamera spenta; gli interventi sono stati sempre sollecitati e mai spontanei (se si
escludono tre o quattro studenti). Al fine di venire incontro alle difficoltà didattiche e ai disagi tecnici e
psicologici legati all’attuale momento storico, sono state concordate sempre le verifiche orali oltre che
quelle scritte.
In questo anno scolastico le verifiche sono state sia scritte, secondo le tipologie A, B e C previste per
l’esame di stato, sia orali, attraverso interrogazioni individuali, in cui è stata privilegiata la conoscenza
diretta del testo letterario.
A causa dell’emergenza non sono state svolte simulazioni della prima prova.
7Macroargomenti
La cultura post- unitaria
1
Positivismo, Naturalismo, Verismo: Emile Zola, Giovanni Verga
2
Simbolismo, Estetismo eDecadentismo: Charles Boudelaire–Oscar Wilde - Giovanni Pascoli - Gabriele
3
D’Annunzio - Italo Svevo - Luigi Pirandello
La poesia del primo Novecento: Giuseppe Ungaretti, Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore
4
Quasimodo.
Obiettivi cognitivi disciplinari
Conoscenza dei movimenti letterari e dei loro contesti culturali, dei profili degli autori più
1
rappresentativi,dei testi letterari analiticamente indicati nel programma
Sviluppo delle capacità d’indagine critica e di analisi testuale: contestualizzare il testo in esame nella
2
produzione dell’autore e nel quadro storico di riferimento
Capacità di esporre con correttezza le proprie riflessioni critiche (nella produzione scritta e
3
nell’esposizione orale) su un autore, un testo, un periodo letterario
Capacità di stabilire relazioni fra autori, testi e periodi storico letterari diversi
4
Capacità di utilizzare un lessico ricco e vario
5
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a)Lezione frontale 3 a) Interrogazione 3
b)Lezione interattiva 2 b) Interrogazione breve 2
c)Analisi guidata di documenti 3 c) Prove semistrutturate 1
d) Produzione di testi 2
Indicare le metodologie prevalentemente adottate Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando
usando la scala da 1 a 3 la scala da 1 a 3
(Ad un numero più alto corrisponde una maggior (Ad un numero più alto corrisponde una maggior
frequenza) frequenza )
STORIA
Metodologie didattiche e verifiche
8Nel corso di questo anno scolastico, il programma di Storia è stato svolto in modo interdisciplinare con
quello di Italiano per favorirne la reciproca comprensione, ponendo l’accento sulle grandi questioni e sulla
loro evoluzione nel tempo.
Ogni argomento è stato affrontato attraverso lezioni frontali che hanno mirato ad integrare le informazioni
fornite dal manuale. Trattandosi di una materia orale, nonché di un validissimo strumento di esercizio di
trasmissione del proprio sapere mediante i collegamenti tra le conoscenze pregresse, la linea del tempo e la
propria capacità di analisi della causa e degli effetti, le verifiche sono state svolte esclusivamente mediante
interrogazioni orali individuali. Al fine di venire incontro alle difficoltà didattiche e ai disagi tecnici e
psicologici legati all’attuale momento storico, sono state concordate sempre le verifiche.
Molto spesso il programma di Storia si è intersecato, completandosi vicendevolmente, con l’intervento di
educazione civica soprattutto relativamente agli argomenti di cui ho fornito la relazione per Educazione
civica, appunto.
A corredo delle informazioni ricavabili dal libro di testo, sono stati visionati filmati e approfondimenti
mediante il web.
Macroargomenti
L’Italia unita: Destra e Sinistra Storica – L’Italia Giolittiana
1
La prima guerra mondiale – La rivoluzione russa
2
Il fascismo – Il nazismo – Lo stalinismo -La seconda guerra mondiale.
3
L’Italia repubblicana
3
Il mondo nell’epoca del bipolarismo e della guerra fredda.
4
Obiettivi cognitivi disciplinari
Comprendere il processo di sviluppo politico delle nazioni europee
1
Conoscere e comprendere i processi di conquista di libertà e/o indipendenza
2
Potenziamento del metodo d’indagine e di studio dei fenomeni e delle problematiche storiche
3
Capacità di elaborare riflessioni sulle cause degli eventi politici, sociali ed economici.
4
Capacità di comparazione delle problematiche storiche in senso diacronico e sincronico
5
9Metodologie adottate Strumenti di verifica
a) Lezione frontale 3 a) Interrogazione 3
b) Lezione interattiva 1 b) Interrogazione breve 2
c) Analisi guidata di documenti.
Indicare le metodologie prevalentemente adottate Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati
usando la scala da 1 a 3 usando la scala da 1 a 3 (Ad un numero più alto
(Ad un numero più alto corrisponde una maggior corrisponde una maggior frequenza)
frequenza)
ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI
Gennaio 2019: visione di filmati inerenti il “Giorno della Memoria” e relativa discussionedi confronto e
iterazione.
Febbraio 2019: visione di filmati inerenti il “Giorno del ricordo” e relativa discussione e iterazione.
Pisa, 12 maggio 2020
MATEMATICA APPLICATA
Prof. LAURA PARENTI
Relazione finale
La classe, che conosco da tre anni, è composta da 16 alunni.
La frequenza è stata nella maggior parte dei casi regolare, il comportamento generalmente corretto.
Le lezioni sono state organizzate in forma interattiva, in modo da sollecitare l’intervento degli alunni nella
ricerca delle soluzioni e da sviluppare la capacità di ognuno di procedere nello studio in modo personale e
costruttivo.
Gli obiettivi didattici che mi ero prefissata sono stati complessivamente raggiunti: tutti gli argomenti
previsti nella programmazione iniziale sono stati svolti.
Dal punto di vista didattico, alcuni studenti hanno raggiunto buoni risultati e, in alcuni casi, ottimi,
mostrando impegno costante, partecipando attivamente alle lezioni, sia in presenza, sia nella didattica a
distanza, lavorando adeguatamente e rielaborando personalmente gli argomenti trattati. Altri alunni si
sono impegnati solo superficialmente, talvolta in maniera non adeguata, anche in termini di continuità, ed
hanno ottenuto risultati appena accettabili.
10Macroargomenti
1 Ottimizzazione di funzioni in due variabili e applicazioni all’economia
2 Ricerca Operativa
3 Programmazione Lineare
Obiettivi cognitivi disciplinari
Utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare fenomeni e risolvere problemi
1
nei vari ambiti del mondo reale e del contesto socio-economico
Costruire un modello matematico dall’analisi di situazioni problematiche reali elaborando
2
opportune strategie di risoluzione.
3 Acquisire un corretto linguaggio logico-matematico.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a) Lezione frontale 2 a) Interrogazione 3
b) Lezione interattiva 3 b) Interrogazione breve 3
c) Gruppi di lavoro 1 c) Prove strutturate 2
d) Utilizzo DAD con applicativi Gsuite 3 d) Prove semi strutturate 2
(Classroom-Meet) e) Risoluzione di problemi 3
f) Costruzione di modelli, schemi e 3
tabelle
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la
scala da 1 a 3 scala da 1 a 3
(Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza) (Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza)
11ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Sergio Pierotti
Relazione finale
Per questa materia è stata rispettata la continuità didattica infatti il sottoscritto ha seguito gli studenti dalla
classe terza.
Lo svolgimento del programma ha rispettato la programmazione iniziale.
Le lezioni si sono svolte in parte in presenza e in parte a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.
Le metodologie didattiche utilizzate durante l'anno sono state: lezioni partecipate con richiesta di frequenti
interventi da parte degli studenti, problem solving, studio di casi, brain storming.
I mezzi didattici usati sono stati: libro di testo, codice civile, dispense fornite dall'insegnante; abbiamo
utilizzato la piattaforma Google Classroom e "meet" per le lezioni a distanza; si è fatto largo uso del foglio
elettronico di calcolo (excel e simili) per le spiegazioni e la correzione degli esercizi a distanza.
E' stato regolarmente effettuato il recupero in itinere e nella prima parte dell'anno scolastico la scuola ha
anche messo a disposizione degli studenti sportelli didattici; dopo la chiusura del primo quadrimestre sono
stati regolarmete effettuati corsi di recupero per gli studenti insufficienti. Per ogni argomento svolto sono
state proposte verifiche sommative scritte di tipo non strutturato (6 scritti per l'intero anno scolastico che
si sono svolti esclusivamente in presenza) e interrogazioni orali abbastanza frequenti (4 o 5 orali per
l'intero anno scolastico anch'esse svolte esclusivamente in presenza).
La classe si presenta disomogenea per quanto riguarda sia l'impegno che la motivazione allo studio. Quasi
tutti gli studenti hanno iniziato la quinta classe con le dovute conoscenze e competenze iniziali (3 studenti
non hanno saldato il debito della quarta classe) ma in questo anno scolastico si è riscontrato un calo
dell'impegno profuso da un certo numero di studenti; Il comportamento è stato positivo per la totalità degli
studenti e la partecipazione all'attività didattica è stata attiva per un buon numero di essi. Globalmente si
tratta di una classe di medio livello. I risultati raggiunti sono comunque differenziati: per alcuni alunni
permangono lacune anche molto gravi, ma la maggior parte di essi ha raggiunto livelli di preparazione
adeguati e in diversi casi buoni e anche eccellenti.
La valutazione finale globale ha tenuto conto, oltre alla misurazione dei risultati, anche della partecipazione
al dialogo educativo, del metodo di studio, dell'impegno profuso dagli studenti, del progresso e delle
capacità di recupero.
Macroargomenti
1 CONTABILITA' GENERALE, REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL'IMPRESA.
2 RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
123 FISCALITA' D'IMPRESA
4 CONTABILITA' GESTIONALE
5 STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
6 PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE
Obiettivi cognitivi disciplinari
Rilevare in PD le principali operazioni aziendali, redigere, riclassificare e analizzare il bilancio
1 d'impresa.
Analizzaren documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale alla luce dei criteri sulla
2
responsabilità sociale d'impresa
Individuare, accedere e interpretare la normativa fiscale e saper clacolare il reddito fiscale
3
d'impresa
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
4 analizzandone i risultati; calcolare le varie stratificazioni di costo e utilizzarle per compiere scelte.
Conoscere gli strumenti di pianificazione e programmazione, redigere i vari budget; Conoscere il
5 contenuto tipico del business plan.
6 Orientarsi nel mercato dei prodotti finaziari destinati alle imprese, saperli utilizzare e scegliere.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
Lezione frontale 3 Interrogazione 3
Lezione interattiva 3 Interrogazione breve 1
Analisi guidata di documenti. 1 Prove non strutturate 3
Problem solving 3
utilizzo la scala da 1 a 3 utilizzo la scala da 1 a 3
(Ad un numero più alto corrisponde una maggior (Ad un numero più alto corrisponde una
frequenza ) maggior frequenza )
INGLESE
prof. Valeria Sturniolo
Libri di testo:
- A.A.V.V., “Business Expert”, Pearson Longman.
- A.A.V.V., “Grammar and Vocabulary for the Real World”, OUP.
- A.A.V.V., “Your INVALSI Tutor”, Macmillan.
1. Relazione finale
13Durante l’anno è stato portato avanti il metodo di studio e di lavoro impostato in quarta. La classe si
presenta composta da studenti molto vivaci ed abbastanza interessati, ma con livelli diversi di competenze
nella lingua. Il livello raggiunto è, in generale, medio.
Molti studenti hanno beneficiato della sistematicità delle lezioni, e numerosi approfondimenti sono stati
così possibili, soprattutto dal punto di vista del lessico, del lavoro sul testo e sull’attualità. E’ stato creato un
ambiente di classe sereno, che rendesse possibile l’esercitazione costante della fluency degli studenti. La
docente ha insistito soprattutto sul brainwashing di inizio lezione e sul controllo della accuracy nella
produzione orale. La produzione scritta non è stata trascurata, ma ha sofferto della contingenza della
didattica a distanza per il Covid-19. Si è lavorato sul saggio breve, sul riassunto e sulla comprensione del
testo.
Per quanto riguarda la microlingua ed i contenuti specialistici del corso di studi, tutti gli argomenti dell’anno
sono stati trattati e ripassati in tre fasi (pausa natalizia, mese di febbraio e mese di aprile). Gli studenti
hanno usato schemi, mappe e PowerPoint per esporre la lezione in modo chiaro ed ordinato.
Molto si è lavorato, inoltre, sulle abilità trasversali che la scuola e lo studio di una lingua straniera
forniscono in modo silente, ma non casuale, agli studenti.
La valutazione complessiva, intesa non solo come giudizio sulla crescita culturale, ma anche civile dello
studente, ha tenuto conto delle tabelle di valutazione del PTOF e di: livello di partenza e peculiarità dello
studente, partecipazione al dialogo formativo, assiduità della frequenza, applicazione allo studio.
2. Macroargomenti
Business Communication
Finding job vacancies.
Analysing job interviews.
Analysing and writing a covering letter.
Understanding and writing a curriculum vitae.
Business, Finance and Marketing
The market and marketing: marketing, market research, e-marketing, market position: SWOT analysis.
The marketing mix.
The European Union: treaties, European institutions.
Globalisation: globalisation, glocalisation, outsourcing and offshoring.
Business ethics and green economy: the Triple Bottom Line, Corporate Social Responsability, Fair Trade,
Microfinance, ethical banking and investment.
Cultural insights
How the UK is governed.
How the USA is governed.
Political parties.
14The austerity debate.
3. Obiettivi cognitivi disciplinari
1 Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti.
2 Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato.
3 Comunicare, riferire, documentare con chiarezza e usando un linguaggio appropriato su
argomenti di civiltà e di carattere economico.
4 Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte operative
effettuate.
4. Metodologie utilizzate e strumenti di verifica.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a) Lezione frontale ➔3 a) Interrogazione ➔3
b) Lezione interattiva ➔2 b) Interrogazione breve ➔3
c) Gruppi di lavoro ➔2 c) Produzione di testi ➔2
d) Attività di laboratorio ➔1 d) Prove strutturate ➔1
e) Analisi guidata di documenti ➔3 e) Prove semistrutturate➔1
f) Utilizzo DAD con applicativi Gsuite ➔2 f) Costruzione di schemi, tabelle ➔1
Indicare le metodologie prevalentemente adottate Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando
usando la scala da 1 a 3(ad un numero più alto la scala da 1 a 3(ad un numero più alto corrisponde una
corrisponde una maggior frequenza). maggior frequenza).
SPAGNOLO
Prof.ssa Carmen Llerena del Castillo
Relazione finale
Obiettivi didattici perseguiti
a) Prendere coscienza delle figure professionali del commercio a livello di abilità linguistiche,
15relazionali e tecnico operative.
b) Acquisire competenza comunicativa orale (comprendere e produrre messaggi orali).
c) Acquisire competenza comunicativa scritta (decodificare e produrre messaggi scritti).
d) Riconoscere ed usare adeguatamente registri comunicativi diversi in contesti situazionali vari.
e) Ampliare il bagaglio lessicale, le conoscenze, abilità e competenze inerenti all'uso della lingua
inglese e alla cultura dei paesi anglofoni per un consapevole riferimento alla vita della società ed in
modo specifico al settore economico-politico.
Metodologie e verifiche
Nel corso dell'anno si è cercato di favorire l'acquisizione di competenze sia scritte che orali infatti,
attraverso l'individuazione di moduli tematici inerenti all'area economico-politica, si sono egualmente
sviluppate la comprensione e la produzione scritta, così come sono state riviste, qualora necessario, alcune
strutture morfosintattiche. In modo particolare è stato curato l'ampliamento lessicale, soprattutto riguardo
ai campi semantici inerenti al settore professionale di riferimento. Le verifiche sono state intese come fasi
intermedie di controllo degli obiettivi conseguiti e come feed back da parte degli alunni.
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei progressi conseguiti, della
partecipazione e dell’impegno dimostrato durante il percorso di apprendimento. I livelli di
sufficienza sono stati identificati sulla base di:
a) conoscenza essenziale dei contenuti,
b) comprensione globale di testi scritti e messaggi orali di difficoltà intermedia dal punto di vista
lessicale e sintattico,
c) esposizione comprensibile, anche se semplice e con errori formali.
Obiettivi mediamente raggiunti
La classe risulta composta da due diversi gruppi: il più numeroso formato da studenti disinteressati e mal
disposti alla materia, con pochissime competenze di comprensione orale e scritta e meno ancora di
espressione; mentre quello più piccolo formato da alunni che ha maturato negli anni un certo livello di
competenze linguistiche. Gli alunni hanno partecipato alle attività proposte ciascuno con le proprie
capacità, alcuni dimostrando poco impegno e poca consapevolezza, poca disponibilità all’apprendere. In
alcuni casi hanno mostrato un certo interesse per gli argomenti proposti, ciascuno secondo le proprie
propensioni, anche se spesso con difficoltà dei linguaggi specifici. Attualmente la classe conosce in
maniera lacunosa gli elementi basilari della lingua e della civiltà spagnola, nonché il linguaggio tecnico
relativo ad argomenti specifici del settore professionale. Solo alcuni studenti hanno quindi raggiunto, in
linea generale, un' adeguata competenza comunicativa sia nelle situazioni di vita quotidiane, che in un
16contesto lavorativo professionale. La comprensione generale di testi di livello intermedio viene raggiunta
da questi pochi con certa facilità, e la produzione orale è media, mentre la produzione scritta può
evidenziare ancora alcune difficoltà. Per gli altri, è molto scarsa.
Macroargomenti
El mundo empresarial: Un viaje de negocios. Relaciones comerciales.Marketing empresarial.
1 Negocios y ventas. Comercialización y exportación.
La agenda 2030.
2
La España económico-política. Historia económica en Hispanoamérica.
3
Obiettivi cognitivi disciplinari
Decodificare, analizzare e produrre testi e documenti.
1
Comunicare efficacemente in forma scritta ed orale utilizzando un lessico adeguato.
2
Comunicare, riferire, documentare con chiarezza e usando un linguaggio appropriato su argomenti di
3 civiltà e di carattere economico.
Organizzare il proprio lavoro in modo coerente ed autonomo giustificando le scelte operative
4 effettuate.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a)Lezione frontale �1 0 Interrogazione
b)Lezione interattiva �1 0 Interrogazione breve
c)Gruppi di lavoro � 3 Produzione di testi
d)Attività di laboratorio 3 1 Prove strutturate
e)Analisi guidata di documenti. �2 1 Prove semistrutturate
�1 1 Costruzione di schemi, tabelle
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando la
scala da 1 a 3 scala da 1 a 3
( Ad un numero più alto corrisponde una maggior ( Ad un numero più alto corrisponde una maggior
frequenza ) frequenza )
DIRITTO
Prof.ssa DORETTA BENELLI
Relazione finale
Conosco la classe dalla terza e quindi ho potuto seguire gli studenti per l'intero triennio.
La continuità didattica mi ha permesso di organizzare il lavoro sui tre anni in ambedue le discipline e di
17sfruttare al meglio il tempo a mia disposizione non dovendo verificare se le conoscenze pregresse fossero
state acquisite oppure no.
I ragazzi nel triennio sono cresciuti maturando un atteggiamento più consono all’apprendimento pur
rimanendo spesso vivacemente partecipi
Il lavoro in classe è stato sempre proficuo; spesso nell'affrontare i diversi argomenti si è cercato di mettere
in relazione le due materie facendo collegamenti e sviluppando spunti critici.
Purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19non sono state sempre possibili le lezioni in presenza
penalizzando la partecipazione attiva e l’esposizione dei contenuti
Tuttavia, grazie ad un recupero finale, è stato possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti nella
programmazione
Macroargomenti
1 Lo Stato e la sua evoluzione.
2 La Costituzione italiana:caratteristiche e contenuto.
3 Gli organi costituzionali dello Stato.
5 Le garanzie costituzionali. La magistratura.
6 La pubblica amministrazione e gli atti amministrativi.
Obiettivi cognitivi disciplinari
1 Conoscere le caratteristiche essenziali dello Stato e le varie forme di Stato e di Governo.
Inquadrare storicamente il processo di integrazione europea e conoscere l’organizzazione dell’
2
Unione europea.
Conoscere l’evoluzione delle istituzioni italiane dallo Statuto Albertino alla Costituzione
3
repubblicana.
Comprendere la tutela costituzionale delle libertà fondamentali del cittadino e delle organizzazioni
4
sociali, economiche e politiche di cui fa parte.
Individuare ed analizzare struttura, funzioni e rapporti tra gli organi costituzionali della Repubblica
5
italiana.
Conoscere i principi alla base dell’attività della PA, la sua organizzazione, il procedimento
6
amministrativo e le principali tipologie di provvedimento amministrativo.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a) Lezione frontale �3 a) Interrogazione 3
b) Lezione interattiva �2 b) Interrogazione breve 2
c) Analisi guidata di documenti. �1 c) Produzione di testi
a) utilizzo DAD con applicativi Gsuite �3 d) Prove strutturate 3
(Classroom-Meet) e) Prove semistrutturate2
18Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati
a3 usando la scala da 1 a 3
( Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) (Ad un numero più alto corrisponde una maggior
frequenza )
SCIENZA DELLE FINANZE
Macroargomenti
1 L’attività finanziaria pubblica. Evoluzione, soggetti e ruolo attuale della finanza pubblica.
2 Le forme di finanziamento dell’attività finanziaria pubblica.
3 La spesa pubblica ed i suoi effetti sul sistema economico.
4 Le entrate pubbliche. L’imposta ed i suoi effetti.
5 Il bilancio dello Stato e gli altri documenti giuridico-contabili come strumenti di politica economica.
Obiettivi cognitivi disciplinari
1 Conoscere, analizzare e mettere in relazione gli strumenti dell’attività finanziaria pubblica
2 Conoscere i principi giuridici e gli effetti economici del carico tributario.
3 Conoscere, analizzare e mettere in relazione le varie tipologie di spesa pubblica.
Conoscere e comprendere le funzioni, i caratteri, la struttura e le modalità di formazione del
4
bilancio statale. Saper collegare i diversi documenti legati al bilancio.
5 Conoscere i lineamenti generali del sistema tributario italiano.
Metodologie adottate Strumenti di verifica
19a) Lezione frontale �3 a) Interrogazione 3
b) Lezione interattiva �2 b) Interrogazione breve 2
c) Analisi guidata di documenti �1 c) Prove strutturate 3
d) utilizzo DAD con applicativi �3 d) Prove semistrutturate2
Gsuite(Classroom-Meet)
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati
scala da 1 a 3 usando la scala da 1 a 3
( Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) ( Ad un numero più alto corrisponde una
maggior frequenza )
SCIENZE MOTORIE
Prof. Massimo Galoppini
Relazione finale
La classe, che conosco dalla terza, presenta un livello qualitativo dal punto di vista motorio molto buono
con alcune punte di eccellenza. La partecipazione e l’impegno è stato continuo nella didattica in presenza
con punte di vivacità a volte eccessiva, buono anche l’impegno in quella a distanza anche se non
paragonabile a quello nella pratica. Indubbiamente la scarsità delle ore in palestra ha leggermente
penalizzato alcuni alunni molto più inclini e performanti nelle attività sportive. Il comportamento, per
quanto riguarda la componente femminile, minoritaria, è sempre stato corretto e responsabile; qualche
eccesso di vivacità e comportamenti non sempre all’altezza di una classe quinta per maturità, si sono invece
manifestati tra i ragazzi.
La classe dimostra di aver acquisito, attraverso il lavoro pratico, buone conoscenze oltre che delle
caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati, anche delle qualità motorie di base.
Con il lavoro a distanza, invece, gli alunni hanno acquisito conoscenze in particolare sugli stili di vita e sulla
prevenzione utili al raggiungimento e al mantenimento del benessere psicofisico.
La classe è inoltre in grado di:
1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari
contenuti tecnici;
2. Praticare con una tecnica adeguata almeno due degli sport programmati nei ruoli congeniali alle
proprie attitudini e propensioni.
Dimostra infine di aver conseguito miglioramenti nelle capacità di:
1. Compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità.
2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
Metodologia didattica
La metodologia utilizzata si è basata sulla organizzazione di attività in situazione, sulla continua
individuazione e correzione anche autonoma dell’errore; tali attività sono state scelte anche tenendo conto
delle inclinazioni e delle preferenze espresse dagli allievi.
Nello svolgimento della lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro di gruppo o
individualizzato, in relazione anche alla disponibilità pratica degli spazi in palestra e delle attrezzature ivi
20presenti. Nella dad è stato utilizzato classroom per lezioni frontali, anche con utilizzo di video e lavori di
gruppo.
Criteri di valutazione
La valutazione, per quanto riguarda l’esigua mole di lavoro pratico, si è basata soprattutto sulla
effettuazione di prove pratiche e sulla osservazione sistematica degli alunni in situazioni competitive e non
anche per una valutazione complessiva delle capacità attitudinali inerenti le scienze motorie quali
l’affidabilità, l’autonomia, la collaborazione, l’attenzione, il rispetto delle regole, la comprensione della
situazione in relazione alla sicurezza propria e degli altri. Per il lavoro in DAD sono stati utilizzate verifiche
orali e lavori di gruppo.
Macroargomenti
Modalità ed analisi del riscaldamento e del valore fisiologico come preparazione all’attività ginnico-
1
sportiva
Esercizi semplici-composti e combinati per la coordinazione neuromotoria - Mobilizzazione
2 articolare -Tonificazione muscolare in circuito e con l’HIT. Giochi sportivi in forma individuale o a
coppie – Pallavolo – Pallacanestro – Calcio a 5
Salute e benessere: fattori della salute, alimentazione, effetti del movimento, dipendenze, doping.
3
Il linguaggio del corpo, la comunicazione efficace.
Dietro lo sport: imparare a collaborare, strategie di gruppo, adattarsi al cambiamento.
4 Lo sport e la storia: dittature e totalitarismi
Obiettivi cognitivi disciplinari
1 Armonico sviluppo corporeo e motorio – potenziamento fisiologico dei vari distretti muscolari
2 Consolidamento del carattere – Sviluppo della socialità e del senso etico
3 Padronanza dei mezzi tecnici ed atletici esecutivi nelle diverse discipline sportive
Conoscenza dei principi dell’allenamento sportivo, con riferimento anche all’alimentazione, al
4
doping e al ruolo dello sport nella società di oggi e del passato.
5 Consapevolezza e conoscenza di buoni stili di vita per uno stato di benessere psicofisico
Metodologie adottate Strumenti di verifica
21a) Lezione frontale 3 a) Interrogazione
b) Lezione interattiva b) Interrogazione breve 2
c) Gruppi di lavoro 3 c) Produzione di testi 2
d) Attività di laboratorio d) Prove strutturate
e) Analisi guidata di documenti. e) Prove semistrutturate 2
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando Indicare gli strumenti prevalentemente utilizzati usando
la scala da 1 a 3 la scala da 1 a 3
( Ad un numero più alto corrisponde una maggior ( Ad un numero più alto corrisponde una maggior
frequenza ) frequenza )
RELIGIONE
Prof Alessandro Corsi
Relazione
Conosco gli studenti della classe fin dalla prima. Coloro che si sono avvalsi dell’IRC hanno sempre
partecipato, per la maggior parte, con interesse e, pur nei limiti della peculiarità della materia insegnata,
con profitto culturale e umano.
Macroargomenti
1 DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA
2 SCIENZA E FEDE
3 IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI
4 RELIGIONE E CONTEMPORANEITÀ
Obiettivi cognitivi disciplinari
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELL’ETICA CRISTIANA SUL LAVORO E LA SUA DIMENSIONE
1
SOCIALE
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE LE DIFFERENZE ED I POSSIBILI PUNTI DI CONTATTO TRA LA FEDE E LA
2
SCIENZA
3 CAPACITÀ DI COGLIERE IL VALORE E L’ATTUALITÀ DEL DIALOGO E DELLA TOLLERANZA TRA CULTURE
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE GLI ASPETTI ETICI E SPIRITUALI DI ALCUNE EMERGENZE DEL MONDO
4
CONTEMPORANEO
22CAPACITÀ DI INDIVIDUARE IL PERCORSO STORICO DEL PENSIERO DELLA CHIESA SULLE VARIE
1
TEMATICHE STORICHE
2 SAPER PERCEPIRE L’ATTUALITÀ DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
Metodologie adottate Strumenti di verifica
a) Lezione frontale 2 a) Interrogazione breve 2
b) Lezione interattiva 1 b) Valutazione livello partecipativo 1
c) Gruppi di lavoro 0 c) Produzione di testi 2
d) Analisi guidata dei testi 3
e) Analisi guidata di documenti 3
Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da Indicare le metodologie prevalentemente adottate usando la scala da 1 a 3 (
1 a 3 ( Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza ) Ad un numero più alto corrisponde una maggior frequenza )
ATTIVITA' DI RECUPERO
Nel triennio sono stati effettuati interventi di recupero in itinere in tutte le materie. Durante il triennio sono
stati attivati corsi di recupero di Economia aziendale, Matematica.
ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI
La classe ha svolto nel triennio diverse attività extracurricolari:
Viaggio d'istruzione a Praga (3° classe) dal 9 al 14 aprile 2019
Progetti
o Avvocati in aula (3° e 4° classe; a.s. 2018/19 e 2019/20); argomenti trattati:
la figura del mediatore
la condizione femminile (visione film Suffragette, Monna Lisa smile, Il diritto di contare
telemedicina.
o CAF - ISEE (4° classe): gli studenti hanno ricevuto una formazione da esperti del CAF ACLI di Pisa
e dopo aver acquisito conoscenze e competenze relative alla pratica ISEE, hanno ricevuto
l'utenza e hanno curato tali pratiche in autonomia, supervisionati dall'esperto del CAF.
o Progetto AVIS (5° classe); 6 studenti hanno partecipato al progetto che prevede donazione del
sangue.
23 Attività varie
o nell'ambito del progetto "cinema" gli studenti hanno partecipato alla visione di tre film:
Mulholland drive, Ready player one, Non essere cattivo.
o nell'ambito del progetto "educazione alla legalità" incontro con gli operatori della "casa
circondariale "Don Bosco".
ELABORATI ASSEGNATI AGLI STUDENTI
Ai sensi e per l’articolo 10 dell’OM 53/21, comma 1 lettera a),dedicato all’elaborazione del documento del
consiglio di classe si indicano di seguito gli argomenti assegnati a ciascun alunno per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio.
L’elenco è redatto rispettando la numerazione dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi
delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi.
CANDIDATO ARGOMENTO DOCENTE REFERENTE
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
1 indici; N.I immobilizzazioni
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
2 indici; P.O e sostituzione impianti
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
3 indici;N.I. patrimonio
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
4 indici; N.I patrimonio
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
5 indici;fabbisogno finanziario
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
6 indici;scritture di assestamento
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
7 indici; reddito fiscale
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
8 indici; N.I. immobilizzazioni
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
9 indici; acquisizione beni strumentali
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
10 indici; budget
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
11 indici; scritture di assestamento
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
12 indici; budget investimenti fissi
24Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
13 indici; break even analisys
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
14 indici; contabilità gestionale full costing
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
15 indici; rendiconto finanziario
Redazione Bilancio (SP e CE) sua riclassificazione e analisi per Prof. Pierotti Sergio
16 indici; contabilità gestionale direct costing
Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano
VOL. 3 Pag.
Giovanni Verga
Rosso Malpelo T2 102
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia) T4 123
I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico(da I Malavoglia) T5 128
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia) T6 134
Charles Baudelaire
Corrispondenze (da I fiori del male) T1 185
Giovanni Pascoli
Lavandare (da Myricae) T2 304
X Agosto (da Myricae) T3 306
Temporale (da Myricae) T5 312
Novembre (da Myricae) T6 314
Il lampo (da Myricae) T7 317
Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) T9 328
Italo Svevo
Le ali del gabbiano (da Una vita) T1 437
Il ritratto dell’inetto (da Senilità) T2 446
Il fumo (da La coscienza di Zeno,cap.III) T3 457
25La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap. IV) T4 462
Psico-analisi (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) T5 471
La profezia di un’apocalisse (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) T6 478
Luigi Pirandello
Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) T1 501
Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) T3 515
La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX) T4 530
Lo “strappo nel cielo di carta” (da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XII) Dal web
Nessun nome (da Uno, nessuno e centomila) T5 541
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in cerca d’autore) T10 811
Giuseppe Ungaretti
Il porto sepolto(da L’allegria) T2 709
Veglia (da L’allegria) T3 711
Sono una creatura (da L’allegria) T4 713
I fiumi (da L’allegria) T5 715
San Martino del Carso (da L’allegria) T6 719
Mattina (da L’allegria) T7 721
Soldati (da L’allegria) T8 722
Umberto Saba
Trieste (dal Canzoniere) T2 686
Amai (dal Canzoniere) T3 688
Ulisse (dal Canzoniere) T4 690
Eugenio Montale
I limoni (da Ossi di seppia) T1 758
Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) T2 762
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di Seppia) T3 764
Spesso il male di vivere ho incontrato(da Ossi di seppia) T4 766
26PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
REPORT PCTO
CA FORMAZIONE IN AULA O TIROCINIO O TIROCINIO O TOT.
NDI A.S. 2018/19 R A.S. 2018/19 R A.S. 2019/20 R ORE
DAT
O
E GIUGNO E SETTEMBRE E
1 Corso sicurezza (12h) 30 In altra scuola ELEA SOFTWERE 150 180
Progetto ISEE (18h)
ISTOS EDIZIONI
a.s.17/18
2 Corso sicurezza (8h) 23 SAI ASSICURAZIONI 10 246
Progetto ISEE (15h) a.s. 18/19 3
STUDIO 12
3 Corso sicurezza (12h) 52 COMMERCIALE 0 STUDIO 50 152
Avvocati in aula (25h) ROVENTINI COMMERCIALE
Progetto ISEE (18h) 50 ROVENTINI
STUDIO COM .
4 Corso sicurezza (12h) 55 MANNUCCI e STUDIO COM . 50 155
Avvocati in aula (25h) MATTEUCCI MANNUCCI e
Progetto ISEE (18h) 50 MATTEUCCI
CAF ACLI
5 Corso sicurezza (12h) 55 CAF ACLI 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h) B. PISA e FORNACETTE 50
a.s.17/18
6 Corso sicurezza (8h) 23 B. PISA e FORNACETTE 254
Progetto ISEE (15h) a.s.17/18
LANDI S.r.l. 11
3
7 Corso sicurezza (12h) 55 STUDIO DEL CORSO LANDI S.r.l. 50
Avvocati in aula (25h) a.s.16/17 12
Progetto ISEE (18h) STUDIO DEL CORSO 0
a.s.17/18 354
STUDIO NIZZI a.s. 50
8 Corso sicurezza (12h) 12 18/19
B. PISA e FORNACETTE
11
0
279 Corso sicurezza (12h) 55 STUDIO COM . B. PISA e 50 155
Avvocati in aula (25h) MANNUCCI e 12 FORNACETTE
Progetto ISEE (18h) MATTEUCCI 2
10 Corso sicurezza (12h) 55 CAF ACLI 12 STUDIO COM . 50 155
Avvocati in aula (25h) 2 MANNUCCI e
Progetto ISEE (18h) MATTEUCCI
50
11 Corso sicurezza (12h) 55 In altra scuola CAF ACLI 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h)
MISERICORDIA di PISA 50
12 Corso sicurezza (12h) 37 CALCIATORE 150
Avvocati in aula (25h) PROFESSIONISTA
AUTOITALIA GROUP
13 Corso sicurezza (12h 55 S.r.l. MERCEDES 50 MISERICORDIA di PISA 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h) ASSICURAZIONI
GENERALI AUTOITALIA GROUP
14 Corso sicurezza (12h) 55 S.r.l. MERCEDES 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h) CAF ACLI ASSICURAZIONI
50 GENERALI
15 Corso sicurezza (12h) 55 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h) CAF ACLI
50
16 Corso sicurezza (12h) 55 50 155
Avvocati in aula (25h)
Progetto ISEE (18h)
50
50
EDUCAZIONE CIVICA
ITALIANO e STORIA
I quadrimestre:ASPETTI STORICO-LETTERARI relativi al DIVARIO NORD-SUD post unitari: nello specifico, la
“questione meridionale”.
- Lettura di brani antologici tratti da novelle e romanzi di G. Verga; la questione meridionale
affrontata in ambito parlamentare dai governi della “destra storica” e della “sinistra storica”.
28II quadrimestre: ASPETTI STORICO-LETTERARI relativi alla DEMOLIZIONE dello STATO LIBERALE durante il
ventennio fascista;
il ruolo della “resistenza” nel processo di liberazione degli Stati europei dall’oppressione totalitarista nel
corso della seconda guerra mondiale
- Lettura di brani antologici, visione di video ‘dedicati’ agli argomenti, discussione in classe.
DIRITTO:
I quadrimestre LA CITTADINANZA DIGITALE
II quadrimestre L’EMERGENZA SANITARIA e le QUESTIONI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
INGLESE
I quadrimestre:HOW THE UK IS GOVERNED. HOW THE USA IS GOVERNED. POLITICAL PARTIES.
II quadrimestre:EUROPEAN UNION. EUROPEAN INSTITUTIONS.
Nella cornice della programmazione di lingua inglese, per educazione civica si è affrontata la tematica
dell’analisi delle istituzioni repubblicane nei due paesi anglosassoni maggiormente studiati (Regno Unito e
Stati Uniti d’America) e nell’Unione Europea.
Gli studenti si sono dimostrati particolarmente interessati all’argomento, vista anche la concomitanza con
la Presidential Election e l’attacco a Capitol Hill negli USA. Inoltre, hanno particolarmente apprezzato di
saper leggere ed interpretare lo scandalo del “sofagate” che ha coinvolto le due massime figure della
Commissione Europea e del Consiglio Europeo in Turchia.
Le istituzioni repubblicane sono state analizzate anche dal punto di vista del principio dei “checks and
balances” e del “rule of law”.
Programmi allegati:
PROGRAMMA DI ITALIANO
Prof.ssa Antonella Iannaccone
Testi utilizzati
G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dall'età postunitaria ai giorni nostri.
Volume 3, Paravia
I testi letti e analizzati durante l’anno scolastico sono esplicitati nell’elenco parte del documento del
Consiglio di classe, dunque non sono indicati in questo programma.
L’ETÀ POSTUNITARIA
Lo scenario: società, cultura, idee – Le ideologie – Le istituzioni culturali – Gli intellettuali – La questione
della lingua – Fenomeni letterari e generi
Temi: La lingua e la letteratura post-romantica
Generi: Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia
Il Naturalismo francese: Zola – Il ruolo dello scrittore
Il verismo italiano: tecniche narrative, l’impersonalità – Il discorso indiretto libero
Autori: Giovanni Verga
29La vita – Le opere preveriste – La svolta verista – Poetica e tecniche narrative del Verga verista – L’ideologia
verghiana – Confronto fra il Naturalismo zoliano e il verismo di Verga – Le raccolte di novelle: Vita dei Campi
e Novelle rusticane – Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.
Incontro con l’Opera: I Malavoglia
IL DECADENTISMO
Lo scenario: società, cultura, idee - La visione del mondo – La poetica del Decadentismo – La relazione del
Decadentismo con il Romanticismo e con il Naturalismo – Le influenze del Decadentismo sulla letteratura
del Novecento - l’Estetismo.
Genere: La poesia simbolista e il romanzo decadente; L’esperienza letteraria dell’Estetismo
Charles Baudelaire, Gabriele d’Annunzio, Oscar Wilde.
Autori: Gabriele d’Annunzio
La vita - Il pensiero e la poetica – L’estetismo e la sua crisi – I romanzi del superuomo – Le Laudi
Incontro con l’opera: Il piacere
Autori: Giovanni Pascoli
La vita - La visione del mondo - La poetica –Temi e soluzioni formali della poesia pascoliana - Le raccolte
poetiche
Incontro con l’opera: Myricae
IL PRIMO NOVECENTO
Lo scenario: società, cultura, idee. Ideologia e nuove mentalità
Temi: La stagione delle avanguardie - I futuristi – Marinetti –
Genere: La lirica del primo Novecento in Italia
Autori: Italo Svevo
La vita – La cultura– Il pensiero –I romanzi: Una vita - Senilità
Incontro con l’Opera: La coscienza di Zeno
Autori: Luigi Pirandello
La vita –La visione del mondo - La poetica – Le novelle – I romanzi – Il teatro
Incontro con l’Opera: Il fu Mattia Pascal
LA POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO
Dal periodo tra le due guerre al secondo dopoguerra: società, cultura, idee, ideologie e nuove
mentalità
Autori: Giuseppe Ungaretti
La vita – la cultura – la poetica – temi e soluzioni formali della poesia ungarettiana - le raccolte di
liriche: L’allegria –Il sentimento del tempo – Il dolore
Incontro con l’opera: L’allegria
Autori: Umberto Saba
La vita – la poetica – i temi e soluzioni formali della poesia di Saba
Incontro con l’opera: Il Canzoniere
Autori: Salvatore Quasimodo
Cenni biografici – la poetica – il legame con l’Astrattismo e l’Ermetismo
30Lettura e analisi dei brani “Alle fronde dei salici” e “Ed è subito sera”
Autori: Eugenio Montale
La vita – la poetica - i temi e soluzioni formali della poesia di Montale
Incontro con l’opera: Ossi di seppia
IL ROMANZO E LA STORIA
L’eredità del romanzo storico ottocentesco: La storia, di Elsa Morante
Pisa, lì 12 maggio 2021
PROGRAMMA DI STORIA
Prof.ssa Antonella Iannaccone
Testo utilizzato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La storia in campo: l’età contemporanea, vol. 3
MANUALE
Unità 1 Dalla belle époque alla prima guerra mondiale
Cap. 1 Il volto del nuovo secolo
Cap. 2 Lo scenario mondiale
Cap. 3 L’età giolittiana L’età giolittiana
Cap. 4 La prima guerra mondiale La prima guerra mondiale
Unità 2 I totalitarismi e la seconda guerra mondiale
Cap. 5 Dopo la guerra sviluppo e crisi L’eredità della prima guerra
mondiale in Europa *
Cap. 6 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura La rivoluzione russa
Cap. 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo Il dopoguerra in Italia e l’avvento del
fascismo (1918-20) *
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del
fascismo (1920-26)*
Lezione SNS Le leggi razziali
Cap. 8 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich La crisi della Repubblica di Weimar e
l’avvento del nazismo*
31Puoi anche leggere