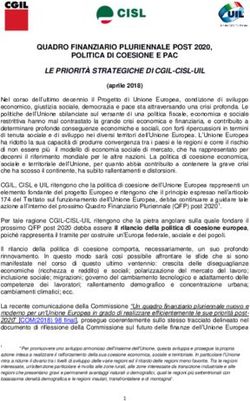DANTE "A MENTE" DI BENIGNI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rino Caputo
DANTE “A MENTE” DI BENIGNI
Nei primi giorni di febbraio del 2007, in occasione dei festeggiamenti giubilari
per il pensionamento di Franco Musarra, prestigioso maestro dell’Italianistica di
Lovanio, Roberto Benigni, reduce dagli ormai planetari successi cinematografici,
ha recitato “a mente”, secondo la sua stessa espressione e, cioè, a memoria, il canto
V dell’Inferno, quello di Paolo e Francesca.
Non era, del resto, la prima volta che l’artista eseguiva tale performance: già
alcuni anni prima, in sedi universitarie come in molti teatri e istituzioni culturali
estere, e soprattutto, archetipicamente, nel suo memorabile intervento nel corso
della trasmissione televisiva Babele (un programma di divulgazione libraria e cul-
turale, condotto da Corrado Augias, che ha avuto un buon seguito di audience, in
particolare per la capacità di rendere spettacolare il dibattito intellettuale), Benigni
aveva, per così dire, “improvvisato” il canto V dell’Inferno.
Ma, oltre al riconoscimento dovuto all’abilità del protagonista dei suddetti
eventi e all’importanza dello spazio massmediale interessato – la televisione – e
prima di accennare almeno ad alcune tra le esperienze significative di esecuzione
“ad alta voce” e, cioè, oralmente, della Commedia per tutto il corso degli anni Ot-
tanta e Novanta, occorre premettere alcune considerazioni solo apparentemente di
contorno. La prima è che Dante è un autore che presso il pubblico italiano funzio-
na ancora e sempre. Le ragioni di tale persistente interesse superano la spiegazione
più ovvia e, cioè, il valore storico-culturale del poeta fiorentino e della sua opera.
Dante, ormai, com’è stato già da tempo rilevato, è un autore quasi naturalmente
audiovisivo, ben inserito nella connessione contemporanea dei vari mezzi di comu-
nicazione di massa1. Eppure il ricordo del significato assunto dall’opera dantesca
1
Cfr. Amilcare A. Iannucci, Dante, Television and Education, in «Quaderni d’Italianistica»
X (1989), 1-2, pp. 1-33 e, anche, Dante autore televisivo, in «Le Forme e la Storia», n.s., VI (1994),
pp. 107-124. I testi suddetti prendono le mosse dal convegno Dante at the Movies and on Tele-
vision. A Charles Speroni Chair Colloquium, organizzato dal Department of Italian della UCLA
57
4. Caputo.indd 57 17/02/2020 12:17:12Rino Caputo
dal primo Ottocento in poi e, soprattutto, per tutta la fase del Risorgimento na-
zionale, è per il pubblico italiano la premessa di ogni attenzione emotiva e di ogni
sensibilità, per così dire, mediatica.
Non si spiegherebbe, se così non fosse, il titolo solo apparentemente singolare
di un articolo, uscito alle soglie degli anni Duemila, che fa la cronaca di una lectura
dantis di Vittorio Sermonti, di fronte a un (sempre più) vasto pubblico di ascoltatori:
Dante for President («Il Diario», III, 1998, 7). Si noti che questo titolo costituisce
il centro tematico e grafico della copertina del periodico che, appunto, presenta la
“conversazione” del giornalista Luca Fontana con Vittorio Sermonti accompagnata
dal significativo commento: «Alla ricerca della nostra lingua, della nostra identità na-
zionale e del nostro senso di comunità: perché l’Alighieri continua ad essere attuale
(e fantastico)». E, del resto, il più appropriato titolo dell’articolo contenuto nelle pp.
16-24 è: «Il piacere di leggere Dante».
Da questo consolidato punto di vista, si può affermare che il Dante italiano
diverge ancora molto da quello nordamericano, di Ch. Eliot Norton e di Charles
S. Singleton, come di John Freccero e dell’ultima generazione di esegeti canadesi
e statunitensi: Dante è per gli italiani, fin dai banchi della scuola, il «ghibellin
fuggiasco», quello un po’ storicamente e ideologicamente contraddittorio, ma
poeticamente riuscito, dei Sepolcri di Ugo Foscolo, lo stesso autore che consegna
alla generazione successiva di intellettuali e patrioti, di poeti e soldati (garibaldini
e regolari), la formula canonica della fondazione della civiltà, non solo letteraria,
italiana: «Dante tenzona, Petrarca suona» ovvero Dante lotta e trasforma lo stato
di cose e Petrarca, invece, modula versi che, pur non incidendo immediatamente
sulla realtà, consente di leggerla, per così dire, soprattutto in relazione agli stati
d’animo emozionali. Dal canto suo Francesco De Sanctis, il grande critico e stori-
co della letteratura italiana dell’Ottocento, proseguirà su questa linea, con la sua
acuta esegesi venata di motivazioni romantico-risorgimentali, fino a stabilire Dante
come archetipico genitore dell’Italia unita in Stato e Nazione2. Di qui le tante vie e
piazze intitolate – come ogni visitatore delle più belle città italiane, piccole e gran-
di, può agevolmente notare – innanzitutto a Dante, oltre che a Garibaldi, Mazzini,
Vittorio Emanuele II e Cavour, i quattro più celebri protagonisti del Risorgimento
nazionale italiano.
(Los Angeles, 29-31 maggio 1997) sulla base dell’iniziativa del sempre compianto illustre dantista
canadese, ma di intensa cultura linguistica e letteraria italiana, Amilcare A. Iannucci. In quell’occa-
sione chi scrive riferì i primi risultati della ricerca svolta intorno alle “esecuzioni” dantesche nella
radiotelevisione italiana, e di Roberto Benigni in particolare, rammentate dagli accademici dell’U-
CLA all’attenzione del Nostro, nell’occasione prestigiosa del ritiro dell’Oscar nel marzo del 1999.
2
Rinvio, per un più ampio sguardo sull’intera problematica, al mio Per far segno. La critica
dantesca americana da Singleton a oggi, Roma, Il Calamo, 1993, rielaborato nel più largo Il pane
orzato. Saggi di lettura intorno all’opera di Dante Alighieri, Roma, Euroma, 2003.
58
4. Caputo.indd 58 17/02/2020 12:17:12Dante “a mente” di Benigni
Occorre premettere, tuttavia, che le performances di Benigni non esauriscono
il panorama di «Dante on television». È, quindi, allora possibile delineare una
produttiva sequenza negli scorsi ultimi decenni. E le lontane premesse sono, poi,
da ricercare nella duttilità del mezzo televisivo, in grado di contenere il teatro
come la poesia, il cinema come il servizio quotidiano d’informazione giornalistica
(quest’ultimo avviato, peraltro, sempre più progressivamente, a irreversibile spet-
tacolarizzazione e, oggi, al predominio del mezzo digitale). Basterà ricordare, in
proposito, e a titolo esemplare, l’importante messinscena televisiva dell’Orlando
Furioso, adattata dall’opera di Ludovico Ariosto a cura di Luca Ronconi, e l’uso,
allora sempre più crescente, dei grandi attori teatrali e cinematografici nello spazio
televisivo, culturale e non: si pensi a Eduardo De Filippo, a Carmelo Bene oppure
a Vittorio Gassman, al quale, in particolare, si debbono, com’è noto, le più reite-
rate e rimarchevoli attenzioni televisive a Dante e alla Commedia. E tutto ciò ha
avuto, inoltre, un benefico effetto per la letteratura italiana in quanto tale: si pensi
alle varie ricorrenze centenarie per Petrarca, Leopardi, ecc.
È però davvero proverbiale la difficoltà di rendere la Commedia attraver-
so il mezzo audiovisivo. L’arduo compito è stato svolto, tuttavia, da volenterosi
quanto ardimentosi autori e registi cinematografici fin dai primi anni del Nove-
cento. E saranno da ricordare, allora, l’Inferno di Dante, diretto e interpretato da
Giuseppe de Liguoro alla fine degli anni Dieci del Novecento e Dante e Beatrice
di Mario Caserini del 19123. E più numerosi e noti sono, poi, gli esperimenti e
le produzioni effettive realizzate al di qua e al di là dell’Atlantico nei decenni
successivi, fino alla comparsa del mezzo radiotelevisivo: sarà, forse, da ricordare,
in Italia, la Vita di Dante realizzata nel 1965, in occasione del settimo centenario
della nascita del poeta, dal regista Vittorio Cottafavi con protagonista Giorgio
Albertazzi.
È però singolare (come, pure, è stato già evidenziato) che la resa televisiva
della Commedia in Italia si sia configurata, all’inizio, come un’impresa soprattutto
accademica, con gli indubbi meriti intrinseci ma, anche, con gli inevitabili difetti di
appesantimento dello specifico risultato spettacolare. Si deve, infatti, al compian-
to Giorgio Petrocchi, editore critico della Commedia, coadiuvato da un ristretto
manipolo di colleghi dantisti, storici della lingua e della letteratura italiana, la pre-
disposizione di una lectura dantis in cui il “commento” critico-esegetico si unisce
all’esecuzione vocale e visiva di tre grandi attori “dicitori” come Giorgio Albertaz-
zi, Giancarlo Sbragia e Enrico Maria Salerno.
Ma non si tratta di contrapporre sensibilità scenica a rigore scientifico; di cer-
to, una maggiore reciproca libertà avrebbe valorizzato la specifica resa audiovisiva,
3
Cfr. Il Dante di Gassman. Cronaca e storia di un’interpretazione della “Divina Commedia”, a
cura di Maurizio Giammusso, Milano, Mondadori, 1994, p. 67 ma, soprattutto, in seguito, Dante
nel cinema, a cura di Gianfranco Casadio, Ravenna, Longo, 1996.
59
4. Caputo.indd 59 17/02/2020 12:17:12Rino Caputo
impedendo forse l’esito più scontato di una sorta di “teatro in televisione”. Un
teatro, si badi, privo, peraltro, della sua peculiare attrazione drammatica.
Quello che risalta, paradossalmente, dall’esperienza di Petrocchi e del suo re-
gista Marco Parodi, svoltasi verso la metà degli anni Ottanta, è appunto la conge-
niale “oralità” del testo della Commedia, come se esso fosse stato scritto da Dante
per essere letto e scritto per essere “detto”. Tale dotazione dell’opera dantesca
è apparsa evidente in tutte le operazioni di sceneggiatura teatrale e audiovisiva
susseguitesi, appunto, negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta.
Si pensi alla lectura dai forti echi ritmico-timbrici di Carmelo Bene il 2 agosto
del 1981, a Bologna, allestita per commemorare, a un anno di distanza, la tragica
strage terroristica alla stazione ferroviaria; all’esperienza di Paolo Giuranna presso
il Teatro Stabile di Genova negli anni 1983-1986; alla lettura integrale promossa
dall’allora direttore del Teatro di Roma Pietro Carriglio e dal poeta, critico lette-
rario e scrittore Giovanni Raboni nel biennio 1991-1993: poeti, scrittori, artisti e
intellettuali leggevano sul palcoscenico la Commedia ogni lunedì, quando, com’è
noto, le compagnie teatrali riposano; al Ravenna Festival; alla lettura di Leo de Be-
rardinis a Palermo, nel febbraio del 1992; a quel 28 luglio 1992 quando, a Cividale
del Friuli, con la consulenza di Edoardo Sanguineti, il gruppo dei “Magazzini”
legge il poema dantesco per tutta la notte; oltre, ovviamente, ancora una volta, a
Vittorio Sermonti e a Vittorio Gassman, e, come si è già detto, a Roberto Benigni4.
Nel 1988 Sermonti dà inizio, presso Rizzoli, alla pubblicazione cartacea della
sua lettura integrale della Commedia con l’Inferno, seguito a due anni di distanza
dal Purgatorio e poi dal Paradiso (ma si noti che già nel 1993 le edizioni e ristampe
sono almeno quattro). Nello stesso tempo, oltre a una diffusa programmazione ra-
diofonica, su reti diverse e in fasce orarie differenziate, le audiocassette di Sermon-
ti sono distribuite commercialmente dalla Divisione Marketing della RAI. Non
si può prescindere, insomma, dall’esperienza di Sermonti, un autentico crocevia
audiovisivo, dove si uniscono tradizione e innovazione; né sarà da trascurare che
l’operazione culturale è tutelata, fin dall’inizio, dal grande critico e filologo Gian-
franco Contini, il cui sguardo sollecito sarà interrotto solo dalla morte, avvenuta in
itinere, per così dire, il 1 febbraio 1990.
Sermonti è esplicito, in via preliminare, sulla destinazione radiofonica della sua
lectura dantis; ma, fin dall’inizio della sua rievocazione, risalta la carica quasi pro-
digiosa del testo dantesco. Forti sono pertanto le motivazioni che hanno spinto un
tale singolare uomo di cultura a leggere Dante in pubblico, fino al quasi sacrosanto
riconoscimento del 31 agosto 1997, quando Sermonti dice e commenta il canto
XXIII del Paradiso davanti a papa Giovanni Paolo II.
4
Cfr. Dante in scena: voci del Novecento, in Il Dante di Gassman, cit., pp. 117-156.
60
4. Caputo.indd 60 17/02/2020 12:17:12Dante “a mente” di Benigni
Così Sermonti definisce la sua nozione di esecuzione del testo della Commedia:
La voce ne sa più di me, più di quanto ne so io. Mi affido a lei. È lei che scopre
nel testo, in cesure, arsi, tesi, scarti ritmici, l’espressione in senso musicale. 1)
Non fare finta di essere Dante – quello che dice Io è un personaggio che lui s’è
inventato – quell’io simula di ricordare un viaggio che ha fatto. Io mi costrin-
go a un solo livello di simulazione, quello del personaggio fittizio che legge se
stesso. 2) Non assumere l’aria pensosa del genio assoluto. 3) Non si devono
recitare i discorsi diretti contenuti tra virgolette, le persone che parlano sono
personaggi della memoria del personaggio Dante. Quando racconti battute de-
positate nella tua memoria mormori scandendo, urli a bassa voce, risolfeggi il
testo. Insomma, non devi fare Ulisse, gonfiando il tono predicatorio. Questo io
intendo per lettura di contro a recitazione: spielen Dante, play, jouer, ma mai re-
citare. Mi accorgo poi che non leggo mai un canto di Dante due volte allo stesso
modo. E che però, quasi sempre, dopo un lungo collaudo, tendo a mimare la
primissima lettura, a regredire a quella prima stupefazione5.
Ma intorno alla metà degli anni Novanta c’è un altro Dante ‘detto’ e ‘letto’ in pub-
blico, a teatro e in televisione, oltre a quello di Sermonti e a quello di Benigni: il Dante
di Gassman, secondo il titolo di un pregevole volume curato da Maurizio Giammusso
nel 1994, che raccoglie in pagine ora dense ora lievi l’eccezionale esperienza dantesca
di Vittorio Gassman, non a caso intesa nel sottotitolo – a diradare ogni equivoca nube
– come «cronaca e storia di un’interpretazione della Divina Commedia»6.
Con Gassman l’esecuzione vocale ovvero la lettura “ad alta voce” della Com-
media irrompe nello spazio audiovisivo multiespressivo e multicomunicativo del
teatro, proprio mentre si ribadisce la mancanza di esperienze teorico-pratiche pre-
cedenti nel panorama italiano (ma si rammentano i riferimenti anglosassoni, ben
presenti all’attore, uomo di vasta e ricercata cultura generale e specifica ma, anche,
colto studioso di buone letture: da Francis Ferguson, e il suo Idea di un teatro, a
Thomas S. Eliot, e al suo Dante dalla “più facile” leggibilità, a J. Freccero e alla sua
visione del poema dantesco come un «viaggio di trasformazione»)7.
La lectura di Gassman procede dunque dalla volontà, avvertita come sfida
artistico-culturale, di collegare il Teatro e la Commedia. A tale scopo, oltre alle pre-
messe – teoriche e tecniche, appunto – dei referenti stranieri, conta in Gassman la
5
Ibid.
6
Cfr. Il Dante di Gassman, cit., che, appunto variamente, raccoglie preziose e illuminanti
testimonianze sulla lectura di Gassman.
7
Cfr. Gassman, Inferno e Paradiso. Diario del set, pp. 13-53, in particolare pp.9-10 e Io e
Dante. Conversazione tra Vittorio Gassman, Luciano Lucignani e Rubino Rubini, pp. 55-80, in pa-
ricolare pp. 59-68, ambedue in Il Dante di Gassman, cit. Cfr., per un più ampio panorama, il mio
Per far segno, cit. e, ancora, il mio “Easier to read”: poeti nordamericani critici di Dante, in Il pane
orzato, cit., pp. 103-117.
61
4. Caputo.indd 61 17/02/2020 12:17:12Rino Caputo
ripresa di certa tradizione italiana, teatrale e dantesca insieme, legata all’Ottocento
romantico-risorgimentale e incentrata sul grande attore (e patriota) Gustavo Mo-
dena che, appunto vestito da Dante, recitava sulla scena la Commedia, davanti al
pubblico italiano ma, soprattutto, costretto all’esilio, davanti al pubblico europeo
e, in particolare, inglese: a conferma, se ce ne fosse stato ancora bisogno, della cor-
rente italofona e peculiarmente dantesca che si assesta in Inghilterra con i Panizzi,
i Rossetti e, prima ancora, con Ugo Foscolo (quella corrente, sia detto, per bre-
vità, veramente “tra parentesi”, che attraverso la fruizione di Henry Wadsworth
Longfellow e degli Eliot si radicherà a Cambridge, Mass. e giungerà, “per li rami”,
a Charles S. Singleton e alla moderna critica dantesca nordamericana!)8.
Ma Gassman, come Sermonti, è d’altra parte legato all’immagine primigenia
più consueta della presenza di Dante nel senso comune dell’italiano colto: la reci-
tazione a memoria, «ad alta voce», come dice proprio Gassman, avvenuta storica-
mente e archetipicamente nello spazio familiare e scolastico:
Dante, per lui, è un ricordo d’infanzia, il ritorno alle gare di memoria con la
madre... è il sentimento dell’adolescenza, segnata dalle lezioni al liceo Tasso
del professor Vladimiro Cajoli... leggeva soprattutto...dando legittimità ad
una interpretazione «ad alta voce»
sicché anche per Gassman, prima di ogni più teoricamente, filologicamente e er-
meneuticamente agguerrita “interpretazione”, vale il parallelismo col poeta-pelle-
grino, protagonista del viaggio oltremondano: «Quel lungo e aspro viaggio dall’In-
ferno al Paradiso era solo l’ultimo tratto di un percorso più lungo, cominciato
chissà quando: il fiume carsico di una esperienza di vita e arte, che usciva ora defi-
nitivamente alla luce»9. Perciò la “lectura” deve procedere, per Gassman, senza far
ricorso ai consueti mezzi tecnici dell’attore di teatro: nessun “gobbo” (il nastro su
cui vengono scritte le parole che l’interprete deve pronunciare), nessun suggerito-
re umano, bensì, quando, in particolare, si giunge al trentatreesimo del Paradiso,
«tutto a memoria»; a confermare, ancora una volta, la sacrale accettazione della
tradizione e fino a configurare, talora, una sorta di rinnovata «dantemania»10.
Il culto di Dante si conferma, in tal modo, una risorsa preziosa dello “spirito
pubblico” italiano e accomuna, proprio come nel Trecento, chierici intellettuali
e popolo sollecitati intensamente e profondamente dall’«esecuzione» della Com-
8
Cfr. Dante in scena: Roma o morte! Le “dantate” di Gustavo Modena, in particolare pp.
82-105 in Il Dante di Gassman, cit.; cfr., ancora, Per far segno, cit., in particolare pp. 23-30 e Rino
Caputo, La critica dantesca nordamericana dal 1965 al 1990, in Dalla bibliografia alla storiografia.
La critica dantesca nel mondo dal 1965 al 1990, a cura di Enzo Esposito, Ravenna, Longo, 1995,
pp. 217-237.
9
Cfr. Il Dante di Gassman, cit., p. 17 e p. 14.
10
Ivi, p. 40 e p. 53.
62
4. Caputo.indd 62 17/02/2020 12:17:12Dante “a mente” di Benigni
media. Non stupirà allora che il colto Gassman e l’(apparente) in-colto Benigni
rinnovano, ciascuno a suo modo, la tradizione orale delle campagne e delle chiese
toscane, così come dei banchi di lettura degli studi dei dotti di ogni parte d’Italia.
Ma tutto ciò avviene oggi, sempre più, nella piazza (apparentemente) virtuale
della realtà audiovisiva che, grazie a Dante e al suo «poema sacro» fondato sul «vi-
sibile parlare», può giustificare le sue più promettenti (e prodigiose) prospettive.
Di questa “piazza” Roberto Benigni è indubbiamente il protagonista più du-
revole e efficace. Sia detto fin da ora: l’operazione dell’attore, peraltro autore “co-
mico”, si configura non tanto come lectura, in senso accademico, e non solo come
comunicazione a memoria del singolo canto, bensì come una vera e propria inter-
pretazione del testo dantesco alla stregua di uno spartito musicale: Benigni dice
Dante come se eseguisse un brano in concerto e, in tal senso, la sua performance
teatrale è una vera e propria “esecuzione” della Commedia.
E allora, pur essendo già noto per aver ‘eseguito’ Dante presso l’Università di
Siena, non c’è dubbio che l’autentica consacrazione avviene alla fine di maggio del
1993, quando, durante la trasmissione televisiva Babele, condotta da Corrado Augias,
alla presenza di Luigi Berlinguer, allora rettore, appunto, dell’Università di Siena, di
Vittorio Sermonti e del pubblicitario Gavino Sanna, Benigni dice ovvero “esegue”
il canto V dell’Inferno. Solo apparentemente si può parlare, in questo archetipico
caso, di improvvisazione. In realtà, sollecitato all’impronta da Augias, con tono ar-
gomentativo apparentemente colloquiale, Benigni premette alla pronuncia del canto
una vera e propria introduzione critico-ermeneutica, non rinunciando a citare, sia
pur indirettamente, le risultanze più aggiornate della dantologia contemporanea, in
particolare quella nordamericana, legata all’intreccio tra gli studi di Erich Auerbach
e le impostazioni teoriche di Ch. S. Singleton e di J. Freccero11.
Sicché l’evento di “Babele” sposta, per così dire, la capacità espressiva di Benigni
dalle pur consistenti interazioni teatrali nei luoghi più e meno ampi delle università
o delle piazze fisiche (Santa Croce, a Firenze, ad esempio, dove si ripeteranno le pre-
senze dell’attore) verso la piazza virtuale, televisiva, audiovisiva, digitale e, tuttavia,
non meno reale e definitivamente amplissima, tendenzialmente planetaria.
L’“esecuzione” del febbraio 2007 a Lovanio, in onore di Franco Musarra e alla
presenza di Umberto Eco e di altre personalità culturali italiane e straniere, di cui si
diceva all’inizio, è certamente il momento più acuto del lavoro di Benigni su Dante.
Questa esperienza non mancherà di registrare le conseguenze più mature e consa-
pevoli successivamente e, in particolare, ne risentirà beneficamente il libro Il mio
Dante, del 2008, scritto da Roberto Benigni con un contributo approfondito quan-
to ironico di Umberto Eco12. Questo pur qualificato intervento dell’attore riceve,
Cfr. nota 7.
11
Cfr. Roberto Benigni, Il mio Dante, con uno scritto di Umberto Eco e la postafazione di
12
Valentina Pattavina, Torino, Einaudi, 2008.
63
4. Caputo.indd 63 17/02/2020 12:17:12Rino Caputo
però, senso aggiunto soprattutto dal più recente volume curato e introdotto proprio
da Franco Musarra nel 2017, che raccoglie gli Atti del Convegno di Apiro del 18
ottobre 2015 “Il mio Dante” di Roberto Benigni13. Dedicato a Umberto Eco “in me-
moria”, nel frattempo scomparso, il contributo si vale dell’introduzione ragionata di
Franco Musarra che mette in rilievo la «spettacolarità» e, insieme, la «seria e scienti-
fica preparazione di Benigni» (p. 25). Viene d’altra parte valorizzata la recitazione “a
mente”, dichiarata dall’attore, già nel suo volume del 2007 e qui ripresa da Musarra,
come eredità familiare: «la mamma voleva fargli “capire che Dante aveva una memo-
ria di ferro che anch’io dovevo avere la memoria di ferro che aveva Dante. E pure
il mio babbo voleva che sviluppassi la memoria»14. Benigni è attento all’importanza
delle pause, ribadisce Musarra. E effettivamente basti ascoltare le varie esecuzioni di
questi anni del canto quinto dell’Inferno per confermare tale rilevazione: come, ad
esempio, nello stacco dei versi 67 e 68 «“e più di mille / ombre mostrommi e nomi-
nommi a dito”, in cui Benigni separa la parola rima di fine verso col tempo giusto,
affinché sia considerata nel ritmo orale del verso e, insieme, nel legame sintattico che
purtuttavia mantiene con il sostantivo iniziale del verso successivo»15.
L’analisi attenta e capillare di Musarra mira a rintracciare, nel Benigni lettore
critico di Dante, sia il comico che l’ironico16. Illuminante, per sintesi, è la conclusione
dell’argomentazione esegetica di Musarra relativa all’esecuzione di Benigni:
La sua è una doppia lettura: da un lato è sostanzialmente orale, con il coin-
volgimento costante di un tu in cui noi lettori/ascoltatori ci riconosciamo…,
dall’altro è scientifica e non solo nel momento della performance recitativa
ma anche in quello della lettura/spiegazione del poema, in cui la nota domi-
nante è l’evidenza, sino a rendere chiari i versi più complessi17.
Forse, dopo questa perspicua messa a punto di Musarra, anche Benigni potrà
rimanere “contento al quia” della sua lettura dell’opera di Dante, non (troppo)
lontana, almeno nelle intenzioni, da quella dell’invidiato Boccaccio.
Alla vigilia della ricorrenza settecentenaria del 2021, quindi, il “Dante a men-
te” di Roberto Benigni si presenta come limpido e schietto testimone della dure-
volezza del Sommo poeta (che già Th. S. Eliot definiva «easier to read»18), pronto
a parlare, ancora, come proprio padre Dante dice (Paradiso, XVII, 120), anche a
«coloro che questo tempo chiameranno antico».
13
Cfr. “Il mio Dante” di Roberto Benigni, a cura di Franco Musarra, Pacifico Ramazzoni e
Nadia Sparapani, Firenze, Cesati, 2017.
14
Ivi, p. 29.
15
Ivi, p. 31
16
Ivi, p. 42.
17
Ivi, p. 43.
18
Cfr., ancora, nota 7.
64
4. Caputo.indd 64 17/02/2020 12:17:12Puoi anche leggere