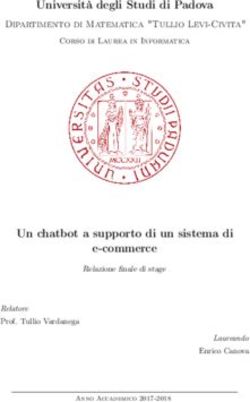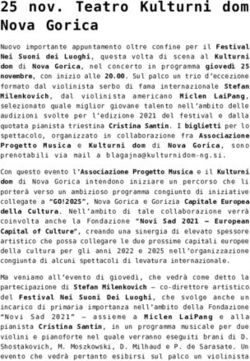Classica Vox Rivista di Studi Umanistici 2 2020 - La Rivista
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Classica Vox
Rivista di Studi Umanistici
2 · 2020Classica Vox
Rivista di Studi Umanistici
I.I.S. Liceo «Concetto Marchesi» - Mascalucia (CT)
Dipartimento di «Civiltà Antiche e Moderne»
Università degli Studi di Messina
CONTATTI
I.I.S. Liceo «Concetto Marchesi», via Case Nuove, I-95030 Mascalucia (CT)
Tel. + 39 095 7272517
e-mail: ctis02600@istruzione.it
PEC: ctis02600@pec.istruzione.it
URL: www.classicavox.it
Corrispondenza editoriale: classicavox@gmail.com
Copyright ©
2020
Quest’opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons
AttributionNonCommercialNoDerivatives 4.0 International il cui testo è disponibile
alla pagina Internet https://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0
ISSN 2724-0169 (online)Classica Vox
Rivista di Studi Umanistici
2 · 2020
CATANIA · MESSINA
2020INDICE SAGGI E NOTE Claudio MELIADÒ L’impianto scenico dell’Ifigenia in Tauride: elementi per una ricostruzione 9 Luigi SPINA Consiglieri da evitare, ovvero se valga più la proposta o il proponente 17 Philippe MUDRY Les vaisseaux fantômes. Réflexions sur la lettre vésuvienne de Pline 6, 16 27 Klaus-Dietrich FISCHER Le coq est mort: Ein Tierversuch zum Nachweis der Tollwut bei Pseudo-Apuleius und in griechischer Überlieferung 39 Mario LENTANO Tutti gli uomini di Lucrezia. Sviluppi tardo-antichi e medievali di un mito romano 55 Sergio AUDANO Due epitafi per un re. Sulle perdute iscrizioni funebri di Alfonso II d’Aragona nel Duomo di Messina 81 Anita DI STEFANO Presenze di Rutilio nella poesia di Iacopo Sannazaro 103 Michele NAPOLITANO Ancora su Caproni e i classici. Un verso del Passaggio d’Enea 119 Tommaso BRACCINI L’autobus non ferma più a Eleusi: miti di survival e fortuna dell’antico 127 SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE DIDATTICA Olga CIRILLO Il latino e il greco nella scuola 2.0: insidie e vantaggi della didattica digitale integrata 151 RECENSIONI Maria CANNATÀ FERA (ed.), Pindaro, Le Nemee, 2020 (Donato LOSCALZO) 169 Emanuele Riccardo D’AMANTI (ed.), Massimiano, Elegie, 2020 (Rosalba DIMUNDO) 173 Sara REY, Le lacrime di Roma. Il potere del pianto nel mondo antico, 2020 (Donatella PULIGA) 181 Petros BOURAS-VALLIANATOS, Barbara ZIPSER (edd.), Brill’s Companion to the Reception of Galen, 2019 (Domenico PELLEGRINO) 185 Fabio STOK, Letteratura latina. Generi e percorsi, 2020 (Lavinia SCOLARI) 197 AUTORI 205
PETROS BOURAS-VALLIANATOS, BARBARA ZIPSER (edd.), Brill’s Companion to the
Reception of Galen. Leiden-Boston: Brill, 2019, pp. XXVI + 684. [«Brill’s
Companions to Classical Reception, 17»]. ISBN: 978-90-04-30221-1. € 180.
N ella prestigiosa serie «Brill’s Companions to Classical Reception», diretta
da Kyriakos N. Demetriou, è recentemente apparso un volume
interamente dedicato alla ricezione dei testi di Galeno. L’opera, curata da Petros
Bouras-Vallianatos e Barbara Zipser e dedicata alla memoria di Piero Tassinari,
ha il merito di riunire attorno allo stesso tema alcuni dei principali esperti della
materia e, conseguentemente, di offrire alla comunità scientifica tutta uno
strumento di studio e di lavoro che conta ben trentuno capitoli. Obiettivo
dell’opera è quello di indagare la trasmissione e la ricezione del magistero
galenico non soltanto in testi medici (greci, latini, arabi, siriaci e in altre lingue),
ma anche farmacologici, alchemici o filosofici.
Il volume si articola in cinque grandi sezioni, ciascuna delle quali intende
riflettere sul tema da angolature diverse: la prima («Galen in Late Antiquity and
Byzantium», pp. 9-160) scandaglia il modo in cui il magistero galenico è stato
ereditato, interpretato e trasmesso nel corso della Tarda Antichità e a Bisanzio,
anche in testi non medici, sino al 1453; la seconda sezione («Galen in the
Medieval Islamic World», pp. 161-316) focalizza l’attenzione sulla ricezione
galenica nel mondo siriaco e arabo, passando in rassegna i principali traduttori
che hanno contribuito alla nascita di un Galeno Arabo; la terza («Galen in the
Medieval West», pp. 317-434) offre al lettore una riflessione sul Galeno Latino a
partire dalle prime traduzioni, che risalgono all’XI e al XII secolo, per giungere
alla fruizione di tali traduzioni nelle università medievali dal XIII al XV secolo;
la quarta («Galen in the Renaissance and Beyond», pp. 435-534) è dedicata
all’approdo di Galeno nel mondo moderno, partendo dalle prime edizioni a
stampa (latine prima, greche poi) per giungere sino al Corpus Medicorum Graecorum
pubblicato dalla Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften; la
quinta e ultima sezione del volume («Galen in Other Cultures», pp. 535-638)
accoglie una riflessione sulla ricezione del pensiero medico galenico nei testi
scientifici ebraici redatti in epoca medievale, nella tradizione armena, nella
produzione di testi alchemici in area orientale e, più in generale, in territorio
asiatico. Chiudono il volume l’Index rerum et nominum (pp. 639-656) e l’Index
locorum (pp. 657-684), entrambi sempre precisi.
Dopo i ringraziamenti (p. XI), una List of Figures (p. XII), una sezione dedicata
alle abbreviazioni dei titoli delle opere galeniche (pp. XIII-XVII), le informazioni
sugli autori dei contributi (pp. XVIII-XXV) e una nota per il lettore (p. XXVI),
apre il volume l’Introduction (pp. 1-7) di Petros BOURAS-VALLIANATOS e Barbara
ZIPSER. Constatando che «the reception of Galen’s theories and works has not
to date been the subject of a comprehensive study» (p. 2), i curatori hanno inteso
mettere insieme i contributi di diversi esperti sul versante del Galenismo
cosicché tale lacuna potesse essere finalmente colmata e fosse disponibile uno
strumento di lavoro a partire dal quale nuovi studi possano svilupparsi. IlRECENSIONI
volume, suddiviso in cinque parti, può anche essere letto – suggeriscono gli
autori – seguendo tre diverse direttrici tematiche: «textual tradition» (p. 2),
«Galen’s impact on medical theory and practice» (p. 5) e «the reception of Galen
outside medicine and book production» (p. 6), nelle quali confluiscono in
maniera armonica i diversi contributi, a seconda delle specificità di ognuno.
La prima sezione, «Galen in Late Antiquity and Byzantium», consta di sette
capitoli. Il primo, Galen’s Early Reception (Second-Third Centuries) (pp. 11-37), è a
firma di Antoine PIETROBELLI. L’autore intende indagare sulla fortuna di Galeno
quando era ancora in vita e subito dopo la sua morte, attraverso la ricerca e il
commento di menzioni (esplicite e/o occulte) del suo nome o dei suoi metodi
d’indagine razionale in opere composte tra il II e il III secolo d.C. Nel tentativo
di offrire «a picture of Galen in the eyes of his contemporaries» (p. 12),
Pietrobelli imposta la sua riflessione partendo dalla presenza di Galeno nelle
opere di due illustri figli di Naucrati, Polluce e Ateneo. Nelle sezioni
dell’Onomasticon dedicate alla medicina, Polluce afferma di aver consultato le
opere di un medico – senza mai nominarlo – per il suo spoglio lessicografico;
Ippocrate viene citato ma, nel caso delle tuniche oculari, Polluce attinge a fonti
diverse da quelle ippocratiche, dal momento che in Ippocrate sono attestate solo
due tuniche, mentre Polluce (proprio come Galeno) segnala il nome di ben
quattro membrane. «No concrete proof directly links Galen with Pollux» (p. 15),
ma entrambi operarono nell’entourage di Commodo. Galeno è inoltre uno dei
protagonisti dei Deipnosophistai di Ateneo: sui tre luoghi dell’opera in cui il
Pergameno viene citato si è pronunciata la critica, giungendo a considerarli
comunque genuini, e il fatto che Galeno compaia nei primi tre libri di
quest’opera (prima come protagonista, poi come interlocutore) ad un’altezza
cronologica a lui estremamente vicina è una dimostrazione in più della fama che
aveva già conquistato in vita. La fama di Galeno è poi indagata da Pietrobelli
nell’opera di un altro filosofo del II-III secolo d.C., Alessandro d’Afrodisia. Non
sappiamo se i due si siano mai incontrati, ma sicuramente Alessandro d’Afrodisia
doveva tenere in gran conto Galeno, dal momento che lo pone sullo stesso piano
di Platone ed Aristotele, al punto da considerarlo «an authoritative competitor
in the arena of truth, judged by his writings and incriminated for his attacks on
Aristotle» (p. 22). Interessante è notare l’impatto che il metodo di analisi testuale
delle fonti, fondata su princìpi filologici, di Galeno ha avuto anche sul mondo
cristiano delle origini: nella Roma del II secolo d.C. Galeno fu considerato dai
Cristiani un filosofo e da questi tenuto in altissima considerazione al punto che
divenne «a model of logical methods and also a teacher of textual exegesis» (p.
25); infine, Pietrobelli indaga gli echi galenici nelle opere di Clemente di
Alessandria e di Origene, giungendo alla conclusione che Galeno è passato alla
storia come uno dei padri della medicina antica, mentre «in the eyes of his
contemporaries» era strettamente legato al mondo della filosofia. Nel secondo
capitolo, Galen in Late Antique Medical Handbooks (pp. 38-61), Petros BOURAS-
VALLIANATOS indaga la sopravvivenza galenica nei testi medici d’età tardoantica
sia greci sia latini. In primo luogo, sono esaminate le opere di Oribasio, Aezio e
Paolo Egineta, tutti dipendenti da Galeno, sia pur in modi e con margini di
186RECENSIONI
autonomia diversi. Il primo a impostare il recupero di informazioni galeniche
con una certa problematicità è stato Alessandro di Tralles: Bouras-Vallianatos,
infatti, sostiene che «it is worth dividing the Galenic citations in Alexander’s
work into three main groups. First are cases in which Alexander has been
influenced by Galen but does not refer to him by name. Second are examples in
which Alexander provides a reference to a piece of Galenic advice and explicitly
mentions his master by name; here Galen is sometimes used as an authority on
a certain subject to support Alexander’s use of a particular recommendation.
Third are the cases in which Alexander does not hesitate to disagree with Galen’s
views» (p. 47); questo atteggiamento ha fatto di Alessandro il primo autore a
dimostrare la debolezza di alcuni ragionamenti del maestro. Sul fronte dei testi
latini, lo studioso prende in esame i casi di Celio Aureliano, Teodoro Prisciano
e Cassio Felice. Dal quadro tratteggiato, emerge che in epoca tardoantica la
ricezione e trasmissione del pensiero galenico ha conquistato via via una maturità
e un’indipendenza sempre maggiore. Il capitolo terzo, Galen’s Legacy in
Alexandrian Texts Written in Greek, Latin, and Arabic (pp. 62-85), a firma di Ivan
GAROFALO, è una miniera di informazioni. L’attenzione dello studioso si
concentra sul canone delle opere galeniche oggetto d’insegnamento presso la
Scuola di Alessandria: «once the relevant Galenic texts were selected, they were
shortened and systematised by the Alexandrian scholars. This led to the
production of commentaries, summaries, and schematic diagrams, or tabulae» (p.
65); tale selezione, inevitabilmente, ha influenzato la trasmissione delle stesse
opere di Galeno nei secoli seguenti. Garofalo, infine, segnala che gli Alessandrini
non furono certo esenti da errori, che fecero progredire il magistero galenico
(«perhaps, the most important addition of the Galenism was the introduction of
a third type of pneuma, the natural pneuma, which before then was only a
hypothesis in Galen», p. 73) e che tra i prodotti del Galenismo alessandrino ci
sono alcune opere pseudo-galeniche. Segue un nuovo capitolo a cura di Petros
BOURAS-VALLIANATOS, Galen in Byzantine Medical Literature (pp. 86-110), in cui
si esaminano le modalità di recupero del pensiero galenico in opere mediche
bizantine tra il VII e il XV secolo. Inizialmente, l’autore riflette su opere che,
inevitabilmente, si sono intersecate con l’antropologia cristiana (come il Περὶ τῆς
τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς di Teofilo e il De natura hominis di Melezio), per poi
passare a testi bizantini che forniscono istruzioni di tipo diagnostico e
terapeutico, spesso dedicati a polsi e urine. Uno spazio particolare è riservato a
tre autori bizantini (Symeon Seth, Giovanni Attuario e Giovanni Argiropulo)
che, in diversi modi, hanno reso peculiare il loro approccio a Galeno. Il capitolo
5, Galen in Byzantine iatrosophia (pp. 111-123), a cura di Barbara ZIPSER, tenta di
definire la presenza di Galeno negli iatrosophia, particolare genere letterario dai
contorni assai sfumati e labili. L’autrice prende in esame cinque casi di iatrosophia,
di epoche diverse, come diverse sono la struttura e la qualità che li caratterizzano.
Oltre al carattere compilativo, ciò che sembra accomunare testi così diversi è
proprio la ricezione di Galeno, le cui opere vengono qui «amalgamated» (p. 121)
e che, pur vedendosi riconosciuto il ruolo di auctoritas, non è certo l’unica fonte
utilizzata in questo genere letterario. A seguire si trova il capitolo di Paola
187RECENSIONI
DEGNI, Textual Transmission of Galen in Byzantium (pp. 124-139), che focalizza la
propria attenzione sulla trasmissione di testi galenici a Bisanzio. I manoscritti di
quest’epoca che tramandano Galeno non differiscono in nulla rispetto a quelli
che conservano altri testi (medici e non), se non per il fatto che «we lack
manuscripts transmitting Galen’s entire corpus» (p. 129); l’attenzione si sposta
poi su nove manoscritti, vergati nello scriptorium di Ioannikios (sei dei quali
tramandano soltanto testi galenici, mentre i restanti a quelli galenici affiancano
testi di altri medici bizantini), per poi passare ad alcuni manoscritti italo-greci e
all’ormai famoso ms. n. 14 del monastero Vlatadon di Salonicco, risalente al XV
secolo, all’interno del quale nel 2005 Antoine Pietrobelli ha trovato preziosissimi
materiali galenici, tra i quali si ricordi almeno il testo di un’opera, il Περὶ ἀλυπίας,
che si pensava fosse irrimediabilmente perduta. L’ultimo capitolo di questa
sezione, Galen in Non-medical Byzantine Texts, 600-1453 (pp. 140-159), è a cura di
Dionysios STATHAKOPOULOS, che tratteggia un quadro denso e articolato della
sopravvivenza di Galeno in testi d’argomento non medico in epoca bizantina,
«trying to determine which of his works were actually read (and thus specifically
cited or alluded to), when, where, and by whom» (p. 141). Stathakopoulos prende
in esame la presenza di Galeno e della sua opera in autori come – tra gli altri –
Sofronio di Gerusalemme, Fozio, Giovanni Siceliota, Michele Psello (il cui
utilizzo di Galeno rappresenta uno scatto rispetto agli standard dei suoi
predecessori e «suggests the beginning of a more serious engagement with his
texts, which must have been based on the existence of manuscripts», p. 146),
Eustrazio di Nicea e Michele di Efeso, Anna Comnena, Giovanni Tzetze,
notando come del corpus galenico da questi autori furono maggiormente utilizzati
i testi medici e non quelli con uno sfondo filosofico.
La seconda sezione, «Galen in the Medieval Islamic World», consta di nove
capitoli e si apre col contributo di Siam BHAYRO, The Reception of Galen in the Syriac
Tradition (pp. 163-178). L’autore fa il punto sulle tre stagioni delle traduzioni
siriache dei testi galenici: la prima, che risale al VI secolo, ha come protagonista
Sergius di Resh ‘Aina, il quale – stando alle più recenti indagini – «took a reader-
orientated approach to translation, with a pragmatic use of Greek loanwords»
(p. 166); la seconda, che risale al IX, ruota attorno alla figura di Ḥunayn Ibn
Isḥāq; la terza, collocabile tra XI e XIII secolo, è comunemente definita
«Rinascimento Siriaco» («Syriac Renaissance»). Nonostante il crescente interesse
degli studiosi verso questa provincia di studi, «much remains to be done before
we can properly describe the receptions of Galen in Syriac» (p. 173); in questo
senso, la realizzazione di un Corpus Medicorum Syriacorum sarebbe determinante.
Segue il capitolo a cura di Glen M. COOPER, Ḥunayn Ibn Isḥāq and the Creation of
an Arabic Galen (pp. 179-195), nel quale la studiosa concentra la propria
attenzione sul metodo di traduzione di Ḥunayn e sul suo contributo alla
formazione di un Galeno Arabo. Il traduttore ha elaborato un proprio stile di
traduzione «reader-oriented», teso cioè a essere quanto più chiaro possibile agli
occhi del proprio lettore senza badare a un’adesione pedissequa al testo tradotto,
caratterizzato da peculiarità che Cooper enuclea e discute nei diversi paragrafi
del capitolo: si tratta, infatti, di «expansions» rispetto al testo fonte (par. 4),
188RECENSIONI
elementi aggiuntivi o esplicativi (par. 5), traslitterazioni e definizioni di un
termine tradotto (par. 6), «deliberate (mis)translation» (par. 7), sovrapposizioni e
slittamenti semantici (par. 8). L’analisi, chiara e supportata da esempi
circostanziati, aiuta a entrare nelle fibre di un metodo di traduzione certamente
complesso, che ha consentito al pensiero galenico di traghettare in Occidente. Il
contributo di Pauline KOETSCHET, From Commentary to Polemic: the Reception of
Galen by Abū Bakr al-Rāzī (pp. 196-214), riflette sul modo in cui l’eredità galenica
è stata gestita da Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīya’ al-Rāzī, medico vissuto
nella seconda metà del IX secolo e morto intorno al 925. La prospettiva ottimista
di al-Rāzī sul progresso scientifico si basava sulla convinzione che le scienze
sono in continua evoluzione e che tale evoluzione implicasse una correzione
degli errori fatti in passato; ciò implica un costante uso delle fonti. Tra queste
spicca certamente Galeno, contro il quale al-Rāzī fu «as far as is known, the only
Islamic physician who dared to devote a polemical treatise, Doubts About Galen»
(p. 197). Lo studio di Koetschet si articola in quattro interessanti sezioni: la prima
esamina il metodo di lavoro al-Rāzī su diverse opere galeniche; la seconda è
dedicata al già citato Doubts About Galen, testo in cui il medico arabo, passando
in rassegna più di venti opere, mette in evidenza passaggi in cui il Pergameno
cade in contraddizione o fonda le proprie convinzioni scientifiche su basi poco
solide; nella terza si riflette sul fatto che l’approccio critico di al-Rāzī al testo
galenico – con un focus mirato su natura della materia ed elementi, teleologia e
ottica – ha stimolato il dibattito scientifico tra IX e X secolo; la quarta è dedicata
agli effetti generati nel mondo islamico dall’approccio critico di al-Rāzī alle opere
galeniche, con un interessante riferimento alle critiche rivolte da Ibn Riḍwān non
solo al sistema di formazione dei medici del suo tempo, ma anche a Ḥunayn e al-
Rāzī per «their supposed misunderstanding of the Greek sources» (p. 209). Il
capitolo 11, Avicenna between Galen and Aristotle (pp. 215-226), scritto da Gotthard
STROHMAIER, è dedicato ad Avicenna, vissuto tra X e XI secolo e autore
dell’insuperato Canone della medicina (Canon of Medicine), in cui – in contrasto
col suo predecessore al-Fārābī – ha considerato la medicina come parte
integrante delle scienze naturali. «The result was an overlapping between the
diverging statements of Aristotle, ‘the first teacher’, and Galen» (p. 218) e su tale
contrasto di vedute si sofferma Strohmaier, offrendo al lettore una magistrale
riflessione su tre questioni di anatomia e fisiologia (funzionamento di cuore e
cervello; passaggio del sangue dal ventricolo destro a quello sinistro; comparsa
degli organi principali nello sviluppo embrionale). Alla ricezione di Galeno dopo
il magistero di Avicenna è dedicato il capitolo 12, The Reception of Galen after
Avicenna (Eleventh-Twelfth Centuries (pp. 227-243), di Miquel FORCADA. L’autore
si concentra su come il mondo arabo reagì di fronte al Canone di Avicenna, che
per la sua completezza iniziò quasi a sostituirsi ai testi di Ippocrate e Galeno,
opere su cui però si ritornò tra XI e XII. A Baghdad troviamo, infatti, Ibn al-
Ṭayyib (morto nel 1043), «an original thinker who was not only very erudite but
was also able to make novel contributions to science and philosophy» (p. 230),
che nel suo commento all’Ars medica (l’unico ad oggi studiato) dimostra di ben
conoscere la tradizione dei commentatori galenici e di utilizzare testi tradotti dal
189RECENSIONI
greco in arabo «which differ from Ḥunayn’s versions but coincide with the
Summaria Alexandrinorum» (p. 230); inoltre, in questo testo Ibn al-Ṭayyib, in
armonia con lo stile degli Alessandrini, arricchisce la propria riflessione con
riferimenti ad altre opere galeniche, a quelle di altri medici greci (tra cui troviamo
Sorano di Efeso) e a fonti filosofiche, trovandosi talvolta in disaccordo con lo
stesso Galeno. In Egitto, sempre nello stesso periodo, ha luogo l’esperienza di
Ibn Riḍwān, medico-filosofo che riuscì a diventare «chief physician of the
Fatimids» (p. 231), dominando così la scena medica del Cairo per anni; convinto
che un medico dovesse possedere anche conoscenze teoriche e che non
bastassero quelle pratiche, promosse una solida conoscenza delle opere
ippocratiche e galeniche e iniziò ad insegnare a un gruppo di studenti,
componendo anche numerosi commenti a testi di Galeno. Nella Spagna islamica
(al-Andalus) del XII secolo troviamo un rinnovato interesse per Galeno a
Saragozza, ove si formò Ibn Bājja, «the originator of the process of
Aristotelisation that dominated the intellectual life of al-Andalus during the
twelfth century» (p. 235); Ibn Bājja subì molto l’influenza dell’opera di al-Fārābī,
cui voleva introdurre i lettori dei suoi commenti a Galeno. In questo contesto
opera, tra gli altri, anche Averroè (Ibn Rushd), il cui aristotelismo fu
«overshadowed by Galen and the Galenism of the Canon in Europe and the
Muslim world» (p. 239). Maimonides and Galen (pp. 244-262) è il capitolo a cura
di Y. Tzvi LANGERMANN, un’interessante riflessione sulla ricezione del pensiero
galenico nell’opera di Maimonide, con particolare riferimento al Moreh Nevukhim,
opera da questi dedicata al pensiero ebraico. L’analisi di Langermann si
concentra su problemi non di poco conto, tra cui la concezione di tempo (e
quindi di eternità) e di creazione di parti del corpo (come ciglia e sopracciglia), e
di miracolo (e quindi di combinazione di elementi che, ex nihilo, danno corpo a
qualcosa che prima non esisteva, come accadde con la manna). È indubbio che
il confronto col pensiero galenico abbia indotto Maimonide a un supplemento
d’impegno e non si può non concordare con le conclusioni di Langermann,
secondo cui «in any event, Galen spurred Maimonides into giving as full an
explanation as he does anywhere as to what creation means for him, what a
miracle is, and why these two occurrences are so critical. Too bad that he did
not live long enough to put a final polish on his exposition» (p. 260). NAHYAN
FANCY dedica il suo contributo, Galen and Ibn al-Nafīs (pp. 263-278),
all’approccio critico e maturo di Ibn al-Nafīs, medico e giurista siro-egiziano
vissuto nel XIII secolo, tanto all’opera galenica quanto al magistero di Avicenna.
Ibn al-Nafīs, infatti, ha commentato le sezioni anatomiche del Canone
(utilizzando Galeno) e ha voluto sottoporre tutto a taḥqīq, ovvero a un processo
di verifica che lo ha portato a concordare con Galeno contro Avicenna (come
sul numero dei ventricoli, due e non tre, e sull’assenza di comunicazione tra
loro), a concordare con Avicenna contro Galeno (come sulle questioni relative
a seme maschile e seme femminile), oppure a confrontarsi quasi alla pari con i
due maestri quando entrambi si mostravano concordi su un fatto
(l’interpretazione del polso come risultato della simultanea espansione e
contrazione di cuore e arterie). In ogni caso, Ibn al-Nafīs basa le proprie
190RECENSIONI
considerazioni non sul principio di autorità, bensì su quello di verifica,
confermando o smentendo quanto sostenuto dai maestri del passato in virtù
della propria esperienza. Infine, i suoi commenti ad alcuni trattati ippocratici
sono indipendenti da Galeno e Ippocrate stesso è ‘riletto’ da Ibn al-Nafīs alla
luce delle nuove scoperte scientifiche. «What remains to be investigated is how
subsequent medical writers and commentators responded to Ibn al-Nafīs’
extensive critique of Galenic theory and his non-Galenic interpretations of
Hippocrates» (pp. 275-276). Segue il capitolo di Robert ALESSI, The Reception of
Galen in Ibn Abī Uṣaybiʿah (pp. 279-303), in cui si riflette sulla presenza di Galeno
nell’opera di Ibn Abī Uṣaybiʿah, a cui molto dobbiamo, dal momento che
testimonia «the reception of Greek medicine in the Arabic tradition at the
turning point between the Ayyūbid and Mamlūk eras» (p. 279). L’opera di Ibn
Abī Uṣaybiʿah risulta ancor più preziosa perché arricchita da liste di opere
galeniche consultabili in traduzione araba nel XIII secolo e tra quelle citate
trovano posto anche opere non giunte sino a noi. Chiude la sezione del volume
dedicata alla ricezione di Galeno nel mondo arabo il capitolo di Leigh CHIPMAN,
The Reception of Galenic Pharmacology in the Arabic Tradition (pp. 304-316), che offre
uno spaccato sul modo in cui la conoscenza galenica in materia di farmacologia
circolò nel mondo islamico in epoca medievale. Dopo aver fatto il punto sui
trattati farmacologici di Galeno (o a lui attribuiti) in traduzione araba, la studiosa
passa a indagare la ricezione sia teorica di tali conoscenze, che ha imposto
l’inquadramento nella teoria umorale galenica, sia pratica, prendendo in esame
tanto i testi galenici quanto le prescrizioni farmacologiche rinvenute nella
Genizah del Cairo, un insieme di testi spesso frammentari, «considerably short,
focused» e che «make use of known and common drugs» (p. 311).
La terza sezione del volume, «Galen in the Medieval West», si compone di
cinque capitoli, il primo dei quali è a firma di Monica H. GREEN, Gloriosissimus
Galienus: Galen and Galenic Writings in the Eleventh- and Twelfth-Century Latin West
(pp. 319-342). L’autrice offre al lettore un contributo magistrale, interrogandosi
sulle modalità che hanno accresciuto la fama di Galeno fino ad affiancarlo al
padre della medicina, Ippocrate, e rintracciando nel lavoro di traduzione di
Costantino l’Africano del corpus galenico la chiave della sua fortuna in Occidente:
infatti, proprio attorno al 1076, anno in cui Costantino approdò in Italia,
«Galen’s fortunes in the Latin West would begin to change» (p. 325). Tra Salerno
e Monte Cassino, Costantino tradusse numerose opere galeniche; una di queste
(la Tegni) è tràdita da un manoscritto composito (Paris, BNF, MS lat. 7029),
risalente in parte al secolo XI e testimone più antico dell’Articella. Il fatto che la
prima e l’ultima delle tre sezioni che lo compongono siano state vergate
sicuramente nel monastero di Monte Cassino «means that we can, at last, localise
the creation of the Articella – whose origins have hitherto baffled generations
of historians – right at Monte Cassino» (p. 327). Alla fortuna di Galeno e alla
creazione del «Nuovo Galeno» contribuirono certamente anche altri traduttori
del XIII secolo, come Gerardo da Cremona, Marco da Toledo e Burgundio da
Pisa, che si impegnarono a tradurre Galeno ora dall’arabo ora dal greco. Alle
traduzioni arabo-latine è dedicato il capitolo a cura di Brian LONG, Arabic-Latin
191RECENSIONI
Translations: Transmission and Transformation (pp. 343-358), che propone un quadro
puntuale ed efficace dei tre principali traduttori arabo-latini, Costantino
l’Africano, Gerardo da Cremona e Marco da Toledo, mettendo a confronto i
loro programmi di traduzioni. Alle versioni greco-latine è invece dedicato il
capitolo di Anna Maria URSO, Translating Galen in the Medieval West: the Greek-Latin
Translations (pp. 359-380), che pubblica uno studio destinato a restare a lungo di
riferimento. La riflessione della studiosa si articola in due ampie sezioni. Nella
prima (Medieval Translations of Galen: an Overview), dopo aver fatto il punto sulla
fortuna di Galeno tra Tarda Antichità e XII secolo, si sofferma sul metodo e
sugli stili di traduzione che hanno caratterizzato le traduzioni dei testi medici, in
epoca tardoantica tradotti sia ad sensum sia ad verbum, solo letteralmente durante
il Medioevo; l’autrice, tuttavia, avverte che «homogeneity of method does not
mean homogeneity of application» (p. 361), dal momento che a fronte di un rigido
letteralismo si registra uno sforzo linguistico considerevole, e aggiunge un
paragrafo sulla ricezione e l’impatto di queste versioni sul sistema di istruzione
medievale. Nella seconda (Translators and Translations from Greek) offre un quadro
sintetico ed esaustivo dei principali traduttori greco-latini di testi galenici:
Burgundio da Pisa, Stefano da Messina, Guglielmo di Moerbeke, Pietro
d’Abano, Niccolò da Reggio, fornendo per ciascuno di essi una panoramica
aggiornata dei testi tradotti e preziosi riferimenti ai tratti di stile. Il capitolo
seguente è a cura di Michael MCVAUGH, Galen in the Medieval Universities, 1200-
1400 (pp. 381-392) e ripercorre la fortuna di queste traduzioni nelle università
medievali, accompagnando il lettore a Parigi da Gilbertus Anglicus e a
Montpellier, ove incontriamo prima due autori di commenti a singole opere
dell’ars medicine, «Henry of Winchester, identified in the charter as chancellarius,
and Cardinalis» (p. 383), poi Arnau de Vilanova; a Bologna da Taddeo Alderotti.
Nella sezione conclusiva del suo studio, McVaugh prende in esame anche
l’impatto che su questo mondo ebbero le traduzioni di Niccolò da Reggio. Di
Iolanda VENTURA è il capitolo 21, Galenic Pharmacology in the Middle Ages: Galen’s
On the Capacities of Simple Drugs and its Reception between the Sixth and Fourteenth
Century (pp. 393-433), un vero e proprio viaggio «throughout the Latin tradition
of On the Capacities of Simple Drugs and Galenic pharmacology in Western Europe»
(p. 426). Ventura affronta con perizia la storia del testo e la ricezione delle sue
versioni latine: partendo dalle conoscenze farmacologiche che circolavano in
epoca medievale prima della diffusione delle traduzioni di questo testo, la
studiosa riflette sulla versione (incompleta) arabo-latina realizzata da Gerardo da
Cremona nel XIII secolo, soffermandosi anche sulla tradizione manoscritta e
sulla sua ricezione negli ambienti accademici medievali, per poi ragionare su
quella (completa) greco-latina esemplata da Niccolò da Reggio all’inizio del XIV
secolo, con opportuni riferimenti a peculiarità stilistiche, tradizione manoscritta
e ricezione (proponendo l’esempio del Liber pandectarum di Matthaeus Sylvaticus).
La quarta parte di quest’opera, «Galen in the Renaissance and Beyond», si
apre col prezioso contributo di Stefania FORTUNA, Editions and Translations of
Galen from 1490 to 1540 (pp. 437-452), capitolo in cui la studiosa, con la consueta
limpidezza, si muove tra le traduzioni e le edizioni di testi galenici realizzate tra
192RECENSIONI
la fine del XV e la metà del XVI secolo. Sono passate in rassegna tutte le edizioni
galeniche, dalla princeps del 1490, pubblicata da Diomede Bonardo a Venezia,
all’ultima edizione giuntina curata da Gadaldini nel 1565. Di tutte queste edizioni
è presentata la struttura e raccontata la storia; sono indicati i contenuti di maggior
rilievo e, all’occorrenza, la presenza delle traduzioni umanistiche che, per la loro
maggiore fruibilità, soppiantarono quelle medievali. L’affresco, vivido e
coinvolgente, offerto dalla studiosa fa emergere la vivacità dell’approccio
all’opera galenica sino alla metà del ‘500, quando ritornò sulla scena Ippocrate e
«Galen the interpreter of Hippocrates became more interesting than Galen the
physician» (p. 449). Segue il capitolo a cura di Christina SAVINO, ‘Galenic’ Forgeries
of the Renaissance: an Overview on Commentaries Falsely Attributed to Galen (p. 453-471),
nel quale l’autrice presenta alcuni testi per molto tempo considerati galenici e
che, in realtà, altro non sono se non il prodotto di una falsificazione riconducibile
sempre a Giovanni Battista Rasario, medico e traduttore di testi greci vissuto nel
XVI secolo. Le opere su cui si concentra l’attenzione della studiosa sono il
commento di Galeno al trattato sugli umori di Ippocrate, il Commento a Epidemie
VI (ll. VI-VIII), il Commento al Timeo di Platone, il Commento al De alimento di
Ippocrate e, infine, quello a Epidemie II. L’opera di falsificazione realizzata da
Rasario ha come presupposto una più che solida conoscenza linguistica e
contenutistica e, riprendendo un passaggio della riflessione di Savino, si può
asserire che Rasario «deserves acknowledgement for having contributed
significantly through his talent and his excellent language skills to updating and
expanding the corpus of the Latin Galen in the Renaissance, even if not always
in an exactly decent way» (p. 466). Vivian NUTTON firma il capitolo 24,
Renaissance Galenism, 1540-1640: Flexibility or an Increasing Irrelevance? (p. 472-486),
nel quale riflette sull’evoluzione della conoscenza anatomica e fisiologica
all’inizio dell’età moderna e – come suggerisce già il titolo – sul declino della
dottrina galenica in quest’ambito. Per farlo, Nutton prende in esame
primariamente tre profili che contribuirono al superamento dell’anatomia di
Galeno: quello di Andreas Vesalius, autore del De humani corporis fabrica (1543);
quello di William Harvey, impegnatosi sul fronte dell’anatomia cardiaca e sul
sistema cardiovascolare; quello, infine, di Paracelso, figura centrale nello
sviluppo della terapeutica. Che Galeno, quindi, sia stato da questi (e, in seguito,
anche da altri) superato è un dato fisiologico; che la sua figura, centrale nella
storia della medicina, e la sua scoperta/riscoperta abbiano stimolato la ricerca
scientifica è incontrovertibile. Per dirla con le parole dello stesso Nutton,
«flexibility may not be the precise word to describe the reason for its long
survival, and one can admit that much of what Galen had taught became
increasingly irrelevant over time. But, nonetheless, enough remained still
recognisable decades after Vesalius, Paracelsus, and Harvey» (p. 482). Sulla scia
delle considerazioni di Nutton si pone il capitolo seguente a cura di Maria Pia
DONATO, Galen in an Age of Change (1650-1820) (pp. 486-507), nel quale l’autrice
riflette su come Galeno e il Galenismo siano stati recepiti tra XVII e XVIII
secolo. Tornare a Galeno anche solo per contraddirlo e far progredire le
conoscenze scientifiche è sempre stata una dinamica feconda, come
193RECENSIONI
opportunamente nota la studiosa: «as Galen’s was an all-embracing system,
revision in one area elicited research in others» (p. 494), proponendo, tra le altre,
l’esperienza di Malpighi; oggetto di riflessione sono anche le ricadute di tali scatti
in avanti sulla pratica medica sensu lato. La quarta sezione del volume è, infine,
chiusa dal contributo di Piero TASSINARI, Galen into the Modern World: from Kühn
to the Corpus Medicorum Graecorum (pp. 508-534), che tenta di seguire «Galen’s
migration from the dominion of learned doctors to that of professional
philologists» (p. 509). La riflessione di Tassinari prende in esame primariamente
l’impresa editoriale di Karl Gottlob Kühn, pietra miliare nella storia del
Galenismo che, ancor oggi, rimane punto tradizionale di riferimento, e il lavoro
di Charles Daremberg, che ha avuto un ruolo cruciale nella ricezione di Galeno
[«if Kühn had conveyed the Renaissance Galen into the nineteenth century,
Daremberg brought it into modernity» (p. 516)], giungendo alla creazione del
Corpus Medicorum Graecorum.
La quinta e ultima sezione del volume, «Galen in Other Cultures», è aperta
dal contributo di Carmen CABALLERO-NAVAS, The Reception of Galen in Hebrew
Medieval Scientific Writings (pp. 537-558), in cui l’autrice ripercorre la presenza del
magistero galenico negli scritti ebraici di natura scientifica, tenendo presente che
«although the number of translations into Hebrew from the Galenic corpus was
small, Galen’s influence on Jewish medicine and thought was not» (p. 538).
L’indagine di Caballero-Navas prende in esame, in un primo momento, le
citazioni presenti in opere di autori ebrei che scrissero opere in arabo poi tradotte
in ebraico, come accadde per il celebre Maimonide, per passare poi all’esame
dell’opera di Shem Tov ibn Falaquera, che tradusse in ebraico excerpta galenici
letti in arabo per inserirli nelle proprie opere. L’autrice prende poi in
considerazione l’altro canale attraverso cui il magistero galenico raggiunse il
mondo ebraico, cioè quello delle traduzioni dei suoi testi, ragionando sull’attività
di diversi traduttori. La narrazione della presenza di Galeno in altre culture
rispetto a quelle sin qui indagate procede col capitolo di Alessandro ORENGO
(con contributi di Irene TINTI), The Reception of Galen in the Armenian Tradition
(Fifth-Seventeenth Centuries) (pp. 559-576), uno studio interessante e affascinante
per la sua ‘esoticità’ rispetto ai contorni che generalmente hanno gli studi su
Galeno e il Galenismo. L’autore tenta un’opera di sistemazione razionale di
quanto disponibile in lingua armena su Galeno, ricercando riferimenti al
Pergameno prima in testi armeni d’argomento non medico e poi in testi armeni
di medicina. L’attenzione si concentra, quindi, su tre illustri medici armeni vissuti
in epoca medievale, Abowsayid, Mxit‘ar Herac‘i e Amirdovlat‘ Amasiac‘i, e su
un’interessante opera, Baṙk‘ Gałianosi, un dizionario galenico. L’ultimo paragrafo
è, infine, dedicato a brevi opere in lingua armena ascritte proprio a Galeno. Il
capitolo 29 del volume è a cura di Matteo MARTELLI, Galen in the Late Antique,
Byzantine, and Syro-Arabic Alchemical Traditions (pp. 577-593). L’autore offre al
lettore un affresco della complessità della materia trattata, muovendosi con
agilità tra testi appartenenti a diverse epoche, tradizioni e culture, passando da
testi tardo-antichi e d’epoca bizantina ai testi della tradizione alchemica in siriaco
e in arabo, in cui si rintracciano citazioni più o meno esplicite di testi galenici.
194RECENSIONI
Ronit YOELI-TLALIM, col suo capitolo Galen in Asia? (pp. 594-608), amplia
ulteriormente il campo d’indagine della ricezione di Galeno, consentendo al
lettore di seguirla alla ricerca di tracce riconducibili al Pergameno tra testi di
medicina tibetana, in India, in Cina con la storia – tra gli altri – di Giuio Alieni,
gesuita italiano vissuto nel XVII secolo, che come alcuni suoi compagni scrisse
trattati in cinese basati sulle conoscenze scientifiche europee del tempo (una
delle sue opere, Xinxue cushu, «is considered to have been the main vehicle for
Western ideas about human physiological, anatomical, and psychological
notions», p. 603). Il volume si chiude col capitolo 31, Medieval Portraits of Galen
(pp. 609-638), di Stavros LAZARIS, un innovativo e coinvolgente studio sulle
raffigurazioni di Galeno in manoscritti d’ogni tradizione e in affreschi presenti
in chiese e monasteri (sono pubblicate delle tavole alle pp. 625-634), che
impreziosiscono ancor di più quest’opera.
Il volume, curato in ogni dettaglio (rarissimi i refusi) 1 e ricchissimo di
contenuti significativi, accoglie contributi preziosi per lo sviluppo delle linee di
ricerca già attive ed è fecondo per la nascita di nuove indagini. Si tratta, in
definitiva, di un’opera di cui si sentiva la mancanza e che, d’ora in avanti,
costituirà un indubbio punto di riferimento nella storia degli studi sul Galenismo.
DOMENICO PELLEGRINO
1 Ad esclusivo beneficio del lettore, segnalo soltanto: la mancanza di una stringa bibliografica
per la voce Wallis (2011) che si legge alla nota 36 di p. 332 (probabilmente, si tratta di F. WALLIS,
Why Was the Aphorisms of Hippocrates Retranslated in the Eleventh Century?, in R. WISNOVSKY, F.
WALLIS, J. C. FUMO and C. FRAENKEL (edd.), Vehicles of Transmission, Translation, and
Transformation in Medieval Textual Culture, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 173-193); i rimandi al
commento di Michele di Efeso ai Parva Naturalia aristotelici edito da Wendland, pubblicato nel
1903 (come correttamente segnalato in bibliografia, p. 157), e non nel 1913, come invece si legge
alle note 47 e 48 di p.148 e alle note 49 e 50 di p. 149.
195Puoi anche leggere