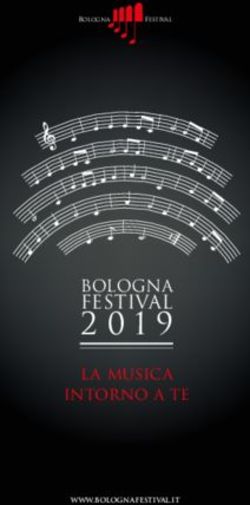Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Accademia Nazionale di Santa ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
14/15 Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Stagione Sinfonica
Auditorium
Parco della Musica
Orchestra dell’Accademia
Sala Santa Cecilia Nazionale di Santa Cecilia
Domenica 3 maggio 2015
ore 18
Manfred Honeck
Turno A-A2 direttore
Lunedì 4 maggio 2015
ore 20.30
Turno B
Martedì 5 maggio 2015
ore 19.30
Turno C
Il concerto è registrato da Rai Radio 3 per successive
trasmissioni e verrà trasmesso su Rai 5 il 21 maggio alle ore 21.15Gustav Mahler in una fotografia del 1907 al Teatro dell’Opera di Vienna
Programma
Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)
durata prima parte: Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 “Jupiter”
35’ circa
Allegro vivace
Andante cantabile
Minuetto: Allegretto
Molto allegro
Gustav Mahler
(Kalište, Boemia 1860 - Vienna 1911)
durata seconda parte: Sinfonia n. 1 in re maggiore “Il Titano”
53’ circa
Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut. Im Anfang
sehr gemächlich
(Lento. Trascinato. Come un suono della natura.
All’inizio molto tranquillo)
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell. Recht gemächlich
(Vigorosamente mosso, ma non troppo veloce.
Tranquillo)
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
(Solenne e misurato, senza trascinare)
Stürmisch bewegt
(Tempestosamente mosso)Da Mozart a Mahler:
sinfonie mitologiche
di Giovanni D’Alò
La Sinfonia “Jupiter” La Sinfonia Jupiter di Mozart
All’inizio del film Manhattan, nel suo personale elenco
Data di composizione di “cose per cui vale la pena vivere”, insieme a Groucho
1788
Marx, Cézanne, Marlon Brando, Frank Sinatra, Flau-
Organico bert, i film svedesi e altre icone della cultura intellettuale
Flauto, 2 Oboi, dell’Upper West Side newyorchese alla fine degli anni
2 Fagotti, 2 Corni, ’70, Woody Allen menziona anche il secondo movimento
2 Trombe, della Sinfonia “Jupiter”1.
Timpani, Archi Scelta raffinata, niente da dire. L’elenco serviva al per-
sonaggio per arrivare a rievocare il ricordo della giova-
nissima compagna da cui era stato appena lasciato, ma
è diventato col tempo anche un giochino intellettuale
buono per tutte le occasioni, in cui ciascuno può divertir-
si a riscrivere la lista dell’attore/regista americano in base
alle proprie preferenze.
Potremmo discutere su tutto e sostituire tutto, ma chi
avrebbe il coraggio di depennare il secondo movimento
della Sinfonia “Jupiter”? Per quanto ci riguarda, rincaria-
mo la dose: meno schizzinosi di Woody Allen, aggiun-
giamo anche gli altri tre movimenti (con una una lieve
preferenza per l’ultimo, se proprio messi alle strette) ed
eleggiamo senz’altro la “Jupiter”, per intero, tra le cose
per cui valga la pena vivere.
1
«Idea per un racconto sulla gente a Manhattan che si crea costantemente
dei problemi veramente inutili e nevrotici perché questo le impedisce di oc-
cuparsi dei più insolubili e terrificanti problemi universali. Beh, deve essere
ottimistico... Perché vale la pena di vivere? È un’ottima domanda. Ci sono
certe cose per cui vale la pena di vivere, ok? Per esempio... per me, io direi...
il vecchio Groucho Marx... Joe DiMaggio... il secondo movimento della Sin-
fonia “Jupiter”... Louis Armstrong (l’incisione di Potato Head Blues)... i film
svedesi, naturalmente... L’educazione sentimentale di Flaubert... Marlon
Brando, Frank Sinatra... quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne,
i granchi da Sam Wo... il viso di Tracy... ».
Manhattan, 1979, regia di Woody Allen [Sam Wo è uno storico ristorante
cinese di San Francisco; Tracy è la giovanissima fidanzata da cui è stato
lasciato il personaggio interpretato dallo stesso Allen].Nell’immagine, un fotogramma Del resto, l’ultima Sinfonia di Mozart, come tutte le
del film Manhattan (1979).
opere “estreme” dei grandi compositori, non è una par-
titura come le altre. Se ne accorse anche il pubblico
dell’epoca, quello inglese, meno provinciale rispetto a
quello viennese e salisburghese, che colse immedia-
tamente la dimensione “superiore” della Sinfonia in do
maggiore n. 41, cominciando ad identificarla come “Ju-
piter”. Giove, la divinità suprema della mitologia clas-
sica. Forse furono gli spettatori, forse i critici, o forse a
dare l’impulso fu una strategia di marketing di Johann
Peter Salomon, l’impresario che in quegli stessi anni
stava pianificando anche il successo di Haydn a Lon-
dra. In ogni modo, il titolo si diffuse indipendentemente
da Mozart, che terminò la sua opera a Vienna il 10 ago-
sto del 1788, subito dopo la Sinfonia in mi bemolle mag-
giore n. 39 K 543 e la Sinfonia in sol minore n. 40 K 550,
con le quali forma un trittico che, cronologicamente ed
esteticamente, si pone al vertice della sua produzione
sinfonica.
Non è ben chiara l’occasione per cui il trentaduenne
Mozart compose queste partiture, forse destinate a
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 7LIBRI una non identificata Accademia viennese, e a dire il vero
non si è certi nemmeno che siano state effettivamente
Massimo Mila eseguite, vivente l’autore.
Le Sinfonie di Mozart
A suggerire l’accostamento al padre degli dèi proba-
Milano, Einaudi 2012
bilmente non fu solo l’incipit trionfalistico e cadenzato di
Wolfgang Amadeus Mozart questa Sinfonia, che per dimensioni e architettura for-
Tutte le lettere di Mozart. male non ha precedenti in Mozart e neppure in Haydn.
L’epistolario completo della Anche a un primo ascolto si avverte il peso specifico di
famiglia Mozart 1755-1791 una scrittura che si fonda su un’abbondanza di mate-
Varese, Zecchini 2011 (3 voll.) riali tematici che andranno ad alimentare procedimenti
contrappunistici molto complessi (come il fugato del
Alberto Basso
movimento finale), su una tensione armonica ugual-
I Mozart in Italia. Cronistoria
dei viaggi, documenti, lettere, mente inconsueta, e in extremis su un impasto timbrico
dizionari dei luoghi e delle che, nonostante la luminosità “genetica” della tonalità
persone d’impianto, inclina istintivamente verso zone espressi-
Roma, Accademia di Santa ve attraversate da un inaspettato, intimo dolore.
Cecilia 2006 Non siamo in epoca romantica, per cui non sarebbe
giusto pretendere di ritrovare in questa musica tratti au-
tobiografici o elementi che rimandino direttamente alla
sfera emozionale dell’autore. Però è vero che in Mozart
l’elemento individuale, il “fattore umano”, preme costan-
temente ai margini dell’oggettività formale della tecnica
compositiva. E, se non proprio l’anello di congiunzione,
possiamo considerare la “Jupiter” il punto più prossimo
agli orizzonti sinfonici romantici che si apriranno di lì a
qualche anno già con il primo Beethoven.
Ad aggiungere ulteriore interesse alla Sinfonia, c’è poi
una subliminale compresenza di sacro e profano che
Mozart dispone come tessere di un mosaico segreto
all’interno della sua cattedrale sinfonica. Non si tratta di
un livello accessibile all’ascoltatore moderno, e per co-
glierlo sono necessarie alcune informazioni.
Per esempio, quella terza idea tematica che, nel primo
movimento, arriva alla fine dell’esposizione come un ef-
fetto rinfrancante dopo le tensioni esplose nei pieni or-
chestrali precedenti, è un calco dell’aria per basso “Un
bacio di mano” K 541 che Mozart scrisse per la ripresa
viennese dell’opera Le gelosie fortunate di Pasquale
Anfossi. Il testo, forse di Lorenzo Da Ponte, è un cliché
dell’opera buffa italiana e mette in guardia un ingenuo
spasimante dai rischi che comporta corteggiare una
8 HoneckCD donna molto più giovane2. Quale funzione abbia questa
citazione (molto più consona a certe trame di Woody
Mozart Allen) in una dimensione maestosamente drammatica
“Karajan.
come quella disegnata da questo movimento, è difficile
Haydn, Mozart, Schubert
Symphonies 1970-1981” da spiegare. Se non, forse, con la tendenza mozartiana,
Berliner Philhamoniker già riscontrata in età adolescenziale, di inglobare al mo-
Herbert von Karajan direttore mento della scrittura anche le imprevedibili suggestioni
Warner classics 2014 (8 cd) provenienti dal paesaggio sonoro circostante, come
pure probabilmente quelle reminiscenze musicali che
“Abbado Mozart” continuano a ripresentarsi come “tarli” dell’orecchio
Sinfonie nn. 29, 33, 35, (“earworms” li chiama il neurologo Oliver Sacks).
38, 39-41
Ha una funzione strutturale invece la citazione dell’in-
Orchestra Mozart
Claudio Abbado direttore no gregoriano Lucis creator corrispondente alle prime
DGG 2014 (8 cd) quattro note che ascoltiamo all’inizio dell’ultimo movi-
mento e che ritroviamo come soggetto del fugato fi-
Sinfonie nn. 35, 40, 41 nale. Un motto d’uso nelle scuole di contrappunto che
Wiener Philharmoniker Mozart ha fatto proprio innumerevoli altre volte e nelle
Karl Böhm direttore situazioni più varie (dalla primissima Sinfonia K 16 al
DGG 2004 “Credo” della Missa brevis K 192), trasformandolo in una
sorta di sigillo personale.
Privo di una sezione introduttiva, il percorso della
Sinfonia si apre con tre statici e burberi accordi dell’or-
chestra al completo, seguiti da una figurazione più deli-
cata tendente verso l’alto, affidata ai soli archi. In questo
contrasto c’è già, in nuce, la dialettica drammatica che
attraversa l’intero Allegro vivace, scandito in quest’avvio
da quei ritmi puntati così tipici del vocabolario mozartia-
no, che qui costituiscono l’impalcatura di una tensione
incipiente. La creazione della tensione è un principio
essenziale della drammaturgia di cui Mozart, come
sappiamo, è maestro, ed è anche la parola chiave di
questa partitura. L’elaborazione dei motivi iniziali sfocia
transitoriamente in una seconda zona tematica, appa-
rentemente tranquilla e galante, nella quale Mozart ino-
cula i germi di un cromatismo armonico che prolifererà
nel corso della scrittura, e che conquista gradualmente
il registro acuto su cui si spegne in deboli sospiri carichi
d’attesa. Attesa che, dopo un silenzio che immobilizza
2
Vi si legge, fra l’altro: “Voi siete un po’ tonto, mio caro Pompeo, le usanze
del mondo andate a studiar... Un uom che si sposa con giovin vezzosa...
dee libere voglie lasciare alla moglie... Se il re degli sciocchi non vuole
sembrar”.tutta l’orchestra, esplode nel pieno orchestrale più po-
tente del Mozart sinfonico, nervoso e tesissimo. È al
termine di questo passaggio che ascoltiamo, concilia-
toria, la citazione dell’aria buffa, terzo elemento temati-
co che esaurisce anche i doveri tonali dell’esposizione.
Relativamente breve lo sviluppo, in cui riemergono so-
prattutto gli elementi iniziali.
Il secondo movimento è un perfetto manuale di “stra-
tegia della tensione” mozartiana. È un Andante cantabi-
le, ma il tema d’apertura stenta a “cantare”, almeno nelle
prime battute, ammorbidito dalle sordine degli archi e
interrotto per due volte da secchi accordi dell’orchestra.
Il canto decolla soltanto quando ai violini si sovrappon-
gono i legni, poi lo si ascolta nel registro basso, mentre
i violini rispondono con miniature ornamentali di marca
haydniana, e con le sottolineature dei corni. È a questo
punto che il colore di fondo vira su toni più scuri. Entra
la tonalità di do minore e tutto è pronto per evocare “l’in-
verno dello scontento” mozartiano. Ai bassi, una statica
e funerea griglia ritmica. Ai violini e alle viole appare un
profilo melodico discendente in sincope, alternato con la
ripetizione meccanica di brevissimi frammenti, che han-
no non solo un effetto destabilizzante per la regolarità
ritmica, ma risultano carichi di urti dissonanti che Mozart
sfiora appena con l’arditezza infantile di chi sta giocando
col fuoco. Segue una progressione cromatica che innal-
za verso l’acuto il disegno sincopato già sentito, tesa sui
suoni tenuti dei fiati e innervata su una dinamica che on-
deggia instabilmente tra “forte” e“piano”. Il brano ha una
forma binaria, dunque ascolteremo lo stesso materiale
in ordine inverso e opportunamente variato, all’interno
del quale acquisteranno via via più importanza le fioriture
ornamentali e le sollecitazioni insistenti dei corni.
Il cromatismo melodico alla base del Minuetto, il cui pri-
mo tema deriva da un’idea del primo movimento, ci dice
che nonostante l’apparente recupero di un portamento
nobile, l’inquietudine non è del tutto domata. E infatti un’e-
co della cupezza dell’Andante cantabile affiora proprio
nel cuore del Trio, espressa da un martellante ostinato
ritmico, intrecciato da archi e corni, e dalla tensione ar-
monica creata dai legni.
10 HoneckLa Sinfonia “Jupiter”, e ribadiamo l’aura di superiorità divina che i primi ascoltatori le riconobbero all’istante, ha il suo degno finale nel quarto movimento, Molto al- legro. Una pagina che, benché in forma di sonata, ha la sua ragion d’essere nella scrittura contrappuntistica: dato tutt’altro che consueto in ambito classicista vien- nese, che travalica qualsiasi riferimento ai modelli del genere. Fatta eccezione per alcune Sinfonie composte pochi anni prima da Michael Haydn che effettivamente si concludono con dei finali fugati, ma di fattura piutto- sto convenzionale e neanche lontanamente paragona- bili alla monumentale architettura pianificata da Mozart. Cellula germinale del movimento, il motto mozartiano di quattro note si imprime subito, svettante e tagliente nel suo nitore (un soggetto di fuga esemplare), e funzio- na come un generatore di energia ininterrottamente ali- mentato dagli altri elementi del tessuto connettivo mu- sicale, sostentuto dalla presenza costante dei timpani. Un flash di quanto accadrà nella seconda parte lo ab- biamo già nel fraseggio a quattro voci degli archi, i cui sviluppi conducono al secondo tema. Che a sua volta è una variante permutativa in tre suoni del motto iniziale. Se normalmente lo sviluppo vero e proprio di una for- ma-sonata è la riserva entro cui i compositori classici destrutturano e ricompongono i materiali presentati in nuove combinazioni, qui gli incastri mozartiani sembra- no quasi un interludio d’alleggerimento rispetto alla so- lidità contrappuntistica ristabilita dalla ripresa. Spicca, in particolare, la progressione cromatica discendente a cui è sottoposto il motto ormai riconoscibilissimo. Il culmine lo si raggiunge però nella coda, un modello di ars combinatoria in cui Mozart arriva a sovrapporre cinque dei sei motivi ritmico-melodici ascoltati finora in un fugato a contrappunto invertibile a cinque parti. Passo conclusivo, come chiosa Giovanni Carli Ballola, «di un itinerario personale analogo a quello che aveva portato Bach all’Arte della Fuga, e che porterà Beetho- ven alla Sonata op. 106, alla Nona Sinfonia e alla Missa Solemnis». Accademia Nazionale di Santa Cecilia 11
Mahler direttore d’orchestra in una serie di silhouettes di Otto Böhler
La Prima Sinfonia “Il Titano” di Mahler.
ll velo squarciato
Quando diciamo che un suono è chiaro oppure scuro,
facciamo ricorso a un tipo di metafora che la retorica
classica chiama “sinestesia”. Stiamo, cioè, qualificando
qualcosa che percepiamo mediante un senso (l’orecchio,
in questo caso) con un concetto che appartiene a un al-
tro dominio sensoriale (la vista). La Sinfonia n. 1 di Mahler
comincia, appunto, con una sinestesia. Più che un suono,
quello che ascoltiamo all’inizio di questa partitura è un ef-
fetto di luce reso mediante una stupefacente invenzione
timbrica. Un fascio di luce tagliente, diafano, immobile e
allo stesso tempo “materico”, che riporta alla mente quel-
la teoria corpuscolare della luce che, prima di Newton,
fu intuita poeticamente da Lucrezio. Lo stesso Mahler,
secondo i ricordi dell’amica Natalie Bauer-Lechner, rivelò
che intendeva evocare lo «scintillio» e il «tremolio dell’aria»,
immagini luminescenti che fanno pensare a quell’effetto
di rifrazione della luce che con il calore rende traballante
una visione lontana, come un miraggio. Come all’alba di un
La Prima Sinfonia
nuovo giorno, o forse il primo giorno di un “nuovo mondo”:
non sarà un caso che negli stessi anni in cui Mahler lavo-
Data di composizione rava al suo primo cimento sinfonico (1884-88, senza con-
1884-1888 tare le revisioni successive) prendeva forma anche Così
parlò Zarathustra di Nietzsche (1883-85), che qualche
Prima esecuzione tempo dopo il compositore citerà esplicitamente nella
Budapest Sinfonia n. 3.
20 novembre 1889
Theodor W. Adorno preferisce un’altra metafora e
Direttore
parla di «un suono dal sibilo fastidioso, simile a quello
Gustav Mahler emesso da certe locomotive antiquate». Non è un giu-
dizio negativo, anzi, il filosofo è ben consapevole della
Organico portata innovativa e pionieristica di questo incipit, e ag-
4 Flauti (2 Ottavini), giunge: «Tutta la musica promette col suo primo suono
4 Oboi (Corno inglese), qualcosa di diverso, promette di fendere un velo».
4 Clarinetti Il velo squarciato (ci sovvengono le tele di Fontana)
(2 Clarinetti piccoli,
è quello dei limiti tracciati da una tradizione sinfonica
Clarinetto basso),
3 Fagotti (Controfagotto),
mitteleuropea che negli anni Ottanta, dopo le prospet-
7 Corni, 4 Trombe, tive aperte da Mendelssohn, Schumann e Brahms,
3 Tromboni, Basso Tuba, comincia a mostrare i segni dell’inattualità. «Al di là della
Timpani, Percussioni, sostanza crepuscolare, è sorprendente lo sconvolgi-
Arpa, Archi mento che Mahler porta nel mondo della Sinfonia» – ha
Accademia Nazionale di Santa Cecilia 13LIBRI scritto Pierre Boulez, che di modernità se ne intende –
«Mahler sconvolge la forma sinfonica, devasta questo
Henry-Louis De La Grange terreno troppo ordinato, investe dei suoi fantasmi il
Gustav Mahler.
sancta sanctorum della logica».
La vita, le opere
Torino, EDT 2012 In questi termini, non stupisce che tra i primi a capire
la portata del genio mahleriano (in anni in cui non tutti
Natalie Bauer-Lechner erano disposti a riconoscerlo, ricordiamolo) fu Arnold
Mahleriana. Diario Schönberg, che sotto la sua influenza scrisse i primi la-
di un’amicizia vori importanti e al quale nel 1912 dedicò una conferen-
Milano, Il Saggiatore, 2011 za che ancor oggi può considerarsi un’illuminante intro-
duzione alla sua opera. In fondo, in quell’idea di suono/
AA.VV.
timbro/luce/colore che apre la Prima Sinfonia di Mahler
Gustav Mahler.
Il mio tempo verrà c’è già lo Schönberg espressionista di Farben (“Colori”,
Milano, Il Saggiatore 2010 1909). E se guardiamo in prospettiva, vi troviamo in
nuce anche il concetto di “fascia sonora” sviluppato
nel secondo Novecento da compositori come Ligeti
e Penderecki, e dai più recenti Grisey e Murail, alfieri
di quella scuola “spettralista”, che trae origine proprio
dallo studio del suono come fenomeno fisico. Del resto,
cos’è un suono se non un fenomeno della natura?
Come un suono di natura
Ed eccoci tornati al punto di partenza, quel suono
che “promette di fendere un velo”, ma con una parola
chiave: “natura”. Eppure la parola era già lì, scritta a
chiare lettere da Mahler stesso in testa alla partitura, ad
accompagnare come un viatico la sua invenzione tim-
brica: Wie ein Naturlaut (“Come un suono di natura”). Il
pubblico, però, non è tenuto a saperlo. Non essendo un
titolo bensì un’indicazione in partitura, il “messaggio” in-
fatti non è rivolto al pubblico, ma al direttore d’orchestra,
al quale spetta il compito di comunicarlo all’ascoltatore
attraverso il suono che riuscirà ad ottenere dall’orche-
stra. Lungi dall’essere un fatto tecnico, il concetto di
Naturlaut è uno dei punti centrali della poetica mahleria-
na, e di un immaginario musicale in cui trovano posto ri-
chiami al canto degli uccelli o a versi di altri animali, l’uso
di campanacci da pascolo, corni da caccia, segnali mi-
litari, citazioni di marce, danze popolari e altra musica di
consumo, così ricorrenti nella sua produzione sinfonica.
Alcuni commentatori riferiscono l’espressione a una
14 Honecknatura “idealizzata”, altri a una natura “stilizzata”. Hans
Heinrich Eggebrecht, uno dei massimi esponenti della
musicologia tedesca, estende il Naturlaut mahleriano
all’insieme di tutti i suoni precompositivi presenti in na-
tura e conclude affermando che la musica stessa, per
Mahler, sarebbe una rappresentazione sonora della
totalità del mondo, «espressione, emanazione, rispec-
chiamento della totalità cosmica ed egli stesso è solo lo
strumento chiamato a crearla nell’opera musicale».
Molto probabilmente il concetto di Naturlaut, così
come lo troviamo in questa Prima Sinfonia, è qualcosa
che Mahler nel corso degli anni ha elaborato e gradual-
mente affinato, adattandolo e contestualizzandolo,
anche in base alla presenza o meno di testi poetici. Ci
sia permesso di osservare, però, che il termine Laut non
indica un suono necessariamente determinato, bensì
una sonorità percepita nella sua componente materi-
ca, “fonetica”, più vicina a un rumore che a una melodia
e tantomeno a un canto. In questo senso, il “suono di na-
tura” che Mahler invoca in apertura della sua Sinfonia in
re maggiore è da intendersi come la scintilla generatri-
Max Oppenheimer (1885-1954),
Gustav Mahler dirige i Wiener ce (non aveva parlato Mahler di “scintillio”?) dalla quale
Philharmoniker (1935) il suono “musicale”, e dunque “la musica”, ha origine.CD Dal punto di vista strumentale, il suono che apre
questa partitura è un amalgama timbrico basato sulla
Mahler sovrapposizione di una stessa nota (un “la”), ottenuto
“Leonard Bernstein.
però attraverso i “suoni armonici” degli archi, tutti im-
The Complete
Mahler Symphonies” mobilizzati nella regione sovracuta, ad eccezione del
New York Philharmonic terzo gruppo dei contrabbassi che controbilancia il
Leonard Bernstein direttore tutto tenendo il suono fondamentale nel registro basso.
Sony classical 2012 (11 cd) Questa fascia timbrica si espande in partitura per ben
46 battute, corrispondenti a una durata di circa due
Sinfonia n. 1, minuti e mezzo (almeno stando alle interpretazioni di un
Sinfonia n. 10: Adagio mahleriano della prima ora come Bruno Walter, ma con
Wiener Philharmoniker,
direttori come Abbado, Sinopoli e Boulez si va anche
Chicago Symphony
Orchestra oltre i tre minuti). Un’estensione d’ascolto lunghissima
Claudio Abbado direttore per un fondale sonoro sul quale si innestano gradual-
DGG 2012 mente i primi spunti melodici, originati da un semplice
intervallo di quarta discendente. Questo intervallo,
“Mahler Complete che l’ascoltatore potrà facilmente riconoscere perché
Symphonies” ricorda il caratteristico verso del cuculo, è la cellula ge-
London Symphony nerativa dei principali materiali tematici non solo dell’in-
Orchestra
Klaus Tennstedt direttore
troduzione ma dell’intero primo movimento e riaffiorerà
Warner classics 2011 (16 cd) a tratti anche in quelli successivi. Ed è anche l’inciso su
cui i clarinetti e i flauti intessono a più riprese un dialo-
go che rimanda a un immaginario bucolico popolato di
uccelli primaverili. Lo troviamo, inoltre, come impulso
iniziale del primo chiaro motivo della Sinfonia, esposto
dai violoncelli, che è poi una citazione del “Lied” Ging
heut’ morgen übers Feld, secondo dei quattro Lieder
eines fahrenden Gesellen.
Composto sul finire del 1884 ed orchestrato nei
mesi successivi, questo ciclo vocale si intreccia con gli
abbozzi della Prima Sinfonia e ne condivide alcune im-
magini. Autore anche dei testi poetici, Mahler tratteggia
una variante del “viandante” schubertiano (l’innamo-
rato deluso che fugge dai suoi luoghi per dimenticare
le sofferenze d’amore), e nel secondo Lied descrive in
prima persona il suo viaggio per i prati e la sensazione
di felicità che prova nell’immergersi nella dimensione
della natura, tra il canto degli uccelli, la delicatezza dei
fiori e la brillantezza della luce del sole.
Il primo movimento della Sinfonia segue la scansione
della forma-sonata (introduzione, esposizione ripetuta
16 Honecke sviluppo, con un Finale al posto della ripresa) ma tutto il fluire delle idee musicali si svolge in perfetta continui- tà, a delineare un percorso di “risveglio della natura” che aumenta gradualmente di tensione e di volume sonoro fino a raggiungere il suo climax (uno “scintillante” fortis- simo esaltato dalle percussioni e dalla brillantezza delle trombe e dei corni), dopo il quale Mahler cambia passo e imprime all’orchestra un’accelerazione di tempo con cui si dirigerà festosamente verso la conclusione. “Il Titano” Prima di introdurre all’ascolto degli altri movimenti, però, sarà bene fornire qualche informazione sulle varie stesure che precedettero la versione definitiva di questa Sinfonia, e che riguardano per l’appunto il suo assetto formale, nonché il titolo “Il Titano”, con cui è ancor oggi conosciuta. Alla sua prima esecuzione, av- venuta il 20 novembre 1889 a Budapest (dove Mahler era stato nominato direttore del Teatro dell’Opera Nazionale), infatti, la Sinfonia non fu presentata come tale, ma come “Poema sinfonico in due parti” articola- to in ben cinque movimenti, il secondo dei quali era un Andante. “Il Titano” deriva da un romanzo dello scrittore tedesco Jean Paul e comparve alla seconda esecuzio- ne (il 27 ottobre 1893 ad Amburgo) insieme a un lungo programma letterario, non vincolato, però, al romanzo di Jean Paul, ma che il compositore decise di redigere per facilitare il pubblico nell’ascolto di una Sinfonia così lunga e dispersiva. Un accorgimento dettato anche dal- la tiepida e persino ostile accoglienza che il pubblico e la stampa gli avevano riservato alla “prima” ungherese. In questa occasione l’Andante fu rinominato “Blumine” (probabile riferimento a un altro romanzo di Paul) e così fu anche per la terza esecuzione che ebbe luogo al Festival di Weimar nell’estate del 1894. Ma due anni dopo, in vista della quarta esecuzione (a Berlino) Mahler riprese la partitura per sottoporla a un profondo riassetto formale, che è poi sostanzial- mente quello in cui la ascoltiamo oggi: non più “poema sinfonico” ma “Sinfonia in re maggiore” e riduzione dei movimenti da cinque a quattro (con la soppressione di Accademia Nazionale di Santa Cecilia 17
“Blumine”). Nella medesima occasione Mahler si liberò
anche del “Titano” e del programma letterario.
Ecco perché è fuorviante, oggi, ascoltare questa
partitura facendo riferimento a contenuti narrativi o
visivi. «Musica “a programma”, cioè rappresentazione
musicale di un evento non musicale, Mahler non l’ha mai
scritta», asserisce Bruno Walter. E la conferma arriva
da Mahler stesso che, in una lettera all’amico Max Mar-
schalk il 26 marzo del 1896, motiva così la sua scelta:
«Mi sembra una insulsaggine inventare della musica a
partire da un programma dato. Analogamente, voler ac-
collare un programma a un pezzo di musica mi sembra
insoddisfacente e del tutto sterile».
Altri suoni
L’idea primigenia di questa Sinfonia si trova in alcuni
schizzi per pianoforte a quattro mani dell’attuale secon-
do movimento: uno Scherzo cadenzato secondo l’an-
damento di Ländler, tipica danza contadina austriaca,
da cui ebbe poi origine il valzer. Anche in questo caso,
per il tema iniziale Mahler cita un Lied giovanile, Hans
und Grete, con cui condivide il clima rustico, danzerec-
cio e persino infantile come la tipica filastrocca Ringel,
Ringel Reihe (“Giro, giro tondo”) che apriva il testo poe-
tico. Un mondo evocato anche attraverso il richiamo
allo jodler tirolese, con i suoi ampi salti melodici, presen-
ti sia nella prima parte che nelle tessiture più rilassate
del Trio. La dimensione popolare della musica, quella
più vicina allo spirito genuino e “naturale”, è un altro
aspetto del Naturlaut di cui abbiamo parlato: dopo aver
presentato la natura (e quindi la vita) attraverso l’origine
del suono, la gioiosa danza campestre introduce l’Uo-
mo nella sua dimensione più vicina alla terra.
L’immaginario infantile torna in maniera ancor più di-
retta nel terzo movimento, il più famoso della Sinfonia,
ma anche quello che suscitò maggiori perplessità nel
pubblico delle prime esecuzioni. Quello che Mahler ci
fa ascoltare, infatti, non è altro che il celebre canone
Bruder Martin, che da noi suona come “Fra Martino
campanaro”, trasposto però in modo minore. Un colpo
di genio (e anche di teatro) che trasfigura questo alle-
18 Honeckgro canto per bambini in una nenia grottesca. Nel suo
programma posticcio Mahler suggeriva di pensare al
corteo funebre di un cacciatore, accompagnato dai
vari animali del bosco, e li elencava tutti (lepri, gatti, ro-
spi, cornacchie, cervi, caprioli, volpi…). A più di un seco-
lo dalla sua composizione, possiamo tranquillamente
fare a meno di questo espediente così limitativo delle
possibilità espressive che Mahler realizza con questa
pagina sorprendente, e seguire liberamente il lento e
sommesso dipanarsi del canone (avviato dal contrab-
basso solo sull’ostinato dei timpani), i contrappunti
degli oboi, e le inaspettate virate in quella Trivialmusik
colorata dall’accompagnamento godereccio di piatti
Caricatura di Mahler che dirige e grancassa, dalle impennate in glissando dei violini e
la sua Prima Sinfonia a Vienna, dalle linee oscillanti delle trombe, che i contemporanei
pubblicata il 25 novembre del
1900 in “Illustriertes Wiener
mal tolleravano.
Extrablatt” Con l’eccezione della sezione centrale, in cui risuonaancora una citazione di un Lied giovanile, Die zwei
blauen Augen, nostalgico ricordo di un amore per sem-
pre lontano.
Un colpo di piatti fortissimo introduce il Finale
Stürmisch bewegt [Tempestosamente mosso], così
diretto nell’evocazione di una natura che si afferma
finalmente in tutta la sua potenza. Una pagina che è
anche una prova di virtuosismo strumentale da parte di
un compositore appena ventottenne e già pienamente
padrone dei suoi mezzi espressivi. Oltre alla compo-
nente puramente timbrica, Mahler fa qui sfoggio di una
scrittura contrappuntistica che evita gli accademismi e
si mette al servizio dei contrasti tematici e delle oppo-
sizioni strumentali. Ne è un esempio il tema dei corni
che si impone dopo la concitazione iniziale, contrap-
puntato da un moto perpetuo degli archi, e nuovamente
riaffermato dalla supremazia degli ottoni. Questa tes-
situra, che coinvolge l’orchestra al completo, si sfalda
e si frammenta per lasciare spazio a una regione lirica
e ariosa, appena un’anticipazione dei grandi Adagi e
Adagietti del Mahler maturo. La furia orchestrale ripren-
de quindi il suo percorso per incanalarsi in una regolari-
tà ritmica impostata dagli archi, che naufraga ancora su
una zona di quiete. Ricompaiono, a questo punto, i temi
che abbiamo ascoltato all’inizio della Sinfonia e su cui
ci siamo soffermati: il pedale degli archi, la successione
degli intervalli di quarta, le volatine dei fiati, il “mormorio
degli uccelli” nei flauti, il Gesellenlied, ammantanti di una
luce ovviamente diversa, e privi dell’originale coerenza,
come frammenti sparigliati di memoria.
È l’ultimo coup de théâtre prima di cedere il passo a
una Coda giubilante e trionfalistica, lontana anch’essa
da quel velo violato attraverso il quale Mahler aveva in-
travisto l’origine del suono. E della vita.
20 HoneckLa Prima Sinfonia di Mahler nei ricordi di Natalie Bauer-Lechner Originariamente, Mahler aveva intitolato la sua Prima Sin- fonia Titan, poi però molto tempo fa questo titolo, come tutte le didascalie delle sue opere, era stato eliminato, perché alcune persone lo fraintendevano pensando che alludesse a un programma. Per esempio, associavano il suo Titan a quello di Jean Paul, mentre lui aveva in mente soltanto un individuo forte ed eroico, la sua vita, le sue sof- ferenze, le lotte e le sconfitte contro il destino […]. Nel primo movimento siamo rapiti da un’atmosfera festo- sa, dionisiaca, non ancora interrotta o turbata da alcunché. Con la prima nota, un la trattenuto con gli armonici, siamo trasportati in mezzo alla natura: nel bosco, in cui la luce della giornata estiva tremola e scintilla attraverso i rami. “La conclusione di questo movimento” disse Mahler “non verrà certamente compresa dal pubblico; sarà una delusione, mentre avrei potuto facilmente renderla più efficace. Il mio eroe scoppia a ridere e se ne va. Nessuno, di sicuro, individuerà il tema, che alla fine è andato al timpa- no! Nel secondo movimento il giovane se ne va in giro per il mondo con l’aria più forte, vigorosa e disinvolta”. […] Il terzo movimento è quello di Bruder Martin, il più frain- teso e criticato. Mahler ne ha parlato di recente: “A questo punto il mio eroe ha già trovato un capello nella minestra e il suo pasto è rovinato”. Disse inoltre che fin da bambino Bruder Martin non gli era mai sembrato allegro come lo si canta di solito, bensì profondamente tragico: già allora riu- sciva a scorgervi ciò che poi sarebbe diventato. […] L’ultimo movimento comincia con un urlo inquietante: il nostro eroe è in balia degli eventi e lotta fino all’ultimo san- gue con tutto il dolore del mondo. “Se prova a ribellarsi e ad assumere il controllo, riceve ripetute batoste dal destino”, e la stessa sorte tocca al motivo vittorioso. Solo con la mor- te […] conquista la vittoria (sublime corale vittorioso!). […] Natalie Bauer-Lechner. Mahleriana. Diario di un’amicizia. Milano, il Saggiatore 2011
Le esecuzioni
a Santa Cecilia
La Sinfonia n. 41 “Jupiter”
1908 Richard Strauss, Karl Panzner; 1922 Bruno Walter; 1928
Erich Kleiber; 1936 Pietro Mascagni, Gino Marinuzzi Sr.; 1939
Sergio Failoni; 1942 Leo Borchard; 1945 Carlo Zecchi; 1947 Car-
lo Zecchi, Clemens Krauss, Fernando Previtali; 1949 Joseph
Krips; 1950 Carlo Zecchi; 1951 Ermanno Wolf-Ferrari; 1953 Jo-
seph Krips; 1954 Eugen Jochum; 1955 Fernando Previtali; 1958
Igor Gjadrov, John Pritchard; 1959 Carlo Zecchi; 1960 Jascha
Horenstein; 1961 Claudio Abbado, Enrique Jorda; 1965, 1975
Carlo Zecchi; 1977 Carl Melles; 1979 Peter Maag; 1980 Carlo Ma-
ria Giulini; 1987 Yehudi Menuhin (Sinfonia Varsovia), Wolfgang
Sawallisch; 1991 Carlo Maria Giulini; 1994 Iona Brown (Academy
of St. Martin in the Fields); 1996 Shlomo Mintz; 1998 Gianluigi
Gelmetti, Myung-Whun Chung; 2003 Zubin Mehta (Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino); 2004 Ivor Bolton; 2005 Myung-
Whun Chung; 2006 Antonio Pappano; 2008 Louis Langrée, An-
tonio Pappano 2010 Claudio Abbado, Diego Matheuz (Orche-
stra Mozart), Christian Arming.
La Prima Sinfonia “Il Titano”
1912 Bruno Walter; 1921 Willem Mengelberg; 1937 Bruno Walter;
1961 Willem van Otterloo; 1964 William Steinberg; 1967 Georges
Prêtre; 1968 Pierluigi Urbini; 1970 Pawel Klecki; 1972 Igor
Markevitch; 1976 Igor Markevitch, Zubin Mehta (Los Angeles
Philharmonic Orchestra); 1977 Nicholas Harsanyi (North Carolina
School of Arts Orchestra); 1978 Daniel Oren; 1979 Piero Bellugi;
1981 Claudio Abbado (European Community Youth Orchestra);
1982 Zdenek Macal; 1985 Bruno Aprea; 1986 Lorin Maazel
(Orchestra del Norddeutscher Rundfunk di Amburgo); 1987, 1988
Giuseppe Sinopoli (anche in tournée in Australia); 1989 Zubin
Mehta (European Community Youth Orchestra); 1990 Georges
Prêtre; 1992 Zoltán Peskó; 1993 Daniele Gatti; 1996 Myung-
Whun Chung (anche in tournée in Spagna e Portogallo); 1998 Yuri
Temirkanov; 2000 Roberto Abbado; 2001 Myung-Whun Chung;
2003 Zubin Mehta (Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino);
2007 Antonio Pappano (anche in tournée in Germania, Austria,
Svizzera e Giappone); 2010 Jonathan Webb (Orchestra
Giovanile Italiana); 2011 Antonio Pappano (anche in tournée in
Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Belgio e Germania); 2013
Semyon Bychkov.
22 HoneckManfred Honeck
direttore
Dalla stagione 2008-2009, e fino al 2020, Manfred
Honeck è Direttore musicale della Pittsburgh
Symphony Orchestra. Con l’orchestra statunitense
si è esibito nelle più grandi città europee e festival
quali Rheingau Musikfestival, Schleswig-Holstein
Musik Festival, Beethovenfest Bonn, Musikfest Berlin,
Grafenegg Festival, Festival di Lucerna, BBC Proms,
Musikverein di Vienna. Nell’estate del 2013 hanno suo-
nato, tra l’altro, a Berlino, Bucarest, Parigi, Francoforte e
Lucerna.
L’attività discografica con l’orchestra negli ultimi
anni è stata molto intensa: nel 2012 la Quarta Sinfonia
di Mahler (Exton Label) è stata premiata con l’Interna-
tional Classical Music Award. Il cd dedicato ai Poemi
sinfonici di Strauss ha ottenuto ottime recensioni così
come la Quarta Sinfonia di Bruckner appena pubblica-
ta. L’Ottava Sinfonia di Dvořák e la suite tratta da Jenufa
approntata dallo stesso Honeck ha ottenuto una nomi-
nation ai Grammy.
© Jason CohnDal 2007 al 2011 è stato Generalmusikdirektor della
Staatsoper di Stoccarda dove ha diretto, tra l’altro, Les
Troyens, Idomeneo, Aida, Dialogues des carmélites, Il
cavaliere della rosa, Il pipistrello, Lohengrin, Parsifal e
concerti sinfonici con la Staatsorchester Stuttgart.
Inoltre è stato ospite della Semperoper di Dresda,
Komische Oper di Berlino, Théâtre de la Monnaie di
Bruxelles, Royal Opera of Copenhagen, Festival delle
notti bianche di San Pietroburgo, Festival di Salisburgo.
Nato in Austria, Manfred Honeck ha fatto parte per
molti anni dei Wiener Philharmoniker e ha iniziato la sua
carriera direttoriale a Vienna come assistente di Clau-
dio Abbado; successivamente è stato Primo Kapell-
meister dell’Opernhaus di Zurigo, uno dei Direttori prin-
cipali della MDR Sinfonieorchester di Lipsia, Direttore
musicale della National Opera di Oslo e Primo direttore
ospite della Oslo Philharmonic Orchestra. Dal 2000 al
2006 è stato Direttore principale della Swedish Radio
Symphony Orchestra di Stoccolma, e fino al 2016 rico-
prirà il ruolo di Primo direttore ospite della Filarmonica
Ceca di Praga. Inoltre è salito sul podio del Deutsches
Symphonie-Orchester di Berlino, Gewandhausor-
chester di Lipsia, Staatskapelle di Dresda, Royal
Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, London
Symphony, Orchestre de Paris, Wiener Philharmoniker,
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Negli Stati Uniti ha diretto la New York Philharmonic,
The Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orche-
stra, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra
e Boston Symphony Orchestra. Nel 2013 ha debuttato
con i Berliner Philharmoniker con i quali ha inciso per la
Dgg il Concerto per violino di Dvořák eseguito da Anne-
Sophie Mutter.
Tra gli appuntamenti recenti e futuri segnaliamo le sue
collaborazioni con i Bamberger Symphoniker, New York
Philharmonic, Wiener Symphoniker, Tonhalleorchester
di Zurigo e Rotterdam Philharmonic Orchestra.
Manfred Honeck sarà di nuovo a Santa Cecilia dal
7 al 10 novembre per dirigere la Messa da Requiem di
Giuseppe Verdi.
24
HoneckHoneck Proust si era divertito a elaborare un
questionario che sottoponeva agli amici
e il questionario con domande sulle loro preferenze.
Nel 1889 fu compilato anche dal celebre
di Proust compositore Claude Debussy.
La virtù preferita? Il personaggio preferito nella letteratura?
Umiltà Gabriel Bagradian del romanzo I quaranta
giorni del Mussa Dagh di Franz Werfel, in
La qualità che preferisce nell’uomo? ricordo del 100° anniversario del genocidio
La verità e la natura pacifica degli Armeni
La qualità che preferisce nella donna? I nomi che preferisce?
La riservatezza e la purezza di cuore Maria e i nomi di tutti i miei figli
L’occupazione preferita? Il suo vizio più grande?
Leggere, riposare Troppo appetito
La sua idea della felicità terrena? Qual è il personaggio più odioso nella storia?
La prospettiva del cielo Coloro che feriscono la dignità umana
Cosa detesta maggiormente? Per quale errore ha maggiore indulgenza?
La disonestà e la superbia Per quelli commessi per ignoranza
Il fiore e il colore preferiti? Cosa apprezza particolarmente nei suoi
Giglio, bianco, blu, oro amici?
La loro benevolenza e le loro critiche
Se non fosse chi è, chi vorrebbe essere?
Sono contento di essere ciò che sono Il suo motto preferito?
Vivi come se fosse l’ultimo giorno della tua vita
Dove vorrebbe vivere?
Con la mia famiglia
Lo scrittore che preferisce?
L’Evangelista Giovanni, Dostojevskij,
Scott Hahn
I pittori e i musicisti preferiti?
Mozart, Caravaggio, mia figlia Anna Maria
Gli eroi preferiti nella vita?
Madre Teresa di Calcutta, Santa Gianna
Beretta Molla e tutti i cristiani che in questo
momento vengono perseguitati a causa della
loro fedeOrchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Carlo Rizzari direttore assistente
Violini primi Carlo Maria Parazzoli*, Roberto González-Monjas*,
Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La Montagna,
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi,
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Kaoru Kanda,
Jalle Feest, Nicola Lolli, Daria Leuzinger, William E. Chiquito
Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Roberta Cannas
Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli,
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari,
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani,
Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori,
Alice Costamagna, Cristiano Giuseppetti, Olesya Emelianenko
Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger,
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea
Alpestre, Lorenzo Falconi, Stefano Trevisan, David Bursack, Luca
Manfredi, Federico Marchetti, Elena Favilla, Stefania Pisanu
Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori,
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi,
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile,
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto,
Giuseppe Scaglione
Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Anita
Mazzantini*, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Piero Franco Cardarelli,
Enrico Rosini, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Simona Iemmolo,
Margherita Naldini
26 HoneckFlauti Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani Ottavini Davide Ferrario, Giovanni Gandolfo Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri, Stefania Mercuri Corni inglesi Maria Irsara, Gabriele Cutrona Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, Simone Sirugo Clarinetto piccolo Marco Torsani Clarinetto basso Dario Goracci (anche clarinetto piccolo) Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti Controfagotto Alessandro Ghibaudo Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli, Marco Bellucci, Arcangelo Losavio, Luca Agus, Giuseppe Accardi, Gabriele Falcioni, Sabino Allegrini Trombe Andrea Lucchi*, Ermanno Ottaviani, Antonio Ruggeri, Michele Lotito, Roberta Fustaino Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Agostino Spera, Stefano Centini Trombone basso Maurizio Persia Tuba Gianluca Grosso Timpani Enrico Calini*, Antonio Catone*, Marco Bugarini Percussioni Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere, Michele Camilloni Arpa Cinzia Maurizio* * Prime parti soliste. NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto Accademia Nazionale di Santa Cecilia 27
Puoi anche leggere