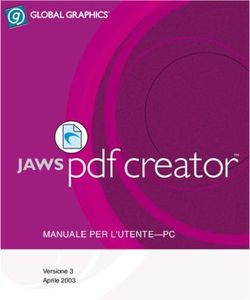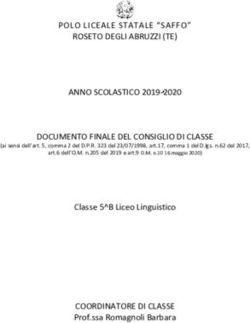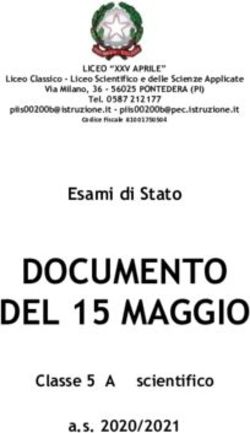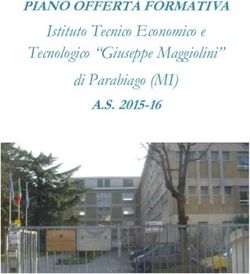UN VIAGGIO NELLA LETTERATURA ITALIANA DEL NOVECENTO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
TESI MASTER DI
ILARIA D’ALESSANDRO
MASTER OF ARTS SUPSI IN INSEGNAMENTO PER IL LIVELLO
SECONDARIO I
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
UN VIAGGIO NELLA LETTERATURA ITALIANA
DEL NOVECENTO
AFFRONTARE IL TESTO LETTERARIO NEL SECONDO BIENNIO DI
SCUOLA MEDIA
RELATORE
LIVIA RADICI TAVERNESEDal profondo del cuore, il mio ringraziamento più grande va a mamma e papà, che mi hanno insegnato i valori fondamentali della vita, che hanno sempre creduto in me supportandomi anche in questo percorso formativo e che mi hanno trasmesso in ogni momento il loro amore incondizionato. Spero un giorno di diventare un genitore come voi. A mio fratello Paolo e al mio fratellino Carmelo esprimo un’immensa gratitudine per essere stati sempre presenti e pronti a strapparmi un sorriso nei momenti di sconforto. A nonna Elodia e a zia Franca che mi hanno sostenuta ogni giorno dimostrandomi tutto il loro affetto: grazie! Grazie a Tiago, Sarah, Davide e Soraya, diventanti ormai parte integrante della nostra famiglia. Ringrazio tutto il resto dei miei familiari, le mie docenti di pratica professionale Gisella e Claudia, i miei amici di sempre e i compagni conosciuti in questi due anni di formazione, per aver condiviso con me momenti più e meno felici. Un grazie speciale a Livia, mia relatrice nonché formatrice, per la quale provo una profonda stima sia sul piano professionale sia su quello umano. Da ultimo, ma non per questo meno importante, desidero ringraziare per la pazienza, l’aiuto e il suo affetto il mio compagno Nicola senza il quale avrei faticato molto a superare quest’ultimo periodo di formazione con la serenità dovuta. Dedico questo lavoro di diploma a zio Franco, che ha costantemente avuto fiducia in me e mi ha incoraggiata a credere nei sogni ogniqualvolta ho pensato di non riuscire a realizzarli. Vorrei tanto poterti abbracciare e mostrarti che ce l’ho fatta. Sono sicura che, anche se da lassù, sei stato tu a trasmettermi la forza necessaria per affrontare questi mesi. Mi manchi Zio, ti voglio tanto bene!
Ilaria D’Alessandro
Abstract
Ilaria D’Alessandro
Master of arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I
Un viaggio nella letteratura italiana del Novecento
Professoressa Livia Radici Tavernese
Con il presente lavoro si indaga sulla possibilità di rendere interessante lo studio del testo letterario
per i discenti e si tenta di dimostrare in che modo sia possibile sviluppare le competenze della scrittura
e dell’oralità tramite la letteratura.
Grazie all’applicazione di un metodo sia qualitativo sia quantitativo è stato possibile rilevare dati
precisi. Difatti, prima di iniziare l’itinerario didattico gli allievi hanno compilato un questionario
relativo all’apprezzamento della letteratura; il medesimo esercizio è stato svolto con un questionario
consegnato al termine del percorso. Oltre a ciò, sono state previste due prove scritte (con
l’assegnazione di una valutazione sommativa), una in entrata e una in uscita, e tre verifiche formative
alla fine di ogni unità didattica.
I risultati ottenuti dalla raccolta dei dati hanno mostrato un generale miglioramento delle competenze
dell’intero gruppo e un diffuso senso di soddisfazione.
A conclusione del percorso, quindi, è stato possibile confermare quanto sperato: l’insegnamento della
letteratura nella scuola media non è inutile.
Parole-chiave: educazione letteraria, didattica per competenze, figure retoriche, registri linguistici,
testo letterario.
iiINDICE
1. Introduzione ......................................................................................................................................... 1
2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca ................................................................................... 5
L’educazione letteraria e il ruolo del docente ............................................................................................. 5
L’interpretazione del testo letterario e la didattica per competenze ................................................................................. 9
La scelta degli stimoli ......................................................................................................................................... 11
Le città invisibili, Italo Calvino ...........................................................................................................................................................13
La Storia, Elsa Morante ..........................................................................................................................................................................14
Il mare color del vino, Leonardo Sciascia ......................................................................................................................................15
Analisi del compito e programmazione didattica .................................................................................... 15
Le domande di ricerca ........................................................................................................................................ 18
3. Quadro metodologico ..................................................................................................................... 21
La metodologia di ricerca ................................................................................................................................. 21
Gli strumenti e le tecniche utilizzate per l’analisi degli elaborati ..................................................... 21
Il campione di riferimento ............................................................................................................................... 23
Fasi del percorso didattico ............................................................................................................................... 23
Prima unità didattica ..............................................................................................................................................................................24
Seconda unità didattica .........................................................................................................................................................................25
Terza unità didattica ...............................................................................................................................................................................26
4. Raccolta, analisi dei dati e risultati ........................................................................................... 29
Raccolta e analisi dei dati quantitativi: le prove scritte ........................................................................ 29
Prova in entrata ........................................................................................................................................................................................29
Prova in uscita ...........................................................................................................................................................................................29
Risultati ................................................................................................................................................................... 29Ilaria D’Alessandro
Questionari di apprezzamento iniziale e finale ..........................................................................................................................30
Verifiche formative..................................................................................................................................................................................32
Il percorso di tre allievi .........................................................................................................................................................................32
5. Discussione e bilancio finale ........................................................................................................ 37
Risposte alle domande di ricerca ................................................................................................................... 37
Potenzialità e limiti del percorso didattico ................................................................................................ 37
Possibili sviluppi ......................................................................................................................................................................................38
6. Conclusioni ......................................................................................................................................... 41
Bibliografia ................................................................................................................................................ 43
Allegati ......................................................................................................................................................... 47Ilaria D’Alessandro
1. Introduzione
Il presente lavoro di diploma si prefigge di esaminare la possibilità di insegnare la letteratura italiana
nelle scuole medie inferiori, in particolar modo nel secondo biennio.
La scelta di proporre agli allievi un’educazione letteraria nasce dal desiderio di offrir loro sia la
possibilità di accrescere il proprio patrimonio culturale sia di sviluppare la competenza linguistica:
“[...] la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della tradizione, oltre a offrire
delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano e del mondo” (Divisione
della scuola, 2015, p. 95).
Come scrive Guido Armellini, riprendendo Ernst Gombrich, è sbagliato pensare che non serva
studiare i testi letterari durante la scuola dell’obbligo solo perché si ha l’impossibilità di
approfondirne tutti gli aspetti.
Chi è padrone di una “cultura generale” condivisa da una certa comunità dispone di un
repertorio di «metafore privilegiate» che lo aiutano a dare nome a valori, emozioni,
esperienze ed a comunicarle ad altri; [...]. E infine la cultura generale è uno strumento per
orientarci nella storia, una raccolta di segnavia e punti di riferimento che ci aiutano a
collocare le cose e noi stessi nel tempo e nello spazio. (Armellini, 2008, p. 29)
Il testo letterario permette di affrontare tematiche molto importanti e di trasmettere valori
fondamentali ed edificanti per la formazione dei cittadini del futuro: “a scuola le pagine degli autori
vengono interrogate su un piano umano, che coinvolge i ragazzi, portandoli, a partire dall’ascolto di
altre voci, a indagare su se stessi” (Carnero, 2020, p. 7).
Il giovane studente di oggi è un lettore abituato a ricevere molte informazioni rapidamente, in poco
tempo, facendosi “incantare” dai numerosi stimoli audiovisivi dei social media. Marianne Wolf
(2018) sostiene che oggigiorno noi tutti siamo esposti ad una consistente presenza di stimoli possibili
di lettura, dei quali tuttavia ci appropriamo solo in parte, rimanendo a quella che la scrittrice definisce
la “prima vita” del lettore: ci limitiamo cioè a raccogliere informazioni e ad acquisire alcune
conoscenze senza affrontare le letture in modo profondo. Ciò implica una capacità minore di
sviluppare il pensiero critico; pertanto, il ruolo dell’educazione alla lettura e alla letteratura deve
aiutare ad invertire questa tendenza.
1Ilaria D’Alessandro
In Zanchini leggiamo:
[...] Si va chiudendo una storia intellettuale cominciata sotto i Lumi e protrattasi sino agli
anni settanta e ottanta del secolo scorso. La civiltà massmediatica, non più fondata sulla
preminenza del testo scritto, rappresenta un passaggio persino più radicale della
rivoluzione di Gutenberg. Nella sua analisi Asor Rosa sembra in realtà attribuire alla
cultura di massa, all’industria culturale e al suo strumento più pervasivo, la televisione, il
ruolo di grande intellettuale collettivo e persuasore di massa, l’arma che marginalizza la
parola scritta e il ruolo del pensiero critico e degli intellettuali [...]. (2016, pp. 65-66)
È dunque questa la sfida che si tenta di affrontare nel presente lavoro di ricerca: dimostrare che lo
studio del testo letterario alle scuole medie sia uno strumento efficacissimo per la crescita degli
allievi. Nel percorso didattico proposto verranno attivate ed esercitate principalmente le competenze
della scrittura e dell’oralità, sviluppando al contempo il pensiero riflessivo e critico, nonché quello
creativo. Oltre a ciò, un’attenzione particolare verrà rivolta anche alla riflessione sulla lingua. La
letteratura, scrive Ezio Raimondi (2007), è diventata marginale nella nostra epoca dominata dai
linguaggi mediatici digitali; eppure, riveste ancora un importantissimo ruolo conoscitivo: ci permette
di raggiungere una nuova capacità di comprensione del reale.
Il campo di ricerca si circoscrive principalmente allo studio di tre autori italiani del Novecento: Italo
Calvino, Elsa Morante e Leonardo Sciascia. Sarà da privilegiare dunque un approccio induttivo nel
quale “il confronto tra diversi testi [...] consente agli studenti di individuare le costanti e le variabili
su cui sviluppare un progressivo lavoro di riflessione, analisi e sintesi” (Armellini, 1987, p. 100).
Il primo capitolo, di taglio teorico, presenta un breve excursus dedicato all’educazione letteraria e
alla didattica della letteratura. Vengono inoltre spiegate le ragioni che hanno portato a scegliere gli
autori e i brani da trattare. Dopo un’analisi del compito, il capitolo si conclude con l’esposizione degli
interrogativi di ricerca.
Il capitolo successivo è dedicato al quadro metodologico nel quale si spiegano anche gli strumenti
utilizzati per gli interventi didattico-disciplinari e per l’analisi degli elaborati. Oltre a ciò, viene
descritta brevemente la classe scelta per lo svolgimento di questo percorso e si illustrano tutte le fasi
dell’itinerario didattico.
Nel terzo capitolo si mostrano i dati raccolti e la loro successiva interpretazione, che permette di
rispondere alle domande di ricerca.
In seguito, vengono presentate le risposte ai quesiti che muovono questa ricerca e si sviluppano alcune
riflessioni rispetto ai limiti e ai possibili sviluppi dell’itinerario didattico.
2Ilaria D’Alessandro
Infine, a conclusione dell’intero lavoro di ricerca, si traccerà un bilancio generale.
3Ilaria D’Alessandro
2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca
L’educazione letteraria e il ruolo del docente
Questa ricerca si muove all'interno di un quadro teorico e storico molto ampio: se parliamo di
educazione letteraria in Italia intesa come “iniziazione alla letteratura” (Balboni, 2004, p. 6), sono in
effetti svariate le voci autorevoli da citare. Pertanto, i contributi segnalati di seguito non hanno la
pretesa di esaurire completamente l’argomento trattato, bensì di offrirne un resoconto generale allo
scopo di rispondere ai quesiti di ricerca.
Un'influenza indubbiamente forte l’ha avuta a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento Francesco
De Sanctis e la sua Storia della letteratura italiana, che si è imposta nella Penisola e ha dominato a
lungo anche la didattica scolastica. Alla base di questa tradizione sta la volontà di utilizzare la
letteratura come strumento di formazione culturale e come mezzo per creare una coscienza nazionale
della classe dirigente del futuro, ragion per cui l’opera desanctisiana presenta cronologicamente le
biografie e i testi letterari dei più illustri autori italiani. In questa fase dell’educazione letteraria si
introduce il concetto di forma “intesa come unità inscindibile di ideologia e di espressione” (Tellini,
2010, p. 2) e tramite la letteratura si studiano le personalità degli autori: “la nozione di «forma» è la
chiave per l’intelligenza critica dell’opera, in stretta connessione con il momento storico che l’ha
vista nascere” (ivi, p. 4). Se pur in modo differente, anche i metodi della Scuola storica e
dell’idealismo di Benedetto Croce si muovono nella stessa direzione (centralità dell’autore).
La Scuola storica, che si afferma poco dopo l’Unità d’Italia fin circa ai primi vent’anni del Novecento,
prende le distanze dall’approccio desanctisiano in quanto prova ad indagare la letteratura con l’ausilio
di strumenti sicuri come la filologia, l’erudizione o la documentazione storica. Giosuè Carducci è tra
gli esponenti di questo metodo, che tenta di sottoporre la letteratura a un’interpretazione di tipo
meccanicistico e deterministico, considerando cioè l'opera come conseguenza necessaria, determinata
in maniera meccanica, dalle circostanze storico-geografiche e socio-ambientali (ivi, pp. 15-20).
Al positivismo della Scuola storica si oppone alla fine dell’Ottocento l’idealismo di Benedetto Croce:
egli pone l’attenzione sulla soggettività dell’artista, ciò che importa è “soprattutto l’autonomia
dell’arte, il suo non risolversi in valori intellettuali, economici, edonistici, morali. Perciò difende il
carattere essenzialmente lirico e metastorico dell’arte, al di là dell’orizzonte ideologico che l’ha
prodotta” (ivi, p. 36).
Mentre si sviluppano i metodi dell’educazione letteraria sopracitati, per la didattica della letteratura
si utilizza tendenzialmente l’approccio storicistico fin circa agli anni Settanta del Novecento: lo studio
5Ilaria D’Alessandro
dei testi letterari si focalizza sull’analisi dell’autore, visto come trasmettitore di grandi ideali politici,
in relazione al contesto storico (Spaliviero, 2020, pp. 41-44). Le lezioni sono perlopiù frontali, si
fondano su un modello trasmissivo, monodirezionale e i discenti hanno generalmente un ruolo
passivo all’interno della situazione didattica: la richiesta che si fa loro è quella di memorizzare e
ripetere i contenuti.
Negli anni Settanta del Novecento, con l’affermazione della società e della scuola di massa, i modelli
sopra descritti (focalizzati sugli autori e sul contesto storico) vengono messi sempre più in discussione
e inizia invece a prendere piede l’approccio strutturalistico-semiotico. L’attenzione si sposta
dall’autore al testo stesso, sulla scorta del formalismo russo: il testo letterario si considera come
un'entità autonoma di cui si studiano tutte le componenti e in particolare la lingua. Il circolo
linguistico di Mosca, fondato da Roman Jakobson tra il 1914-1915, e la Società per lo Studio del
Linguaggio Poetico, che annovera tra i principali esponenti Boris Ejchenbaum, Viktor Sklovskij, Jurij
Tynjanov e Osip Brik, sono i due gruppi che sviluppano il metodo formalista.
Gino Tellini a riguardo scrive:
I punti fondamentali d’orientamento riguardano lo studio analitico del linguaggio
letterario, in diretto rapporto con la linguistica, mentre non importa il giudizio di valore
in base a valutazioni estetiche, né importano i nessi tra esperienza artistica e realtà sociale,
né le relazioni tra scrittura e vicenda biografica dell’autore. (2010, pp. 93-94)
Nel 1929 nasce lo strutturalismo con la pubblicazione delle Tesi del Circolo linguistico di Praga, nelle
quali si esplicita la volontà di analizzare un testo “non per spiegarne il significato artistico, storico,
psicologico, esistenziale, ma per descriverne il meccanismo di funzionamento, la tipologia, le
funzioni dei vari elementi espressivi, la coerenza strutturale dell’insieme” (ivi, p. 168). Tale approccio
si diffonde in Italia tra il 1960 e il 1975 grazie agli studi di Cesare Segre, che, insieme ad altri colleghi,
come Dante Isella e Maria Corti, assume la direzione della rivista Strumenti critici a partire dal 1966
(Spaliviero, 2020, pp. 48-53).
Si diffuse così la tendenza a credere possibile una “scienza della letteratura”, capace di spiegare i
fenomeni letterari con oggettività e verificabilità. È a questo punto che prende piede lo studio del
testo da un punto di vista perlopiù linguistico, lasciando ancora una volta da parte l’interpretazione
soggettiva del lettore: si suggerisce lo studio del testo come sistema di relazioni, offrendo agli studenti
metodi di analisi che permettano loro di individuarne le caratteristiche strutturali.
Infine, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, si diffonde in Italia l’approccio ermeneutico,
focalizzato sull'interpretazione dei lettori riguardo ai messaggi contenuti nei testi. Hans Georg
6Ilaria D’Alessandro
Gadamer, uno dei principali teorici moderni dell’ermeneutica letteraria, critica lo scientismo
strutturalistico affermando che le procedure della scienza non possono essere applicate in campo
umanistico, dove invece “la verità sta dalla parte dell’interprete” (Tellini, 2010, p. 198). Secondo il
modello ermeneutico, difatti, per dare senso al contenuto di un’opera il lettore gioca un ruolo di
fondamentale importanza: la sua interpretazione (del testo) permette di sviluppare un dialogo tra
presente e passato.
Conseguente a questo cambiamento di idee è una nuova linea di tendenza relativa alla didattica della
letteratura: l’attenzione si focalizza principalmente sull’allievo, il quale diventa così attore attivo
dell’unità didattica (Chiosso, 2018, p. 30). L’insegnante, che accoglie positivamente questi nuovi
approcci didattici, inizia a proporsi come mediatore, come facilitatore nei confronti degli alunni,
stimolando la loro curiosità, sollecitandoli a fare delle inferenze e a ipotizzare delle soluzioni. Camilla
Spaliviero scrive:
Nell’approccio ermeneutico, oltre alla relazione più egualitaria tra il testo e il singolo
lettore sulla scia della semiotica interpretativa, il confronto sui possibili significati che
l’opera può rivestire al giorno d’oggi determina lo sviluppo di una relazione dialogica tra
tutti i suoi fruitori. Questi ultimi costituiscono, così, una «comunità ermeneutica» [...].
(2020, p. 63)
In sintesi, è possibile distinguere tre grandi fasi dell’educazione letteraria (Tellini, 2010, p. 196):
1. Intentio auctoris: il significato del testo si determina sulla base delle intenzioni dell’autore;
2. Intentio operis: il significato dell’opera si scopre tramite l’analisi delle strutture semantiche e
stilistiche dell’opera;
3. Intentio lectoris: l’attenzione si focalizza sull’interpretazione del lettore.
Anche Antoine Compagnon (2000, pp. 46-50) parla della “morte dell’autore”, alla quale segue la
valorizzazione del lettore, ritenuto “il luogo in cui si produce l’unità del testo, nella sua destinazione
invece che nella sua origine [...]” (ivi, p. 48).
A partire dagli anni Duemila, i metodi dell’educazione letteraria si basano tendenzialmente sulla
centralità del lettore, anche se ciò non comporta la totale rimozione degli approcci anteriori; difatti se
ne conservano alcuni aspetti, quali lo studio del contesto storico-culturale, l’attenzione alla biografia
dell’autore e l’analisi degli elementi stilistici dell’opera, ritenuti fondamentali per la comprensione.
7Ilaria D’Alessandro
“Il risultato è l’impiego simultaneo dei metodi dello storicismo, dello strutturalismo e
dell’ermeneutica, combinati insieme in una forma ibrida” (Spaliviero, 2020, p. 41).
L’educazione letteraria è stata poi influenzata anche dalle teorie glottodidattiche che spiegano in
maniera più approfondita quali strategie un insegnante può attuare per sviluppare un buon
apprendimento da parte degli studenti, sia sul fronte linguistico sia su quello neurologico. Gli studi
neurolinguistici svolti da Norman Geschwind e Albert Galaburda mostrano che l’attività cerebrale si
suddivide in parte tra l’emisfero destro e quello sinistro, ognuno dei quali svolge una funzione
differente. La prima area è quella stimolata di fronte a compiti analogici, mentre la seconda è
predisposta a compiti analitici (Danesi, 2015, p. 50; Wolf, 2018, pp. 38). A tal proposito, nel 1986
Marcel Danesi (2015, pp. 35-36) propone il modello didattico della bimodalità, sostenendo che i
compiti “misti” vanno a sollecitare entrambi gli emisferi, che agiscono in modo correlato: “[...] si
tratta di una prospettiva interdisciplinare dell’educazione [...] in quanto considera l’apprendimento
umano come un processo pluridimensionale che esige una risposta educativa ugualmente articolata
che cerci di integrare varie possibilità operative” (ivi, p. 36). Ne consegue dunque che, se l’insegnante
desidera coinvolgere la mente dell’allievo nell’apprendimento, sia l’emisfero destro sia quello sinistro
devono essere stimolati contemporaneamente attraverso input differenti: verbali, visivi, audiovisivi e
scritti, che al giorno d’oggi possono essere potenziati anche grazie all’ausilio di strumenti digitali. Le
nuove tecnologie, tuttavia, devono essere utilizzate con cautela: il passaggio dalla lettura cartacea a
quella online non ha portato esclusivamente dei vantaggi per il lettore. In particolare, se osserviamo
quanto avviene nella lettura attraverso uno schermo, vediamo che spesso essa è caratterizzata dalla
frammentarietà: sono letture brevi, d’impatto che fanno leva sulla percezione emotiva e sulla
molteplicità di rinvii che offrono. Si tratta quindi di un processo mentale che poggia sull’associazione
di idee, ma non ancora sulla costruzione di un pensiero lineare, logico, deduttivo, che è ciò che
presiede la formazione di un pensiero vero e proprio. Questo porta alla necessità di insegnare ed
educare a stare sui testi, per l’evoluzione di un pensiero logico-deduttivo. Il compito dell’insegnante,
difatti, non è esclusivamente quello di creare dei “chirurghi della letteratura”, ma anche quello di
diventare uno stimolatore della coscienza, un attivatore della meraviglia. Questa è l’idea della lettura
contemplativa, flessibile: ritorna sulle parole per comprenderle; incentiva le inferenze; promuove
analogie; favorisce riflessioni oltre il testo dato.
8Ilaria D’Alessandro
L’interpretazione del testo letterario e la didattica per competenze
L’impostazione dell’educazione letteraria proposta oggigiorno nelle scuole è chiaramente influenzata
dalle tradizioni passate: non solo vengono esaltati contenuti e forme del testo, ma si avvalorano anche
le abilità degli allievi di usare gli strumenti di analisi letteraria. La nostra è una scuola che parla
principalmente di competenze piuttosto che di conoscenze: gli insegnanti sono chiamati a sviluppare,
in unità di apprendimento, percorsi didattici che concorrono ad attivare negli alunni competenze
spendibili anche in altri contesti.
Inoltre, il docente ha il compito di offrire all’apprendente le migliori condizioni per potere apprendere
anche tramite percorsi differenziati. Il suo ruolo non è più, com’è capitato in passato, quello di
trasmettere i propri saperi attraverso lezioni frontali; l’allievo d’altro canto non deve limitarsi ad
apprendere passivamente i contenuti per poi memorizzarli e ripeterli, ma egli sta proprio al centro
dell’apprendimento: a partire dai suoi bisogni, il docente deve quindi organizzare delle unità
didattiche (suddivise al loro interno in unità d’acquisizione) che permettano agli alunni di sviluppare
delle competenze attraverso la scoperta, in modo induttivo, in accordo con il Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese in cui si esplicita che “(...) per competenze si intendono le capacità di un
allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi
e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente.” (2015, p.
7)
E ancora:
Le Discipline di insegnamento si pongono come snodo chiave dell’incontro tra
Competenze trasversali e contesti di esercizio, qualificandosi in chiave epistemologica
come strumenti di lettura del reale utili a promuovere lo sviluppo della persona la cui
progressiva padronanza caratterizza il compito dell’educazione scolastica. (ivi, p. 20)
Il concetto di unità didattica, che va a scardinare l’idea di lezione, venne ripreso da Giovanni Freddi
(1994, p. 112): egli non parlava più di un modello didattico monodirezionale, ma ne proponeva uno
in cui l’attenzione si spostava verso l’apprendente. Al discente veniva sottoposto un input, cioè il
testo da cui partiva l’unità d’acquisizione, e riceveva dall’insegnante anche un aiuto a capire cosa
fare con il testo (riflessione e analisi), fino ad arrivare all’utilizzo effettivo della lingua.
Prima Freddi e poi Balboni (2014, pp. 159-162), infatti, ci hanno proposto un’unità d’acquisizione
articolata in questi momenti:
9Ilaria D’Alessandro
Motivazione: si tratta della fase iniziale della lezione in cui si verifica il momento del contatto
con il testo. Si va a sollecitare la motivazione dell’apprendente, il suo interesse: si potrebbe
mostrare soltanto il titolo di un’opera e poi chiedere agli allievi di ipotizzarne il contenuto, ad
esempio (attività di brain storming); per farlo bisogna per forza entrare in una fase di
globalità;
Globalità: l’approccio globale al testo significa guidare alla comprensione, esplorare parole
chiave, ecc. Dalla globalità si passa poi all’analisi;
Analisi; sintesi; riflessione: in questa fase si va effettivamente ad attivare l’attenzione
dell’alunno sugli aspetti che rappresentano gli obiettivi d’apprendimento che si vogliono
raggiungere. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un lavoro sul lessico: si osservano nel testo
quali sono gli elementi che permettono di definire il registro stilistico dello scritto. Dopo aver
sistematizzato si sviluppa un’attività a coppie nella quale gli studenti devono creare un dialogo
in cui viene messo in atto quanto appreso;
Verifica o controllo: l’ultima fase è costituita dalla verifica e dalla valutazione al fine di
osservare se il traguardo di competenza è stato raggiunto (è anche possibile prevedere delle
attività di glottomatetica, cioè di autovalutazione).
Figura 1 - L’unità d’acquisizione (Balboni, 2014, p. 160)
Come dice Roberto Carnero (2020, pp. 12-16), la letteratura è un’immensa e magnifica risorsa che i
docenti di italiano hanno a disposizione per offrire ai ragazzi un’altra chiave di lettura della realtà e
catturare, quindi, la loro attenzione. Raffaele La Capria pure scrive che “per sapere chi siamo è
10Ilaria D’Alessandro
necessario sapere chi siamo stati, e questa memoria ci serve per mantenere la nostra identità” (2002,
p. 103).
Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese parla di ambiti di competenza delle varie
discipline che per l’italiano lingua scolastica riguardano la scrittura, l’oralità, l’ascolto e la riflessione
sulla lingua (2015, pp. 96-98). Che cosa si impara dunque dalla letteratura? La risposta è duplice: se
da un lato il testo letterario permette di trasmettere dei contenuti, dei valori culturali di generazione
in generazione, dall’altro il suo studio offre la possibilità di implementare le proprie conoscenze
linguistiche e di saperle sfruttare a seconda delle necessità e dei contesti d’uso.
La competenza testuale, perciò, si sviluppa sia in direzione ricettiva sia in quella produttiva.
Attraverso gli esercizi di analisi si attiva la riflessione sulla lingua e si scoprono elementi riguardanti
la struttura e la forma del testo; tuttavia, è attraverso l’interpretazione che si riesce ad attribuirgli un
significato.
Infatti, Armellini scrive:
Se la comprensione si riferisce sostanzialmente a che cosa un testo dice, l’analisi
concentra l’attenzione su come il testo lo dice. Naturalmente tra i due momenti non si può
tracciare un confine netto, perché in un testo letterario le scelte di linguaggio e di stile
non sono separabili dai contenuti: in linea generale si può dire che una corretta analisi del
testo presuppone la sua comprensione. [...] Da questo punto di vista l’analisi si pone come
un fondamentale momento di supporto all’interpretazione. (2008, p. 134)
Lo scopo ultimo è, pertanto, quello di essere in grado di attribuire un significato profondo al testo
studiato e di esprimere un proprio pensiero in merito.
La scelta degli stimoli
Innanzitutto, è opportuno esplicitare che prima di cominciare questo itinerario didattico era già stata
costruita insieme agli studenti una definizione di letteratura intesa come “corpus omogeneo di opere,
che hanno tutte caratteristiche simili”.
L’intento di questo lavoro è stato quello di incuriosire gli studenti verso un argomento che solitamente
è ritenuto noioso, attraverso attività di diverso genere e con la scelta di testi che potessero avvicinarsi
il più possibile alle loro esperienze personali di vita reale.
In una società che punta sempre di più verso l’individualismo, verso relazioni mediate dai social
network, trovo sia indispensabile far riflettere i più giovani anche attraverso la letteratura.
11Ilaria D’Alessandro
Riguardo all’argomento, Roberto Carnero scrive:
Nella desertificazione dei valori e nell’appiattimento commerciale della società odierna,
la letteratura può servire a recuperare una dimensione altra. [...] Tra le altre cose,
insegnare letteratura significa, perciò, educare l’immaginario dei ragazzi e aiutarli a
sollevarsi dall’appiattimento conformistico di pensieri, concetti, modelli e slogan
veicolati dalla comunicazione mediatica e social. (2020, p. 12)
Se pure brevi, le esperienze di insegnamento che ho avuto la fortuna di fare negli anni precedenti alla
formazione presso il DFA mi hanno lasciato spesso l’amaro in bocca. Più di una volta mi è infatti
capitato di voler proporre dei testi letterari in classe, sia in prosa sia in poesia, e di ricevere una
risposta negativa dall’insegnante che stavo supplendo: “Lascia perdere, non vale la pena”, “È come
dare perle ai porci”, “È troppo difficile per loro”, mi sono spesso sentita dire. Il mio totale disaccordo
rispetto a questa visione dell’educazione letteraria alle scuole medie mi ha portato a riflettere molto
e quando lo scorso anno mi è stato assegnato un incarico limitato, mi son ripromessa di dover fare
almeno un tentativo. Imparare ad interpretare un testo letterario, decodificarlo, decriptarlo, significa
dare a coloro che saranno i cittadini del futuro l’opportunità di conoscere il passato, di arricchirsi, di
ampliare i propri orizzonti e di leggere meglio la realtà riuscendo ad esprimere con consapevolezza i
propri pensieri.
Convinta del fatto che, giunti ormai alla fine di un percorso formativo, gli alunni di IV possiedano
tutte le competenze di base per approfondire lo studio del testo letterario, ho voluto proporre opere
un po’ più complesse rispetto a quelle trattate nei precedenti anni.
La didattica per competenze prevede che l’insegnante scelga dei traguardi di apprendimento ben
definiti e che programmi, a partire da questi, un percorso didattico suddiviso in tappe per le quali
vengono scelti degli stimoli da proporre agli studenti che si paragonano poi alle produzioni per
assegnare una valutazione.
La scelta degli autori e dei testi da utilizzare per l’ideazione di questo percorso didattico è stata molto
ardua, dato che il patrimonio culturale italiano offre un’immensità di proposte.
Innanzitutto, mi sono chiesta se fosse più opportuno proporre dei testi letterari in prosa o in poesia e
ho preferito i primi, in parte perché la classe l’anno scorso si era già avvicinata ad una prosa calviniana
e in parte poiché credo sia più semplice iniziare un’educazione letteraria attraverso testi narrativi,
romanzi o racconti.
12Ilaria D’Alessandro
In seguito, ho individuato il periodo storico da trattare: ho prediletto il panorama novecentesco sia
per tentare di esaminare tematiche più vicine alla realtà degli studenti sia per una maggiore
comprensione a livello linguistico.
Infine, ho optato per lo studio di tre autori, piuttosto che di uno solo, e, dopo essermi concentrata sui
traguardi di apprendimento che intendevo raggiungere, ho selezionato alcuni testi di Italo Calvino,
Elsa Morante e Leonardo Sciascia. Per la selezione dei testi ho prediletto il criterio della brevità (in
alcuni casi sono stati operati anche dei tagli) unito all’attenzione per la trattazione di tematiche
interessanti per i discenti in quanto riconducibili alla loro realtà.
Ciò che mi auguravo prima di iniziare l’itinerario didattico era di riuscire a mettere gli studenti in
condizione di apprezzare il testo letterario, partendo da una riflessione sulla lingua focalizzata
perlopiù sulle scelte sociolinguistiche compiute dagli autori: caratteristiche lessicali, registri stilistici
e figure retoriche.
Le città invisibili, Italo Calvino
L’idea di iniziare il percorso didattico da Italo Calvino è stata dettata dal fatto che l’anno precedente
avevo già trattato con gli stessi allievi un’unità didattica sul Castello dei destini incrociati,
raggiungendo buoni risultati (si vedano gli allegati 1a, 1b, 2a e 2b). Pertanto, ho approfittato
dell’interesse dei ragazzi proponendo loro un altro affascinante testo, esempio, seppure con
un'architettura diversa, di letteratura combinatoria, dell’autore: Le città invisibili.
Questa è stata per me la sfida più grande da affrontare: riuscire a coinvolgere gli alunni offrendo loro
un’opera di una certa difficoltà che avrebbe permesso anche di sviluppare varie competenze. Vista la
complessità dell’opera calviniana, ho proposto delle analisi molto strutturate definendo con
precisione domande e obiettivi di apprendimento. L’analisi è ricaduta su tre capitoli: Ottavia, Marozia
e Leonia, tre testi scelti affinché potessero evidenziare caratteristiche simili e permettessero di far
riflettere gli allievi sulla narrazione utilizzata dall’autore. Si è proceduto seguendo sempre gli stessi
passaggi: prestare attenzione alla focalizzazione del narratore; individuare le caratteristiche spaziali
e temporali (luoghi e momenti delle azioni); soffermarsi sui problemi di stile ragionando sulle figure
retoriche; scoprire le tematiche dei testi per capire quale messaggio avesse intenzione di comunicare
l’autore.
Gli allievi si sono cimentati con lo studio di Ottavia, poiché tra le tre mi pareva la città di più
“semplice” intendimento: testo breve e figure retoriche come la metafora e l’accumulazione che in
parte erano già conosciute e quindi più semplici da individuare e comprendere.
13Ilaria D’Alessandro
In seguito, è stata introdotta Marozia siccome da un lato era un testo che conteneva alcune figure
retoriche già affrontate in Ottavia e dall’altro offriva la possibilità di introdurne due “nuove”: la
similitudine e la personificazione.
Da ultimo è stato proposto il racconto di Leonia, che presenta un testo più lungo degli altri, ma che
può rivelarsi di più facile comprensione in quanto espone una tematica attuale con la quale gli alunni
possono confrontarsi: il consumismo e l’inquinamento globale. Ciò mi ha permesso di affiancare alla
parte di analisi testuale, in cui è stata scoperta un’altra figura retorica (l’allegoria), un momento di
riflessione in plenaria per ascoltare il pensiero degli allievi.
Al termine di questa unità didattica, ho consegnato agli studenti una tabella relativa alle caratteristiche
narrative dell’opera da compilare con l’aiuto dei tre testi analizzati. In questo modo sono stati
individuati gli elementi principali della narrazione, che i ragazzi hanno poi dovuto seguire quando è
stato chiesto loro di inventare, sulla base del modello calviniano, un nuovo capitolo dell’opera
creando la propria città invisibile.
La Storia, Elsa Morante
Dopo aver proposto un’opera in cui la dimensione astratta prevaleva su quella reale, ho scelto di
trattare il romanzo storico-sociale La Storia, di Elsa Morante, per poterlo affrontare in concomitanza
al programma di storia: infatti, in accordo con il docente di storia, abbiamo scelto lo stesso momento
del semestre per proporre lo studio di un periodo storico (gli anni Quaranta del Novecento) che fosse
il medesimo di cui si parlava nel romanzo studiato durante le lezioni di italiano.
Vista l’impossibilità di affrontare l'intera opera per evidenti esigenze di programmazione didattica,
sono stati selezionati quattro estratti del testo che potessero comunque offrirne una panoramica
generale e, soprattutto, che evidenziassero le caratteristiche della narrazione della Morante sulle quali
volevo far riflettere gli alunni: oltre a ritrovare anche nel testo di questa scrittrice figure retoriche
scoperte nelle Città invisibili di Calvino, ho voluto far emergere dagli estratti del romanzo le peculiari
scelte lessicali operate dall’autrice. Per una comprensione ottimale della Storia, ho proposto quattro
brani in ordine cronologico: l’introduzione, la descrizione della prima uscita nel mondo di Useppe, il
bombardamento su Roma del 1943 e il finale di tutta la vicenda.
L’introduzione del romanzo ha permesso di puntualizzare il periodo storico nel quale le vicende erano
narrate e di iniziare ad analizzare alcuni aspetti lessicali: si è chiesto agli allievi di individuare nel
testo tutti i sostantivi alterati e di dividerli in vezzeggiativi, diminutivi e dispregiativi, usati perlopiù
nella descrizione di Ida Ramundo. Oltre a ciò, sono stati selezionati dei termini per i quali è stato
14Ilaria D’Alessandro
chiesto di trovare un sinonimo. Sulla base di questi due esercizi si è sviluppata la prima riflessione in
plenaria inerente al registro linguistico del testo.
Nel secondo brano l’attenzione è stata posta sul linguaggio di un personaggio, Nino, il quale
comunica interamente utilizzando il dialetto romano e su quello del piccolo Useppe, che ha da poco
iniziato a pronunciare le sue prime parole.
Nel terzo estratto, gli studenti si sono concentrati sui nomi e gli aggettivi alterati che l’autrice ha
scelto di usare per descrivere Useppe. Questo, paragonato agli esercizi dei primi due testi proposti,
ha permesso agli alunni di riflettere sul registro linguistico adottato dalla Morante.
Anche per questa unità d’acquisizione, le schede didattiche sono state articolate sempre nella
medesima maniera: una prima parte di comprensione del testo, finalizzata a riassumere poi oralmente
le vicende narrate, ed una seconda di analisi.
Il mare color del vino, Leonardo Sciascia
Da ultima, un’unità didattica relativa a Leonardo Sciascia e a due testi appartenenti alla raccolta di
racconti Il mare color del vino: Il lungo viaggio e L’esame. La scelta dei due racconti non è stata
casuale, bensì ha risposto all'esigenza di seguire una continuità tematica. Nel primo semestre, difatti,
era stata affrontata la lettura del libro Nel mare ci sono i coccodrilli, grazie al quale avevamo riflettuto
molto sul viaggio di Enaiatollah e quindi su tematiche attuali: l’accoglienza e l’accettazione di
qualcuno che è diverso da noi per cultura, lingua o religione, in un gruppo classe in cui sono molti i
casi di migranti. Per questa ragione, al fine di poter ampliare l’argomento dell’emigrazione, sono stati
scelti due testi di Sciascia che permettessero di paragonare alcuni aspetti della tematica. Anche questa
volta i testi si sono rivelati ottimi per l’osservazione sia delle figure retoriche che delle scelte lessicali
compiute dallo scrittore.
Analisi del compito e programmazione didattica
I materiali creati per affrontare le diverse unità d’apprendimento sono stati costruiti in maniera tale
da sviluppare attività didattiche variate e interattive, così da tentare di coinvolgere il più possibile gli
studenti a partire da un approccio induttivo.
In primo luogo, è stato necessario circoscrivere con rigore gli elementi dei testi che desideravo far
scoprire ai ragazzi: la scelta è ricaduta su aspetti generici della narratologia (tipologia dei nomi che
davano i titoli ai capitoli; narratore interno/esterno; tempo verbale prevalente; luogo e tempo della
narrazione), sullo studio di alcune figure retoriche che si potevano ritrovare più volte nei testi dei vari
15Ilaria D’Alessandro
autori (sia quelle già affrontate negli anni scolastici precedenti sia quelle ancora sconosciute) e su
interessanti scelte lessicali.
Una prima difficoltà con la quale gli studenti avrebbero potuto scontrarsi poteva essere data proprio
dalla comprensione di testi di un certo spessore letterario. In questo senso è stato fondamentale l’uso
di strumenti ausiliari come i dizionari, ma anche un lavoro di comprensione minuziosa svolto prima
di giungere all’analisi testuale.
Inoltre, per facilitare il lavoro degli studenti, le schede sono state strutturate principalmente in due
parti: la prima prevedeva sempre domande di comprensione e la seconda conteneva invece un
apparato di analisi del testo. La prima parte era indispensabile per poter poi lavorare sul testo e, in
alcuni casi, manipolarlo; pertanto era necessario far riflettere gli alunni su quesiti precisi al fine di
rendere il più fruibile possibile il testo.
Lerida Cisotto scrive:
Le domande a corredo del testo svolgono una funzione duplice: la prima e più diffusa è
quella di controllo e verifica di ciò che gli allievi hanno capito o ricordano dopo la lettura,
la seconda funzione è quella di facilitazione della comprensione e del ricordo del testo.
(2006, p. 123)
Un ulteriore ausilio alla comprensione è stato quello, alle volte, di affiancare delle illustrazioni per
condurre con più facilità gli allievi ad ipotizzare o a capire parti dei racconti: “le immagini
rappresentative dirigono l’attenzione in modo selettivo, guidando il lettore a prendere in
considerazione determinati elementi [...]” (ivi, p. 125).
Infine, ogni testo è stato corredato di un apparato di note in modo da fornire agli allievi il significato
di termini che ritenevo di difficile intendimento.
Il primo autore proposto ai ragazzi è stato Italo Calvino e data la complessità dei contenuti dell’opera,
visto il grado di astrazione, ho scelto di affiancare ai testi scritti anche una rappresentazione grafica
che potesse facilitare la comprensione e l’immaginazione della città in questione (dato che si tratta di
luoghi inesistenti nella realtà).
Oltre a ciò, le domande sono state strutturate facendo spesso riferimento al testo, in maniera tale da
permettere agli studenti di trovare le risposte andando a ricercare le informazioni e
contestualizzandole.
Per questo primo autore temevo che la difficoltà maggiore stesse principalmente nella comprensione
di concetti astratti e invece si è rivelata l’opera più interessante per gli allievi, che sono riusciti senza
molti problemi a svolgere l’attività conclusiva: scrivere individualmente un nuovo capitolo delle Città
16Ilaria D’Alessandro
invisibili seguendo il modello narrativo di Calvino (considerando quindi tutte le caratteristiche
trovate, condivise con l’intero gruppo classe e sistematizzate attraverso una tabella riassuntiva. Si
veda l’allegato 3).
Per il romanzo storico-sociale di Elsa Morante, seconda opera letteraria trattata, sono state ideate
delle schede di lavoro con tipologie di esercizi maggiormente diversificati: oltre alle domande di
comprensione e di analisi ho previso la compilazione di piccole tabelle e ho introdotto alcune
domande a risposta multipla. Per quanto riguarda questo romanzo ci si è focalizzati molto anche
sull’aspetto sociolinguistico: la presenza del dialetto romano e l’alternanza di registro linguistico sono
stati spunti di riflessione. Nell’esercizio finale, nel quale i ragazzi hanno dovuto immaginare e
scrivere la fine dell’opera, e quindi la sorte dei personaggi principali, lo scopo era quello di verificare
se riuscissero ad utilizzare un lessico simile a quello adoperato dalla scrittrice all’interno dei loro
racconti. Vista la difficoltà dell’attività è stato proposto agli alunni di svolgerla a coppie e di
riguardare le schede già affrontate come ausilio. In ultima istanza, è stato chiesto agli allievi di
raccontare il proprio finale esponendolo oralmente (senza impararlo a memoria e potendo tenere solo
una piccola scaletta da leggere) davanti a tutta la classe.
Infine, ho scelto di proporre due racconti (Il lungo viaggio e L’esame) appartenenti alla raccolta Il
mare color del vino di Leonardo Sciascia, che trattassero la stessa tematica ma da punti di vista
differenti: l’emigrazione. Anche in questo caso, c’è stata la possibilità di analizzare alcune figure
retoriche e di riflettere sulle caratteristiche linguistico-lessicali dell’autore con l’introduzione di
alcune “alterazioni” dovute, questa volta, al dialetto siciliano. Per il primo racconto si è scelto di
avviare l’unità d’acquisizione con l’osservazione di un’immagine alfine di far ragionare gli studenti
sul suo possibile contenuto (tramite un approccio induttivo) e in seguito è stato letto il testo in
plenaria.
Dopo aver terminato la lettura e l’analisi di entrambi i testi, la riflessione sull’emigrazione è stata
ampliata alla lettura continuata che avevamo affrontato nel primo semestre: Nel mare ci sono i
coccodrilli di Fabio Geda. È stato dunque chiesto agli studenti di compilare una tabella strutturata
nella quale si dovevano confrontare le tre storie attraverso due elementi: la descrizione del viaggio
(mezzi di trasporto utilizzati, tappe del viaggio e tempi di percorrenza) e le ragioni che hanno spinto
i protagonisti ad emigrare.
La fase successiva è stata quella di approfondire l’argomento facendo un riferimento anche alla nostra
contemporaneità: sono stati proposti due articoli pubblicati dalla RSI che parlavano dell’emigrazione
di alcune donne dall’Afghanistan ad altri Paesi. Dunque, l’ultimo esercizio a cui sono stati sottoposti
17Ilaria D’Alessandro
gli alunni è stato proprio quello di adottare il punto di vista di Zarifa Ghafari, della quale era stata
letta la testimonianza, e di raccontare la propria esperienza.
Nell’intero percorso didattico gli ambiti di competenza che gli studenti hanno dovuto attivare sono
stati plurimi. La riflessione sulla lingua è difatti stata sviluppata per ogni testo proposto così come
anche l’ambito della lettura e quello della scrittura, che sono stati verificati con gli esercizi di
comprensione, con l’analisi testuale e tramite le attività conclusive di ogni unità didattica
Nel caso di studio inerente a Elsa Morante è stato possibile, inoltre, lavorare sull’ambito dell’oralità
(per una spiegazione approfondita si veda il capitolo 3).
Le domande di ricerca
Scopo di questo lavoro di diploma è cercare di ottenere delle risposte ad alcuni interrogativi di ricerca,
incentrati sulla volontà di comprendere se sia opportuno o meno insegnare la letteratura italiana nelle
scuole superiori di I grado e soprattutto in quale maniera sia possibile incrementare l’interesse dei
discenti nei confronti del testo letterario, in particolar modo nel secondo biennio, mettendo in atto
una didattica per competenze. Ci si è pertanto chiesti:
1. Si possono sviluppare le competenze della scrittura e dell’oralità attraverso il testo letterario?
In che modo?
2. È possibile rendere interessante lo studio della letteratura tramite l’analisi testuale?
Al fine di fornire delle risposte ai quesiti citati poc’anzi, ho deciso di sperimentare un percorso
didattico incentrato sulla letteratura, proponendo la lettura e l’analisi di alcuni testi letterari in prosa
del Novecento italiano. Lo studio, nello specifico, ha voluto esaminare se gli alunni di una classe di
quarta media mostrassero un miglioramento nella competenza della scrittura e dell’oralità dopo aver
affrontato un percorso didattico sul testo letterario.
L’interesse per questo aspetto della disciplina dell’italiano si fonda sulla convinzione che far
conoscere agli studenti i capisaldi della letteratura italiana già a partire dalla scuola media sia di
fondamentale importanza per la loro crescita personale. Riuscire in questa impresa significherebbe
promuovere il senso critico e riflessivo degli studenti, ampliando di conseguenza la loro capacità di
interpretare la realtà circostante. A riguardo nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese
leggiamo: “[...] la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della tradizione, oltre
18Ilaria D’Alessandro
a offrire delle vie per capire meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano e del mondo”
(2015, p. 95).
È stata dunque attuata una ricerca di tipo sperimentale che mi ha permesso di controllare e aggiustare
man mano le variabili.
19Puoi anche leggere