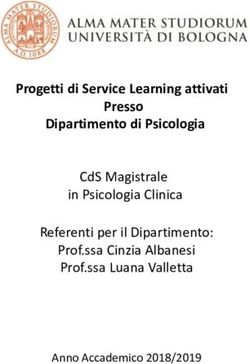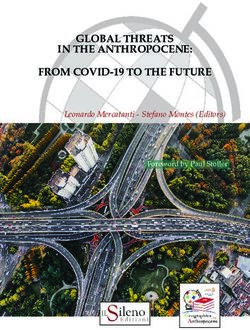La sfida dell'educazione alla post-modernità
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La sfida dell'educazione
alla post-modernità
Giuseppe Savagnone
II problema dell'educazione nella postmodernità può essere considerato da due
punti di vista diversi e complementari: da un lato esso riguarda la sfida che la
postmodernità pone nei confronti delle concezioni e delle pratiche educative
tradizionali, mettendole in crisi e costringendole a un radicale ripensamento; dall'altro
evidenzia la resistenza che l'idea di educazione presenta rispetto ad alcune tendenze
della post-modernità e la sua capacità di interagire con essa, interrogandola e
lasciandosene interrogare, in una dialettica creativa che, se non lascia immutata l'una,
può incidere profondamente anche sul corso dell'altra.
Noi esamineremo, nell'ordine, entrambe queste facce della questione, non
prima, però, di aver accennato ad alcuni processi che riguardano la società complessa
e che incidono in modo decisivo sulla trasformazione dei termini stessi del problema
educativo.
Scenari della complessità
Fino a poco più di vent'anni fa, la società italiana era dominata da alcune
grandi istituzioni, tendenzialmente monolitiche, rispetto alle quali l'individuo
realizzava un rapporto di appartenenza che lo coinvolgeva spesso fin dalla prima
giovinezza in modo totalizzante. Erano la Chiesa, i partiti, i sindacati, con la loro
organizzazione capillare, le loro strutture educative, ricreative, operative. Veniva
chiesta un'adesione ad esse incondizionata riguardo alle idee, agli stili di vita, alle
valutazioni concrete delle rispettive realtà associative, senza incertezze, senza
sfumature. Le divisioni interne erano considerate un fenomeno patologico, da
risolvere con una presa di posizione dell'autorità. II clima della lotta ideologica
contribuiva a rafforzare questa appartenenza rigida, rendendo automaticamente
sospetto e alla fine espellendo chiunque mostrasse di avere dubbi, oppure pericolose
simpatie per il fronte avverso.
La crisi delle appartenenze «forti». Oggi questa realtà di appartenenza è solo
un ricordo. All'adesione incondizionata di un tempo ne è subentrata una che
potremmo definire «limitata», piena di riserve e di «distinguo», che talora rende il
dialogo tra i membri di una stessa istituzione altrettanto problematico di quello con
l'esterno. Ma anche la partecipazione è diventata meno assorbente, meno assidua.
Agli inviti di condivisione si risponde in modo generico, prendendo le distanze,
rifiutando un impegno troppo vincolante.In senso stretto, nessuno appartiene più a niente. Non mancano, anzi si
moltiplicano, i centri di interesse. Ma, proprio perché sono diventati numerosi, il
singolo troverebbe strano legarsi ad uno in modo esclusivo: preferisce frequentarli
tutti, prendendo da ciascuno ciò che gli è utile. In questo modo egli non è più
rigidamente inquadrato in una struttura, ma ridefinisce incessantemente la propria
identità nel passaggio da un ambiente all'altro. Il suo senso critico, in questo modo, è
ben più fortemente esercitato che nel passato, anche se a prezzo di un rischio - non
meramente ipotetico - di individualismo. Non bisogna dimenticare, del resto, che le
istituzioni in questione sono da un certo tempo entrate in una crisi sempre più
evidente. La caduta del muro di Berlino, le ha messe tutte in difficoltà.
Di questa crisi istituzionale è un aspetto non secondario quella dei «modelli»
professionali. Basta pensare a quello del magistrato, un tempo intangibile e
insospettabile amministratore della giustizia, superiore ad ogni controversia politica o
sociale, ed oggi coinvolto in interviste clamorose, adesioni ideologiche o addirittura
partitiche, prospettive di governo o di sottogoverno. Un vera e propria crisi di
identità, che fa riflettere e consente di comprendere meglio quella di cui è vittima il
professore.
Il crollo delle ideologie. Gli anni a cui facevamo riferimento, parlando di
istituzioni monolitiche, sono gli stessi che erano caratterizzati dal prevalere delle
ideologie. Con questo termine si intendono, abitualmente, alcune grandi visioni
totalizzanti dell'uomo e della storia, sorte nel contesto di una lotta per la
conservazione o il sovvertimento di certi equilibri socio-economici e quindi non
puramente speculative, bensì essenzialmente orientate all'azione. Per questo
un'ideologia non mira a suscitare una riflessione critica, che potrebbe indebolire
l'efficacia operativa, ma una fede assoluta, infrangibile, nel successo finale. Di queste
ideologie il marxismo era il tipo classico, ma non certo l'unico. La lotta ideologica ha
dominato la storia del dopoguerra, fino a tempi recenti.
Anche le ideologie, comunque, come è noto, sono tramontate. Non ci sono più
visioni onnicomprensive: si interpretano le esperienze, nella loro mutevolezza e
relatività. Né si prefigurano utopie sociali o politiche, in nome delle quali combattere
l'attuale sistema: l'accettazione del presente ha prevalso sulla vertigine - ma anche
sulla speranza - del futuro. Quanto all'impegno, non manca se ci si riferisce al
servizio concreto, particolare, del volontariato, mentre è pressoché totale
l'indifferenza verso quello di più ampio respiro politico. Di «fede», poi, ne è rimasta
ben poca, dopo le disillusioni maturate nel clima della caduta del muro e del dilagare
di tangentopoli. Le «grandi narrazioni», dietro le loro formule magiche - giustizia,
libertà, difesa della persona umana - hanno rivelato squallidi giochi di potere e di
interessi. II singolo si chiude nel suo discorso privato (la professione, gli amici, il
rapporto di coppia) senza rimpianti. Anche di tutto questo bisogna ricordarsi quando
si parla del problema della scuola e dell'educazione.La relativizzazione dello spazio e del tempo. E poi c'è il sovvertimento delle grandi
coordinate del vivere umano che sono lo spazio e il tempo. Nel corso dei secoli si era
assistito a un profondo processo di riduzione delle distanze sia spaziali che temporali.
Oggi questo processo ha toccato esiti tali da sovvertire il senso tradizionale della
distanza. Per quanto riguarda lo spazio, ormai la maggiore o minore lontananza di
una località è data, piuttosto che dal numero dei chilometri, dalla funzionalità dei
mezzi di trasporto. Si può essere più «vicini» a una città distante migliaia di
chilometri, ma raggiungibile in aereo, che a una località che si trova nella propria
regione e che è mal servita dai mezzi di trasporto.
Questo annullamento delle distanze fisiche è ancora più evidente se si guarda ai
mezzi di comunicazione. Si assiste in diretta a eventi che si stanno verificando in altri
continenti. II mondo è diventato un villaggio, secondo la famosa formula di
McLuhan, e in questo villaggio siamo tutti vicini di casa che si incontrano nell'atrio
costituito da questo o quello spettacolo di intrattenimento.
Questi processi non riguardano solo lo spazio. La presenza pervasiva dei
massmedia tende ad annullare la percezione del passato e l'aspettativa del futuro,
proiettando incessantemente l'attenzione in un presente troppo ricco di fatti e
assorbente per lasciare spazio alla memoria e alla speranza. Notizie, immagini si
susseguono in un flusso incessante, talora convulso, ma privo di direzione. Si vive
«l'attimo fuggente», la sensazione immediata, l'esperienza puntiforme, restando
chiusi, malgrado l'apparente dinamismo, in un immutabile presente.
Anche il consumismo incide su questo logorìo del senso del tempo. Una volta
gli oggetti si tramandavano di padre in figlio. Una casa, una penna, un orologio,
venivano da lontano e andavano custoditi per essere trasmessi in eredità ad altri.
Avevano, insomma, una storia. La nostra società -basata sull' «usa e getta» - ci ha
abituati a un mondo di cose perennemente «nuove», che non hanno un passato e che
non sono destinate ad un futuro.
La frammentazione dell’apparato educativo. Anche le strutture entro cui si svolge il
processo educativo hanno subito una profonda trasformazione. Un tempo
l'educazione era monopolio di alcune grandi agenzie - la famiglia, la scuola, la Chiesa
depositarie di messaggi autorevoli, custodi di una disciplina di vita, il cui valore si
dava per scontato. C'erano delle regole su cui tutti si era, più o meno, d'accordo.
Oggi questo monopolio si è rotto. Polverizzato in una miriade di punti di
riferimento mobili, il sistema educativo ha assunto la forma di una galassia in cui la
televisione, la famiglia, il corso di lingua straniera, la scuola, il gruppo sportivo, la
comitiva di amici, si vengono a trovare più o meno sullo stesso piano, rendendo
difficile al giovane un reale lavoro di selezione e di sintesi dei messaggi che riceve in
sovrabbondanza. Se è vero, come qualche studioso sostiene, che la ricerca di senso
richiede, più che l'acquisizione di nuovi dati, la capacità di sciogliere lecontraddizioni insorgenti fra quelli - troppo numerosi e spesso incongruenti - a nostra
disposizione, bisogna concluderne che l'attuale sovrabbondanza di stimoli non facilita
il recupero del loro significato. La molteplicità di cui parlavamo non si pone solo tra
le diverse agenzie educative, ma anche al loro interno.
L'educazione alla prova della post-modernità
Il quadro della società complessa, che abbiamo appena delineato, contiene già
numerose implicazioni di ordine culturale. Ma bisogna passare a un esame più
specifico del significato della post-modernità in ordine al problema dell'educazione. Il
«post-moderno» si contrappone, per definizione, al «moderno». È, dunque, nella crisi
di alcuni grandi temi tipicamente moderni che noi dobbiamo individuare il senso
della nuova situazione creatasi.
Caduta dei presupposti del concetto moderno di educazione Primo fra essi,
quello della soggettività. L'epoca moderna è stata dominata dalla progressiva scoperta
e poi dall'enfatizzazione del tema del soggetto, fino all'assolutizzazione di
quest'ultimo. Dal Rinascimento all'idealismo romantico, attraverso Cartesio, questo
itinerario è stato percorso con una linearità senza cadute. Anche le filosofie «di
rottura» non hanno avuto tentennamenti nel denunziare proprio nella crisi del
soggetto, nella sua «alienazione», la fonte di ogni infelicità: nel pensiero di
Feuerbach, di Marx, di Kierkegaard, troviamo soluzioni diverse, ma convergenti
nello sforzo di diagnosticare e di superare la scissione dell'identità profonda
dell'uomo.
Questa prospettiva viene drasticamente rinnegata dal pensatore che viene
considerato l'ispiratore della cultura post-moderna, Nietzsche. Per lui l'io, con la sua
coscienza unitaria, è «una favola, una finzione, un gioco di parole» (Il crepuscolo
degli idoli), una crosta superficiale che nasconde la vera realtà dell'uomo, costituita
da un caos fluente di pulsioni e di ciechi stimoli disarticolati e contraddittori. Una
visione che ha un significativo riscontro nella contemporanea dottrina di Freud,
secondo cui la vera identità dell'uomo non sta nella sua soggettività, nella sua
coscienza, ma nell'inconscio, che egli chiama con il pronome neutro es per
sottolinearne il carattere impersonale. Siamo, insomma, davanti alla dissoluzione del
soggetto: non più come fenomeno patologico, a cui cercare rimedio, ma come stato
costitutivo, riconosciuto e accettato.
Un secondo tema fondamentale per la tradizione educativa messo in
discussione dalla nuova tempèrie culturale, è quello della verità. Comunque la si
concepisse, l'educazione aveva a che fare con l'alternativa vero/falso. Non si era
d'accordo, evidentemente, sul contenuto di questi termini, ma si riconosceva il loro
valore determinante. La crisi delle ideologie ha segnato l'avvento di una situazione
nuova. A prima vista essa si presenta come una conquista: l'avvento del pluralismo, la
vittoria della tolleranza e del rispetto nei confronti delle idee altrui. A ben vedere,però, dietro questo c'è qualcos'altro di più profondo: la convinzione, più o meno
apertamente dichiarata, che ognuno ha la sua verità, che non vale più di quella degli
altri. Il che equivale, semplicemente, a dire che in realtà la verità non esiste e che
anche quella che personalmente si ritiene tale è in fondo una questione di gusti.
Si spiega cosi il fatto che da questo pluralismo non derivi un confronto più
aperto sui problemi di fondo, ma il silenzio su di essi; non un dialogo rispettoso, nella
sincera ricerca comune della verità, ma lo scadimento in un pragmatismo utilitaristico
in cui non solo non ci si cura di verificare il pensiero dell'altro, ma neppure di
approfondire coerentemente il proprio.
Al fondo di questo atteggiamento sta la perdita del senso della realtà. La
società della comunicazione totale è anche quella dove è diventato difficile
determinare il messaggio che viene comunicato. Nei programmi di giornalismo-
spettacolo, nei documentari, nella cronaca dei quotidiani, nella pubblicità, il confine
tra apparenza e realtà si è fatto incredibilmente tenue, sfuggente. La fugace immagine
delle cose, delle persone, delle situazioni è diventata più importante del loro essere
effettivo, in un certo senso, anzi, lo costituisce: «Il mondo vero è diventato favola»,
scrive Nietzsche ne Il crepuscolo degli idoli: tra verità e favola non c'è più differenza.
Un ultimo presupposto dell'educazione, che il pensiero moderno aveva
maturato e che quello post-moderno ha lasciato cadere è il senso della storia. La
modernità si definisce precisamente per l'idea di progresso e per la convinzione che
l'uomo si realizzi nella storia. Non a caso il suo esito è lo storicismo assoluto, che
esalta la storia come un assoluto.
La post-modernità è, invece, dominata dall'esperienza della caduta di tutti i miti
del progresso: il trionfo della ragione, il continuo sviluppo della scienza e della
tecnica, la speranza in una rivoluzione liberatrice, si sono rivelati illusioni vane e
perfino pericolose, da cui guarire. Anche la consapevolezza del valore decisivo che
hanno gli atti dell'uomo, in una prospettiva che non sia quella dell'eterno ritorno, si
attenua. La cultura dell'effimero induce a ritenere «leggere» le azioni, le situazioni
che si verificano solo una volta quelle, appunto, storiche: «una volta, nessuna volta» è
la formula ricorrente ne L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera.
L'avvento della scuola-contenitore
Non c'è da stupirsi se una scuola che era incentrata sul soggetto, sulla
trasmissione di certe verità e sulla dimensione storica, come quella italiana, si trova in
serie difficoltà nel nuovo contesto culturale. Di queste difficoltà di fondo, per la
verità, la società civile sembra non essersi neppure accorta. Senza percepire che le
basi stesse della scuola tradizionale vacillavano, piuttosto che fare la fatica di
ripensarle ha creduto di poter identificare le ragioni della sua crisi in una mancata
rispondenza alle istanze socio-economiche e in una scarsa «produttività». Inquest'ottica, ha creduto di contribuire a risolvere detta crisi cercando di farla essere
«utile» col moltiplicare i suoi compiti in rapporto alle nuove esigenze.
Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi: una paurosa crisi di senso, che
cresce in modo direttamente proporzionale al moltiplicarsi delle attività. La
fisionomia della scuola che ne viene fuori è quella di un gigantesco contenitore di
iniziative e di esperienze, privo però della chiara percezione delle proprie finalità e di
conseguenza incapace di unificare vitalmente questa molteplicità.
Sempre più si cerca di sostituire una consapevolezza e una convinzione, che
mancano, con la forza coinvolgente delle esperienze: viaggi d'istruzione, concerti,
mostre, gemellaggi con scuole straniere, rappresentazioni teatrali, danno sfogo a una
espressività che ormai viene assunta, nella varietà indefinita delle sue manifestazioni,
come ultimo punto di riferimento. Alternativa a questo sembra essere solo la
rigidezza repressiva di qualche preside o docente che evoca con nostalgia la vecchia
scuola, con tutto ciò che essa aveva di fiscale, di astratto e di elitario. In assenza degli
adeguati supporti culturali, stili diversi stentano a farsi strada. Tutto quello che
potrebbe richiamare il calmo raccoglimento dell'io, la disciplina che è sacrificio,
l'impegno senza agitazione, l'adesione nella libertà, la consapevole fedeltà
all'impegno preso, la responsabilità verso gli altri, tutto ciò, in questo contesto, non
solo non viene favorito, ma è tendenzialmente scoraggiato. Anche se e quando si
studia, è la logica dell'informazione a prevalere, non quella della maturazione del
soggetto nel dialogo con larealtà percepita nella sua storicità.
La crisi più profonda è quella che vivono i docenti. Smarriti in questo
passaggio fra un'identità irrimediabilmente perduta - e a cui, anche se fosse possibile,
non sarebbe neppure desiderabile ritornare - e quella, che si vuole loro assegnare
dall'esterno, di intrattenitori, essi vivono nella maggior parte in una specie di limbo,
consolandosi con lo scaricare tutte le colpe della loro situazione su altri: gli alunni,
che non sono più quelli di una volta, il governo, che non aumenta gli stipendi, ecc. La
verità è che essi stessi non sanno più per che cosa lavorano. Spesso sono i primi ad
avere risentito, più o meno consciamente, della crisi della società e dei valori
moderni. Sono essi i primi a chiedersi «a che cosa serva» uno studio volto alla
crescita interiore del soggetto, uno studio che suppone la percezione della verità di
alcuni valori ed è incentrato sulla storia del passato.
Né ci si può illudere di sopperire a questo vuoto, che riguarda i fini, curando
l'aggiornamento sui mezzi: il susseguirsi dei corsi, dei convegni, dei seminari, non
può sostituire una prospettiva di fondo che manca. Per l'insegnante «perplesso» essi
diventano, piuttosto, una fuga dalle sue classi e dai suoi problemi, un modo per
rimandarli.
Anche la crisi degli organismi rappresentativi della scuola è in larga misura
riconducibile a questo smarrimento complessivo. Là dove non è ben chiaro ad alunnie professori - meno che mai al personale ausiliario e amministrativo - il «progetto
storico» che la scuola nel suo insieme e quella determinata comunità scolastica in
particolare devono perseguire, assemblee, consigli d'istituto, sono destinati a girare a
vuoto.
La sfida dell'educazione
Dicevamo prima che, a fronte di questo disagio, indotto nel cuore dell'apparato
e del processo educativo dalla post-modernità, vi è anche una sfida che l'educazione
rivolge alla post-modernità. In altri termini, proprio a partire dal concetto di
«educazione» e dalle pratiche a cui esso ha dato luogo nella tradizione occidentale è
possibile discernere nel clima culturale del nostro tempo gli aspetti positivi da quelli
che non lo sono, recuperando i primi e operando per liberarsi, gradualmente, dei
secondi.
In questo senso, la scuola può costituire un laboratorio di idee per costruire il
futuro, e non soltanto un museo delle conquiste del passato; un luogo di elaborazione,
e non solo di trasmissione della cultura. A patto che non si insista per farla essere, a
tutti i costi, funzionale ai meccanismi della società neocapitalista, specchio passivo
della mentalità e delle esigenze di quest'ultima. Si parla tanto di «autonomia»: ma la
prima autonomia non è quella economico-amministrativa dei singoli istituti, bensì
quella culturale che l'istituzione educativa deve assolutamente mantenere nei
confronti dei signori dell'economia e della politica, come in genere nei confronti delle
logiche oggi dominanti. Solo cosi essa potrà esercitare quella funzione creativa e
critica che costituisce il suo insostituibile servizio alla società.
La ricomposizione della soggettività.
Partiamo dunque dal concetto di «educazione», sfruttandone fino in fondo
l'etimologia: educere, condurre fuori. Risalta subito l'originalità di questo processo
rispetto a quello dell'istruzione e in genere dell'informazione. Mentre quest'ultimo va
dall'esterno verso l'interno del soggetto e opera su di lui, imprimendogli una forma
che non è la sua, l'educare implica un movimento dall'interno verso l'esterno.
Ma che cosa dev'essere «condotto fuori»? La risposta più ovvia è che vi è in
ognuno un mondo che gli altri non conoscono - il suo io, la sua personalità, forse la
sua anima - e che precisamente questo deve potersi manifestare nel processo
educativo. Ma allora, l'opera dell'educatore si ridurrebbe a sbloccare persone timide,
che non riescono a esprimere ciò che hanno già dentro di sé? Sarebbe semplicistico
ridurla a questo. La realtà è più complessa. L'io di una persona non è una cosa, un
oggetto già costituito una volta per tutte. L'unità profonda che ognuno cerca, sotto
forma di ordine ed equilibrio interiore, di pace, dev'essere continuamente
riconquistata facendo i conti con una molteplicità caotica di stati d'animo, istinti
violenti, reazioni incontrollate.Questo vale in modo particolarissimo per chi, più giovane, è ancora alla ricerca
di se stesso. È vero che dentro di lui opera un principio unificante, costituito dalla sua
identità personale, ma esso ha bisogno, per affermarsi, di apprendere le vie
impegnative della consapevolezza, della coerenza e della responsabilità verso se
stesso e verso gli altri. Se ogni uomo - e specialmente il giovane - non è un dato ma
un processo vivente, una nascita continua, si comprende che il compito
dell'educazione non è solo di «condurre fuori» qualcosa di già precostituito, ma
precisamente di accompagnare questo io che ancora non è pienamente se stesso e che
deve uscire dall'indistinzione, dalla confusione e dal gioco cieco di meccanismi che
sfuggono al suo controllo.
Ora, proprio queste implicazioni del concetto di «educazione» possono
costituire una guida per valorizzare le ricchezze delle prospettive post-moderne,
senza lasciarsene travolgere. Non si tratta di tornare all'unità «povera» e rigida della
identità personale monolitica. Un simile ideale - ragazzi e ragazze «tutti d'un pezzo»,
come una volta - non solo non è praticabile, ma comporterebbe tali perdite da
renderlo anche inaccettabile. Bisogna ripartire dalla frammentarietà, dalla
mutevolezza, dalla provvisorietà, dal rischio delle esperienze molteplici in cui oggi
un giovane trova la propria realizzazione. II punto, se mai, è di non fermarsi ad esse,
scambiando il punto di partenza con quello d'arrivo; di uscire dalla staticità
sostanziale in cui questo apparente dinamismo precipita se non sa darsi una direzione,
se non sa diventare cammino, ricerca, speranza.
La scuola può diventare il luogo di questa ricerca e di questa speranza. Il luogo
in cui, a partire dalla varietà e talora dalla contraddittorietà di tutti gli stimoli e le
suggestioni della vita d'ogni giorno, degli spettacoli, delle letture, il singolo può
imparare a far fiorire l'unità del proprio io non lasciandosi alle spalle quella varietà,
ma recuperandola in un'unità più ricca, più articolata e più aperta che non in passato.
Non abbiamo visto proprio in questo itinerario il senso del processo educativo in
generale?
Perché, però, questa unificazione non sia una pura e semplice accozzaglia di
elementi eterogenei, si richiede una capacità di sintesi che, a sua volta, suppone
quella di discernere e selezionare i bisogni reali della persona da quelli fittizi e
fuorvianti. La società dei consumi rischia di ottundere la sensibilità e l'intelligenza
moltiplicando artificialmente i bisogni, fino a farne una variabile indipendente dal
reale processo di crescita della persona e funzionale, piuttosto, alle esigenze del
mercato. I giovani, particolarmente, sono le vittime di questa campagna frastornante e
insinuante. Ebbene, la scuola può diventare il luogo del discernimento critico dei
bisogni. Le discipline insegnate non devono restare oggetti di un interesse
disincarnato, ma fornire i punti di riferimento culturali per una valutazione del
presente. La formazione culturale può diventare allora il miglior antidoto nei
confronti di una mitologia consumistica in fondo abbastanza ingenua e rozza e aprirea una capacità di fruizione della bellezza, dell'intelligenza, della profondità, che
costituirebbe la più autentica liberazione dall'attrattiva di quella mitologia.
Grazie a questa capacità selettiva la persona potrebbe interpretare in modo più
autentico le condizioni della propria realizzazione, identificandole, al di là del vorace
accaparramento di una porzione di successo, di oggetti, di affetto, nel dono di sé agli
altri. Oggi si parla molto di autorealizzazione, insistendo unilateralmente su ciò che
l'individuo deve poter ricevere per attuarla. Raramente si mette in luce che il modo
migliore di realizzarsi è diventare capaci di voler bene e di mettersi al servizio degli
altri. Così, per es., nel lavoro, raramente si sottolinea che -se da un lato è vero che si
sarà utili agli altri nella misura in cui il lavoro che si fa corrisponda alle nostre
esigenze- dall'altro ci si realizzerà veramente nel proprio lavoro quanto meno si
preporranno le proprie esigenze a quelle dei destinatari del proprio servizio. Questa è,
del resto, la natura delle cose: la funzione di un medico non è di autorealizzarsi, ma di
curare i malati e chi va da un dottore non lo fa perché questi si realizzi, ma per essere
curato.
La verità è che i due aspetti non solo non devono essere contrapposti, ma
neppure giustapposti, come se fossero solo paralleli: l'uno, in effetti, dipende
dall'altro, in una circolarità virtuosa che fa del dono la migliore realizzazione di sé.
La scuola può essere il luogo di questo incontro tra autorealizzazione e dono.
Il recupero della realtà
Il processo educativo non riguarda solo le persone che ne sono protagoniste - in
particolare quella del discente - ma i contenuti intorno a cui il loro dialogo si svolge.
Abbiamo già notato che un'educazione degna di questo nome non può prescindere
dall'istruzione, anche se la vive come comunicazione piuttosto che come mera
trasmissione.
Ora, si tratta di percepire la forza di realtà che è in questi contenuti, liberandoli
da ogni artificiosità libresca e nozionistica. Da questo punto di vista la scuola è
chiamata a diventare il luogo della meraviglia, intendendo con questo termine non la
sorpresa che deriva da uno spettacolo inconsueto, ma la scoperta di chi impara a
guardare con occhi nuovi le antiche cose che lo circondano da sempre e che, proprio
perché troppo vicine, erano diventate praticamente invisibili. A che varrebbe, del
resto, il contatto con testi ricchi di arte o di sapienza, se non ad aprire gli occhi sulla
realtà?
È questa - non quella della funzionalità utilitaristica - la reale vicinanza che la
scuola deve realizzare nei confronti della vita. Una vicinanza, peraltro, che implica
una distanza. Senza un certo raccoglimento dell'intelligenza e della sensibilità, senza
una certa capacità di essere soli con se stessi, senza, insomma, un certo distacco dalla
dispersione e dalla fretta dell'azione e dei ritmi produttivi, non c'è profondità néintensità. Questo è la cultura, e questo è la scuola: una distanza che avvicina. Che
rende autentico l'incontro con la realtà.
In questo incontro l'intelligenza impara che la libertà suppone l'obbedienza alla
verità delle cose. Non lo dice il vangelo di Giovanni? «La verità vi renderà liberi».
Ma la verità esige un umile ascolto e un'ascesi coraggiosa. È necessario rinunziare
alle proprie chimere, alle proprie illusioni, alla propria volontà di potenza, per
accettare con semplicità che le cose stiano, talora, in modo assai diverso da come noi
avremmo desiderato. Non si tratta di un'obbedienza come pura adeguazione passiva:
nella tradizione occidentale -per es. in quella benedettina- l'obbedienza è piuttosto
rappresentata come una suprema tensione della personalità, la sua fatica, il suo
impegno più alto e più attivo, in contrasto con la passività che è l'abbandono ai propri
capricci e alle proprie chiusure mentali.
La ricomposizione della comunità
Questa onestà intellettuale non solo non impedisce il dialogo, ma lo rende
possibile. In primo luogo, perché consente di sottrarsi al gioco illusionistico delle
apparenze, degli stati d'animo soggettivi, degli slogan, e di costituire cosi una base
comune senza cui la diversità diventa incommensurabilità e scade nella indifferenza
reciproca. Per parlarsi bisogna che le parole si riferiscano a una realtà comune; per
discutere bisogna condividere alcune strutture logiche; per sostenere le proprie
ragioni e confutare quelle altrui, bisogna essere d'accordo su un metro che costituisca
la misura del vero e del falso. Il pluralismo ha senso se si colloca all'interno di una
comune esperienza della realtà: altrimenti perde quel suo aspetto fondamentale che è
il confronto e si trasforma in pura e semplice solitudine.
Senza un rapporto con la realtà, del resto, il dialogo non solo sarebbe
impossibile, ma anche superfluo. Se non c'è verità non c'è neppure errore e non c'è
alcuna possibilità che nella mia posizione vi sia qualcosa che gli altri possano
discutere o correggere. Lo scetticismo rende infallibili. In positivo: se non c'è verità,
non c'è neppure nulla che io debba apprendere di radicalmente nuovo rispetto a quello
che è già in mio possesso. Il mondo che mi sono costruito a mia immagine e
somiglianza non può essere messo in crisi da acquisizioni che lo mettano in crisi e lo
costringano a superarsi, perché non c'è nulla fuori di me che possa "irrompere" nei
miei schemi mentali e pretendere di esservi accolto. Ancora una volta, il dialogo
perde il suo interesse. Nella migliore delle ipotesi potrà essere utile per conoscere i
miei interlocutori, non per arricchire la mia visione delle cose.
Queste riflessioni diventano importanti in una società che ha fatto del
pluralismo e del dialogo la propria regola di vita e che sperimenta però sempre più
spesso lo scacco di questi ideali. Forse è venuto il momento di rendersi conto che
oggi l'intolleranza e la violenza non fioriscono per ché si hanno delle idee, ma perché
se ne hanno troppo poche. Le sempre più frequenti esplosioni di razzismo che a varilivelli travagliano la nostra società non presentano forti connotazioni ideologiche. A
monte di esse si trova, piuttosto, una mentalità egoista e corporativista che vuole
escludere i più deboli - sentiti come intrusi - dal banchetto delle opportunità a cui la
società opulenta ci aveva abituati e che in tempo di recessione cominciano a
scarseggiare. Si tratta dunque di fenomeni che proliferano all'interno del «grande
brodo» del consumismo e della omologazione che esso ha prodotto.
Come l'educazione indica al singolo la via di un recupero dell'unità nella
varietà delle spinte interiori ed esteriori che popolano la sua esistenza, così essa pone
le condizioni per un analogo processo al livello delle comunità scolastiche. La scuola
deve riscoprire il valore della differenza. Proprio perché è in grado di porre il terreno
comune del dialogo tra i diversi, essanon deve temerne l'esistenza. L'unità che si
propone, perciò, non è quella della piattezza, in cui tutti rinunziano a essere se stessi
per non correre il rischio dello scontro, ma quella che riesce a contenere le
opposizioni, articolandole in un discorso razionale che non le stempera, ma le mette a
confronto. Senza ricadere nella sterile polemica o, peggio, nell'aggressione reciproca
del tempo delle ideologie, le nostre scuole dovrebbero però diventare luoghi di
dibattito permanente in cui idee, interessi, esperienze di varia matrice si aprano
reciprocamente, per interagire e dare luogo a uno spazio creativo.
In questo grande dialogo tra i diversi possono trovare la loro più autentica
composizione termini abitualmente contrapposti, quali «libertà» e «responsabilità». Il
dialogo è, infatti, momento in cui ciascuno si esprime liberamente, ma al tempo
stesso si impegna a «rispondere» ai propri interlocutori, sia di quello che dice -
altrimenti non merita di essere preso sul serio e il dialogo stesso si vanifica- sia a
quello che loro dicono a lui, altrimenti il dialogo diventa uno sterile monologo. Un
vero dialogo ha dunque implicazioni precise sul piano etico. Non vi si può
partecipare se non a certe condizioni che sottraggono il singolo alla logica
dell'individualismo e della "leggerezza" e lo proiettano in quella del rispetto, della
condivisione, dell'impegno comune.
E, nella misura in cui questo dialogo costituisce il tessuto stesso del processo
educativo, libertà e responsabilità lo caratterizzano nel suo insieme e in tutte le sue
componenti scolastiche: docenti, personale ausiliario e amministrativo, alunni,
genitori. Dove non solo le differenze di cultura, di idee, di sensibilità, ma anche
quelle legate ai diversi ruoli acquistano rilievo, nell'ottica che abbiamo sopra indicato.
Perciò anche tutte queste componenti sono coinvolte nel governo della scuola, un
governo destinato ad acquistare maggior peso ora che la personalità giuridica viene
estesa a tutti gli istituti di secondo grado. Il fallimento pressoché totale degli organi
rappresentativi non deve far perdere di vista l'esigenza di fondo che la scuola sia il
luogo dell'educazione politica, non solo attraverso l'insegnamento dell'educazione
civica (un altro strumento di fatto semi-atrofizzato per il non uso), ma anche
attraverso una pratica di autogestione da parte di tutti coloro che ne fanno parte e che
in modi diversi sono legittimati a concorrervi.Il recupero della storicità. L'uomo è «un animale che racconta storie»
(Maclntyre). Le racconta, innanzitutto, a se stesso, quando sente il bisogno di
coordinare la molteplicità disordinata degli eventi e degli stati d'animo e dà loro un
senso articolandoli dentro di sé come se dovesse raccontare a qualcuno la loro storia.
Perché i singoli fatti, al di fuori del contesto di una narrazione, non hanno un valore
univoco. Che cosa significa una strizzata d'occhio? È veramente un «fatto» in sé
compiuto? Oppure è soltanto un dato ancora incomprensibile, finché non si sarà fatto
ricorso a un'interpretazione che, necessariamente, fa leva su ciò che è accaduto prima
e su ciò che accadrà dopo?
Per rendersene conto basta evidenziare che dietro una palpebra che si chiude
possono esservi motivazioni disparate: un tic nervoso, ad esempio; oppure un
approccio sessuale; oppure, ancora, un esercizio imposto dall'oculista durante la
visita; o la prova fatta da un attore che studia la sua parte; o il segnale d'intesa con cui
una spia si fa riconoscere dal complice. Lo stesso atto fisico può dunque rientrare in
fatti diversissimi l'uno dall'altro. Il suo significato, in realtà, dipende dal contesto,
dalla storia in cui è inserito. Se la storia narra di un agente segreto che è in cerca del
suo referente, è improbabile che chi strizza l'occhio lo faccia per una prova teatrale, o
per un approccio sessuale. E così via. La narrazione è, allora, il modo di raccogliere
situazioni, eventi, scelte, in un quadro dotato di senso.
Anche l'educazione è un processo narrativo. Si accompagna qualcuno nel cammino
verso la propria identità insegnandogli a raccontare la sua storia agli altri o a se
stesso, o a Dio. E perché egli impari a far questo, gli si narrano storie. Così, almeno,
si faceva un tempo, e forse il fatto che oggi il bambino cresca senza le favole o i
racconti dei ricordi del nonno, ma con 1'atemporale gioco dei videogame o dei
cartoni animati televisivi è uno dei motivi della perdita dell'identità.
In ogni caso, ancora la nostra scuola è in larga misura fondata sul racconto del
passato: oltre a quella che viene puramente e semplicemente chiamata «storia», molte
altre caratterizzano se non tutti almeno alcuni corsi di studi: storia della letteratura
italiana, di quella inglese o francese, di quella latina e greca; storia della filosofia;
storia dell'arte. E anche delle discipline che non vengono di solito insegnate secondo
un taglio storico –come matematica, fisica, scienze naturali-, ci si rende conto sempre
di più che guadagnerebbero ad averlo. La scuola è una grande narrazione, in cui un
giovane impara -o dovrebbe imparare - a narrare a sua volta.
Il che significa che dovrebbe imparare ad avere memoria e speranza. Una storia
esige un rapporto col passato e col futuro. Col passato, innanzitutto. Non solo quella
occidentale, tutte le civiltà hanno vissuto della trasmissione orale di una tradizione.
Nella nostra scuola «memoria» è diventato sinonimo di nozionismo bigotto. La sola
memoria che oggi noi conosciamo e utilizziamo è quella asettica dei computer -una
memoria che non è vivente, perché in essa i dati memorizzati non plasmano 1'io dichi li custodisce e non sono a loro volta arricchiti da questo io. E i mezzi di
comunicazione ci abituano a gettar via le notizie appena invecchiate.
Anche il futuro, in una storia, è importante. Si vuol sapere come andrà a finire.
E se i protagonisti del racconto sono gli stessi narratori, essi non solo sono costretti a
chiedersi, nell'iniziare ogni nuovo capitolo, quale esito vogliono che abbia il loro
racconto, ma devono impegnarsi perché esso vada in quella direzione. Da qui
l'esigenza di un progetto, e di mezzi adeguati per realizzarlo. Senza ricadere nelle
utopie tipiche del tempo dell'ideologia, si può forse riattivare la facoltà dell'uomo di
pensare in grande, oltre il momento fuggevole, per preparare una società diversa.Puoi anche leggere