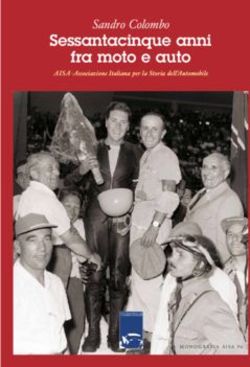La rana e lo scorpione - libro primo GIORGIA SANDONI BELLUCCI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
La rana e
lo scorpione
libro primo
GIORGIA SANDONI BELLUCCICopyright © 2018 Giorgia Sandoni Bellucci
www.giorgiasandonibellucci.com
All rights reserved.
ISBN: 9781720166672Giorgia Sandoni Bellucci
La rana e lo scorpione
libro primoPrefazione
Uno scorpione doveva attraversare un fiume, ma non sapendo nuotare, chiese
aiuto a una rana che si trovava lì accanto. Così, con voce dolce e suadente, le disse:
«Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull’altra sponda». La rana
gli rispose: «Fossi matta! Così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi!» «E
per quale motivo dovrei farlo?» incalzò lo scorpione «se ti pungessi, tu moriresti e io,
non sapendo nuotare, annegherei!» La rana stette un attimo a pensare, e convintasi
della sensatezza dell’obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono
in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena, e
capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire la
rana chiese all’insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione»
rispose lui. «È la mia natura.»
Favola persianaQuesto libro non è un’opera di fantasia. I personaggi e i luoghi citati non sono inventati, ma rielaborati allo scopo di tutelare la privacy. Qual- siasi analogia con persone – vive o scomparse – è assolutamente casuale; quella con luoghi e fatti un po’ meno. In parole povere: la storia che state per leggere è quasi vera. Nell’anima, più che nell’intreccio. Perché se non tutti gli eventi narrati sono accaduti realmente, le emozioni che li accompagnano – ve lo assicuro – un tempo le ho vissute fino all’ul- timo respiro. D’altronde – che stia bene oppure no – la scrittura è sem- pre una questione privata e se qualcuno vi dice il contrario, non crede- tegli. Mente per timore o per vergogna. Perché a volte il pensiero che la gente possa leggerti dentro fa paura e tu non vorresti mai che qualcuno prendesse a schiaffi il tuo bambino. Bambino, sì, avete capito bene: un romanzo è proprio come un figlio. Vive e cresce dentro di te giorno per giorno, viene al mondo dopo una gestazione lunga e dolorosa e per quanto cerchi di cambiargli i connotati, avrà sempre i tuoi stessi occhi. Occhi profondi; capaci di cibarsi delle ossessioni e dei desideri segreti che popolano la tua anima e dar loro nuova forma e significato; di tra- sformare quello che sei in quello che tutti siamo: vita. Quando partorisci un romanzo, lo fai pensando che il tuo libro racconterà la tua storia, ma la verità è che non ci sono storie personali. Esse sono fatte di verità comuni tanto alla sorte di chi legge, quanto al destino di chi scrive. Lungo la favola dell’esistenza prima o poi le barriere letterarie cadono, i ruoli si mescolano, si invertono, si sovrappongono e così le storie che prima avevano un solo padrone improvvisamente si ritrovano a vagare randagie... A diventare storie di tutti. Per questo io ho deciso di confi- darvi la mia: perché voglio che diventi anche vostra. Per anni mi sono domandata se fosse lecito classificare le persone in base alla propria na- tura. Se fosse giusto oppure no, credere a quella vecchia favola persiana secondo cui ciascuno di noi nascerebbe rana o scorpione, senza vie di mezzo. È vero che per ogni individuo in grado di attraversare la tempe- sta del mondo, da qualche parte ne esiste un altro, pronto ad aggrapparsi al suo cuore in cerca di salvezza? Che nel mare della vita c’è sempre chi sa nuotare e chi invece, da solo affoga? Chi è disposto a lasciarsi stra- volgere la quotidianità, pur di rendere meno avvilente quella del pros-
simo e chi al contrario non può fare a meno di condividere l’oppres-
sione della propria identità con qualcuno, anche a costo di trascinarlo
sul fondo dell’abisso assieme a lui? E soprattutto: è vero che la nostra
natura è più forte della nostra volontà oppure è il pregiudizio che non
si possa lottare contro di essa ad accecare la nostra razionalità? E se
l’uomo è davvero così succube dei propri istinti – anche dei più autodi-
struttivi – e delle proprie convinzioni – persino delle più irrazionali, po-
trà l’amore superare e vincere entrambi?
Da brava rana, anch’io una volta ho provato a darmi una risposta,
tentando di salvare il mio scorpione e dal nostro incontro è uscito que-
sto romanzo. Un racconto di provincia e di riviera; di show business e
social network; di amore e ancor più di ossessione: accesa, persistente,
logorante. Ma soprattutto – come tutte le storie ispirate alla realtà – una
favola fatta di tanta musica, che vi consiglio vivamente di ascoltare,
mentre vi addentrate nel vivo della lettura, per riuscire ad immedesi-
marvi meglio nell’atmosfera: canzone dopo canzone, pagina per pagina.
Ebbene, lo ammetto: un tempo io sono stata Greta, come lo sono state
alcune persone prima e altre lo saranno dopo di me; come un giorno
potrebbe capitare di essere esattamente a tutti voi. Perché per ogni rana
che sappia galleggiare sul flusso degli eventi, state certi che là fuori esi-
sterà sempre uno scorpione, pronto ad impersonare il ruolo del vostro
Riccardo su misura. Un Riccardo esiste sempre per tutti. E non importa
che vi disturbiate a cercarlo: se ancora non lo avete incontrato, sarà lui
a trovare voi. Un giorno arriverà, si aggrapperà al vostro cuore nel ten-
tativo di sopravvivere e sarà un amore terribile... Terribile e straordina-
rio.
Credetemi.
GiorgiaPARTE PRIMA
In apnea
1.
Marzo
Quel giovedì Riccardo uscì di casa col sorriso sulle labbra per la
prima volta, dopo un inverno appesantito dalla neve e dalle sue
solite bugie. Al risveglio era stato sorpreso sotto il piumone da un
timido raggio di sole e così aveva deciso di aggrapparsi a
quell’assaggio di primavera, per dare un calcio alla tristezza.
D’altronde al mattino era sempre carico di grandi aspettative e di
vane promesse, che a fine giornata lasciava cadere in un angolo del
portafoglio assieme all’abbonamento della palestra, ai biglietti
obliterati dell’autobus e alla fototessera del suo capo. Ma poi chi
cazzo è che tiene la fototessera del proprio superiore in tasca? Solo
un matto, lui pensava. La verità era che finché non avesse impedito
al lavoro d’invadergli la vita a bordo campo, questo avrebbe
continuato a fargli fallo e a espellerlo dalla corsa verso le sue reali
necessità. Proprio come il faccione di Leo – il direttore radiofonico
di Carpi – che per colpa dell’attrito prodotto dal fotogramma sul
rivestimento del suo documento, continuava a rimanergli incollato
all’identità. Erano quattro mesi che lavorava ininterrottamente;
sedici lunghissime settimane che fra dirette, interviste, serate e
straordinari non aveva avuto né sabati né domeniche. Ormai era
talmente stanco che cominciava a rimpiangere i manuali di Bilancio
e di Marketing Internazionale dell’università. D’altra parte fare
musica era sempre stato il suo sogno e quella maledetta laurea
l’aveva presa soltanto per far tacere i suoi genitori, perché:
9Riccardo, al giorno d’oggi senza un titolo di studio
non vai da nessuna parte, l’hai capito o no?»
Mamma, ma io voglio fare lo speaker.
Riccardo, suonare è un hobby.
Ma papà, io voglio diventare un dj!
La musica non è un mestiere. Il direttore di banca e il manager lo sono
ma la musica, no!
No, non è un mestiere, papà. La musica non è un mestiere.
La musica è la mia vita»
E mano a mano che gli anni passavano, anche se il tempo libero
diminuiva e le difficoltà aumentavano, l’amore che Ricky nutriva per
essa continuava a restare invariato. Aveva cominciato tutto per
gioco, suonando alle feste di compleanno dei suoi amici e ai balli
della scuola, poi a diciotto anni si era fatto regalare la prima tastiera
e da allora aveva finito per trascorrerci sopra tutti i pomeriggi. Più
muoveva le dita su quei pulsanti, più sembrava che la sua vita
acquisisse senso soltanto mediante il loro profilo. A nulla erano valsi
gli ammonimenti dei suoi genitori, perché ormai Ricky sentiva di
aver trovato il suo posto nel mondo e che al mondo piacesse o no,
lui sarebbe diventato un dj a ogni costo. Così, terminate le superiori,
aveva aperto un canale radio sul web in cui inserire i suoi pezzi:
Simpathy for the Devil lo aveva chiamato come la sua canzone
preferita dei Rolling Stones; come il diavolo indiscusso
dell’elettronica, che un giorno sperava tanto di diventare. Finché una
sera, durante un party, Christian Riccucci – l’organizzatore di eventi
notturni più conosciuto di Modena – gli si era avvicinato, dicendo:
«Devil J, sai che suoni bene?»
«Grazie.»
10«Perché non passi in ufficio da me domani? La scorsa settimana
il mio resident dj mi ha lasciato a piedi e sto cercando qualcuno per
rimpiazzarlo. Vorrei farti fare una prova.» All’inizio si era trattato
solo di coprire qualche sostituzione poi però, entrato a far parte a
tutti gli effetti del Golden Staff, il suo successo era andato crescendo
in maniera esponenziale fino a trasformarsi in un idolo. A poco più
di vent’anni Riccardo figurava nella schiera dei dj emergenti italiani
favoriti e aveva aperto le esibizioni di numerosi artisti di calibro
internazionale. Ogni settimana si spostava tra Modena e Riccione,
da Milano a Torino; alcune volte aveva suonato persino a Firenze e
a Roma. Ovunque si recasse, il suo nome di demone riecheggiava
nelle orecchie dei malati di musica house come quello di un
fuoriclasse. Non a caso era stato proprio grazie alle sue garanzie, se
negli ultimi mesi era riuscito a guadagnarsi quel sudato tirocinio a
Virus Radio. Aveva dovuto superare tre colloqui e sbaragliare
numerosi concorrenti; ma alla fine, davanti alla rassegna
interminabile dei suoi concerti e delle sue collaborazioni, Leonardo
Prampolini non aveva potuto che assumere lui. Pazienza se i turni
erano doppi, le mansioni poco gratificanti o se il caffè delle
macchinette faceva schifo: Riccardo avrebbe dato via anche un rene
per lavorare in una delle frequenze radiofoniche più ascoltate del
Nord Italia. No, non è un mestiere, papà. La musica non è un
mestiere. La musica è la mia vita. Ma ora che lo era diventata per
davvero, quella lo stava lentamente assorbendo, risucchiando: come
una forza ingorda, che reclamasse per sé anche il più piccolo
frammento del suo tempo, ogni fibra del suo cuore. Da quando
aveva venduto l’anima alla notte infatti, Riccardo era diventato
irriconoscibile. Asservito ai meccanismi tendenziosi
dell’intrattenimento e della celebrità, quel ragazzino alto e smilzo,
che un tempo giocava a football e serviva la messa nella chiesa della
parrocchia, poco a poco si era trasformato in un venticinquenne
oscuro e imponente, che non conosceva scrupoli o inibizioni e che
11non si curava di niente o di nessuno a eccezione del proprio
tornaconto. Per Riccardo i colleghi di lavoro erano solo pedine, gli
amici poco più di una facciata e le donne nient’altro che un amabile
diversivo. Odiava la gente e di norma sfuggiva qualunque tipo di
interazione umana, a meno che non gli procurasse qualche
vantaggio. Mentre ogni weekend migliaia di fan si prostravano ai
piedi del suo trono stroboscopico, ansiosi di sottomettersi al flusso
ipnotizzante della sua musica, lui invece suonava solo per se stesso,
per dare ordine al caos che aveva dentro. Non gli importava che gli
altri si divertissero, voleva solo che lo adorassero; che quando le luci
della sala si abbassavano assieme ai toni delle note e il vocalist
annunciava a gran voce il suo nome in consolle, loro rispondessero
al suo richiamo, pronti a far fuoco sulla notte. Terminata la sua
performance, di solito si ritirava in un angolo del locale a godersi in
pace il suo vodka tonic e se qualcuno lo disturbava erano guai; per
non dire botte. Che lo scambiassero pure per un tiranno feroce –
pensava – tanto non si sarebbero mai azzardati a levargli di mano il
suo tridente: anche se aveva un caratteraccio, nessuno sapeva
incendiare la pista come faceva lui. Il suo ritmo era prorompente,
avviluppante, impareggiabile; degno di un vero diavolo.
D’altronde, con addosso una giacca di Grifoni, due Prada ai piedi
e un pizzico di house nelle orecchie, là dentro tutti quanti si senti-
vano divinità all’inferno. Ogni venerdì sera orde di peccatori in ghin-
gheri si affollavano all’entrata delle discoteche, pronti a barattare
l’anima con una decina di bottiglie di Möet e Chandon e a esibire,
dall’alto del tavolo imperiale, la corona impressa sul quadrante
dell’orologio. Pazienza se dopo poche ore le luci si alzavano e la
musica sfumava assieme alla quarta coppa C della mora seduta al
bancone. Se gli amici che facevano casino con te, li ritrovavi la set-
timana dopo più ubriachi e ipocriti di quella prima o se alle sgual-
drine che ti sbattevi in hotel – finita la sveltina – non ti disturbavi
nemmeno a lasciare il numero di telefono su un biglietto: tanto mica
12ci restavano a letto con te, ma se ne sgattaiolavano via come ladre,
subito dopo essere venute. Questa era la bella vita, sì. Bella e spie-
tata. Come la fama. Come una femmina. Come la notte. Un’esi-
stenza fatta di vacuità precarie, ma travolgenti; di ore piccole e im-
mensi sperperi. Una vita che – Ricky ne era certo – a lungo andare
avrebbe ucciso chiunque. Compreso lui. La sua faccia ne era la prova
evidente: con quegli occhi illividiti dalla stanchezza e la fronte piena
di rughe, dimostrava già più di trent’anni. Ma alla fine mica poteva
spacciarsi per uno di quegli impiegatucci rispettabili – tutti famiglia,
calcio e stipendio fisso – che ogni giorno prima di andare a dormire
si sciacquavano la bocca con sorsi di moralismo provinciale e etica
buonista. Lui spesso il letto non lo toccava proprio, ma si faceva una
riga e ricominciava la giornata daccapo; il sabato pomeriggio si sve-
gliava col palato ancora impastato di fumo dalla sera prima e ai suoi
occhi l’arco di una schiena china e due chiappe sode erano sempre
valsi molto più del pranzo coi parenti, due pargoli, il cane e la piscina
in giardino. Che poi a dirla tutta, gli animali non gli piacevano nean-
che, con tutti quei peli sui vestiti e il loro fastidioso abbaiare, i bam-
bini lo innervosivano e non aveva mai imparato a nuotare. In-
somma, un vero disastro, direte voi. E in effetti lo era. Ma ai suoi
occhi, invece, tutta quella trasgressione aveva un che di eccitante.
Fiero della sua diversità, quel ragazzo si ostinava a portare avanti la
sua condotta dissennata come un raro vanto, senza imporsi limiti né
remore, crogiolandosi nell’autocompiacimento e nella libidinosità
dei suoi eccessi. Soltanto certe notti – rientrato dalla discoteca, in
preda ai postumi della sbornia – capitava che un senso d’insoddisfa-
zione inspiegabile gli afferrasse il cuore, impedendogli di chiudere
occhio fino a mezzogiorno. Allora subito si alzava e andava in bagno
per sciacquarsi il viso, ma non appena si fermava a fissare la sua
immagine riflessa sopra il lavandino, ecco che improvvisamente
quell’inquietudine si faceva più opprimente e soggiogato dai dubbi,
13gli veniva istintivo graffiare la superficie dello specchio per non do- verne più sopportare la vista. E se avesse sempre e solo mentito a se stesso? Se quelle che tuttora si raccontava, non fossero state altro che bugie? Alla fine quanti ne aveva visti di libertini come lui che giunti alla soglia dei quarant’anni, avevano abbandonato lo champa- gne e la BMW per comprarsi una monovolume e bere Pignoletto negli agriturismi con la moglie? E se fra quindici anni anche lui avesse avuto bisogno di tutti quegli schemi, per sopravvivere? Di un contratto a tempo indeterminato? Di un matrimonio? Di un’eti- chetta? Ed ecco che d’improvviso un brivido gli correva giù, lungo tutta la spina dorsale. Impossibile, pensava, scuotendo la testa con un sospiro. Per quanto fosse sgangherata e poco corretta – a diffe- renza di tanti altri – lui quella vita l’aveva scelta con cognizione, sop- pesandone accuratamente vantaggi e limiti, accettandone persino i compromessi più scomodi. Ma se disobbedire ai canoni imposti dalla società era tutto ciò che aveva sempre desiderato fare, allora come mai non era felice? Perché si sentiva come se gli mancasse qualcosa? E più ci pensava, più graffiava forte. Poi però – proprio nel momento in cui le perplessità diventavano più fitte e i contorni del suo aspetto iniziavano a deformarsi, per colpa della pressione esercitata sul vetro Leo lo chiamava per assegnarli altro carico di lavoro o Christian lo reclutava per una nuova serata e allora ecco che le titubanze si dileguavano in un lampo, assieme ai segni dei polpastrelli impressi sullo specchio e alle sue insicurezze. Al diavolo i sensi di colpa e i dilemmi esistenziali, si diceva: tutto ciò che desi- derava non si sarebbe mai esteso oltre il volume di un amplificatore e di un microfono; del bordo di una minigonna o di quello del letto di un hotel. Così riprendeva a suonare, a tirare, a lottare; ad arrivare a mattina come meglio poteva, con chi più forte godeva. Reo di ogni peccato, ma libero da qualsiasi vincolo. Solo e in fiamme. 14
«Per te il solito, Ricky?» domandò la barista, appena quello ebbe
varcato la soglia del Caffè Piccolo per fare colazione.
«Sì, grazie Sabri» replicò con un sorriso prima di prendere posto
su uno degli sgabelli disposti di fronte al bancone.
«Come mai qui? Non è mica domenica.»
«Mi sono preso un giorno libero. Non ne posso più di lavorare»
accennò vago Riccardo, quindi si leccò le labbra e aggiunse: «Come
sono andati gli esami del sangue? Tutto bene con quell’allergia?»
Davanti a quella domanda inaspettata, la ragazza abbandonò i
piattini sporchi nell’acquaio e incrociò di nuovo il suo sguardo.
«Tutto negativo per fortuna, grazie. Non pensavo te ne
ricordassi» Confessò con un sorriso.
«Io di te mi ricordo tutto, lo sai» Ammiccò lui, arricciandosi un
baffo con le dita.
«Se me lo avessi detto prima, mi sarei presa un giorno di ferie
anch’io e saremmo potuti andare al mare a mangiare il pesce»
puntualizzò lei, mentre gli serviva la sua tazza, colma fino all’orlo di
schiuma bollente.
«Prenditelo adesso e ti porto dove vuoi» rilanciò Ricky con tono
languido, poco prima che il titolare, appostato dal lato opposto del
bancone, fulminasse entrambi con lo sguardo, costringendo Sabrina
a girarsi di nuovo verso la macchinetta del caffè con uno sbuffo. Eh
sì, se la sarebbe proprio fatta volentieri - pensò - mentre rimirava
per l’ennesima volta il suo culetto da favola, estasiato. Ormai erano
settimane che si scambiavano provocazioni e sguardi di fuoco. Non
ne poteva più di flirtare e basta: avrebbe voluto scavalcare il bancone
e prenderla lì, su quello stesso ripiano, in mezzo agli aloni delle
tazzine sporche e alle bustine di zucchero, davanti allo sguardo
esterrefatto del suo capo. E a quel pensiero avvertì il basso ventre
irrigidirsi all’istante. Così, invasato dall’eccitazione, afferrò la penna
dalla cassa, scarabocchiò qualcosa su un post-it che teneva nella
tracolla, lo piegò in quattro e glielo allungò assieme a una banconota
15da cinque euro. Sabrina ripose i soldi nel cassetto, gli allungò il resto
e aprì il foglio con un sorriso complice.
Ti aspetto sul retro. Ora.
«Allora, al prossimo giorno di ferie» dichiarò Ricky a voce alta,
assicurandosi che anche il proprietario sentisse. Quindi le lanciò una
lunga occhiata d’intesa, poi uscì in tutta fretta dalla porta e si diresse
verso il retro dell’edificio. Non appena la ragazza ebbe messo piede
fuori, le saltò addosso, famelico. Non gli importava un tubo che
qualcuno li vedesse o che lei rischiasse il licenziamento: ormai in
testa aveva solo le sue chiappe nude. «Ti ho voluto dal primo istante
in cui ti ho visto» sussurrò Sabrina, avvicinandosi al suo viso per
dargli un bacio, ma prima che riuscisse a sfioragli le labbra, lui la
obbligò a girarsi di spalle e a piegare la schiena.
«Taci» ordinò, mentre con una mano le abbassava la divisa e con
l’altra le afferrava il sedere, pronto a inforcarla.
Uno, due, tre colpi.
«Ci tieni molto a queste mutandine?» domandò, voglioso.
«No».
Straaap. E in un istante i resti degli slip caddero a terra.
Quattro, cinque, sei.
Andò avanti così per una decina di minuti poi, quando avvertì
l’orgasmo salirgli al cervello, uscì dal suo corpo e le riversò il suo
piacere sulla schiena con un gemito. Infine, dopo aver riacquisito
fiato, si riallacciò i pantaloni e prese a frugarsi in tasca in cerca di
una sigaretta.
«Per caso hai un accendino?» domandò come se nulla fosse
successo, ma invece di rispondere, la ragazza lo guardò perplessa.
Nella sua vita aveva fatto sesso sul retro del locale diverse volte, ma
mai nessuno aveva impiegato così poco tempo per passare le mani
16dal profilo del suo sedere a quello di una Marlboro, pensò. Quindi
senza aggiungere altro, estrasse il suo Bic dal grembiule e glielo
porse. «Grazie» accennò Ricky, sputando fuori una grossa boccata
di fumo e puntò gli occhi al cielo in attesa del miracolo imminente.
Driiin. Driiin. Driiin. E difatti eccolo: puntuale come sempre.
«Ciao Ricuc!» esclamò al telefono con voce squillante. «No, non
mi disturbi. Adesso? No, non è un problema. Arrivo» e con la stessa
velocità con cui aveva risposto, riattaccò.
«Scusa piccola, ma ho un’emergenza. Devo andare» annunciò,
fingendo rammarico.
«Ma oggi non è il tuo giorno libero?» obiettò e quello tentennò.
«In teoria, sì, ma purtroppo hanno spostato la data dei Two
Fingerz a giovedì prossimo e sembra che io debba suonare al posto
loro, perciò non posso trattenermi. Ti chiamo io, ok?» tagliò corto,
accarezzandole la testa come fosse un cane.
«Ma se non hai nemmeno il mio numero» puntualizzò lei stizzita,
fiutando l’odore della sua menzogna.
«Allora ti scrivo su Facebook» concluse con un sorriso, prima di
gettare il mozzicone a terra assieme alle sue speranze. Anche se
aveva il culo più bello del mondo, quella biondina tutta curve a letto
era peggio di un pezzo di legno. Ma poi si chiamava Sabrina o
Sabina? Boh. Per fortuna esisteva l’app delle Fake Call, in grado di
salvarti da qualsiasi scopata di merda, concluse prima di darle le
spalle e svoltare sotto il portico che conduceva alla tabaccheria.
Riccardo era uscito di casa col sorriso sulle labbra, quel giovedì
mattina. Si era preso un giorno libero, convinto che staccare la spina
dall’ufficio potesse aiutarlo a buttare giù qualche spunto per il
programma che Leo gli aveva chiesto di ideare e invece aveva finito
per farsi una sveltina con una sconosciuta, ancor prima di aver finito
il cappuccino. Ora che l’ardore del sesso aveva preso possesso del
suo corpo, l’idea di trascorrere il resto del tempo davanti a un foglio
17bianco non lo entusiasmava poi così tanto, rifletté, mentre infilava
gli spiccioli all’interno del distributore automatico e selezionava il
tasto di erogazione. Avrebbe potuto chiamare Alice per darsi
appuntamento in pausa pranzo oppure scrivere a Martina, aspettarla
all’uscita di scuola e trascorrere con lei il resto del pomeriggio. Ma
ecco che, proprio quando fu sul punto di lasciar perdere il lavoro e
attaccarsi al telefono a caccia di un altro paio di incontri bollenti,
una tessera – sepolta tra i biglietti da visita del suo portafoglio –
cadde a terra, attirando la sua attenzione. Incuriosito, Ricky la
raccolse e iniziò a rigirarla fra le mani, per metterne a fuoco
l’intestazione.
Sistema bibliotecario intercomunale di Verdicella.
Quella sì, che era una sorpresa, pensò. Non metteva piede in quel
posto da talmente tanti anni che quasi si era dimenticato di posse-
derne l’iscrizione. E dire che quando andava al liceo trascorreva là
dentro tutti i pomeriggi. Mica per fare i compiti, intendiamoci, ma
solo per abb
ordare le studentesse al bar durante la merenda. Chissà, forse
adesso che invece di studiare matematica redigeva palinsesti radio-
fonici, sarebbe stato più facile rimanere seduto dietro la scrivania
per più di dieci minuti consecutivi. E in un attimo si convinse che
valeva la pena tentare. Così verso mezzogiorno si diresse a Verdi-
cella, deciso a rindossare i suoi panni di studente tra le file di quei
banchi. Non sapeva perché, ma avvertiva nell’aria una strana trepi-
dazione, come se tra gli scaffali di quella biblioteca si nascondesse
qualcosa di molto invitante.
182.
Pertanto mi appresto ora a fare una rapida sintesi della Teogonia, a cui farò
seguire ulteriori riflessioni. All’inizio del poema...
No.
Pertanto mi accingo ora a elaborare una rapida sintesi della Teogonia, a cui
seguiranno le opportune riflessioni. All’inizio del poema Esiodo afferma di aver
ricevuto dalle Muse il racconto dei fatti, che si appresta a narrare, invocando la
loro ispirazione, per aiutarlo a riportarli
No.
Pertanto mi accingo ora a elaborare una rapida sintesi della Teogonia, a cui
seguiranno le opportune riflessioni. All’inizio del poema Esiodo afferma di aver
ricevuto dalle Muse il racconto dei fatti, che si appresta a narrare e invoca la loro
ispirazione, per aiutarlo a riportarli: “Salve, figlie di Zeus, datemi l’amabile
canto; /celebrate la sacra stirpe degli immortali, sempre viventi…”
Digitò Greta sulla tastiera con uno sbuffo, dopo mezz’ora che
cancellava e riscriveva lo stesso capoverso. Quindi, stanca di rima-
nere impalata davanti al pc, chiuse il documento di Word e si avviò
in cucina in cerca di uno spuntino. Si sentiva la testa pesante e il sole
primaverile, che filtrava attraverso la fessura degli scuri, le faceva
venire una gran voglia di uscire e lasciare la tesi incompleta. Ormai
erano mesi che stava chiusa in casa a rileggere quel testo giorno e
notte: lasciava camera sua solo per andare in bagno, fumare una si-
garetta al davanzale o bere un caffè. Insomma, peggio che in pri-
gione. Per fortuna mancavano soltanto due settimane alla discus-
19sione e presto sarebbe stata libera di viversi l’estate di meritato ri- poso che tanto sognava. Non vedeva l’ora di andare in vacanza, leg- gersi un libro e soprattutto di scrivere qualcosa, qualsiasi cosa. Un racconto, una poesia, magari un diario di bordo. Era troppo tempo che non lasciava le sue dita libere di muoversi su un foglio bianco, se non per riassumere saggi. Troppi mesi che non partiva alla volta di un posto nuovo, per raccontare tutte le meraviglie che ne face- vano parte. Aveva cominciato a viaggiare con i suoi genitori fin da piccola e da allora non si era più fermata: Inghilterra, Spagna, Gre- cia, Turchia, Marocco, Kenya. E poi ancora Russia, California, Flo- rida, Arizona, New York, Messico, Brasile, Australia, Thailandia: a ventidue anni Greta aveva già visto mezzo mondo. Certe volte par- tiva da sola, altre con le amiche; in alcuni casi lo faceva per imparare le lingue; altre per il piacere di viaggiare e basta. Ma a prescindere dalle motivazioni che la spingessero ad andarsene o dai compagni di avventura che scegliesse di mettersi a fianco, sembrava che quella ragazza si sentisse a casa soltanto coi piedi poggiati su un aereo. Im- mersa nell’altrove. Solo così – libera da qualunque vincolo di appar- tenenza geografica e sociale – Greta era davvero felice, ispirata. Quando percorreva strade mai battute, parlava con gente che non conosceva e ammirava scorci in cui non aveva ancora avuto occa- sione di imbattersi infatti, il brivido della scoperta era capace di su- scitarle dentro emozioni indescrivibili. Riflessioni in grado di fer- mare l’essenza del mondo in impressioni estatiche e profonde, lon- tane dalle ingerenze del tempo e della quotidianità. Ecco perché, pur non avendo ancora prenotato alcuna vacanza, aveva già comprato un taccuino nuovo. Sentiva che la sua vena poetica stava per ritor- nare e nel momento esatto in cui ciò fosse accaduto – in mezzo alle dune di un deserto come fra le strade di una metropoli trafficata – solo una cosa sarebbe stata importante: avere a portata di mano carta e penna. 20
«Allora per oggi hai finito con Dèi e Muse?» domandò Amerigo,
comparso all’improvviso sulla soglia della cucina, proprio mentre
sua figlia allungava le mani dentro al freezer.
«Diavolo, papà! Mi hai spaventata» esclamò quella con un
sobbalzo, quindi scartò l’involucro del cono gelato e sedette a tavola,
pronta a gustarselo. «Dopo aver passato in rassegna dieci
invocazioni diverse, sto per iniziare a parlare in greco antico anch’io»
aggiunse infine ironica e lui sorrise.
«Porta pazienza, ormai hai finito. A proposito hai deciso dove
andrai in vacanza?» chiese ancora, posandole una mano sulla spalla.
«In realtà no, Viv non ha ancora dato l’ultimo esame. Appena finisce
decidiamo, tanto per me non fa differenza. Qualsiasi città
visiteremo, sono certa che avrà qualcosa da raccontarmi» concluse
con un sorriso sporco di panna e cioccolato, e allora al padre venne
istintivo pizzicarle una guancia. Quando lo guardava con quegli
occhioni dolci, gli sembrava ancora la sua bambina. Una bambina
grande in ogni senso. Anche se soffriva di vertigini nfatti, fin da
piccola sua figlia aveva dimostrato di possedere ali maestose, in
grado di elevarla al di sopra dei suoi coetanei e di trasformarla in una
creatura speciale. Mentre gli altri si limitavano a riprodurre i gesti e
le indicazioni che venivano loro insegnati, lei invece ne smontava le
consequenzialità pezzo per pezzo. Non le interessava perdere
tempo sulle verità assodate, ma voleva conoscere quelle di cui
ancora non le era data spiegazione; studiare i fenomeni da ogni
angolazione per comprenderne anche i meccanismi più complessi.
Così durante l’intervallo divorava libri al posto delle merendine, poi
il pomeriggio, finiti i compiti, scriveva poesie su un quaderno di
carta sgualcita e la sera si rifiutava di andare a letto senza aver
rivoltato tutte e ventuno le caselline del suo abecedario.
A di arancia, B di banana e C di cane...
21Aveva cominciato a ripetere quelle lettere quando ancora non sa- peva leggere, eppure era come se già avvertisse, nascosta tra i suoni di quei fonemi, una logica arcana e irresistibile. Era l’amore per il significato, l’attrazione verso il senso ultimo degli eventi, che da lì in avanti non l’avrebbe mai più abbandonata, trasformandola in una curiosa cronica, una malata di conoscenza. Di umanità. Si innamo- rava degli sconosciuti due o tre volte al giorno: in treno, per strada, al supermercato. Non importava dove si trovasse, bastava che in- crociasse lo sguardo di qualcuno che all’improvviso moriva dalla vo- glia di scoprire dove fosse diretto quel tizio con in mano la venti- quattrore; quale canzone stesse ascoltando la ragazza sdraiata sulla panchina del parco o se quei due fidanzati, sorpresi a litigare in mezzo alla strada, si fossero lasciati sul serio o alla fine avessero fatto pace. Si divertiva a indovinare la quotidianità della gente dagli abiti che indossavano, dal colloquio imminente o dall’appuntamento dal dottore di cui stavano parlando al telefono. E se per caso saliva in macchina diretta da qualche parte, finiva sempre per sbagliare strada, intenta com’era ad ammirare le facciate delle case e a imma- ginare le vite di chi le abitava. Non lo faceva apposta ma il suo era un desiderio incontrollabile. Greta voleva conoscere le storie delle persone, le loro passioni, i loro turbamenti, per capire se assomi- gliassero ai suoi; per assaporare mediante le loro parole, i loro gesti e i loro sguardi, le emozioni che ancora non aveva avuto la possibi- lità di vivere in prima persona. Di giorno in giorno quella ragazza rubava brandelli di verità ai passanti, li mischiava ai suoi e rientrata a casa, li trascriveva sul suo diario. Era andata avanti a fermare le sue impressioni sulla carta per anni, finché a un certo punto, presa confidenza con le nuove tecno- logie, non aveva deciso di aprire Normofobia. L’idea iniziale era quella di creare un blog che fornisse al pubblico una visione alternativa della quotidianità, attraverso la discussione di temi di attualità, diari 22
di viaggio, recensioni di film, di libri e di musica. Ma nel tempo la
storia della condivisione virtuale era diventata solo un pretesto. Più
che scrivere per farsi leggere dagli altri infatti, Gre lo faceva per ar-
ricchire se stessa, per riavvolgere di tanto in tanto il nastro della sua
esistenza e non dimenticarsi di tutte le bellezze, le emozioni e i luo-
ghi per cui al mondo sarebbe valsa la pena di andare avanti, anche
quando le avversità avessero rischiato di farla rimanere indietro. Do-
potutto riuscire a vivere e a pensare fuori dagli schemi non era poi
così facile per una nata e cresciuta in provincia. La gente dalle sue
parti era gretta, arresa, limitata. E anche se la sua educazione cosmo-
polita era riuscita a salvarla dall’handicap di una mentalità ristretta e
benpensante, lei stessa aveva impiegato quasi vent’anni prima di tro-
vare il coraggio di vincere i luoghi comuni e lottare per i propri de-
sideri. La ricerca di sé era iniziata una mattina di luglio quando, su-
perata la maturità, di punto in bianco aveva fatto le valigie ed era
saltata su un volo diretto a San Francisco per dormire sul divano di
Juanita, una travolgente insegnante di danza caraibica. Erano stati
tre mesi fantastici quelli del Couchsurfing in California; una paren-
tesi di vita spensierata all’insegna del mare, delle empanadas e del
merengue, che si sarebbe portata dentro per tutta la vita. Rientrata
dalla West Coast infatti, Greta aveva finalmente capito che essere
nata in una piccola cittadina per lei non sarebbe più stato un pro-
blema, perché l’immensità di quelle metropoli – il loro fermento –
ormai se li portava dentro. Ormai era diventata lei stessa una città:
anche quando stava ferma, la sua anima era sempre in movimento.
Così, spinta dalla sua insaziabile sete di scoperta, l’anno successivo
si era trasferita a Bologna per frequentare la facoltà di Lettere. Per
sei mesi aveva vissuto in un appartamento in via Oberdan insieme a
Clara e Betta, le sue due coinquiline. Di giorno si barcamenava tra
lezioni, seminari, mostre e cortei, poi la sera si ritrovava coi suoi
compagni di corso per bere un bicchiere di rosso a buon mercato in
una delle tante osterie del Pratello o di via Mascarella. La domenica
23andava a caccia di abbigliamento vintage ai mercatini delle pulci e ormai non mangiava più niente che non fosse biologico o a km zero. Le piaceva come si viveva in quel posto, ma ancor di più apprezzava la consapevolezza di far parte di quello stile di vita. Fecondata dallo spirito libero e anticonvenzionale del capoluogo, Greta era sbocciata come un fiore nel giardino dei suoi intendimenti. Era come se fino a quel momento tutti i suoi buoni propositi fossero stati là davanti a lei, ma soltanto adesso – immersa in quel clima denso di stimoli – lei fosse riuscita ad afferrarli e a metterli in pratica. Aveva cambiato il suo modo di pensare, di parlare; persino quello di muoversi e di vestirsi. Non si era mai sentita tanto simile a se stessa in vita sua. Eppure più i giorni passavano, più sembrava che le mancasse qual- cosa. Le materie che studiava la appassionavano quanto le conver- sazioni impegnate che intratteneva coi suoi nuovi amici, ma alla lunga la routine iniziava a starle stretta, proprio come al liceo. Aveva bisogno di partire un’altra volta, di darsi nuova forma. Così, senza pensarci troppo, a metà del primo anno accademico si era iscritta al bando di mobilitazione studentesca. Era stata a Brighton, poi a Bil- bao, finché all’inizio del terzo, non si era imposta di rientrare in Italia per ultimare gli studi. Era convinta di poter tornare a vivere nel suo vecchio appartamento, a bere nelle sue amate osterie e invece al suo ritorno le cose erano completamente cambiate: molti dei suoi ex compagni si erano già laureati e si erano iscritti ai corsi magistrali in un’altra città. La casa, in cui aveva alloggiato un tempo, era stata ceduta ad altri studenti. Clara aveva trovato lavoro a Milano, Betta era tornata a Palermo dai suoi genitori e a quel punto a lei erano rimaste ben poche scuse per fuggire da casa. A sei mesi dalla laurea le lezioni da seguire e gli esami da dare erano terminati e a eccezione di quelle poche volte in cui doveva recarsi in dipartimento per foto- copiare le pagine di una rivista specialistica o per andare a colloquio con il professore, Gre trascorreva la maggior parte del tempo a Ver- dicella, chiusa in camera sua. Ancora non sapeva dire se finiti gli 24
studi sarebbe partita per tornare o per andarsene via per sempre; se
spendere la sua giovinezza in giro per il mondo, adoperandosi per
smantellare le sicurezze confortanti di una vita qualunque, fosse più
giusto che rimanere nel paese dove era nata, per provare a costruirne
una sua. Voleva solo andare avanti e vedere dove l’avrebbe portata
la vita, anche a costo di sbagliare, di farsi male. Svegliarsi la mattina
e accorgersi che c’era ancora qualcosa che non aveva sperimentato,
imparato; qualche emozione che potesse ancora raggrinzirle la pelle;
farle sobbalzare il cuore. Sì, per quanto vani o limitanti si fossero
rivelati, Greta voleva portarseli tutti quanti in faccia i suoi tentativi:
le andate, i ritorni, le conquiste, i fallimenti, i principi consolidati e
le idee mandate in rovina. Sperava che le lezioni imparate nel corso
della sua esistenza un giorno le impreziosissero il volto come un
segno di riconoscimento. Come le impronte di un vissuto intenso e
fecondo che, con l’avanzare dell’età, l’avrebbero trasformata in una
di quelle vecchiette sagge e profonde, piene di storie e di rughe. Ma
qualunque sarebbe stato il suo destino per il momento la sua pelle
era ancora liscia e luminosa, i fianchi stretti e gli occhi grandi e az-
zurri come il cielo. Era giovane, bella, voleva il mondo in mano e
tutto quello che doveva fare era andare là fuori a prenderselo. Tappa
dopo tappa. Amore dopo amore. Pagina per pagina.
Driiin. Driiin. Driiin.
Quando il telefono iniziò a squillare, la ragazza si era accoccolata
sul divano in compagnia di Colazione da Tiffany, ormai da un’ora
passata.
«Finalmente! Cominciavo a pensare che fossi stata risucchiata da
un tunnel spazio temporale» attaccò sarcastica, non appena ebbe
letto il nome di Vivienne sullo schermo. Quindi afferrò il
telecomando, per abbassare il volume del televisore e aggiunse:
25«Allora questo maledetto esame te lo anticipa o no? Io non ne posso
più, sto per vomitare saggi.»
«Lascia stare! Un’ora di attesa per sentirmi dire dall’assistente che
il prof è a casa con la febbre a trentanove e che oggi non poteva
ricevere. Ti lascio immaginare cosa le ho risposto» ribatté.
«Meglio di no» ridacchiò lei, divertita. Per quanto le volesse un
bene dell’anima, la sua migliore amica non aveva di certo un bel
carattere.
«Che ne dici di un caffè in biblioteca più tardi? Così ti racconto
tutto» chiese, ma Greta esitò. Da quando era rientrata dall’Erasmus,
non aveva messo piede in quel posto neanche una volta. Nonostante
il sindaco l’avesse fatta costruire con l’intento di creare un’oasi
tranquilla in cui i giovani potessero fare i compiti, navigare in
internet e bersi un’aranciata rifrescante durante le interminabili
sessioni di studio estive, dentro quell’edificio futurista non c’era mai
stato nulla che a Greta facesse venire voglia di studiare. La biblioteca
di Verdicella non era altro che uno spazio affollato e fuorviante, in
cui ogni giorno dopo pranzo orde di studenti svogliati sfollavano
come profughi, in cerca di qualunque distrazione impedisse loro di
aprire libro. C’era chi chiacchierava, chi ascoltava la musica, chi
scriveva messaggi con il cellulare. La maggior parte però,
abbandonati manuali e zaini alla propria postazione, usciva nel
cortile interno allo stabile e si svaccava sulle poltrone di plastica
gialle e rosse a fumare per metà del pomeriggio. Poi verso le cinque
si piazzavano tutti quanti al bar a fare pollaio. Tra una pizzetta e un
frullato di frutta i verdicellesi si perdevano a commentare il look
sfoggiato dalla morosa del proprio ex o le coppie scoppiate sorprese
a pomiciare dietro l’angolo delle scale antincendio. Per non parlare
di quando entravi nella sala principale, cercando di prendere posto
alle scrivanie: sembrava di partecipare a una sfilata di moda.
Chiunque stesse seduto con la testa china sul proprio quaderno, al
primo rumore di passi sul pavimento, sollevava lo sguardo per
26offrirti la sua migliore espressione di curiosità, disappunto, invidia,
ammirazione. Qualcuno alzava un sopracciglio; qualcun altro
bisbigliava qualcosa all’orecchio del suo vicino, senza smettere di
levarti gli occhi di dosso. Nessuno aveva il coraggio di guardarti
dritto negli occhi o di rivolgerti la parola, ma tutti sapevano dove
abitavi, chi erano i tuoi genitori, di quanti vestiti disponevi
nell’armadio e con quali ragazzi eri uscita. O almeno così credevano;
in fondo non importava che quella fosse la verità o no. Volevano
solo spettegolare, riportare, qualche volta inventare; avrebbero fatto
o detto qualsiasi cosa, pur di smettere di annoiarsi e sopravvivere
alla sterminata rassegna delle giornate piatte e insignificanti che
caratterizzavano la loro vita. Chiunque sarebbe voluto fuggire da
quell’inferno, pensava Greta, ma i suoi coetanei invece in
quell’atmosfera ci sguazzavano come nella piscina della Polisportiva
d’estate: cinquanta metri di provinciali purosangue più il bagnino,
forse il peggiore di tutti. Quanto avrebbe voluto che affogassero in
mezzo al loro perbenismo. Purtroppo però al momento rimanevano
ancora tutti quanti a galla.
«Non possiamo berlo in centro?» chiese dunque, confidando nel
buon senso di Viv.
«Tesoro, è giovedì pomeriggio. È tutto chiuso» puntualizzò l’altra
e allora lei fu costretta a rassegnarsi con uno sbuffo.
«Vabbè, vada per la biblioteca» borbottò, senza alcun
entusiasmo.
«Ok, passo verso le sei. A dopo» Greta riattaccò. Un caffè, uno
solo e poi se ne sarebbe tornata dritta a casa a finire la tesi, si disse.
Quindi gettò il cellulare sul tavolino del salotto e riportò lo sguardo
sul viso datato di George Peppard che, come ogni volta, confessava
il suo amore ad Audrey Hepburn a bordo del taxi, nel tentativo di
non farla partire per il Brasile. Rimase alcuni minuti immobile, a
gustarsi quel bacio che aveva fatto la storia del cinema, infine –
quando le note di Moon River iniziarono a inondare la sala assieme
27ai titoli di coda, spostò lo sguardo dallo schermo e sorrise. Quante volte lo aveva visto? Cento, duecento? Forse cinquecento volte. Da quando suo padre glielo aveva regalato alle elementari, quel film per lei era diventato come un ninnolo. Lo guardava prima di andare a letto; quando si svegliava malata, triste, arrabbiata. Non lo prestava mai a nessuno e se lo portava dietro dappertutto: all’università, a casa di Viv, in vacanza. Conosceva a memoria la trama, i dialoghi, persino le pause. Quella storia era come una parte di sé, come se fosse sempre stata certa che prima o poi anche lei avrebbe incontrato un Paul vecchio stile, capace di amarla esattamente per quella che era. Ma per quanto in fondo al cuore il sogno di vivere una grande passione l’emozionasse, in ventidue anni di incontri e di viaggi, proprio come Holly, anche Greta aveva sempre finito per rimanere fedele soltanto a se stessa. Certo, dai primi anni dell’adolescenza fino agli ultimi di università, tanto in Italia quanto all’estero, c’era sempre stato qualcuno che aveva provato a farle cambiare idea; ma fra le innumerevoli esperienze in cui non vedeva l’ora di tuffarsi, l’amore rimaneva ancora la più remota di tutte. Che fosse per colpa della sua istintiva diffidenza o dell’immagine di coppia perfetta e ineguagliabile che i suoi genitori avevano sempre incarnato ai suoi occhi; della società con cui era costretta a rapportarsi, senza riconoscervisi o di quello stronzetto di Gianmaria Grandi che in terza media aveva baciato la Silvia Guidi al posto suo, fatto sta che ai panni di Cenerentola, Greta aveva finito col preferire quelli di Xena, principessa guerriera. Forte del suo temperamento battagliero, fin da piccola aveva riposto le gonne a palloncino e le scarpette di cristallo negli scatoloni in solaio, per indossare tonnellate di jeans strappati e Dr. Martens e dare a bere a se stessa e agli altri che non avrebbe mai e poi mai avuto bisogno di un uomo per essere felice. In tutti quegli anni non aveva mai cercato un ragazzo, neanche per chiedergli i compiti. Aspettava che fossero loro i primi a invitarla a uscire; loro, i primi a non ricevere più una 28
risposta da un momento all’altro dopo mesi di telefonate e messaggi.
E anche le poche volte in cui si era presentata a un appuntamento,
non aveva mai portato avanti una frequentazione al di là della terza
uscita; oltre la soglia di quel paio di baci striminziti, che gli rifilava
con la stessa enfasi, di quelli somministrati alla zia il giorno di Natale.
Un po’ troppo altezzosa? Forse. Ma che fosse lecito o no
ammetterlo, lei si sentiva ancora troppo giovane per accontentarsi;
troppo intelligente per non bastarsi. Senza contare che, se avesse
dovuto trovare la sua anima gemella, frequentando la palestra o il
pub del paese, avrebbe preferito morire zitella. Quei ragazzotti di
quartiere erano tutti così uguali, così noiosi, così banali. Nient’altro
che un ammasso informe di fighetti purchessia con la camicia stirata,
che se ne andavano in giro a rifilare le stesse frasi di circostanza a
tutte, senza nemmeno avere il riguardo di nascondere la loro
superficialità sotto il Moncler. Ma quale storia da fiaba? Aspettare
che uno di loro passasse a prenderti a bordo della sua berlina bianca,
per vivere felice e contenta assieme a lui nel regno delle cento birre
e delle infinite domeniche passate allo stadio, era un incubo, Gre
pensava. E allora via che si rifugiava di nuovo in mezzo ai suoi libri,
ai suoi film, ai volti degli sconosciuti e ai siti di offerte last minute.
Pronta ad andare, a scappare, augurandosi di naufragare e non
tornare mai più. Perché per lei Verdicella era sempre stata una patria
scomoda, una casa inospitale, una macchia verde tutta castelli e
ipocrisie che amava e odiava allo stesso tempo, come si ama e si odia
una madre rinnegata. C’era nata, sì, ma non riusciva a viverci, a
restarci. Non aveva un motivo per farlo, perché tra tutti quei
personaggi da romanzo e le facce da provincia, i nuovi locali che
aprivano e le vecchie conoscenze che subito li infestavano, lei non
aveva ancora trovato qualcuno per cui valesse la pena di rimanere,
di resistere. Una persona che sapesse andare oltre all’apparenza e ai
luoghi comuni; che sognasse un futuro lontano dalla solida certezza
offerta da un posto in banca e da un matrimonio sereno. Un uomo
29che preferisse vivere di avventura e di passione piuttosto che di
convenzionalità. Possibilmente senza essere un mostro. Un po’
troppo pretenziosa? Forse. Però non era colpa sua se i ragazzi belli
erano stupidi e vanitosi. I tipi intelligenti, spesso bruttini e insicuri,
e quelli perfetti, sempre impegnati. Tanto che fosse lei a pretendere
cento o gli altri a valere zero, non cambiava molto. E mese dopo
mese la delusione di veder frustrate le sue aspettative finiva per
lasciarle dentro una sensazione di vuoto e di spaesamento sempre
maggiore.
Two drifters, off to see the world.
There’s such a lot of world to see
We’re after the same rainbow’s end, waitin’ ‘round the bend.
My huckleberry friend, moon river, and me...
Mentre le note della canzone diluivano i suoi pensieri, infonden-
dole in cuore una dolce malinconia, Greta tirò un amaro sospiro,
spense la tv e per alcuni secondi rimase così, immobile sul divano
con la coperta stropicciata fra le gambe a fissare il vuoto. Doveva
smetterla di dirsi bugie, pensò. Da quando era tornata in quella casa,
continuava a raccontarsi che i suoi viaggi, i suoi sogni e la sua cultura
le sarebbero bastati per sempre, ma in fondo al cuore sentiva che
non era vero. Che qualcosa dentro di lei aveva preso a cambiare in
maniera improvvisa e irreparabile. Era sempre la stessa Greta –
quella che amava scoprire, viaggiare, narrare – solo che dopo tanti
anni trascorsi a ballare da sola, ora cominciava a chiedersi come ci
si muovesse in un passo a due. Che cosa si provasse a sentire il re-
spiro di un’altra persona sul collo o la sua presa attorno ai fianchi,
quale conforto riuscissero a offrire le sue braccia. Faceva fatica ad
ammetterlo, sì – perché in passato si era ritrovata più volte a negarlo;
perché non aveva idea di come riuscirci; ma la verità era che anche
30lei – come tutti – avrebbe voluto innamorarsi di qualcuno. Qualcuno
che fosse capace di calmare le sue paturnie, il suo senso di vuoto;
che assomigliasse a quello scrittore con l’impermeabile, a quella
brioche. A Tiffany. E a quel pensiero ecco che il barlume di un sor-
riso tornò a rasserenarle il volto. Troppo visionaria? Forse. Ma an-
che se non aveva la certezza che il suo principe azzurro fosse là fuori
ad aspettarla, di una cosa era sicura: se lo avesse incontrato,
l’avrebbe riconosciuto a primo sguardo. In fondo si sa: un diamante
in vetrina brilla sempre più degli altri.
313.
Tic, tic, tic.
Erano quasi le sei e ancora niente. Relegato attorno a uno di quei
lunghi tavoloni bianchi assieme ad altri ragazzi impegnati a prepa-
rare la versione di latino o l’imminente parziale di analisi, Riccardo
continuava a fissare il vuoto. Tamburellava nervosamente la biro sul
foglio in cerca dell’ispirazione ma non riusciva a buttar giù neanche
una parola. Sembrava proprio che tutte le sue buone idee si fossero
volatilizzate di colpo in seguito al pranzo. Mentre si stava allonta-
nando dal centro di Modena per imboccare la tangenziale, una tele-
fonata di suo padre lo aveva costretto a ritardare tutti i suoi piani:
«Ciao Ricky, sei a casa? Ti va se pranziamo insieme? Sono appena
tornato da Parigi e ho qui un pensierino per te... L’ha fatto Adèle.»
Così senza particolare entusiasmo, il figlio aveva invertito il senso di
marcia e si era immesso nuovamente sui viali per un boccone con
lui alla Vecchia Pirri. Avevano mangiato in fretta; due tagliate di
manzo con verdure grigliate, annaffiate da una bottiglia di acqua
naturale ghiacciata. Nessuno dei due aveva chiesto il dessert: stessi
gusti, stesso temperamento, stesso sangue. Dolce, troppo dolce.
Tanto che per colpa della glicemia alta, compiuti i sette anni, Ricky
aveva dovuto rinunciare alle torte di compleanno ed era stato
obbligato ad assumere quotidianamente farmaci, per evitare di
incorrere in una patologia diabetica seria. Poi a otto, Roberto lo
aveva preso da parte e stringendogli forte le mani, gli aveva detto:
«Ricky, lascio tua madre perché non la amo più.» E allora lui aveva
creduto che tutta quella storia della famiglia, delle torte e del diabete
si trattasse soltanto di una burla e aveva smesso di credere nel
33matrimonio quanto di limitarsi negli zuccheri. Che gli importava se la storia che non sarebbe arrivato vivo a quarant’anni fosse una bugia, oppure no? Intanto quel giorno suo padre se n’era andato per davvero, pensava. Era saltato dentro alla sua Mercedes Station Wagon ed era sparito tra le curve sterrate di via Rivolta per volare dritto in Francia, risposarsi con Magda e fare da genitore alla sua nuova sorellastra. Non era tornato neppure in seguito a quell’incidente; dopo aver saputo che lui era stato ricoverato d’urgenza e che i servizi sociali avevano dichiarato sua madre incapace di seguirlo. Nemmeno quando Rosaria lo aveva chiamato per assumersi la sua custodia. Ricky aveva dovuto aspettare che Roberto divorziasse di nuovo per rincontrarlo; ma persino dopo esser rientrato in Italia in quei dieci anni di tè e di pranzi consumati di fretta attorno al tavolo di un locale qualsiasi – nella casa di Verdicella non l’aveva mai più rivisto. Salvo nella fotografia sul comò della sala; quella in cui appariva ancora come il giovane marito coi capelli castani e gli occhi vispi di cui Daniela si era innamorata. La stessa che tutte le sere ora sua mamma guardava con rammarico quando terminata l’ennesima bottiglia di Merlot si alzava insonnolita dal divano e faticava a infilare le scale per andare a letto. Sì, agli occhi di Riccardo l’immagine del padre era proprio simile a quella impressa su una polaroid ingiallita. Una realtà muta e distante di cui non conosceva nulla eccetto il volto. In tutti quegli anni Roberto non si era mai dimostrato un genitore da grandi effusioni ed elogi e anche prima di sparire all’estero e risposarsi con quella giovane massaggiatrice brasiliana, lo aveva sempre educato con formalità e reverenza. Non un sorriso, un cenno di approvazione, un abbraccio. Fin da quando era piccolo, il signor Deggi si era interfacciato al figlio solo per convenzionalità o per rimprovero, senza mostrare alcuna voglia di intessere con quello un dialogo costante e sincero. Era troppo egoista per farlo. Troppo volubile. Sarà sembrato un paradosso eppure, per quanto passasse le giornate a disegnare edifici 34
magnifici, nella sua esistenza quell’illustre architetto di provincia
non era mai stato capace di sedimentare alcuna certezza. Qualsiasi
legame affettivo avesse tentato di erigere nel corso degli anni era
puntualmente crollato al suolo: prima il suo matrimonio, poi il
rapporto con la sua progenie; persino le relazioni con le sue
numerosissime amanti duravano sempre meno del previsto.
Roberto era un ponte senza travi; un grattacielo senza fondazioni e
anche ora che si era risposato, tutti si chiedevano quando sarebbe
sprofondato di nuovo su se stesso. Cambiava idea, arredamento e
moglie più spesso del vestito a giacca ma nonostante fosse disposto
a calpestare il prossimo, pur di appagare le volubili pretese del suo
capriccioso io, il padre di Riccardo non si amava per niente, anzi.
Detestava la sua fragilità a tal punto che ottemperare ai rigidi canoni
imposte dall’alta società, gli era sempre sembrato l’unico modo per
apparire vincente persino ai suoi stessi occhi. Così da quarantasette
anni a quella parte ogni mattina indossava la sua maschera di artista
eclettico e facoltoso e passava il tempo libero comprando mobili
costosi, belle donne e amici con le sue prodigalità nel solo tentativo
di sentirsi un po’ meno insignificante. Durante la settimana lavorava
in studio dodici ore al giorno, poi il weekend andava fuori in barca
a vela, si rilassava nei centri benessere o prendeva un aereo per
accompagnare qualche suo amico milionario in Sudamerica a caccia
di giaguari. Quando poi toccava a lui invitare qualcuno di loro a
cena, ecco che puntualmente estraeva dal frigo una bottiglia di
Cristal Rosé assieme a un vassoietto di crostini e domandava: «Foie
gras?» Quanto gli piaceva dirlo; quel paté era sempre stato il suo
cavallo di battaglia. Era così francese; così raffinato. Una vera delizia
per gli occhi e per il palato. O almeno si augurava che lo fosse per
quello degli ospiti, dato che lui era allergico al fegato d’oca e tutte le
volte che lo preparava, finiva col rosicchiare soltanto la crosta del
pane. Tanto mica importava che fosse realmente appetitoso; per lui
bastava che sembrasse costoso e che venisse servito in abbondanza.
35Puoi anche leggere