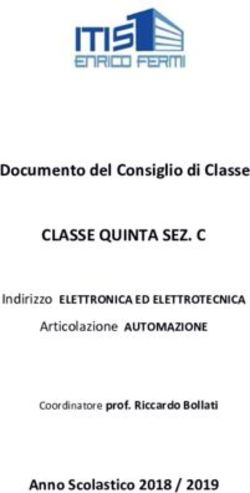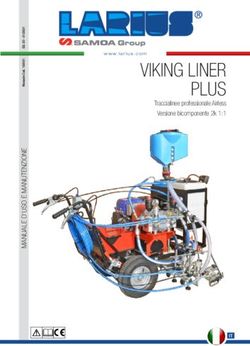INTRODUZIONE ALLE SCIENZE BIOMEDICHE A CURA DI LORENZO LUVISI MPHED MSC PHD - DICEMBRE 2017 - ISI BARGA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Lo scopo di questa presentazione è quello di
acquisire le conoscenze basilari
riguardanti l’organizzazione e la struttura
del corpo umano.
Inizieremo ricostruendo il cammino compiuto
dall’uomo nell’acquisizione delle
conoscenze in ambito biologico,
anatomico e fisiologico, così da
comprendere come, alla fine, si sia giunti
a considerare imprescindibile il
rapporto esistente tra salute, attività
motoria e benessere.I nostri primordiali antenati possedevano conoscenze approssimative
sulla struttura ed il funzionamento del proprio corpo.
Spesso le competenze biomediche erano associate a rituali magici ed
a credente religiose. Chi possedeva tali conoscenze apparteneva
a caste potenti e privilegiate. Il loro sapere era custodito
gelosamente e trasmesso solo per via orale a discepoli fidati.
Prof. Luvisi Lorenzo 3 di 58Con la scrittura (3.500 a.C.) la tradizione orale comincia ad essere codificata. Gli Egizi disponevano di avanzare tecniche chirurgiche e di imbalsamazione.
Solo a partire dall’antica Grecia le scienze che studiavano il corpo
umano trovano una loro autonomia.
Erodico, medico e atleta vissuto nel V secolo a.C., fu un sostenitore
dell’importanza della dieta nell’allenamento, Ippocrate fondò a Kos,
la prima scuola medica destinata a rimanere famosa negli anni.
e fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta
dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né
in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute.
Ippocrate (460-377 a.C.)Diversamente dai Greci, i Romani non si dimostrarono interessati nei
riguardi dello studio del corpo umano e delle scienze mediche e tale
tendenza proseguì nel Medioevo, anche a causa della Chiesa che
si opponeva ad ogni tipo di attività legata al corpo umano.
Fu solo con il Rinascimento, grazie al ritorno
alle fonti culturali classiche, che si
cominciarono a superare i
pregiudizi che fino ad allora avevano
paralizzato la ricerca sul corpo umano.
Nel Seicento, grazie all’invenzione del
microscopio, la ricerca subì un’accelerazione,
in particolare nel campo della citologia e della
fisiologia.Le dimensioni estremamente piccole
richiedono idonei sistemi di misura.
Prof. Luvisi Lorenzo 7 di 58Nel 1800 le conoscenze sul corpo umano si perfezionano e vengono
stabiliti i principi base dell’alimentazione.
Il primo laboratorio di fisiologia del lavoro muscolare fu realizzato nel
1892 all’Università di Harvard. A questa università si devono anche i
primi corsi di studio specifici per la formazione dei futuri insegnanti
di educazione fisica. Anche in Europa si svilupparono studi e
ricerche basilari in questo campo grazie alle scuole danese e
svedese.
In tempi recenti le conoscenze scientifiche hanno subito accelerazioni
impensabili grazie all’applicazione di nuove
e rivoluzionarie tecnologie,
consentendo un allungamento
dell’aspettativa di vita ed una sua
migliore qualità per tutti noi.In natura i sistemi evolvono spontaneamente verso uno stato di disordine. Per mantenere l'ordine e l'organizzazione è indispensabile che una parte di energia venga impiegato proprio per mantenere quest'ordine. La fonte prima dell'energia per tutti i sistemi viventi è il sole, da cui proviene l’ energia luminosa, che viene convertita dalle piante in energia chimica e come tale immagazzinata. L'uomo si procura questa energia mangiando piante ed animali che si nutrono di piante.
Una delle proprietà che caratterizzano gli esseri viventi è che essi mantengono
una precisa organizzazione strutturale di tipo gerarchico.
Livelli di organizzazione
CHIMICO
CELLULARE
TISSUTALE
ORGANICO
SISTEMICO
Livello di ORGANISMO
Livello di POPOLAZIONE
Livello di COMUNITA’
Livello di ECOSISTEMAConseguentemente alla suddetta suddivisione in vari livelli (gerarchie)
di complessità strutturale del protoplasma (dal gr. πρῶτος "primo" e
πλάσμα "materia“, termine generale, che indica tutta la sostanza
vivente della cellula), si sono sviluppate specifiche branche di
studio.
Prof. Luvisi Lorenzo 11 di 58La scienza che tratta di tutte le manifestazioni della vita, prende il nome
di Biologia (dal greco bíos, vita e logos, discorso). La biologia
abbraccia altre scienze come l’anatomia, la fisiologia, ecc.
Prof. Luvisi Lorenzo 12 di 58Il primo livello di organizzazione della materia vivente è l’atomo (dal
greco ἄτομος - àtomos -, indivisibile, unione di ἄ - a - [alfa privativo]
+ τέμνειν - témnein - [tagliare]).
Qualunque materia, sia vivente che non vivente, è formata da atomi.Il secondo livello di organizzazione della materia è costituito
dall'unione di più atomi (uguali o diversi) che si determina in seguito
a legami chimici (ionici, covalenti e di coordinazione) che portano
alla formazione della molecola.
Primo e secondo livello sono oggetto di studio della chimica suddivisa
nelle sue discipline fondamentali quali la chimica inorganica, la
chimica fisica, la chimica analitica,
la biochimica, a cui
si aggiungono
la chimica
farmaceutica,
la chimica
industriale,
la chimica
degli alimenti,
ecc.Il terzo livello di organizzazione della materia è rappresentato da una
piccola struttura derivante dall’unione ordinata e coordinata di più
molecole che si uniscono tra loro a formare un organulo.
I mitocondri e i cloroplasti rappresentano un esempio di organuli che
possono essere paragonati ad una sorta di centrale energetica cellulare.
È all'interno dei cloroplasti che avviene il processo fotosintetico:
Luce solare + 6H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6O2Il quarto livello di organizzazione della materia è costituito dalla
cellula. Tanti organuli tra loro coordinati formano una cellula che
rappresenta l’unità funzionale e strutturale di ogni essere vivente.
Le cellule non sono tutte uguali
durante lo sviluppo del
feto si differenziano in
base alla funzione che
andranno a svolgere.
Questo livello, come il
precedente, sono
oggetto di studio
della Citologia
(dal greco kytos,
cavità e logos,
discorso) o
biologia cellulare.Filmato i segreti della cellula
Vedremo adesso come:
Da una sola cellula si possa arrivare ad avere un individuo.
Come le cellule dipendano da segnali per la crescita, la divisione, la
sopravvivenza ed il movimento.
Come l’incapacità di reagire al segnale dato dall’insulina determini la
comparsa di patologie importanti come il diabete.
Come si possa procedere alla crescita di epidermide in coltura per
riparare i danni derivanti dalle ustioni.
Cosa sono le cellule staminali ed embrionali.
Cosa rappresenti l’apoptosi ed evoluzione.
Da cosa dipendano le malattie neurodegenerative e il cancro.
Come la cellula oltre a morire vada incontro a processi di
invecchiamento (radicali liberi e proteine danneggiate dalle ossidazioni).
Come l’esercizio fisico possa produrre effetti benefici o dannosi.
Prof. Luvisi Lorenzo 17 di 58Gruppi di cellule che presentano le stesse caratteristiche formano una
comunità che viene chiamata tessuto e che rappresenta il quinto
livello di organizzazione della materia, oggetto di studio
dell’istologia (dal greco histós, telaio o tela e logos, discorso).
Esistono quattro tipi fondamentali di tessuti presenti in tutti gli animali:
1. Tessuto nervoso.
2. Tessuto epiteliale.
3. Tessuto connettivo (cartilagineo, osseo, adiposo, sangue e linfa).
4. Tessuto muscolare.
Il tessuto nervoso forma un sistema di comunicazione che ha il
compito di ricevere, trasmettere ed elaborare gli stimoli elettrici e
chimici, interni ed esterni del corpo. È inoltre responsabile, tramite
meccanismi ancora non del tutto chiari,
delle funzioni psichiche e intellettive
degli esseri umani, come la memoria,
la conoscenza, la coscienza.Il tessuto epiteliale (detto anche epitelio) è costituito da strati di cellule
che rivestono la superficie corporea, gli organi interni e alcune
cavità del corpo. I diversi epiteli sono definiti in base alla forma
delle cellule e al numero di strati di cui sono composti.Il tessuto connettivale è formato d un insieme di cellule sparse,
circondate da una sostanza chiamata matrice, composta da fibre
immerse in una sostanza che può essere liquida, gelatinosa o solida.
Svolge funzioni di sostegno e collegamento tra tessuti diversi e
protezione e rivestimento degli organi. Ne distinguiamo 6 tipi diversi.
Prof. Luvisi Lorenzo 20 di 58Il tessuto muscolare è costituito da cellule particolarmente lunghe
chiamate fibre muscolari e costituisce il tipo di tessuto più abbondante
presente nel corpo umano.Più tessuti di tipo diverso si uniscono a formare un organo con
specifiche funzioni dando luogo al sesto livello di organizzazione
della materia.
L'organo è piuttosto un'unità fisiologica anziché anatomica. Il criterio
della forma è spesso inadeguato per definire un organo; è
soprattutto la funzione differente che ci permette di distinguere i vari
organi l'uno dall'altro.
Comunque, da un punto di vista strutturale, gli organi possono essere
distinti in:
organi cavi e
organi pieni.
I primi sono costituiti da pareti che racchiudono un lume, idoneo ad
accogliere un contenuto, mentre i secondi mancano di una cavità
principale, con i tessuti organizzati in strutture compatte e ben
resistenti.Il settimo livello di organizzazione della materia è rappresentato da
dall’apparato, ovvero da un raggruppamento di organi diversi (sia
per funzione che per struttura) che collaborano nello svolgimento di
una specifica funzione.
Quando la collaborazione
avviene tra
organi omogenei
per funzione
e struttura,
tale raggruppamento
prende il nome di
sistema (sistema
nervoso, endocrino,
muscolare)L’ottavo livello di organizzazione della materia è costituito dall’organismo formato da tutti i suoi apparati o sistemi ben coordinati tra loro.
Le scienze deputate, rispettivamente, allo studio della struttura e del funzionamento degli organismi viventi sono l’Anatomia e la fisiologia (due branche della biologia).
Ulteriori livelli di
organizzazione della
materia riguardano la
popolazione, la comunità,
l’ecosistema e la biosfera.
Prof. Luvisi Lorenzo 26 di 58Vediamo adesso un breve sunto riguardo alla struttura ed alle
funzioni dei principali organi ed apparati corporei:
Apparato urogenitale (apparato escretore e apparato riproduttore).
Apparato locomotore (sistema muscolare e apparato scheletrico).
Sistema nervoso.
Apparato tegumentario.
Organi di senso.
Apparato cardiocircolatorio.
Apparato respiratorio.
Sistema linfatico (immunitario).
Sistema endocrino.
Apparato digerente.
Prof. Luvisi Lorenzo 27 di 58Gli organi sessuali primari (gonadi) sono i testicoli nell’uomo e le
ovaie nella donna; producono le cellule sessuali o gameti (funzione
esocrina) e secernono gli ormoni sessuali (funzione endocrina) .
Altre formazioni dell’apparato della riproduzione
sono gli organi annessi all’apparato
riproduttivo. Scopo comune
è generare la prole.
Nei testicoli (o didimi) sono
presenti due diverse
popolazioni cellulari
deputate alla produzione di
spermatozoi e alla
secrezione degli ormoni
(cellule interstiziali).Gli organi annessi sono rappresentati da condotti e da ghiandole che
collaborano al trasporto degli spermatozoi:
Le vie spermatiche sono 3: l’epididimo, il condotto deferente che
continua nei condotti eiaculatori che attraversano la prostata per
sboccare nell’uretra.
La sterilità maschile può dipendere da ostruzione delle vie
spermatiche, da squilibri ormonali, da una rara infiammazione
dei testicoli (orchite) e da molti altri fattori.
Le ghiandole annesse (vescichette seminali, prostata e
ghiandole bulbouretrali) producono la maggior parte del liquido
seminale. Il liquido seminale contiene sia gli spermatozoi che i
secreti delle ghiandole annesse che svolgono una funzione di
nutrimento, trasporto e protezione degli spermatozoi maturi.
L’ipertrofia prostatica aumenta il rischio di infezione della vescica
(cistite) e di danni renali.Spermatozoi vitali non possono formarsi alla normale temperatura
corporea, la temperatura scrotale è infatti inferiore di circa 3°C.
I genitali esterni comprendono lo scroto e il pene.
Criptorchidismo
2
1
2
Ghiandole annesseIl ruolo principale del maschio nella riproduzione è quello di produrre gli
spermatozoi e secernere l’ormone testosterone.
La spermatogenesi inizia con la pubertà e continua per tutta la vita.
Ogni giorno ogni uomo produce milioni di spermatozoi.L’ormone follicolo-stimolante (FSH) secreto dall’adenoipofisi stimola i
tubuli seminiferi a produrre spermatozoi a partire da cellule staminali
che si dividono prima per mitosi e poi per meiosi.
Agenti esterni (antibiotici, radiazioni,
piombo, marijuana, tabacco,
eccesso di alcol) possono alterare il
normale processo di formazione
degli spermatozoi producendo di anomali.
L’adenoipofisi secerne anche l’ormone
luteinizzante (LH o ICSH) che stimola
le cellule interstiziali a produrre testosterone.
Il testosterone è responsabile della libido e della
comparsa dei caratteri sessuali secondari
maschili:
voce profonda,
peli su tutto il corpo,
Sviluppo dei muscoli e della massa ossea.
Prof. Luvisi Lorenzo 32 di 58Lo stress ossidativo (squilibrio tra produzione ed eliminazione di
ROS) è associato a diverse patologie umane, tra cui la crescente
infertilità maschile.
Piccole quantità di ROS sono necessarie allo spermatozoo per
l’acquisizione della sua capacità fecondante. D’altro canto, eccessivi
livelli di ROS determinano una bassa qualità del seme per i danni
che arrecano alla membrana spermatica.
Prof. Luvisi Lorenzo 33 di 58Il ruolo della femmina nella riproduzione è molto più complesso di
quello del maschio in quanto, oltre a produrre i gameti femminili
(uova) fornisce nutrimento e protezione al feto.
Le ovaie, dalle dimensioni simili ad una mandorla, rappresentano gli
organi sessuali primari ed accolgono numerosi follicoli ovarici
contenenti ciascuno un ovocita immaturo.
Gli organi annessi sono rappresentanti dalle vie genitali femminili
costituite dalle tube uterine, dall’utero e dal canale vaginale.
Le tube uterine (ovariche o di Falloppio), lunghe circa 10 cm,
rappresentano la sede dove può avvenire la fecondazione, in
quanto l’ovocita è vitale fino a 24 ore e il viaggio verso l’utero dura
fino a 24 ore dopo l’ovulazione.
La gonorrea (infezione batterica) propagandosi nella cavità
peritoneale provoca la malattia infiammatoria pelvica che, se non
trattata, può portare a sterilità.L’utero è un organo cavo, delle dimensioni di una pera, destinato ad
accogliere, trattenere e nutrire l’uovo fecondato.
Il Pap test rappresenta la procedura diagnostica per evidenziare
il cancro del collo
dell’utero frequente
nelle donne dai 30 ai
50 anni.
Il canale vaginale è
un condotto lungo
8-10 cm,
parzialmente
chiuso da una
membrana
denominata
imene.Esternamente alla vagina troviamo i genitali esterni (vulva): monte
del pube, grandi e piccole labbra, clitoride, orifizi uretrale e
vaginale e le ghiandole vestibolari maggiori.
Prof. Luvisi Lorenzo 36 di 58La quantità totale di ovociti che la donna può produrre è già determinato al momento della nascita e la sua fertilità termina verso i 50 anni o prima. Il processo che porta alla formazione dei gameti femminili è detto ovogenesi. Gli ovogoni si moltiplicano nella fase fetale e spariscono alla nascita lasciando un numero determinato (circa 700.000) di ovociti primari, situati dentro altrettanti follicoli ovarici. Dopo una fase di quiescenza, alla pubertà l’adenoipofisi comincia a produrre l’ormone follicolo stimolante (FSH) che ogni mese porta a maturazione un piccolo numero di follicoli primari (ciclo ovarico).
Un ciclo ovarico (periodo compreso tra due mestruazioni successive),
della durata vomplessiva di circa 28 giorni, è diviso in tre fasi:
1. fase follicolare (proliferativa),
2. fase ovulatoria (ovulazione),
3. fase luteinica (secretoria).
La fecondazione avviene generalmente nelle tube uterine.
Prof. Luvisi Lorenzo 38 di 58Il l ciclo mestruale o uterino
è una sequenza di
cambiamenti fisiologici
periodici che riguarda
utero e ovaie e che rende
possibile la gravidanza.
Se c’è stata fecondazione
l’embrione produce un
ormone molto simile all’LH
(ipofisario) che mantiene
funzionante il corpo luteo il
quale comincia a produrre
i suoi ormoni; altrimenti il
corpo luteo degenera.La fecondazione può avvenire se il rapporto sessuale ha avuto luogo
non più di 72 ore prima dell’ovulazione e non oltre 24 ore dopo.
La parte anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) produce l’ormone follicolo-
stimolante (FSH) che stimola la crescita e la maturazione dei follicoli
primari e l’ormone luteinizzante (LH) che scatena l’ovulazione e
modifica la struttura del follicolo trasformandolo in corpo luteo.
Gli ormoni ovarici, steroidei, si possono distinguere in:
1. estrogeni correlati alla comparsa dei caratteri sessuali secondari
femminili e
2. progesterone, secreto dal corpo luteo e dalla placenta. Regola il
ciclo mestruale, concorre al mantenimento dello stato di gravidanza
e prepara la ghiandola mammaria alla produzione del latte.
Le ghiandole mammarie derivano da ghiandole sudoripare modificate
con il ruolo di produrre il latte per nutrire il neonato.
Il cancro della mammella è la maggior causa di morte negli USA,
dove una donna su 8 sviluppa questa patologia.
Prof. Luvisi Lorenzo 40 di 58LE GHIANDOLE MAMMARIE Le ghiandole mammarie sono presenti in entrambi i sessi, ma normalmente funzionano solo nelle donne, nelle quali subiscono un’ipertrofia alla pubertà su stimolazione prevalente degli ormoni estrogeni. Queste ghiandole sono particolarmente inclini a sviluppare patologie talvolta piuttosto pericolose, per le quali è fondamentale una diagnosi precoce ottenibile mediante autopalpazione del seno e mammografia.
LA GRAVIDANZA
La gravidanza è il periodo che va dal concepimento alla nascita e durante
la quale si verificano notevoli variazioni anatomiche e funzionali.
A livello embrionale, dopo la formazione delle gonadi inizia lo sviluppo
degli annessi e dei genitali esterni, che saranno di tipo maschile o
femminile a seconda che sia presente o meno il testosterone.
Se nel maschio non si produce testosterone, l’individuo svilupperà organi e
genitali esterni femminili.
Se il feto femmina subisce l’influenza del testosterone (ad es. per tumore
delle surrenali materne) svilupperà vie spermatiche e genitali esterni
maschili.
La anomala separazione di alcuni cromosomi durante la meiosi può
comportare malformazioni congenite dell’apparto riproduttivo (XXY, X0,
Y0.
La pubertà è quel periodo della vita, generalmente compreso tra i 10 e i 15
anni, durante il quale gli organi dell’apparato riproduttivo si accrescono
fino a raggiungere le dimensioni adulte.
Prof. Luvisi Lorenzo 42 di 58N. totale dei cromosomi: 46. 46,XX - cariotipo normale Femminile
46,XY - cariotipo normale Femminile
Sindrome di
Turner 45,X
•Bassa statura
•Torace a scudo
•Mammelle
Iposviluppate
•Peli pubici radi
•Pterigio del collo
Sindrome di Klinefelter 47,XXY – caratteri sessuali secondari di tipo femminile
H>175 cm, sterilità, ginecomastia, genitali poco sviluppatiL’ apparato escretore è costituito dai reni, anche se i
polmoni e la cute partecipano a loro volta
all’escrezione delle sostanze di rifiuto.
Al di sopra di ciascun rene si trova la ghiandola
surrenale, appartenente all’apparato endocrino.
Gli altri organi dell’apparato urinario sono:
2. gli ureteri,
3. la vescica urinaria,
4. l’uretra, che può dar luogo ad una
uretrite (nella donna) che può infiammare
anche la vescica (cistite).
Essi fungono da condotti di trasporto
e da serbatoio dell’urina.I reni, lunghi circa 10/12 cm si estendono da
T12 a L3 parzialmente protetti dalla gabbia toracica.
Un ammasso di grasso, la capsula adiposa,
circonda ciascun rene e concorre a mantenerlo
nella sua sede. Un rapido dimagrimento può
dar luogo ad una ptosi dei reni.
Ogni minuto passa attraverso i reni
circa ¼ di tutto il sangue del corpo.
In seguito a infezioni ricorrenti, traumi dei reni,
avvelenamento da metalli pesanti e inadeguata
irrorazione sanguigna può insorgere
l’insufficienza renale. Sfortunatamente i segni e i
sintomi di questa patologia si manifestano solo quando
si è perso già il 75% della funzionalità renale.Il rene è costituito da due regioni distinte:
1. la sostanza corticale e la
2. la sostanza midollare.
Presenta un’insenatura mediale che prende il nome di ilo da cui
entrano ed escono ureteri, nervi e vasi sanguiferi.
Prof. Luvisi Lorenzo 46 di 58Ciascun rene contiene oltre un milione di formazioni microscopiche
denominate nefroni che rappresentano le unità anatomo-
funzionali dei reni.
Ogni nefrone consta di due parti principali:
1. Il glomerulo, un gomitolo di capillari arteriosi
2. Il tubulo renale la cui estremità, detta capsula glomerulare,
avvolge completamente il glomerulo.
La maggior parte dei nefroni si trovano nella sostanza corticale
Prof. Luvisi Lorenzo 47 di 58La formazione dell’urina è il risultato dei processi di filtrazione,
riassorbimento e secrezione.Il glomerulo funziona come un filtro, la pressione sanguigna assai
elevata al suo interno induce la filtrazione dei fluidi e di alcuni soluti.
Proteine e cellule del sangue sono di solito troppo grandi per passare
attraverso il filtro; se alcune di queste sostanze si trovano nelle urine
vuol dire che esiste qualche problema a livello del filtrato
glomerulare.
Ogni giorno si producono da 1 a 1,8 L di urina. La scarsa produzione di
urina prende il nome di oliguria (100-400 mL/die) o anuria (< 100
mL/die).
Prof. Luvisi Lorenzo 49 di 58GLI ESAMI DELLE URINE
Un’analisi routinaria dell’urina dovrebbe far parte di ogni buona visita
medica.
Il pH delle urine è compreso tra 4,5 E 8, di solito leggermente acido (pH 6);
il consumo di grandi quantità di proteine animali e frumento tende ad
acidificare le urine, mentre la dieta vegetariana (a scorie alcaline) ne
alza il pH, Anche le infezioni batteriche delle vie urinarie possono
dar luogo ad alcalinizzazione delle urine.
Il peso specifico varia tra 1,001 e 1,035, un valore basso si riscontra nelle
persone che bevono molto o sono affetti da insufficienza renale cronica.
Prof. Luvisi Lorenzo 50 di 58La composizione del sangue dipende principalmente da tre fattori:
1. la dieta,
2. Il metabolismo cellulare.
3. La produzione di urina.
I reni filtrano approssimativamente da 150 a 180 litri di plasma
sanguigno al giorno.
I compiti principali svolti dai reni sono i seguenti:
Escrezione delle scorie azotate, ovvero dell’urea prodotta nel
fegato per impiego degli aminoacidi a scopo energetico, dell’acido
urico derivante dal metabolismo degli acidi nucleici e della
creatinina associata al metabolismo della creatina nei muscoli.
Mantenimento dell’equilibrio idrico ed elettrolitico del sangue.
Mantenimento dell’equilibrio acido base del sangue.MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO IDRICO DEL SANGUE
Affinché il corpo rimanga adeguatamente
idratato, non si può perdere più acqua di
quanta se ne introduce.
Quando, per una causa qualsiasi, il volume
del sangue diminuisce, la pressione
arteriosa scende e di conseguenza si
riduce la quantità di filtrato prodotta dai
reni. L’ipotalamo invia segnali all’ipofisi
posteriore che in risposta rilascia
l’ormone antidiuretico (ADH) o
vasopressina, che determina un maggior
riassorbimento di acqua nel rene e una
vasocostrizione.
Nel diabete insipido manca la vasopressina
il che comporta l’eliminazione di grandi
quantità di urina giornalieri (fino a 25 litri).
Prof. Luvisi Lorenzo 52 di 58MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ELETTROLITICO DEL SANGUE
Quando nel sangue c’è poco sodio risulta troppo diluito e si possono
formare edemi. Nel caso di abbassamento dei livelli di sodio la
corteccia surrenale rilascia aldosterone che favorisce il
riassorbimento del sodio (NaCl) a livello dei tubuli renali.
Lo stimolo comunque più importante per il rilascio dell’aldosterone è
ripresentato dal sistema renina-angiotensina.
La bassa pressione induce il rene a rilasciare
l’enzima renina, la quale catalizza una serie
di reazioni che portano alla formazione
dell’angiotensina II che determina
vasocostrizione e rilascio di aldosterone.
Prof. Luvisi Lorenzo 53 di 58L’angiotensina stimolando il surrene (in caso di pressione bassa) a produrre aldosterone (che aumenta la ritenzione idrica e quindi la pressione), rappresenta un obiettivo ideale per farmaci antipertensivi.
MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ACIDO-BASE DEL SANGUE
Il pH del sangue deve mantenere un valore compreso tra 7,35 e 7,45.
Esistono vari sistemi per mantenere l’equilibrio acido-base de sangue:
I tamponi ematici rappresentano la prima linea di difesa contro i
cambiamenti del pH. I 3 più importanti tamponi chimici sono
rappresentati dal bicarbonato, dal fosfato e dai sistemi tampone
proteici. Bloccano temporaneamente l’eccesso di H+ o di basi.
L’apparto respiratorio modifica il pH ematico trattenendo o
eliminando in quantità maggiore la CO2 tramite l’adeguamento del
ritmo e della profondità del respiro.
I meccanismi renali sono i soli che permettono di eliminare
definitivamente dall’organismo i vari tipi di acidi prodotti durante il
metabolismo. È un processo più lento ma più potente dei
precedenti, si basa essenzialmente sull’escrezione o sul
riassorbimento e formazione di ioni bicarbonato (HCO30),
Prof. Luvisi Lorenzo 55 di 58Due sfinteri uretrali (uno involontario e uno volontario) permettono di
controllare la minzione. La vescica si riempie fino a contenere circa
200 mL di urina quindi si avverte lo stimolo a svuotarla.
Normalmente non è realistico aspettarsi un completo controllo notturno
prima del 4° anno di età.
Quando non si è in grado di controllare lo sfintere uretrale esterno si ha
incontinenza. Con l’età si assiste a un progressivo declino della
funzione renale il cui filtrato si dimezza dopo i 70 anni (con
impellenza, maggior frequenza e nicturia).
Prof. Luvisi Lorenzo 56 di 58I reni svolgono anche altre funzioni: producono l’ormone eritropoietina
(o EPO) che stimola il midollo osseo a produrre i globuli rossi ed
inoltre convertono la vitamina D nella sua forma più attiva.
Prof. Luvisi Lorenzo 57 di 5858
Puoi anche leggere