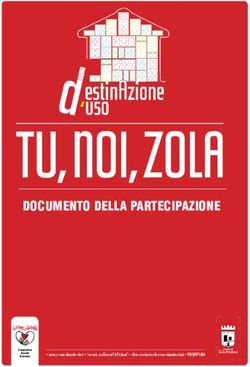INTERVENTI DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ - A cura di Jada Fantasia Giulia Lotti Angela Pugliese Monica Rosati - Unipd
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
INTERVENTI DELLA GIUSTIZIA
MINORILE E DI COMUNITÀ
A cura di Jada Fantasia
Giulia Lotti
Angela Pugliese
Monica Rosati
1Un ringraziamento speciale all’Assistente Sociale Minorile
Enza Elena Gatto, che con la sua passione, professionalità,
competenza e pazienza ci ha indirizzato in questa tematica,
e le cui parole non saranno dimenticate.
2INDICE
1- INTRODUZIONE……………………………….........pag. 4
2- IL QUADRO NORMATIVO………………………. ..pag.6
3- LA REALTÀ ALL’INTERNO DELLE COMUNITÀ PER
MINORI ……………………………………………pag. 24
4- DALL’ACCOGLIENZA
ALL’AUTONOMIA………………pag.43
5- DATI STATISTICI: SERVIZI DELLA GIUSTIZIA
MINORILE………………………………………pag.59
6- CONCLUSIONE……………………………………pag. 78
7- BIBLIOGRAFIA……………………………………pag.79
3INTRODUZIONE
A cura di Monica Rosati e Jada Fantasia
La Comunità Educativa è un servizio residenziale che accoglie
temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o
incapace di assolvere il proprio compito.
Offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione giornaliera
dei vari aspetti della vita ed è vissuta come luogo di socializzazione con tempi
e modalità simili allo stile familiare. L’obiettivo primario è il Benessere fisico,
psichico e sociale del minore ponendo al centro dell’intervento educativo la
relazione come stimolo alla scoperta e allo sviluppo delle potenzialità
individuali verso un percorso di autonomia.
La tutela dei bambini e degli adolescenti fuori dalla propria famiglia di
origine costituisce una delle sfide fondamentali accolte dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza. La condizione dei minorenni che vivono
un’esperienza di allontanamento necessita, invero, di particolare attenzione e
sostegno sia nella scelta della risposta più conforme al bisogno specifico di
ciascun minorenne, sia nella fase dell’eventuale reinserimento all’interno
della dimensione sociale. La comunità educativa per minori si propone come
luogo fisico e relazionale caratterizzato da un clima familiare, nel quale il
minore possa rielaborare i propri sentimenti e le proprie esperienze, offrendo
un affiancamento affettivo ed educativo che consenta al minore stesso di
sviluppare una nuova identità. La comunità per minori è un servizio
educativo - assistenziale che ha il compito di accogliere il minore durante il
giorno, qualora il nucleo famigliare sia impossibilitato o incapace a garantire
il benessere e i bisogni, anche primari, del ragazzo. Essa si rivolge quindi a
minori in situazioni di disagio sociale, familiare e personale non
particolarmente grave, ma in condizioni di precarietà e fragilità affettiva e
relazionale, tali da compromettere un'evoluzione personale, equilibrata ed
4armonica. La comunità per minori è luogo di vita quotidiana; è alternativa
all’affidamento; è lavoro di rete tra operatori, genitori e ragazzi; è una nuova
casa e famiglia per i minori; è luogo d’incontro e di scontro; è ambiente di
rieducazione e di ascolto; è un insieme di emozioni, affetti e storie di vita
differenti ma che s’intrecciano creando un sentire comune e un sentimento di
accettazione reciproca. Questo servizio pone al centro il minore e lo vede
come persona inserita in un contesto relazionale sia interno sia esterno dal
luogo di ospitalità. Da ciò si può evincere che il modello teorico di
riferimento delle comunità è quello sistemico - relazionale poiché si
considera il singolo come persona unica inserita in diversi sistemi di
relazione; la comunità è quindi un sistema aperto, che scambia informazioni
con l’ambiente circostante e con tutti gli altri servizi di cui il minore
quotidianamente usufruisce. C’è da aggiungere cha la comunità, oltre ad
essere un luogo “protetto” perché assicura al minore protezione e tutela, è
anche un luogo “esposto” a rischio poiché è inserito in un contesto
rappresentato dalle aspettative dei soggetti in gioco. In questo
approfondimento il tema degli “interventi della giustizia e comunità
minorile” viene affrontato sotto la sfera giuridica e sociale con particolare
attenzione all’aspetto inclusivo dei minori nella società e al quadro dei dati
statistici più recenti.
5IL QUADRO NORMATIVO
A cura di Angela Pugliese
Il maltrattamento dei minori è sempre esistito, ma viene percepito come un
fenomeno a se stante, e come problema sociale e medico, verso la seconda
metà del Novecento, ed è definito socialmente come la soglia posta per
indicare se un minore sia o meno vittima di abusi; esso cambia in virtù delle
violazioni alle pratiche di allevamento, alla centralità dell’infanzia e della
famiglia nel contesto culturale nonché sulla base dei criteri morali e legali
che governano la vita della collettività.
Il concetto di abbandono, nel diritto come nella vita sociale, si radica sul
riconoscimento che vi è, da una parte, una persona che non è in grado di
badare adeguatamente a se stessa per insufficienze fisiche, mentali o di
sviluppo e, dall’altra, qualcuno che, pur avendone il dovere morale, omette
di prendersi cura di lei in alcuni casi. L’abbandono, fisiologicamente, mette a
repentaglio la stessa vita e l’integrità fisica del soggetto incapace; in altri
casi, può compromettere gravemente il suo sviluppo umano quando vengono
a mancare quegli apporti indispensabili per strutturarsi o per vivere.
Dalle situazioni di maltrattamento e abbandono si sviluppano percorsi che
portano all’allontanamento del minore dalla propria famiglia, percorsi di
competenza civile, atti alla protezione e tutela del minore.
Vi sono altri casi, e altri percorsi, quello amministrativo o penale, che
riguardano l’allontanamento del minore dalla famiglia, percorsi che negli
anni sono stati oggetti di modifiche ed evoluzione.
L’allontanamento del minore, all’interno di questi processi, può condurre al
suo inserimento all’interno di una comunità minorile, o alla sua
adozione/affidamento da parte di una famiglia nel caso di competenza civile.
Per quanto riguarda la competenza civile, le disposizioni che consentono
all'autorità pubblica e all'autorità giudiziaria di allontanare un minore dalla
propria famiglia d'origine sono contenute nel codice civile quanto nella legge
6sulle adozioni, n. 184/1983. Quest’ultima è stata modificata dalla legge
476/98, la quale introduce nel nostro sistema la normativa relativa alla
convenzione internazionale dell’Aja in materia di tutela dei minori, firmata
dallo stato italiano nel maggio del 1993. Gli scopi che la Convenzione
intende raggiungere sono molteplici. Il principale è quello di stabilire delle
garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse del
minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal
diritto internazionale. Nel Preambolo della Convenzione si specifica però,
che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate
per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine e che quindi
l'adozione internazionale può offrire un'opportunità solo a favore dei bambini
per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di
origine. Le norme presenti nella Convenzione sono finalizzate anche a creare
un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, che assicuri il pieno
riconoscimento delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.
In seguito, la legge di riforma n°149/2001 sancisce il “diritto del minore a
una famiglia”, introducendo così molte innovazioni nell’iter delle pratiche di
adozione, oltre ad aver modificato nettamente i ruoli all’interno dei servizi
socio-sanitari. Il legislatore con la nuova legge ha inteso dettare misure tali
da rendere pienamente operativo il diritto del minore ad una propria famiglia,
da intendersi sia quella naturale d’origine sia quella cui sia eventualmente
affidato a causa delle difficoltà della stessa.
Le novità riguardanti le funzioni dei servizi socio-assistenziali degli enti
locali che sono contenute nella stessa all’articolo 29-bis, comma 4:
“I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure,
sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter;
7b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni
che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle
esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché
acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del
tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.”
A questo punto i servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all’attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati entro i
quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
La nuova normativa demanda ai servizi socio-assistenziali ed ai loro
operatori, nuovi e importanti compiti:
1- INFORMAZIONE SULL’ADOZIONE INTERNAZIONALE:
2- INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DELL’ ADOZIONE
INTERNAZIONALE;
3- L’INFORMAZIONE SUGLI ENTI AUTORIZZATI;
4- L’INFORMAZIONE SULLE ALTRE FORME DI SOLIDARIETA’
NEI CONFRONTI DEI MINORI IN DIFFICOLTA’;
5- LA PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE.
Per queste nuove competenze gli operatori necessitano di acquisire nozioni
aggiornate, nonché attivare una collaborazione con gli esperti del settore e
con gli enti autorizzati.
Tra le competenze degli operatori del settore è importante la preparazione
delle coppie. Questo perché è stato colto il bisogno espresso dagli aspiranti
genitori adottivi di un iter che non sia finalizzato soltanto ad una valutazione,
seppur necessaria, al conseguimento dell’idoneità, ma ad un’azione più
completa e precisa di un percorso di accompagnamento verso l’adozione.
8Quando un minore, nonostante la presenza di entrambi i genitori, è
adottabile?
Bisogna innanzi tutto sapere che nella fisiologia della complessa vicenda
familiare, vi sono i due diritti di pari dignità sotto il profilo della tutela
giuridica, quello dei genitori ad istruire, mantenere ed educare la prole, e
quello dei figli a crescere armonicamente nella famiglia di origine
coincidono.
Nelle relazioni familiare è contemplato il diritto dei genitori alla genitorialità,
che fisiologicamente garantisce, per l’ordinamento, quello del minore ad un
armonico sviluppo psico-fisico, affinché, si tuteli al contempo, il diritto
fondamentale del bambino a crescere nel nucleo di provenienza.
Nel momento in cui tale diritto non viene rispettato, la patologia
normalmente emerge, in maniera più o meno esplicita, attraverso alcuni
indicatori quali deperimento psico-fisico, difficoltà di apprendimento o
scarso rendimento a scuola, frequenza scolastica irregolare, ritardo psico-
motorio, frequenti ricoveri ospedalieri, e altro.
In presenza di suddetti indicatori, e laddove vi sia il consenso, ovvero la
disponibilità dei genitori esercenti la podestà, a collaborare con i servizi
socio-sanitari di zona a seguire le indicazioni, l’intervento delle istituzioni
sarà unicamente di tipo amministrativo-assistenziale. A volte, purtroppo, le
situazioni familiari sono talmente compromesse e deteriorate (grave
dipendenza da stupefacenti, da alcool, gravi malattie psichiatriche, …) da
non consentire, o comunque, rendere incompatibile che il minore stia con la
famiglia d’origine.
L’intervento del giudice si rende necessario, laddove vi sia un’opposizione
dei genitori a seguire le indicazioni del servizi socio-sanitari di zona, e vi sia
la necessità di limitare la podestà genitoriale degli stessi.
Infatti l'art. 330 del codice civile disciplina le ipotesi di allontanamento del
minore per decadenza dalla responsabilità genitoriale, mentre l’articolo 333
del codice civile giustifica comunque la misura dell'allontanamento a seguito
9di un comportamento pregiudizievole del genitore ai figli, ipotesi meno
grave ma più frequente rispetto a quella descritta dall’articolo 330 c.c.
Articolo 330
Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della responsabilità genitoriale
quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
Articolo 333
Condotta del genitore pregiudizievole al figlio
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può
adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Il contenuto dei provvedimenti che il giudice può adottare non è indicato
dalla legge, ma è rimesso al suo apprezzamento, che si configura come
strumento di protezione del minore contro le violazioni dei genitori. Il
giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti dello stato di
abbandono, ed è poi chiamato ad esprimersi circa la necessità di recidere, in
modo totale e perpetuo, ogni legame tra il minore e la sua famiglia d’origine.
All’intervento giudiziale, vengono comunque posti dei limiti: perseguimento
dell'interesse del minore, proporzione con la gravità del pregiudizio per
quest'ultimo, limitazione al campo dei rapporti relativi alla persona, rispetto
dell'autonomia dei genitori. La legge n. 149 del 2001, già citata
precedentemente, ha modificato gli articoli 330 e 333 c.c., prevedendo che il
giudice possa disporre l'allontanamento dalla casa familiare del genitore o
del convivente, che maltratta o abusa del minore. Questo provvedimento può
10adottarsi in via immediata e provvisoria a norma dell'articolo 336.3 c.c., che
permette di risparmiare alla vittima di un abuso in famiglia, il danno ulteriore
di subire egli stesso l'allontanamento da casa.
Articolo 336
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricordo
dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta
di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito
il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il
genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio,
provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio.
L’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile al Tribunale
per i Minorenni regola riguardo la domanda di limitazione o decadenza della
potestà genitoriale. Quando però tali procedimenti si inseriscono nell'ambito
di un giudizio di separazione o divorzio, la competenza passa al tribunale
ordinario.
La Corte di Cassazione ha da ultimo precisato che la competenza a conoscere
della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori, rimane
radicata presso il tribunale per i minorenni, anche se, nel corso del giudizio,
sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione
personale dei coniugi o di divorzio, in ossequio al principio della perpetuatio
jurisdictionis e a ragioni di economia processuale, che trovano fondamento
anche nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 8
CEDU e art.24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
11Articolo 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del
proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o
della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Diritti del bambino
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche
o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere
considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Il codice civile, all’articolo 403, regola anche l’intervento della pubblica
autorità a favore dei minori quand’essi siano moralmente o materialmente
abbandonati, quando siano allevati in locali insalubri o pericolosi, oppure
quando un genitore, o il loro tutore, è incapace di provvedere all’educazione
12del minore. La pubblica autorità alla quale si fa riferimento coincide con i
servizi sociali locali, vale a dire con quello stesso organo competente per
l'affidamento familiare, fermo restando che il servizio sociale dovrà poi
segnalare l'abbandono al tribunale per i minorenni quando riscontri
l'esistenza di una situazione di questo tipo, o altrimenti provvedere
all'affidamento familiare nei modi previsti dalla legge. Questa disposizione,
originariamente, valeva come principio generale, con il quale si riconosceva
l’intervento dell’autorità a favore dell’infanzia abbandonata. Oggi è la
Costituzione, tramite gli articoli 30.2 e 31, la fonte del principio da cui deriva
il generale dovere della pubblica autorità, e dello stesso legislatore ordinario,
di provvedere agli interessi dei minori abbandonati.
Nel sistema vigente, il Tribunale per i Minorenni ha una competenza di
carattere generale, che si estende ad ogni tipo di situazione tale da esigere il
collocamento coattivo del minore in luogo diverso da quello in cui si trova:
l'art. 403 c.c., prevedendo l'intervento di altra autorità, ha funzione residuale.
La norma assicura la protezione dei minori anche quando un tempestivo
provvedimento del giudice non sia possibile: trovando applicazione solo
nelle ipotesi di urgente necessità, e quindi procedendo al collocamento, si
conciliano le esigenze di non lasciare privo di protezione alcuno dei minori
che ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di
provvedervi spetti, di regola, ad un organo giudiziario.
Il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver
effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo. Un
intervento diverso dall’autorità del giudice, è consentita solo quando vi sia il
pericolo che lo stesso non possa provvedere tempestivamente; per cui la
concorrente competenza di più organi è giustificata dall’urgenza. Si
garantisce così che almeno uno degli organi provveda in modo tempestivo. Il
collocamento implica l'affidamento del minore a chi, almeno
temporaneamente, possa proteggerlo.
La forza di riferimento normativo di fondo della giustizia minorile resta, il
d.P.R n 448/1988, che ha innovato la procedura penale minorile. Il sistema
13processuale minorile e le istituzioni sociali in tale contesto coinvolte
protendono verso il recupero dell’individuo di minore età, a vario titolo
entrato nel circuito giudiziario. L’intero apparato normativo, sostanziale e
processuale mira, in particolare, ad evitare che la risposta penale possa
lasciare segni evidenti nell’evoluzione del giovane. Il d.P.R n.448/1988 e le
norme di attuazione contenute nel decreto legislativo n.272/1989, approvano
un sistema di giustizia penale diversificato, dove il passaggio più
significativo è costituito dallo spostamento dell’attenzione al minore da
oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Si configura un
sistema penale adeguato alla capacità del soggetto adolescente di valutare la
portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione. Il testo
normativo sollecita provvedimenti che consentano la rapida chiusura del
processo, la riduzione di risposte limitative della libertà personale e la
riduzione del danno che l’impatto con la giustizia può produrre sul piano
educativo. Per la fuoriuscita dal circuito penale, la norma traccia percorsi
diversificati che valorizzano interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso
il livello del caso individuale, e il livello territoriale, con il coinvolgimento
delle risorse presenti nel contesto per una lettura/risposta a fenomeno della
devianza, nella realtà in cui si origina e sviluppa.
I principi cardine del d.p.R n.448/1988 sono:
- PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA: il processo penale minorile deve
adeguarsi alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in
quanto deve essere teso alla reintegrazione del minore nella società. Il
processo penale, quindi, deve restituire il minore alla normalità della
vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la
personalità.
- PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITÀ: con tale principio viene
evidenziata l’esigenza di tenere in considerazione come il contatto del
minore con il sistema penale possa creare rischi allo sviluppo
armonico della sua personalità e compromettere l’immagine, anche
sociale. Ciò comporta il vincolo, per giudici e operatori, di
14preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi
educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel
circuito penale consentendogli, per quanto possibile, di usufruire di
strumenti alternativi. Quest’ultimi possono essere: il perdono
giudiziale, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto,
prescrizioni, permanenza in casa/, sospensione del processo e messa
alla prova, tutti previsti dal d.P.R n. 488/1988.
- PRINCIPIO DI DE-STIGMATIZZAZIONE: sempre al fine di evitare
al minore il pregiudizio nel confronti della sua immagine che può
derivargli dal contatto col processo penale, l’ordinamento tende a
garantire la tutela della riservatezza e dell’anonimato rispetto alla
società esterna.
- PRINCIPIO DI RESIDUALITÀ DELLA DETENZIONE: secondo tale
principio l’ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la
carcerazione sia l’ultima e residuale opzione da applicarsi. Questa
trova applicazione in misure quali il collocamento in comunità,
misura cautelare di livello intermedio tra la permanenza in casa e la
custodia in carcere.
- PROCESSO DI AUTO SELETTIVITÀ DEL PROCESSO PENALE:
tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative
del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene
pertanto ad “autoeliminarsi”.
Determinante nell’ambito del sistema penale minorile è il concetto di
imputabilità: affinché si possa procedere penalmente nei confronti di un
minore è necessario che questi sia imputabile. L’imputabilità è
determinata dall’età del soggetto, la quale deve essere superiore ai
quattordici anni.
Ai soggetti non imputabili che siano resi responsabili di un reato,
possono essere applicate sia misure amministrative sia di sicurezza.
15Le misure di sicurezza si rivolgono a persone, ritenute pericolose
socialmente, che abbiano commesso un reato, al fine di impedirne la
recidiva. La pericolosità sociale si desume dal reato e dalla probabilità di
commissione di nuovi reati, in base alle circostanze individuate
dall’articolo 133 del codice penale, ossia la gravità del reato e la capacità
a delinquere.
Articolo 133
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente , il
giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e
da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del
colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita
del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Le misure di sicurezza sono a tempo indeterminato: la legge fissa una data
minima al cui termine vi sarà il riesame della pericolosità; se dall’esame
viene meno la pericolosità, la misura cessa, altrimenti si procede a un nuovo
esame. Le misure di sicurezza possono essere di due tipi: non detentive, la
libertà vigilata, e detentive, il riformatorio giudiziario con la modalità del
collocamento in comunità. Affinché si possa affermare la pericolosità sociale
del minore bisogna fare riferimento all’articolo 37.2 del d.P.R n. 448/1988,
secondo cui è possibile applicare una misura di sicurezza in via provvisoria
se “ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del codice penale e
16quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta
delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro
la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di
criminalità organizzata”.
Nei confronti dei minorenni la libertà vigilata è eseguita nelle forme previste
dagli articoli 20 e 21 del d.P.R n.488/1988 e la misura del riformatorio
giudiziario è applicata soltanto per i delitti previsti dall’articolo 23 ed è
eseguita nelle forme dell’articolo 22 del d.P.R n.488/1988, ossia del
collocamento in comunità.
La competenza amministrativa concerne gli interventi e le misure
applicabili ai minori di anni 18 che diano manifeste prove di irregolarità
della condotta e del carattere. Si concretizza in misure amministrative, o
definite anche rieducative, che hanno lo scopo di prevenire la commissione
di reati, in situazioni di evidente rischio, e quindi di evitare che il minore
possa incorrere nella giustizia penale. “Possono essere definite
provvedimenti di natura non penale, consistenti in trattamenti risocializzati,
educativi o terapeutici, con funzione di prevenzione speciale ante
delictum1”. È possibile che siano comunque applicate nei confronti di minori
che abbiano commesso reati, se infraquattordicenni o incapaci di intendere e
di volere.
A seguito di segnalazione il Tribunale dei Minori esplica approfondite
indagini sulla personalità del minore e dispone, se necessario, con
decreto motivato una delle seguenti misure:
- Affidamento al servizio sociale. Precedentemente al d.P.R n.
616/1977 il servizio sociale titolare di questa misura era il servizio
sociale del Ministero della giustizia; dal 1977 in poi, a seguito del
decentramento delle competenze agli enti locali, tale misura compete
al servizio sociale del Comune;
1
RICCIORRI R., La giustizia penale minorile, Cedam, Milano, 2007.
17- Collocamento in strutture residenziali ossia Comunità educative
pubbliche o convenzionate con gli enti locali. Anche in questo caso
bisogna fare riferimento al d.P.R n. 616/1977 e al relativo passaggio
di competenza nella gestione della misura all’ente locale.
Precedentemente a tal data esisteva il collocamento in casa di
rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico, strutture del
Ministero di grazia e giustizia, attualmente soppresse.
La competenza amministrativa nel nostro sistema si è connotata con un
approccio di tipo para-penale e con evidenti caratteristiche di controllo
sociale che hanno caricato le cosiddette misure rieducative di notevoli
ambiguità e contraddizioni.
La condotta irregolare del ragazzo che non sfocia in violazioni della legge
penale, più che di risposte di tipo para-penale, necessita di un sistema
articolato di interventi forse più di natura civile a sostegno e aiuto al minore
e alla famiglia.
Tali interventi non sono stati garantiti dal semplice trasferimento della
titolarità dei servizi della giustizia minorile ai servizi territoriali con il d.P.R
n. 616/1977.
La discrezionalità degli enti locali ha, infatti, comportato una risposta molto
differenziata sul territorio nazionale, nell’offerta di servizi e politiche a
favore della condizione giovanile. Il che, di fatto, ha prodotto, sulla base di
variabili di contesto socio-economico diverse, una realtà sperequata
nell’offerta di opportunità, che non ha garantito, in certe aree, alcun tipo di
servizio, o il subentro nell’intervento del servizio sociale della giustizia
minorile, su esplicita richiesta dell’Autorità Garante
Minorile.
Il codice di procedura penale minorile ha posto le basi per una
trasformazione culturale che trova fondamento nel riconoscere il soggetto
minorenne come titolare di diritti peculiari e individuo meritevole di
particolare tutela.
18Negli ultimi decenni, anche a livello internazionale e comunitario ci sono
stati degli sviluppi nell’ambito della giustizia e della tutela minorile.
In particolare, d.P.R 448/1988 anticipa di un anno la Convenzione ONU sui
Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio
1991, n. 176. I diritti sanciti dalla convenzione rappresentano il simbolo di
come tutti i dispositivi giuridici debbano porsi al servizio dei diritti dei
minori, che si fondano sul principio paritario de “il miglior interesse”. Tali
diritti valgono anche qualora un minore sia autore di reato: l’articolo 40 della
convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia chiarisce questo aspetto e
stabilisce “il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto
colpevole di aver commesso un reato, ad un trattamento tale da favorire il
suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto
per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua
età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e
di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima”.
Centrale è il tema del benessere del minore che chiama in causa un intero
sistema di diritti di cui esso è titolare, di cui quattro coincidono con quelli
che l’ordinamento penitenziario chiama “elementi del trattamento”,
intendendo il trattamento non come imposizione di comportamenti e valori in
vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità
che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e
della civile convivenza.
Tali elementi, inoltre, se, da una parte, sono quelli che, più di altri, possono
essere considerati quali strumenti per la realizzazione della personalità e il
cui mancato esercizio può compromettere gravemente l’equilibrio psico-
fisico dei soggetti entrati in conflitto con la giustizia, da un’altra, sono quelli
che forse meglio rendono l’idea di una “responsabilità” condivisa, di una
collaborazione come condizione necessaria per un positivo reinserimento
sociale che si consegue, non solo attraverso l’adozione del Ministero della
giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma attraverso
19l’assunzione di responsabilità, in questo processo, da parte di queste quelle
agenzie deputate alla presa in carico del minore. Tali diritti sono:
- DIRITTO ALLA PROTEZIONE: implica la tutela del benessere
generale e della salvaguardia della condizione psicofisica del
soggetto, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo armonioso
del minore. La limitazione della libertà di un minorenne è lecita
unicamente allo scopo di sorvegliare la sua educazione.
- DIRITTO ALLA SALUTE: la giustizia minorile e i servizi del sistema
di salute pubblica collaborano al fine di assicurare la tutela della
salute del minore, in virtù di quanto stabilito dai cambiamenti
normativi previsti dal d.P.C.M del 1 aprile 2008, che ha trasferito al
Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie e le relative risorse
finanziarie, umane e strumentali afferenti la medicina penitenziaria. Il
minore è sempre sottoposto a verifica medica, fisica e psicologica.
- DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE: sono garantiti
l’istruzione e il proseguimento degli studi. La scuola si impegna a:
organizzare percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire
l’acquisizione e il recupero delle abilità e competenze individuali. In
accordo con diverse aziende, il sistema di giustizia minorile opera per
la formazione e l’inserimento lavorativo, come opportunità di
crescita, autorealizzazione e opportunità per la persona di operare
attivamente nella società.
- DIRITTO ALLO SVAGO: come la salute, l’alloggio, il lavoro, il
riposo, l’educazione, lo svago è indispensabile alla dignità e allo
sviluppo della persona, ancorché del soggetto minorenne. Le pratiche
sportive, culturali, artistiche, formative, di rilassamento o di
divertimento costituiscono importanti fattori non solo per un
armonico sviluppo della personalità, ma anche ai fini di una positiva
integrazione sociale. Rappresentando il reinserimento nel contesto
sociale, il momento topico dell’intervento della giustizia minorile, è
20evidente come l’efficacia dell’intervento non possa non passare per
una proficua collaborazione da parte del sistema della giustizia
minorile con quelle realtà che, a livello locale, presiedono servizi
deputato allo svago.
Gioca anche a favore della necessità della tutela della condizione del minore
che entra nel circuito penale la direttiva 2016/800/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i
minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che dovrà essere recepita
dagli stati membri entro tre anni. Si tratta del primo strumento normativo
dell’Unione volto a disciplinare i procedimenti penali che vedono coinvolti
minori tenendo conto delle specificità di quest’ultimi.
Circa un milione di minori ogni anno in Europa entra formalmente in
contatto con le forze dell’ordine e con la giustizia penale. Sono molti: il 12%
del totale della popolazione coinvolta in procedimenti penali. E come tutti i
minori, ma ancor di più, proprio perché in conflitto con la legge, sono
particolarmente fragili e vulnerabili, specie nel contesto di una vicenda, il
processo, che hanno difficoltà a comprendere e decifrare. Per questo motivo,
come l’esperienza italiana ha dimostrato, un sistema giudiziario a misura di
minore è, nella maggior parte dei casi, la condizione indispensabile per il
reinserimento sociale dei ragazzi autori di reati e, quindi, ora la prevenzione
delle recidive. Una necessità, questa, alla quale l’Unione Europea ha risposto
con la nuova direttiva sulle garanzie procedurali per i minori penalmente
indagati o imputati, ponendo fine così a una diffusa disarmonia tra le
normative nazionali in questo settore. È la nascita del giusto processo penale
minorile europeo: per la prima volta viene introdotta una disciplina specifica
dei procedimenti penali nei confronti dei minori. Un grande risultato, nel
quale si riflette in buona parte il modello italiano.
La direttiva è un catalogo di diritti e garanzie procedurali elevate che colma
le distanze tra gli ordinamenti nazionali delineando un modello condiviso in
cui poter bilanciare l’esigenza di accertare i fatti di reato, con le relative
responsabilità, e quella di tenere nella dovuta considerazione gli specifici
21bisogni dei minori.
Il superiore interesse del minore è posto al centro del sistema. Sono fissati
importanti punti fermi tra i quali, innanzitutto, la necessaria assistenza di un
difensore, finora non sempre riconosciuta dalle legislazioni interne, il
principio della detenzione separata rispetto agli adulti e, ancora, la
formazione specialistica sia dei magistrati che degli altri operatori coinvolti
nel procedimento, fin qui prevista solo in sei stati membri.
La direttiva afferma anche il diritto del minore a una valutazione individuale,
il cui esito va documentato e messo a disposizione dell’autorità procedente
affinché abbia informazioni sulla personalità del minore, sulla sua
condizione familiare e socio-economica così come su tutti gli altri elementi
utili per capire quale grado di consapevolezza del reato abbia avuto, quale
misura cautelare sia più opportuna, quali siano le prospettive di rieducazione.
A tutti i minori ai quali venga applicata una qualunque restrizione della
libertà personale dovranno essere inoltre assicurati l’assistenza medica
necessaria e il diritto di incontrare prima possibile il titolare della
responsabilità genitoriale.
I governi nazionali dovranno garantire al minore anche la possibilità di
essere informato sui propri diritti e di partecipare attivamente al
procedimento. Altro elemento essenziale è l’obbligo, a carico degli stati
membri, di assicurare ai minori detenuti l’educazione, la formazione e il
regolare esercizio delle relazioni familiari, il tutto nel pieno rispetto della
libertà religiosa e di pensiero. La direttiva sul giusto processo minorile
rappresenta anche un importante passo verso l’ampliamento dello spazio
europeo di giustizia, che favorirà il mutuo riconoscimento delle decisioni
giurisdizionali tra i Paesi membri dell’Unione. Gli stati membri avranno
adesso 36 mesi di tempo, a decorrere dalla pubblicazione della direttiva in
Gazzetta ufficiale, per uniformare la normativa interna.
22LA REALTÀ ALL’INTERNO DELLE COMUNITÀ PER
MINORI
A cura di Giulia Lotti
Che cos’è la comunità per minori?
La comunità educativa per minori si propone come luogo fisico e relazionale
caratterizzato da un clima familiare, nel quale il minore possa rielaborare i
propri sentimenti e le proprie esperienze, offrendo un affiancamento affettivo
ed educativo che consenta al minore stesso di sviluppare una nuova identità.
La comunità per minori è un servizio educativo - assistenziale che ha il
compito di accogliere il minore, qualora il nucleo famigliare sia
impossibilitato o incapace a garantire il benessere e i bisogni, anche primari,
del ragazzo. Essa si rivolge quindi a minori in situazioni di disagio sociale,
familiare e personale, in condizioni di precarietà e fragilità affettiva e
relazionale, tali da compromettere un'evoluzione personale equilibrata ed
armonica. La comunità, oltre ad essere un luogo “protetto”, in quanto
assicura al minore protezione e tutela, è anche un luogo “esposto” a rischio
poiché è inserito in un contesto rappresentato dalle aspettative dei soggetti in
gioco. Primi fra tutti i bambini, che molto spesso formulano delle idee non
positive sulla comunità in cui sono inseriti, individuandola come luogo di
punizione.
Poi ci sono i genitori: alcuni si mostrano favorevoli alle comunità e le
vedono come luoghi di aiuto non solo per i figli, ma anche per loro stessi;
altri invece le considerano come luoghi negativi e inappropriati specie
quando ad essere intaccata è la loro capacità genitoriale.
Non ultimi ci sono gli operatori: educatori, psicologi, assistenti sociali,
giudici, neopsichiatri che devono affrontare quotidianamente delle serie di
problematiche relazionali, burocratiche ed educative.
23Nelle Comunità si assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-
bis, 22, 36 e 37 del d.P.R 448/88. I principi fondamentali su cui si basa il lavoro
delle Comunità ministeriali sono la promozione delle risorse personali,
familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la
permanenza del minore all’interno della struttura e l’importanza di favorire
attività formative, ricreative, ecc., in ambienti esterni alla struttura. Alla luce
di tali principi, gli obiettivi fondamentali del collocamento presso le Comunità
sono:
• stabilire un programma educativo destinato al minore che tenga presente
tanto delle sue esigenze quanto delle sue risorse personali, familiari e sociali;
• favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla
misura restrittiva della libertà personale;
• individuare e valorizzare le risorse del minore;
• offrire al giudice informazioni che contribuiscano ad una scelta conforme il
più possibile alle esigenze educative del ragazzo;
• preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l’eventuale invio
ad altre strutture;
• restituire il minore al suo contesto sociale.
Secondo quando affermato dal d.lgs. 272, 1989, le Comunità devono rispettare
i seguenti criteri fondamentali relativi alla gestione:
• organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni
non sottoposti a procedimento penale (con capienza di massimo dieci unità,
limite che facilita e garantisce una conduzione e un clima educativamente
significativi);
24• presenza di operatori professionali specializzati in diverse discipline
(assistenti sociali, mediatori culturali, ecc.), che accompagnino e sostengano
il minore durante il proprio percorso;
• capacità di collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzo delle
risorse del territorio;
• Attuazione di progetti educativi individualizzati (PEI).
I criteri per l’individuazione della struttura sono:
- Le indicazioni dell’Autorità Giudiziaria;
- La residenza del nucleo familiare (territorialità);
- La continuità del trattamento;
- Le caratteristiche del minore e della struttura;
- La disponibilità dei posti nelle strutture
L’ingresso del minore in comunità è obbligatoriamente accompagnato da una
documentazione che attesta la sua precedente esperienza al fine di garantire
una certa continuità del percorso all’interno del circuito penale.
L’inserimento del ragazzo è seguito dalla definizione di un “Progetto
Educativo Individualizzato” (P.E.I.): si tratta di un piano educativo che viene
stilato prestando attenzione alla personalità del minore e alla valorizzazione
dei processi di responsabilizzazione e risocializzazione del ragazzo, nonché
nel rispetto della garanzia dei suoi diritti ed esigenze educative. Il progetto,
elaborato dopo un’attenta osservazione del minore nella sua globalità, dovrà
indicare:
• gli obiettivi che il minore deve raggiungere
• le attività che dovrà svolgere
• le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività
25• le modalità di verifica, utili all’Autorità giudiziaria.
Attualmente le comunità del privato sociale accolgono la maggior parte dei
giovani sottoposti a misure penali minorili, con particolare riferimento alle
misure cautelari e alle messe alla prova, connotandosi sempre più come un
servizio funzionale ai bisogni dei ragazzi e della magistratura minorile. Le
comunità del privato sociale riflettono inevitabilmente una forte articolazione
legata alla specificità dei contesti territoriali e alla diversità valoriale e/o
organizzativa delle stesse che genera una forte differenziazione nel territorio.
Allo scopo di offrire una corretta visuale del lavoro occorre preliminarmente
porre in evidenza una delle criticità insite nel settore dell’accoglienza dei
minorenni in comunità che sono emerse nel corso dell’osservazione del
fenomeno.
Con riferimento alla diversa denominazione che le strutture di accoglienza
per i minorenni ricevono sul territorio nazionale, si rileva che l’articolo 2
della legge n. 184 del 1983, individua un’unica tipologia di presidio idonea
ad accogliere i minorenni, qualificata come “comunità di tipo familiare”,
caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
Articolo 2 legge n. 184/1983
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1,
è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
26preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche
senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni, nell'àmbito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità
di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi
Tuttavia, a fronte di questa unica e generica classificazione, si rinvengono, in
atti normativi, sia nazionali che regionali, altre tipologie di strutture, il più
delle volte prive di una correlata univoca definizione. Ciò si verifica, ad
esempio, per i “gruppi appartamento” richiamati, insieme alle “comunità di
tipo familiare”, nel decreto del Ministero per la solidarietà sociale n. 308, del
21 maggio 2001, ove trovano menzione anche le “strutture a carattere
comunitario”.
Un importante tentativo di catalogazione delle strutture residenziali è
rappresentato dal “Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi
sociali”, realizzato nel 2009 e giunto, nel 2013 alla sua seconda versione.
Tuttavia, sebbene tale strumento classifichi le diverse tipologie di presidi
27“familiari”, non si è ancora giunti alla unificazione delle definizioni adottate
nei diversi ambiti territoriali e, in particolare, anche con riferimento alla più
diffusa dicitura di “casa famiglia”, si registra tuttora la mancanza di una
definizione univoca e della sua menzione nel citato nomenclatore.
Prescindendo delle differenti nomenclature è comunque utile, a fini pratici,
ricondurre le tipologie di strutture di accoglienza esistenti a tre macro-
tipologie di comunità di accoglienza residenziale, in ragione delle
caratteristiche strutturali che le connotano. Una simile attività è stata
intentata dal Gruppo di lavoro sulle comunità di tipo familiare, istituito
nell’ambito della Consulta delle associazioni e delle organizzazioni,
presieduta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, nel cui
contesto è stata proposta la seguente classificazione:
– COMUNITÀ FAMILIARI/CASA FAMIGLIA: caratterizzate dalla presenza
stabile di adulti residenti (famiglia, coppie, educatori residenti) – comunità
educative/socio-educative, caratterizzate da operatori/educatori che non
abitano in comunità ma che sono presenti con modalità “a rotazione”
–COMUNITÀ SOCIO-SANITARIE: siano esse comunità familiari/case
famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla complementarietà delle
funzioni socio-educative e terapeutiche assunte da operatori professionali e a
titolarità compartecipata tra la competenza sociale e sanitaria.
I soggetti destinatari del servizio educativo
Quando si parla delle comunità per minori, i primi soggetti destinatari del
lavoro educativo sono i minori stessi. In realtà, il servizio di comunità non si
rivolge unicamente ai minori, ma si interessa anche alle loro famiglie e ai
genitori.
28È da questa premessa che possiamo dividere i destinatari di questi servizi
educativi in soggetti diretti e indiretti.
Chiameremo diretti i minori che sono interamente coinvolti nelle attività
quotidiane delle comunità, che passano la maggior parte del tempo
all’interno di questi servizi o che vi vivono stabilmente.
I soggetti indiretti, invece, possono essere individuati nei genitori e nelle
famiglie di questi ragazzi, in quanto, gli operatori ed educatori non hanno
rapporti quotidiani con loro, ma periodicamente hanno degli incontri
finalizzati all’obbiettivo educativo, per le comunità in cui i minori sono
inseriti temporaneamente, di ristabilire un legame solito e “sano” tra genitori
e figli che permetta una continuità della crescita armonica del ragazzo. In
quest’ottica, le strutture di servizio possono assumere, nei riguardi delle
famiglie, diversi tipi di atteggiamento:
a) Il rapporto con le famiglie può essere inesistente: gli operatori del servizio
guardano, in questo caso, agli utenti, i minori, come soggetti avulsi da un
contesto relazionale familiare; si punta unicamente all’aspetto tecnico, cioè a
garantire determinate prestazioni, prescindendo dai legami affettivi dei
bambini. Questo può determinare o una rigidità del servizio, contrassegnato
in certi casi da una progettualità che non tiene minimamente conto della vita
reale degli utenti, oppure, al contrario, uno svuotamento dei contenuti degli
interventi attuati dal servizio, conseguenza della deresponsabilizzazione di
quest’ultimo dall’assoluta mancanza di un confronto con la famiglia.
b) Il rapporto con le famiglie può essere poco influente: in questo caso alla
famiglia viene riconosciuto nei confronti del bambino un ruolo significativo,
ma operante in un ambito diverso e parallelo rispetto a quello sociale,
cosicché il servizio concepisce il proprio intervento come aggiuntivo rispetto
a quello della famiglia; un rapporto in cui ognuno fa la sua parte.
In questa prospettiva alla famiglia viene restituita una funzione e può esservi
29una relazione con il servizio, ma si esclude l’idea di un dialogo costruttivo
tra i due contesti.
c) Un rapporto di interazione tra famiglia e servizio è quello che meglio
può garantire un percorso di crescita e di autonomia del bambino e della
bambina. Secondo quest’ottica ogni intervento non si esaurisce in se stesso,
ma è sempre parte di un più ampio sistema di relazioni. Così come nella
“vita sociale” i bambini portano se stessi con tutti i legami per loro più
significativi, allo stesso modo, nel ritornare in famiglia essi determineranno
in quell’ambiente delle trasformazioni, dovute al fatto che la loro crescente
autonomia, per le esperienze vissute all’esterno, solleciterà i familiari a
modificare i propri comportamenti.
Il servizio sarà allora spinto a progettare interventi non semplicemente sulla
base di ciò che si ritiene utile per l’utente, ma anche sulla base dei messaggi
che arrivano dalla famiglia. In questo senso la consapevolezza che un
servizio offerto ad un individuo abbia una ripercussione non indifferente
sulla sua storia familiare dovrebbe essere per gli operatori un incentivo ad
operare con maggiore senso di responsabilità e, contemporaneamente, ad
avere uno sguardo più ampio, un atteggiamento meno burocratico e più
aperto alle diverse esigenze legate alla sensibilità infantile
Creare dei progetti su una base di maggiore flessibilità senza compromettere
la professionalità non è sempre facile: è più semplice puntare sulle “cose da
fare” e sulle tecniche da adoperare, piuttosto che curare le relazione umane,
che impongono in molti casi di rimettere in gioco i propri schemi operativi.
Chi lavora quotidianamente con bambini sa quanto l’attenzione e la
disponibilità data alle famiglie si rifletta positivamente non solo sulla “salute”
del bambino, ma anche sull’andamento delle attività e sul clima complessivo
30Puoi anche leggere