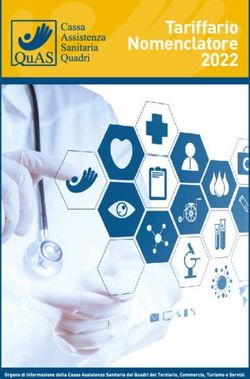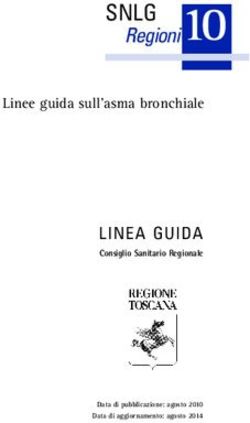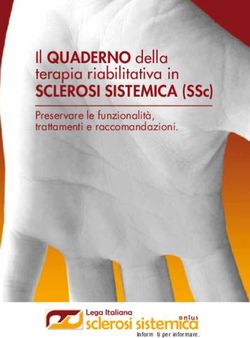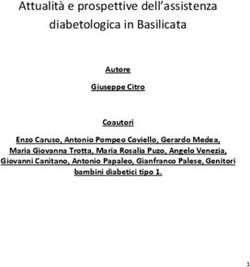Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Capitolo 7
Il trattamento farmacologico
della schizofrenia, delle
comorbidità e delle forme
resistenti
Casi clinici
Giulia è una ragazza di 30 anni che da circa 6 mesi si è trasferita in un’altra città dove
lavora come architetto. In anamnesi, emerge un episodio psicotico dalla diagnosi poco
chiara, avvenuto circa 3 anni fa, trattato con successo con aripiprazolo. A causa dello
stress dovuto al trasloco e al nuovo ambiente lavorativo cominciano a insorgere i primi
sintomi: diventa sospettosa e crede che il nuovo datore di lavoro la voglia licenziare e
che parli sempre male di lei. Il quadro si aggrava e viene ricoverata presso il centro di
salute mentale, dove viene impostata una terapia con olanzapina. I sintomi recedono
e dopo circa 4 settimane Giulia può tornare alla sua vita. Tuttavia, dopo 3 mesi di
trattamento è aumentata di peso di circa 8 kg e non riesce a dimagrire; decide quindi
di diminuire il dosaggio di olanzapina e di interrompere la terapia, fino a quando non
deve essere di nuovo ricoverata d’urgenza. Questa volta la degenza è più lunga e il
recupero più lento. Il datore di lavoro non le rinnova il contratto e Giulia è costretta a
tornare presso la sua città di origine perché non può più mantenersi da sola.
Marco ha 17 anni e frequenta il liceo. Da circa 2 anni fa uso moderato ma regolare
di cannabis e ha uno zio con diagnosi di disturbo schizoaffettivo. Da circa un anno i
genitori riferiscono un progressivo cambiamento del carattere del ragazzo, che passa
sempre più tempo da solo chiuso in camera, appare cupo e taciturno, a volte molto
ansioso, senza alcun apparente motivo. Gli insegnanti riportano un netto deteriora-
mento del rendimento scolastico e del funzionamento sociale. In seguito a un episodio
161
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 161 16/03/15 11:49162 Capitolo 7
di ansia acuta e agitazione psicomotoria i genitori decidono di contattare il medico di
famiglia, che non ritiene necessario un ulteriore monitoraggio e prescrive benzodiaze-
pine al bisogno.
Nei mesi successivi il quadro peggiora progressivamente, il ritiro sociale di Marco di-
venta completo e compaiono episodi di labilità dell’umore e sospettosità. Il curante
decide di prescrivere al ragazzo una visita specialistica, ma i genitori ritengono che la
situazione sia da attribuire agli stress scolastici e rinviano la valutazione. Dopo circa un
mese, si assiste alla comparsa di allucinazioni uditive e sintomi psicotici franchi e Marco
viene ricoverato d’urgenza presso i servizi psichiatrici di zona.
Le attuali linee guida, incluse quelle dell’APA (APA, 2010), propongono per la cura dei
pazienti con schizofrenia tre maggiori pilastri della terapia:
1. la terapia farmacologica;
2. gli interventi psicosociali;
3. la terapia metabolica.
Un recente studio (Cullen et al., 2013) ha mostrato come il trattamento farmacologico
sia associato a un incremento dell’aspettativa di vita dei pazienti con schizofrenia. Siamo
consapevoli degli effetti metabolici e del fatto che alcuni trattamenti possono incremen-
tare i meccanismi apoptotici a livello neuronale. È quindi particolarmente importante il
dato di questo studio che fa vedere come migliori non solo la qualità ma proprio l’aspet-
tativa di vita. Per quanto riguarda gli interventi psicosociali, si rimanda alla trattazione
specifica nei corrispondenti capitoli di questo volume.
In questa sede, ci sembra necessaria una breve premessa sulla terapia metabolica. Oggi si
considerano gli aspetti metabolici e tutte le patologie correlate (diabete, disturbi cardio-
vascolari ecc.) perché l’epidemiologia ha mostrato come:
• questo sia uno dei maggiori effetti negativi dei trattamenti nei nostri pazienti;
• ci siano, pertanto, delle linee guida sulla prevenzione della sindrome metabolica con
esami e misurazioni da ripetere ogni 3 mesi (profilo lipidico, misurazione circonfe-
renza vita ecc.);
• l’esercizio fisico aerobico rappresenti una concreta risorsa per il miglioramento del
funzionamento cognitivo, poiché si associa a un incremento volumetrico cerebrale
di strutture quali l’ippocampo e mostra una specificità per la schizofrenia rispetto ad
altri disturbi psichiatrici (Pajonk et al., 2010; Oertel-Knöchel et al., 2014) (Box 7.1).
Sono trascorsi ormai oltre 60 anni dalla sintesi del primo farmaco antipsicotico, la clor-
promazina, nel 1951. La sua sintesi è avvenuta in epoca precedente alla scoperta dei
meccanismi di funzionamento del sistema dopaminergico, tuttavia la clorpromazina si è
dimostrata fin da subito particolarmente efficace, più di qualsiasi altro farmaco fino ad
allora disponibile, e pertanto venne impiegata prima negli stati di agitazione e succes-
sivamente nella patologia schizofrenica (Ban, 2007). Oggi conosciamo molto più della
neurobiologia di quanto i farmaci ci permettono di creare, motivo per cui assistiamo
a un radicale cambiamento nello sviluppo delle nuove terapie farmacologiche. Da una
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 162 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 163
BOX 7.1
EFFETTI DELL’ESERCIZIO FISICO NELLA PATOLOGIA
SCHIZOFRENICA
• Rispetto alla baseline, il volume ippocampale è incrementato, a seguito dell’esercizio
fisico aerobico, del 12% fra i pazienti e del 16% nei soggetti sani, rispetto a un
decremento dell’1% nei soggetti che hanno fatto esercizio fisico.
• I cambiamenti nel volume ippocampale riscontrati nel gruppo di soggetti che ha
fatto esercizio erano significativamente correlati (r = 0,71 e P = 0,003) con una miglior
prestazione fisica, misurata con il cambiamento del consumo massimo di ossigeno.
• Nei pazienti che hanno fatto esercizio fisico, il cambiamento di volume ippocampale
era associato a un incremento del 35% nel rapporto N-acetilaspartato/creatina,
risultato significativo con analisi post-hoc (P = 0,04). Questi cambiamenti non sono stati
riscontrati nei controlli.
• Nei pazienti, i miglioramenti nella memoria a breve termine erano correlati (r = 0,51 e
P < 0,05) con i cambiamenti nel volume ippocampale.
(Pajonk et al., 2010)
• Gli effetti dell’esercizio fisico aerobico sono stati comparati in due gruppi di soggetti
con disturbo depressivo maggiore (MDD) e schizofrenia (SZ).
• I risultati mostrano un incremento della performance cognitiva nei domini
dell’apprendimento visivo, la memoria di lavoro e la velocità di processazione, una
diminuzione dei livelli di ansia e un incremento della qualità di vita soggettivamente
percepita in tutto il gruppo di pazienti (sia MDD sia SZ) rispetto ai controlli.
• Gli effetti cognitivi tuttavia sono risultati maggiori per i soggetti SZ rispetto ai soggetti
MDD, i quali invece mostravano effetti maggiori nei valori indicanti la psicopatologia.
(Oertel-Knöchel et al., 2014)
terapia strettamente sintomo-specifica si è giunti a una terapia fase-specifica (per
esempio, la supplementazione con acidi grassi polinsaturi nella fase prodromica), con
obiettivi diversi, quali la riduzione o il ritardo nell’espressione del disturbo o delle sue
conseguenze, oppure l’intervento sugli aspetti neurofunzionali o su altre aree specifiche.
Date queste premesse, ciò che diviene evidente è il cambiamento nella strategia di ricerca
dei nuovi farmaci: in questo capitolo poniamo l’accento non tanto sull’utilizzo off-label
di alcuni farmaci, quanto più sulle modalità attraverso le quali si è giunti a proporre
l’utilizzo di quei farmaci in un disturbo completamente diverso da quello per cui erano
stati sintetizzati. Queste nuove strategie di ricerca farmacologica atte a fornire un trat-
tamento sempre più specifico e individualizzato sembrano rappresentare un approccio
promettente nell’ambito della psicofarmacologia.
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 163 05/03/15 10:51164 Capitolo 7
Il primo composto ad azione antipsicotica fu sintetizzato nei primi anni Cinquanta del
secolo scorso. La scoperta della molecola avvenne in maniera casuale: fino agli anni
Quaranta, le fenotiazine venivano usate come antimalarici e antisettici, fino a quando nel
dopoguerra, presso i laboratori della Rhône-Poulenc nell’ambito di ricerche su composti
antistaminici venne sintetizzata la clorpromazina. Durante successive ricerche per valu-
tare l’impiego del farmaco come antishock in ambito anestesiologico, i ricercatori dell’e-
poca si accorsero delle proprietà sedanti e antipsicotiche del farmaco, dovute al blocco
dei recettori D2, e la molecola diventò in poco tempo il trattamento d’elezione per tutta
una serie di condizioni, quali schizofrenia, eccitamento maniacale, agitazione psicomo-
toria e psicosi non meglio definite. La nascita di questo nuovo filone della farmacologia
ha portato nei decenni successivi alla chiusura dei manicomi, in primis in Italia, all’inizio
di un modello di cura all’interno della comunità e a una forte riduzione delle ospedalizza-
zioni e dei ricoveri, sia volontari sia coatti.
A partire dalla clorpromazina vennero poi sintetizzati altri composti con proprietà (nel
bene e nel male) molto simili, ai tempi definiti come “neurolettici”, e che adesso rientrano
nella categoria dei cosiddetti farmaci antipsicotici “di prima generazione”, o “tipici”.
Un’altra importante svolta nello sviluppo di questi farmaci avvenne intorno al 1970,
quando fu introdotta sul mercato la clozapina, una molecola con proprietà marcata-
mente differenti rispetto ai “neurolettici” già esistenti e altamente efficace, ma che a
causa di effetti collaterali potenzialmente gravi venne dopo poco ritirata dal commercio.
Fu “riabilitata” solo dopo diversi anni ed è adesso considerata il farmaco più efficace nel
trattamento dei casi resistenti alla terapia.
Tuttavia, grazie proprio al suo particolare profilo funzionale, la clozapina fu la caposti-
pite di una nuova classe di antipsicotici, che vennero quindi definiti “di seconda genera-
zione”, o “atipici”, teoricamente più efficaci e con meno effetti collaterali, aspettative che
sono state almeno parzialmente disattese nel corso degli anni successivi.
Più recentemente i ricercatori hanno cominciato a focalizzarsi su altre dimensioni del
disturbo, come per esempio i deficit cognitivi, e ai sottostanti circuiti, in particolare il
recettore NMDA per il glutammato e le sue sub-unità, che sembrano essere particolar-
mente coinvolti nei deficit di attenzione e concentrazione presenti nei pazienti schizo-
frenici (vedi il Capitolo 9), portando a un ulteriore cambio di prospettiva e superando,
almeno concettualmente, la distinzione fra antipsicotici di prima e seconda generazione,
introducendo l’idea di un trattamento individualizzato del disturbo, grazie a un utilizzo
multimodale del farmaco e legato più alle proprietà farmacodinamiche dello stesso che
alla categoria di appartenenza.
Una trattazione dettagliata di ogni singolo composto è al di là degli scopi di questa
pubblicazione e in questo capitolo verranno quindi riportati solo i concetti di carattere
generale che sono utili e propedeutici alla comprensione di un modello di trattamento
che va oltre la “neurolettizzazione” del paziente e che punta invece a un approccio indivi-
dualizzato e centrato sulle caratteristiche non solo del disturbo, ma anche del soggetto.
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 164 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 165
Il meccanismo d’azione dei farmaci
antipsicotici: dalla clorpromazina
all’aripiprazolo
Il meccanismo di azione dei cosiddetti antipsicotici di prima generazione (vedi Tabella 7.1
per una lista dei composti) nel controllo dei sintomi psicotici è relativamente semplice e
si basa sul blocco dei recettori della dopamina D2 nella via mesolimbica. Tuttavia, poiché
questi recettori sono presenti non solo all’interno di tale circuito, ma anche in quasi tutte
le restanti aree raggiunte dalle vie dopaminergiche, il blocco unilaterale e non modulato
di questo tipo di composti porta all’insorgenza di un elevato tasso di effetti collaterali,
i più importanti dei quali a livello del sistema di gratificazione (reward) e del sistema
motorio.
I sistemi dopaminergici mesolimbico e mesocorticale, che mettono in comunicazione
strutture come l’area tegmentale ventrale, il nucleus accumbens, la corteccia prefrontale
(PFC) e del cingolo sono ritenute essere la base neurobiologica del sistema motivazionale
e di rinforzo e mediano la risposta dell’individuo a un’ampia gamma di stimoli. Il rilascio
di dopamina all’interno di queste strutture porta non solo a esperire tali stimoli come
piacevoli, ma anche, grazie a modificazioni della plasticità sinaptica, a indurre importanti
modificazioni nei processi di apprendimento e memoria legati alla presenza di incentivi
comportamentali. L’interferenza delle molecole dopamina-antagonisti a questo livello,
in particolare quelle che causano un blocco massivo e non facilmente regolabile del rila-
scio di dopamina, possono essere causa di disfunzione all’interno di questi circuiti, che
a livello comportamentale si riflettono come perdita di interesse in attività solitamente
gratificanti, abulia, anedonia.
A livello motorio, invece, gli effetti dell’antagonismo dei recettori D2 sono dovuti a
un’interferenza con il normale funzionamento nella via dopaminergica nigro-striatale,
causando quelli che vengono definiti comunemente “sintomi extrapiramidali” (i sistemi
piramidale ed extrapiramidale sono un insieme di centri e vie nervose deputate al
Tabella 7.1 I più importanti farmaci antipsicotici in commercio
in Italia
Antipsicotici “tipici” Antipsicotici “atipici”
Clorpromazina Clozapina
Levomepromazina Olanzapina
Perfenazina Risperidone
Aloperidolo Quetiapina
Droperidolo Ziprasidone
Zuclopentixolo Amisulpride
Aripiprazolo
Asenapina (non ancora approvata in Europa
per il trattamento della schizofrenia)
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 165 05/03/15 10:51166 Capitolo 7
Tabella 7.2 I vari tipi di recettori ed effetti collaterali correlati
Recettore Evento avverso
a1 Ipotensione
D2 Distonie, parkinsonismo, aumento di prolattina,
disfunzioni sessuali, apatia
H1 (recettori dell’istamina) Sedazione, aumento di peso
M1-4 (recettori dell’acetilcolina) Vista sfuocata, bocca secca, confusione, stipsi, sedazione
controllo del movimento), che assomigliano molto spesso ai disordini causati dal morbo
di Parkinson, come acinesia, acatisia, tremori. In aggiunta a ciò, il blocco prolungato di
tali recettori può portare a una condizione chiamata discinesia tardiva, un disordine
ipercinetico caratterizzato da movimenti involontari di lingua, bocca, faccia e arti, che
in molti casi di trattamento cronico (mesi/anni) si rivela irreversibile. L’insorgenza di
galattorrea (produzione di secrezioni mammarie) e amenorrea è invece dovuta all’inter-
ferenza con il funzionamento della via tubero-infundibolare.
Oltre a essere attivi sul sistema della dopamina, gli antipsicotici di prima generazione
esercitano il loro effetto anche su altri recettori (in maniera diversa a seconda della mole-
cola), come quelli colinergici, istaminici, o a-adrenergici, causando importanti effetti
collaterali, riportati nello specifico in Tabella 7.2.
Conseguentemente, visto il meccanismo d’azione poco differenziato, la gestione della
terapia antipsicotica con questo tipo di farmaci è semplicemente basata sull’aumento o
sulla diminuzione del dosaggio, in modo da agire velocemente sui sintomi psicotici (a
volte solo in maniera parziale) attraverso un blocco massivo della trasmissione dopami-
nergica. Allo stesso tempo, però, l’insorgenza di gravi effetti collaterali ha un impatto
negativo sulla qualità della vita del paziente, che si riflette poi inevitabilmente sull’ade-
renza al trattamento.
L’avvento degli antipsicotici di “seconda generazione”, dal meccanismo d’azione più arti-
colato, ha portato un aumento di complessità nella pianificazione terapeutica, nono-
stante le aspettative originarie, quali minore insorgenza di effetti collaterali extrapira-
midali e un miglior controllo della sintomatologia negativa, siano state sostanzialmente
disattese (Carpenter e Buchanan, 2008) e anche a livello di efficacia globale le due gene-
razione di antipsicotici siano poco differenti (Kahn et al., 2008).
Molti studi di comparazione diretta fra due molecole diverse, infatti, riportano risultati
contradditori, dando l’idea che tutti i farmaci funzionino in maniera analoga e abbiano
efficacia simile. Tuttavia, vi sono una serie di bias all’interno di questi lavori che possono
portare a questi risultati, come per esempio i criteri d’inclusione, i dosaggi utilizzati,
i metodi di analisi statistica dei dati e, infine, anche l’origine dei finanziamenti per il
compimento dello studio (Heres et al., 2006); l’esperienza clinica ci dice che la maggior
parte dei pazienti molto spesso può rispondere a un farmaco e non rispondere a un altro,
in base al pattern di sintomi presentati e alle eventuali comorbidità o predisposizioni a
effetti collaterali (Leucht et al., 2009; Rummel-Kluge et al., 2010).
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 166 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 167
“Atipicità” di un antipsicotico
• Affinità per recettori serotoninergici (5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C)
• Affinità per recettori dopaminergici D3 e D4
• Antagonismo parziale a livello di recettori D2
FIGURA 7.1 Caratteristiche che rendono un antipsicotico “atipico”.
Pertanto, la distinzione tradizionale in composti “tipici” o “atipici” è attualmente da rite-
nere superata, favorendo un algoritmo di utilizzo di tali farmaci dettato esclusivamente
dalle proprietà farmacodinamiche e farmacocinetiche, quindi in sostanza dal profilo
recettoriale e da quello degli effetti collaterali, da valutare in ogni singolo paziente.
Tuttavia, in questo paragrafo, per comodità di esposizione, saranno ancora mantenute
queste definizioni, fatto salvo per quanto espresso sopra.
Per essere definita “atipica” (Fig. 7.1), una molecola deve influire non solo sul sistema
dopaminergico, ma anche su quello serotoninergico, in particolare su alcuni sottotipi
di recettori (per esempio 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C). Il meccanismo d’azione e l’intera-
zione fra la serotonina e i suoi recettori sono estremamente complessi e un’esposizione,
anche solo parziale, è aldilà degli scopi di questo capitolo. Tuttavia, è possibile affermare
che un’azione a questo livello ha una sorta di effetto modulatorio sulle varie vie dopami-
nergiche, poiché permette di ottenere risultati terapeutici senza una completa satura-
zione dei recettori coinvolti (D2), quindi di utilizzare dosaggi “inferiori” (in termini asso-
luti), e limitare o ridurre l’insorgenza e la gravità degli effetti collaterali. Un’altra carat-
teristica degli antipsicotici più moderni è quella di legarsi al recettore dopaminergico
in maniera più “blanda” e di dissociarsi da esso più velocemente rispetto alle molecole
“tipiche”, oppure di avere proprietà bloccanti e attivanti allo stesso tempo, il cosiddetto
“agonismo parziale”. Ciò fa sì che gli effetti collaterali dovuti a un’interruzione massiva
della trasmissione dopaminergica si instaurino con meno frequenza.
Come già sottolineato sopra, pur non avendo portato a cambiamenti epocali in termini
di efficacia assoluta, l’avvento di farmaci dal profilo “multifunzionale” – un farmaco con
più di un’azione farmacologica terapeutica (Stahl, 2009) ha modificato comunque in
maniera molto importante l’approccio alla gestione terapeutica, da un lato aumentando
la complessità delle valutazioni da fare prima di impostare un trattamento e dall’altro
spostando l’attenzione dalla pura e semplice estinzione del sintomo psicotico “a ogni
costo” alla considerazione della qualità di vita del paziente e agli aspetti soggettivi della
terapia farmacologica.
In particolare, le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche, i più frequenti effetti
collaterali, le interazioni con altri farmaci della molecola in questione, nonché le even-
tuali comorbidità del singolo paziente, sono i parametri che devono fare da guida per
l’impostazione di una corretta terapia farmacologica.
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 167 05/03/15 10:51168 Capitolo 7
Farmacocinetica e farmacodinamica
degli antipsicotici
I concetti di farmacodinamica e farmacocinetica sono alla base della farmacologia clinica
e le caratteristiche di un farmaco relative a essi sono determinanti per comprenderne il
meccanismo di funzionamento e predirne l’efficacia in ogni singolo paziente.
In breve, la farmacodinamica studia gli effetti biochimici e il meccanismo d’azione dei
farmaci, identificando i siti d’azione e delineando le interazioni chimiche e fisiche fra
il farmaco e l’organismo, o fra farmaci diversi: rappresenta, per essere più chiari, come
agisce il farmaco sull’organismo (in particolare sui recettori del SNC) (Fig. 7.2).
La farmacocinetica, invece, studia in maniera quantitativa come il farmaco viene assor-
bito, distribuito, metabolizzato e, poi, eliminato dall’organismo: ovvero, come l’orga-
nismo agisce sul farmaco. Ogni composto, anche se appartenente alla stessa classe, o
sottoclasse, possiede caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche spesso parec-
chio differenti, ed è implicito quindi che la reazione individuale a esso è, entro certi
limiti, variabile.
Per quanto concerne il trattamento delle psicosi, la valutazione di questi aspetti è di
primaria importanza nella scelta di un farmaco, ben di più della scelta dicotomica fra
antipsicotici di “prima” o “seconda” generazione.
I profili recettoriali di alcuni dei più importanti antipsicotici sono elencati nella Tabella 7.3.
Eventuali effetti collaterali e, in misura minore, l’efficacia di una molecola possono essere
previsti tenendo in considerazione la sua affinità per i vari sottotipi di recettori. Per
esempio, farmaci con una grande affinità per il recettore D2 necessitano di dosi minori
per raggiungere l’effetto terapeutico (Lako et al., 2013), ma allo stesso tempo possono
causare sintomi extrapiramidali con più facilità: fra questi ci sono aloperidolo, perfe-
nazina, risperidone, aripiprazolo. Tuttavia, questo non è l’unico fattore a determinare
la probabilità dell’insorgenza di tali effetti. La velocità di dissociazione del farmaco dal
recettore D2 può essere una caratteristica in grado di conferire alla molecola un profilo
migliore a livello di effetti collaterali e, per un certo tempo, essa è stata attribuita in
particolare agli antipsicotici di seconda generazione, tuttavia dati recenti non suppor-
tano questa interpretazione (Sahlholm et al., 2014). L’antagonismo spiccato verso altri
recettori come quelli della serotonina (5-HT2A), o quelli muscarinici e istaminici, tende
Farmacocinetica Farmacodinamica
Studia in maniera quantitativa come il farmaco Studia gli effetti biochimici e il meccanismo
viene assorbito, distribuito, metabolizzato e, d’azione dei farmaci, ovvero come agisce il farmaco
poi, eliminato dall’organismo: ovvero, come sull’organismo.
l’organismo agisce sul farmaco.
FIGURA 7.2 Farmacocinetica e farmacodinamica.
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 168 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 169
Tabella 7.3 Profili recettoriali dei diversi antipsicotici
D2 5-HT1A 5-HT2A 5-HT2C `1 M1 H1
Amisulpride
Aripiprazolo 0,66 5,5 8,7 22 26 > 1000 30
+++ (AP) +++ ++ ++ ++ + ++
Asenapina +++ +++ ++ ++++ +++ + +++
Clozapina 210 160 2,6 4,8 6,8 1,4 3,1
+ + ++ ++ +++ +++ +++
Olanzapina 20 610 1,5 4,1 44 2,5 0,1
++ +++ ++ ++ ++ +++
Quetiapina 770 300 31 > 1000 8 120 11
+ + ++ + +++ ++ +++
Risperidone 3,8 190 0,15 32 2,7 > 10.000 5,2
+++ + ++++ ++ +++ ++
Ziprasidone 2,6 1,9 0,1 0,9 2,6 300 4,6
+++ ++ ++++ ++ ++ ++
Aloperidolo 2,6 > 1000 61 > 1000 17 > 10.000 260
+++ ++ ++ +
Valori di Ki espressi in Nmol: + = affinità bassa (100 < Ki < 1000); ++ = affinità media (10 < Ki < 100); +++ = affinità alta (1 <
Ki < 10); ++++ = affinità molto alta (Ki < 1); AP = agonista parziale.
a mitigare, almeno in parte, il blocco dei recettori dopaminergici e quindi a ridurne il
rischio. Questo è vero in particolare per olanzapina, quetiapina, clozapina, a dosaggio
moderato. Anche l’aripiprazolo, nonostante si leghi fortemente ai recettori D2, in virtù
del suo profilo di agonista parziale, che consente al recettore di mantenere una certa
funzionalità, pare ottenere un risultato analogo.
Le differenze farmacodinamiche e di profilo/affinità recettoriale possono diventare clini-
camente molto rilevanti in caso di passaggio non graduale da un antipsicotico a un altro,
e non devono essere in alcun modo trascurate; in seguito a un antagonismo potente,
i recettori interessati tendono ad aumentare di numero (“upregulation”), e se tale
blocco viene rimosso in maniera improvvisa si possono causare fenomeni di astinenza o
“rebound” (i sintomi ricompaiono, a volte potenziati, in seguito alla brusca interruzione
della terapia). Questo è particolarmente vero in caso di trattamento con molecole dalla
potente azione colinergica o antistaminergica, quindi con uno spiccato effetto sedativo e
modulante a livello motorio, per esempio clozapina, olanzapina, quetiapina; il passaggio
non graduale da questi ad altri composti con profilo recettoriale quasi opposto, quali
risperidone, ziprasidone, aripiprazolo, può causare un’attivazione eccessiva dei recettori
ipersensibilizzati e, quindi, può provocare l’insorgenza di insonnia, ansia, agitazione
psicomotoria, acatisia, sintomi extrapiramidali. Allo stesso modo, il passaggio da un
farmaco con spiccate proprietà antidopaminergiche, per esempio aloperidolo, risperi-
done, ad altri con minore affinità (clozapina, quetiapina) può essere causa di un blocco
meno intenso dei recettori D2, già ipersensibilizzati, e si può assistere alla ricomparsa
di sintomi psicotici, maniacali, agitazione e aggressività. Per una visione più dettagliata
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 169 05/03/15 10:51170 Capitolo 7
delle affinità recettoriali, degli effetti collaterali e dei dosaggi equivalenti dei diversi
antipsicotici si vedano le Tabelle 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 e la Figura 7.3.
L’efficacia e la comparsa di effetti collaterali tuttavia non sono solamente correlate alle
caratteristiche farmacodinamiche della molecola in questione, bensì anche a quelle
farmacocinetiche; particolarmente importanti a livello clinico sono le caratteristiche di
assorbimento, l’emivita (l’intervallo di tempo in cui l’organismo metabolizza il 50% del
farmaco, che influenza in maniera proporzionale anche il tempo necessario a raggiun-
gere lo “steady state”, il livello costante di principio attivo nell’organismo – Fig. 7.4) e
le eventuali interazioni con altri farmaci a livello di metabolismo epatico. Per esempio,
l’assorbimento di ziprasidone è molto ridotto se quest’ultimo è assunto in assenza di
cibo; in caso di trattamento con asenapina (non ancora approvata in Europa per il trat-
tamento della schizofrenia), data la via di somministrazione sublinguale, bisogna invece
evitare di mangiare o bere nei 10-15 minuti che ne precedono o seguono l’assunzione.
Tabella 7.4 Farmaci antipsicotici ed effetti collaterali
OLA QUE RIS ZIP ARI CLO ASE ALO AMI
EPS 0/+ 0 0/++ 0/+ + 0 o/++ +++ 0/++
Discinesie tardive + 0/+ + + + 0 ? +++ +
ä Prolattina + 0 +++ + 0 0 0/+ +++ +++
ä Peso +++ ++ + 0 0 +++ 0 + +
ä Glicemia +++ ++ ++ 0 0 +++ 0 0 +
ä Lipidemia +++ ++ ++ 0 0 +++ 0 0 +
ä QTc 0/+ + + ++ 0 0 0/+ + +
Sedazione + ++ + 0/+ 0/+ +++ + ++ 0/+
Ipotensione + ++ + + 0 +++ + 0 0
Effetti anticolinergici ++ + 0 0 0 +++ 0 0 0
ALO = aloperidolo; AMI = amisulpiride; ARI = aripiprazolo; ASE = asenapina; CLO = clozapina; OLA = olanzapina; QUE =
quetiapina; RIS = risperidone; ZIP = ziprasidone. Modificata da Miyamoto e Fleischhacker, 2012.
Tabella. 7.5 Dose-equivalenti dei vari farmaci antipsicotici
Molecola Dose minima OLA 1 mg RIS 1 mg ALO 1 mg CPZ 100 mg
efficace equivalente equivalente equivalente equivalente
Aloperidolo 4 0,53 2 1 1,6
Aripiprazolo 10 1,33 5 2,5 4
Asenapina 10 1,33 5 2,5 4
Clozapina 300 40 150 75 120
Olanzapina 7,5 1 3,75 1,88 3
Quetiapina 150 20 75 37,5 60
Risperidone 2 0,27 1 0,5 0,8
Ziprasidone 40 5,33 20 10 16
ALO = aloperidolo; CPZ = clorpromazina; OLA = olanzapina; RIS = risperidone. Modificata da Leucht et al., 2014).
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 170 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 171
Interruzione per qualsiasi motivo (OR) Aumento di peso (OR)
Aloperidolo 0,8 (0,71 a 0,90) Olanzapina 0,74 (0,67 a 0,81)
Ziprasidone 0,72 (0,59 a 0,86) Clozapina 0,65 (0,31 a 0,99)
Asenapine 0,69 (0,54 a 0,86) Chlopromazine 0,55 (0,34 a 0,76)
Cloropromazina 0,65 (0,5 a 0,84) Quetiapina 0,43 (0,34 a 0,53)
Quetiapina 0,61 (0,52 a 0,71) Risperidone 0,42 (0,33 a 0,50)
Aripiprazole 0,61 (0,51 a 0,72) Paliperidone 0,38 (0,27 a 0,48)
Risperidone 0,53 (0,46 a 0,60) Asenapine 0,23 (0,07 a 0,39)
Paliperidone 0,48 (0,39 a 0,58) Amisulpride 0,20 (0,05 a 0,35)
Clozapina 0,46 (0,32 a 0,65) Aripiprazole 0,17 (0,05 a 0,28)
Olanzapina 0,46 (0,41 a 0,52) Ziprasidone 0,10 (–0,02 a 0,22)
Amisulpride 0,43 (0,32 a 0,57) Aloperidolo 0,09 (–0,00 a 0,17)
Effetti extrapiramidali (OR) Aumento prolattina (OR)
Aloperidolo 0,8 (0,71 a 0,90) Paliperidone 1,30 (1,08 a 1,51)
Ziprasidone 0,72 (0,59 a 0,86) Risperidone 1,23 (1,06 a 1,40)
Asenapine 0,69 (0,54 a 0,86) Aloperidolo 0,70 (0,56 a 0,85)
Cloropromazina 0,65 (0,5 a 0,84) Ziprasidone 0,25 (0,01 a 0,49)
Quetiapina 0,61 (0,52 a 0,71) Cloropromazina 0,16 (–0·48 a 0,8)
Aripiprazole 0,61 (0,51 a 0,72) Olanzapina 0,14 (+0,00 a 0,28)
Risperidone 0,53 (0,46 a 0,60) Asenapine 0,12 (–0,12 a 0,37)
Paliperidone 0,48 (0,39 a 0,58) Quetiapina –0,05 (–0,23 a 0,13)
Clozapina 0,46 (0,32 a 0,65) Aripiprazole –0,22 (–0,46 a 0,03)
Olanzapina 0,46 (0,41 a 0,52) Amisulpiride NA
Amisulpride 0,43 (0,32 a 0,57) Clozapina NA
Prolungamento QTc (OR) Sedazione (OR)
Amisulpride 0,66 (0,39 a 0,91) Clozapina 8,82 (4,72 a 15,06)
Ziprasidone 0,41 (0,31 a 0,51) Cloropromazina 7,56 (4,78 a 11,53)
Asenapine 0,30 (–0,04 a 0,65) Ziprasidone 3,80 (2,58 a 5,42)
Risperidone 0,25 (0,15 a 0,36) Quetiapina 3,76 (2,68 a 5,19)
Olanzapina 0,22 (0,11 a 0,31) Olanzapina 3,34 (2,46 a 4,50)
Quetiapina 0,17 (0,06 a 0,29) Asenapine 3,28 (1,37 a 6,69)
Aloperidolo 0,11 (0,03 a 0,19) Aloperidolo 2,76 (2,04 a 3,66)
Paliperidone 0,05 (–0,18 a 0,26) Risperidone 2,45 (1,76 a 3,35)
Aripirazole 0,01 (–0,13 a 0,15) Aripiprazole 1,84 (1,05 a 3,05)
Clozapina NA Paliperidone 1,40 (0,85 a 2,19)
Clorpromazina NA Amisulpride 1,42 (0,72 a 2,51)
NA = non disponibile; OR = odds ratio
FIGURA 7.3 Principali effetti collaterali dei farmaci antipsicotici: confronto fra trat-
tamento e placebo. I farmaci sono elencati in ordine decrescente da quello che esercita
maggiormente l’effetto indicato a quello che lo esercita in maniera minore. (Modificata
da Leucht et al., 2013.)
Inoltre, il passaggio troppo veloce da un composto a breve emivita, come quetiapina o
ziprasidone, a un altro dalle caratteristiche opposte e tempi più lunghi per raggiungere
lo “steady state”, come aripiprazolo, può causare una temporanea diminuzione dell’in-
tensità dell’antagonismo dopaminergico, fino a quando il secondo farmaco non abbia
raggiunto il livello terapeutico, con la possibile ricomparsa dei sintomi del disturbo (vedi
Tabella 7.6 per le caratteristiche di farmacocinetiche di ogni singolo composto).
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 171 05/03/15 10:51172 Capitolo 7
Emivita Steady state
L’emivita (t1/2) è un parametro farmacocinetico Lo stato stazionario (steady state) di un farmaco
che indica il tempo richiesto per ridurre del 50% è lo stato d’equilibrio della sua concentrazione.
la quantità di un farmaco nel plasma o nel siero In seguito alla somministrazione, il livello
(nel sangue). del farmaco del sangue subisce delle variazioni
nel tempo, ma dopo un tempo t, la quantità
di farmaco eliminata corrisponde a quella
introdotta e il sistema è in stato stazionario.
Corrisponde generalmente a un tempo pari
a 4-5 volte l’emivita del farmaco.
FIGURA 7.4 Emivita e steady state.
Tabella 7.6 Caratteristiche farmacocinetiche dei diversi
antipsicotici
Biodisponibilità Legame proteine Emivita in ore Giorni per
(%) plasmatiche (%) raggiungere lo
steady state
ALO 60-70 92 10-20 3-5
AMI 43-48 17 12 2-3
ARI NA > 99 48-68 14
ASE 35 95 24 4-6
CLO 12-81 > 90 6-33 4-8
OLA 60-80 93 20-70 5-7
QUE NA 83 5-8 2-3
RIS 68 90 3-24 4-6
ZIP 60 > 99 4-10 2-3
ALO = aloperidolo; AMI = amisulpiride; ARI = aripiprazolo; ASE = asenapina; CLO = clozapina; NA = non disponibile; OLA =
olanzapina; QUE = quetiapina; RIS = risperidone; ZIP = ziprasidone.
Particolare attenzione meritano anche le svariate interazioni che possono esserci fra
più composti a livello di metabolismo, che avviene nel fegato grazie al sistema enzima-
tico del citocromo P450 (CYP450); questo sistema è formato da più tipi di enzimi che
si differenziano in termini di specificità di substrato e di variabilità individuale, la cui
attività può essere inibita o aumentata dalla contemporanea somministrazione di altri
farmaci, causando marcate variazioni nella quantità di principio attivo effettivamente
presente nell’organismo (Tab. 7.7). La diretta conseguenza della scarsa considerazione
di questi aspetti può essere da un lato il mancato raggiungimento della dose terapeu-
tica e dall’altro, invece, l’accumulo di dosaggi eccessivi, con l’insorgenza quindi di effetti
collaterali (Urichuk et al., 2008). A volte l’interazione è clinicamente non significativa,
ma in presenza di forti inibitori e concomitante terapia con farmaci potenzialmente più
rischiosi (per esempio, clozapina) è buona norma rivedere e, nel caso, ridurre sensibil-
mente i dosaggi terapeutici.
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 172 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 173
Tabella 7.7 Citocromi coinvolti nel metabolismo di alcuni
antipsicotici
Citocromo Substrato Induttori Inibitori
CYP 1A2 Clozapina Fluvoxamina
Olanzapina
CYP 2D6 Aripiprazolo Bupropione
Clozapina Fluoxetina
Olanzapina Paroxetina
Risperidone
CYP 34A Aripiprazolo Carbamazepina Claritromicina
Clozapina Fenitoina Eritromicina
Quetipina Fluconazolo
Ziprasidone Fluvoxamina
Ketoconazolo
Profilo d’azione dei farmaci antipsicotici
e utilizzo nelle diverse dimensioni della
schizofrenia
Amisulpride
Amisulpride ha un profilo recettoriale caratterizzato da buona affinità e selettività per i
recettori D2 e D3 e per alcuni recettori serotoninergici (5-HT7A), che adesso sono presi
in considerazione anche nello studio di nuovi farmaci antidepressivi. Sul manuale “Neuro-
science based Nomenclature” (NbN) (Zohar et al., 2014) infatti viene classificato come
target farmacologico (TF): dopamina; modalità d’azione (MA): antagonista dei recettori
D2. Per quanto riguarda l’azione sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato
come antagonista dei recettori D2 e D3 e 5-HT7, mentre a livello umano si dimostra in
grado di bloccare i recettori centrali D2, ma non evidenzia binding con i recettori 5-HT2A.
Per quanto concerne i circuiti cerebrali si riscontrano moderati livelli di occupazione dei
recettori D2/D3 nello striato e livelli significativamente elevati nel talamo e nella corteccia
temporale. La selettività per i recettori D2/D3 a livello limbico spiegherebbe l’efficacia
del farmaco e la scarsa propensione a causare effetti collaterali di tipo extrapiramidale in
assenza di un forte antagonismo serotoninergico, ma non è stata interamente dimostrata
(Bressan et al., 2003). A basso dosaggio l’amisulpiride ha effetto sui recettori presinaptici,
con conseguente aumento del rilascio di dopamina, motivo per cui la dose di attacco da
utilizzarsi deve essere relativamente alta.
Ha scarso legame proteico e basso metabolismo epatico, ma i livelli plasmatici non sono
influenzati dal fumo. È preferibile evitarne la somministrazione in concomitanza con
altri farmaci che prolungano il QTc, avendo anch’esso un effetto dose dipendente. Cloza-
pina e litio, soprattutto il secondo, ne aumentano significativamente i dosaggi plasma-
tici (Bergemann et al., 2004). Questi ultimi sono più stabili nelle donne e negli anziani
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 173 05/03/15 10:51174 Capitolo 7
rispetto ai giovani. Tuttavia alcuni studi evidenziano una certa efficacia dell’associa-
zione clozapina/amisulpride in pazienti agitati e resistenti al trattamento con clozapina
(Assion et al., 2008; Hotham et al., 2013).
Nella metanalisi di Leucht et al. (2009), sembra essere il farmaco con maggiore efficacia
sui sintomi negativi, rispetto agli antipsicotici di prima generazione. Ha una buona effi-
cacia nel trattamento dei sintomi depressivi, sia primari sia secondari.
Aripiprazolo
Aripiprazolo si differenzia dagli altri antipsicotici principalmente per il suo funziona-
mento di agonista parziale a livello del recettore D2 e del recettore 5-HT1A, che, insieme
all’antagonismo sul recettore 5-HT2A, contribuiscono al suo profilo di efficacia e tolle-
rabilità. Sul manuale NbN viene classificato come TF: multifunzionale e dopamina; MA:
agonista parziale dei recettori per la dopamina e serotonina. Per quanto riguarda l’azione
sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come agonista parziale dei recet-
tori D2, D3 e 5-HT1A e come debole antagonista del recettore 5-HT2A, mentre a livello
umano occupa i recettori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cerebrali si riscontra
un aumento di flusso ematico regionale cerebrale (rCBF) nello striato, una sua riduzione
a livello frontale, come l’aloperidolo, rispetto al quale ha effetti opposti nella corteccia
temporale e nel cingolato anteriore.
Inoltre, poiché non svolge un’azione a livello dei recettori colinergici e istaminergici non
causa livelli di sedazione clinicamente rilevanti e può risultare anzi lievemente agitante
in alcuni pazienti.
Aripiprazolo è metabolizzato quasi interamente a livello epatico da parte dei citocromi
CYP3A4 e CYP2D6. Particolare attenzione va posta in caso di somministrazione contem-
poranea di carbamazepina, fluoxetina, paroxetina, ketoconazolo, mentre non sono neces-
sarie modifiche del dosaggio in caso di co-somministrazione con litio o acido valproico
(DeLeon et al., 2004). Si lega quasi completamente alle proteine sieriche.
Da un punto di vista clinico, aripiprazolo è utile nel trattamento dei sintomi positivi della
schizofrenia (non essendo tuttavia il più efficace) e sulla dimensione affettiva; un’im-
portante caratteristica di questa molecola è la scarsa propensione a causare aumento di
peso e alterazioni del metabolismo, in particolare se confrontato con altre molecole come
olanzapina, che lo rende particolarmente utile durante la fase di mantenimento della
terapia (Casey et al., 2003). Ha un profilo di tollerabilità migliore rispetto alla media di
tutti gli altri antipsicotici (Leucht et al., 2014).
Asenapina
Asenapina è uno dei più recenti farmaci antipsicotici introdotti sul mercato (2011 in
Italia); al momento, però, in Italia è approvato solo per il trattamento delle fasi maniacali
nel disturbo bipolare I. Sul manuale NbN viene classificato come TF: multifunzionale
e dopamina; MA: antagonista dei recettori per la dopamina e serotonina. Per quanto
riguarda l’azione sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come antago-
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 174 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 175
nista dei recettori D1, D2, D3 e 5-HT2, 5-HT6, 5-HT7, NE alpha e alpha2, mentre a
livello umano blocca i recettori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cerebrali non
vi sono dati precisi, ma sembra che la sua azione si esplichi a livello striatale, pituitario
e della PFC. I benefici effetti sul controllo dei sintomi antipsicotici possono essere anche
in parte dovuti all’interazione fra asenapina e recettori glutammatergici a livello della
corteccia prefrontale.
Asenapina viene assorbita per via sublinguale e raggiunge il livello di picco plasmatico
in circa 30-90 minuti. Viene metabolizzata a livello epatico ed è necessaria particolare
attenzione se somministrata insieme a fluvoxamina, a causa delle interazioni a livello dei
citocromi, o in caso di insufficienza epatica.
È frequente il riscontro di ipotensione ortostatica, dovuta all’interazione con i recettori
a1-adrenergici (Tarazi e Stahl, 2012).
A livello clinico è utile per il trattamento della dimensione positiva e dei sintomi mania-
cali, sia nel disturbo bipolare sia nella schizofrenia. Inoltre, dati preclinici rilevano una
potenziale utilità di asenapina nel trattamento dei disturbi della dimensione cognitiva,
anche se ancora vi è bisogno di ulteriori conferme effettive in popolazioni cliniche (Tarazi
e Neill, 2013).
Clozapina
Come già menzionato sopra, clozapina è la molecola capostipite dei cosiddetti antipsi-
cotici di seconda generazione e quella con il profilo farmacologico più complesso; è rite-
nuta il “gold standard” per il trattamento dei casi di schizofrenia resistente, anche se
recentemente il suo ruolo come farmaco di prima scelta è in fase di rivalutazione. Sul
manuale NbN viene classificato come TF: multifunzionale e dopamina; MA: antagonista
dei recettori per la dopamina e serotonina e di altri recettori. Per quanto riguarda l’azione
sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come antagonista dei recettori
D1, D2, D3 e 5-HT2, NE alpha1 e alpha2, H1, ACh M1-4; a livello umano, invece, blocca i
recettori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cerebrali non sono ancora disponibili
dati indicativi.
Clinicamente risulta essere superiore rispetto agli antipsicotici di prima generazione
nel trattamento di tutte le dimensioni della schizofrenia, compresa la sfera cognitiva
(Leucht et al., 2009). Particolare attenzione va fatta agli importanti effetti collaterali. Per
una trattazione più dettagliata si rimanda ai paragrafi successivi.
Olanzapina
Olanzapina ha una struttura farmacologica simile a quella di clozapina, con profilo
recettoriale in parte diverso e caratteristiche cliniche non del tutto sovrapponibili. Sul
manuale NbN viene classificato come TF: multifunzionale e dopamina; MA: antagonista
dei recettori per la dopamina e serotonina e di altri recettori. Per quanto riguarda l’azione
sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come antagonista dei recettori
D1, D2, D3 e 5-HT2, NE alpha1, H1, ACh M1-4; mentre a livello umano blocca i recet-
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 175 05/03/15 10:51176 Capitolo 7
tori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cerebrali non sono ancora disponibili dati
indicativi. Tale profilo recettoriale porta a una ridotta insorgenza di effetti extrapirami-
dali e a un livello di sedazione inferiore a clozapina ma superiore rispetto ad altre mole-
cole. È la molecola più fortemente associata ad aumento del rischio cardiovascolare ed
è frequentemente causa di notevole aumento ponderale, quindi il suo utilizzo non è da
considerarsi di prima linea in soggetti a rischio, o particolarmente sensibili a tali effetti
collaterali (Leucht et al., 2012).
Si lega in gran parte alle proteine sieriche e viene metabolizzata prevalentemente a livello
epatico. I livelli plasmatici variano in particolare a seconda del sesso e in concomitanza
con fumo di sigaretta (i soggetti maschi e fumatori hanno una clearance della molecola
maggiore) (Callaghan et al., 1999).
Olanzapina si è rilevata particolarmente efficace nel controllo dei sintomi positivi, in
particolare durante la fase acuta, ed è molto utile nel trattamento dei sintomi maniacali.
È disponibile in formulazione depot.
Quetiapina
Un altro composto con struttura chimica simile a clozapina, ma con proprietà farmaco-
logiche abbastanza differenti, è quetiapina. Sul manuale NbN viene classificato come TF:
multifunzionale e dopamina; MA: antagonista dei recettori per la dopamina e serotonina
e inibitore della ricaptazione della norepinefrina (NE) – (metabolita attivo). Per quanto
riguarda l’azione sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come antago-
nista dei recettori D1, D2, D3 e 5-HT2, NE alpha1 e alpha2, H1; incrementa la 5-HT e la NE
nella corteccia frontale, l’istamina nella corteccia prefrontale mediale e la 5-HT nel nucleus
accumbens. A livello umano blocca i recettori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cere-
brali non sono ancora disponibili dati indicativi. Un tratto distintivo di questa molecola è la
sua bassa affinità per i recettori dopaminergici e la veloce dissociazione da essi, che potrebbe
quindi spiegarne l’efficacia clinica nel trattamento dei sintomi psicotici e la bassissima insor-
genza di effetti collaterali extrapiramidali. L’affinità verso i recettori istaminergici e coliner-
gici può causare moderata sedazione e indurre un moderato aumento di peso. Interessante a
livello farmacologico è il blocco dei recettori 5-HT2C, che sembra conferire alla molecola un
effetto antidepressivo. A tale effetto contribuisce probabilmente la presenza di un metabo-
lita attivo, norquetiapina, con caratteristiche farmacodinamiche non del tutto sovrapponi-
bili a quelle del farmaco di origine: infatti ha un’azione preponderante a livello dei recettori
serotoninergici 5-HT1A, 5-HT7, 5-HT2C e α2 (López-Muñoz e Alamo, 2013).
Quetiapina viene metabolizzata a livello epatico dal citocromo CYP3A4, ma interazioni
clinicamente rilevanti possono verificarsi solo in caso di somministrazione con forti
induttori o inibitori come per esempio ketoconazolo. Il fumo non influisce sui livelli
plasmatici della molecola, e non sono necessari particolari variazioni di dosaggio in
soggetti anziani (DeVane e Nemeroff, 2001).
Rispetto agli altri farmaci antipsicotici, in particolare quelli di prima generazione,
quetiapina sembra essere lievemente meno efficace nel trattamento della dimensione
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 176 05/03/15 10:51Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 177
positiva della schizofrenia e trova indicazione in particolare in quei casi in cui un blocco
massivo dei recettori dopaminergici è controindicato, come per esempio nei pazienti
affetti da morbo di Parkinson oppure in quelli con elevata sensibilità agli effetti collate-
rali extrapiramidali.
Il moderato effetto antidepressivo la rende utile nel trattamento della dimensione affet-
tiva sia nella schizofrenia, sia in caso di depressione in disturbo bipolare, nei casi in cui
sia controindicato l’utilizzo di un farmaco antidepressivo o come terapia aggiuntiva. A
basso dosaggio, ha un prevalente effetto sedativo, che può essere sfruttato per trattare
agitazione o insonnia. Recentemente, inoltre, è stato dimostrato che quetiapina è l’an-
tipsicotico associato al più basso tasso di mortalità nel trattamento dell’agitazione in
pazienti con demenza (Kales et al., 2012).
Risperidone
Risperidone è una molecola con profilo farmacologico alquanto diverso da clozapina, con
alta affinità per i recettori serotoninergici e moderata affinità per D2, H1, NE alpha1 e
alpha2 e un meccanismo d’azione che a dosaggi più alti si avvicina a quello degli antipsico-
tici di prima generazione, con elevati tassi di effetti collaterali extrapiramidali e aumento
dei livelli di prolattina nel plasma. Sul manuale NbN viene classificato come TF: multi-
funzionale e dopamina; MA: antagonista dei recettori per la dopamina e serotonina. Per
quanto riguarda l’azione sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è classificato come
antagonista dei recettori D2 e D3, NE alpha1 e alpha2, 5-HT2A e H1; a livello umano,
invece, blocca i recettori centrali D2. Per quanto concerne i circuiti cerebrali non sono
ancora disponibili dati indicativi. Come quetiapina, viene metabolizzato a livello epatico
in un metabolita attivo che contribuisce anch’esso all’effetto terapeutico (López-Muñoz
e Alamo, 2013). I livelli plasmatici di risperidone possono essere influenzati da induttori
o inibitori del sistema del citocromo CYP 2D6, come paroxetina o fluoxetina. Modifiche
del dosaggio sono necessarie in caso di insufficienza renale o epatica (Huang et al., 1993).
Clinicamente è utile nella gestione dei sintomi positivi della schizofrenia e dei sintomi
maniacali, associati o meno ad aggressività e agitazione, mentre non sembra avere un
effetto significativo sulla dimensione cognitiva e negativa. In una recente metanalisi di
comparazione diretta con gli altri antipsicotici di seconda generazione, si è rivelato lieve-
mente meno efficace di clozapina e olanzapina e più efficace di quetiapina e risperidone.
Tuttavia, come già menzionato sopra, gli elevati tassi di incidenza di effetti collaterali
quali iperprolattinemia e disordini motori di tipo extrapiramidali, superiori rispetto ad
altri farmaci, ne limitano l’utilizzo in molti pazienti (Komossa et al., 2011). È disponibile
in formulazione depot.
Ziprasidone
Il profilo recettoriale di ziprasidone è caratterizzato da buona affinità per i recettori
serotoninergici (5-HT2A, 5-HT2C) e da un meccanismo di agonismo parziale a livello
di 5-HT1A. Il rapporto relativamente alto di affinità 5-HT2A/D2 garantisce un rischio
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 177 05/03/15 10:51178 Capitolo 7
modesto di insorgenza di effetti collaterali extrapiramidali. Sul manuale NbN viene clas-
sificato TF: multifunzionale e dopamina; MA: antagonista dei recettori per la dopamina
e serotonina. Per quanto riguarda l’azione sui neurotrasmettitori, a livello preclinico è
classificato come antagonista dei recettori D1, D2 e D3, NE alpha1, 5-HT2A, 5-HT2C,
H-HT1B e 5-HT7, come parziale agonista dei recettori 5-HT1A e 5-HT1D e come debole
inibitore di NET e SERT. A livello umano blocca i recettori centrali D2. Per quanto
concerne i circuiti cerebrali non sono ancora disponibili dati indicativi. Un’altra carat-
teristica propria di ziprasidone è una moderata affinità per i trasportatori della seroto-
nina e della noradrenalina e un’azione minima a livello dei recettori istaminergici, con
conseguente mancanza di effetti sedativi e di aumento ponderale. Allo stesso modo, a
differenza di altri antipsicotici, ha poca affinità anche a livello dei recettori colinergici.
Ziprasidone viene metabolizzato a livello epatico e possiede uno dei migliori profili di
interazioni fra farmaci diversi. La biodisponibilità del farmaco è massima se sommi-
nistrato durante i pasti. A dosaggi relativamente bassi (Il trattamento farmacologico della schizofrenia, delle comorbidità e delle forme resistenti 179
società tedesca di psichiatria, e successivamente ai contributi Kane nel 1988 e Meltzer
nel 1992 e 1995, che documentarono la riduzione dei comportamenti suicidari in un
limitato campione di pazienti trattati con clozapina, in confronto sia alle fasi in cui erano
trattati con farmaci tradizionali sia a una popolazione di confronto. Studi poi conva-
lidati da più ampie indagini hanno portato alla sua riapparizione a inizio degli anni
Novanta negli Stati Uniti, con l’approvazione della Food and Drug Administration. Oggi
il suo uso è limitato ai casi di schizofrenia resistente e per la riduzione del rischio suici-
dario nei pazienti schizofrenici e schizoaffettivi e in molti paesi europei e non europei
il suo utilizzo rimane estremamente limitato. In questo capitolo mostreremo come la
clozapina, sebbene sia un farmaco con eventi avversi potenzialmente molto gravi, sia il
farmaco antipsicotico con maggiore efficacia e migliore impatto sull’aspettativa di vita
del paziente schizofrenico.
Clozapina e impatto sull’aspettativa di vita
del paziente schizofrenico
Come ha mostrato un recente studio osservazionale della National Association of State
Mental Health Program Directors, i pazienti con disturbi psichiatrici maggiori (tra cui i
disturbi psicotici) muoiono in media 25 anni prima della media della popolazione gene-
rale e, sebbene il suicidio e altre cause innaturali rendano conto di circa il 40% di queste
morti, più del 60% di questi pazienti muore di morte prematura per cause naturali,
quali patologie cardiovascolari e patologie polmonari (Tiihonen et al., 2012). È convin-
zione diffusa che l’introduzione degli antipsicotici di seconda generazione durante i
primi anni Novanta del secolo scorso abbia avuto un impatto negativo sulla mortalità
dei pazienti schizofrenici, particolarmente a causa dell’aumento di morte per patologie
cardiovascolari. Un importantissimo lavoro apparso nel 2011 sull’importante rivista
Lancet, ha affrontato il tema dell’impatto degli antipsicotici sull’aspettativa di vita
attraverso uno studio di follow-up su oltre 60.000 pazienti schizofrenici seguiti per
una media di 11 anni (Tiihonen et al., 2012). Da questo studio emerge in primo luogo
un dato che smentisce la convinzione che gli atipici abbiano ridotto l’aspettativa di vita
dei pazienti schizofrenici. Emerge infatti che, sebbene l’uso di antipsicotici atipici nei
pazienti schizofrenici sia cresciuto dal 13% nel 1996 al 64% nel 2006, l’aspettativa di
vita di questa popolazione rispetto alla popolazione generale non è cambiata sostan-
zialmente e rimane inferiore di 23-25 anni. Altro dato importante è che il rischio di
morte è risultato più basso per i pazienti in trattamento con un farmaco antipsicotico
rispetto a quelli non in trattamento con antipsicotici. Tuttavia il dato più interessante
di questo studio riguarda appunto la clozapina. È emerso infatti che la clozapina è
associata al più basso rischio di mortalità rispetto agli altri atipici e a tipici come la
perfenazina. Inoltre, la clozapina è associata al più basso rischio suicidario rispetto
a tutti gli altri antipsicotici. La differenza di mortalità legata all’uso di clozapina può
essere attribuita a diversi fattori:
07_ch07_PALLANTI_161_216.indd 179 05/03/15 10:51Puoi anche leggere