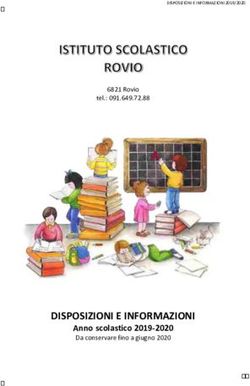Il bambino e la scimmia. Minori stranieri interessati da procedimenti di adottabilità o collocati in affido. Accoglienza o xenofobia?
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
"Articolo pubblicato sul fascicolo n° 4 di Minori e Giustizia, 2014"
4/ Adozioni e affidamenti dei bambini di altre culture presenti nel nostro
Paese
Il bambino e la scimmia. Minori stranieri
interessati da procedimenti di adottabilità
o collocati in affido. Accoglienza o xenofobia?
di Bice Zumbo*
Indietreggia la schiavitù,
ma non il pregiudizio che l’ha fatta nascere
Alexis de Tocqueville (1840)
1. L’osservatorio delle consulenze
La consulenza tecnica d’ufficio, che giunge nella maggior parte dei casi dopo mesi
o anni di interventi di varia natura sulle famiglie in difficoltà, può rappresentare un
osservatorio privilegiato delle valutazioni e delle scelte cliniche svolte nel corso del
lavoro sociale a tutela del minore.
Gli operatori che si trovano a intervenire in questo campo spesso sono travolti da
urgenze e dalla necessità di prendere delle decisioni. Nell’agito essi apportano il
proprio orientamento teorico e i propri pregiudizi, nei quali si embricano e collidono i
rapporti con il gruppo di lavoro e le pressioni degli utenti e, non ultimo, il contesto
socio politico, che costituisce la cornice di significato entro cui la cura
dell’intrapsichico si definisce. Tali dinamiche mi paiono singolarmente attive e
difficilmente portate alla coscienza, in particolare nei casi che riguardano utenti
stranieri.
Talvolta, come bene afferma Bruno Voena1, il pregiudizio è percepibile benché di
difficile dimostrazione, talvolta l’ingiustizia e l’atteggiamento prevenuto sono
palpabili. In ogni caso la sensazione è che nella presa in carico dei minori e delle loro
famiglie si navighi a vista e che, almeno nel campo degli affidi e nella valutazione
della genitorialità in vista di limitazioni della responsabilità genitoriale, molto sia
ancora da comprendere e da discutere. Non esiste, mi pare, un linguaggio comune che
indirizzi gli interventi degli operatori del sociale dal punto di vista della valutazione
della genitorialità, né mi sembra esistano raccomandazioni e buone prassi per quanto
riguarda la scelta delle famiglie affidatarie.
*
Psicologa, psicoterapeuta, consulente tecnico d’ufficio. E-mail bice.zumbo@libero.it
1
M.C. Bruno Voena, “La tutela civile del minore vittima di maltrattamenti domestici in contesti interculturali”, in
questa stessa Rivista, 2012, n. 2, pp. 100-107.
1Ad esempio, le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, redatte nel 2013 a
cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali2, affermano che occorre
“garantire ai bambini, per i quali è stato attivato un processo di protezione e cura, la
presa in carico da parte di un’équipe multidisciplinare, costituita possibilmente dalle
figure dell’assistente sociale, dello psicologo e dell’educatore professionale,
integrata con altre figure in base alle problematiche del bambino e del suo nucleo”
(Raccomandazione n. 311.4) ma poi non prevedono indicazioni particolari e
specifiche per i minori stranieri e le loro famiglie come condizione che meriti
un’attenzione particolare e buone prassi dedicate e specificano solo per l’affidamento
dei minori non accompagnati la necessità, nel caso, dell’intervento del mediatore
culturale3.
Le Linee di indirizzo dispongono inoltre che “le Amministrazioni attivano azioni di
sensibilizzazione e formazione per raccogliere le disponibilità delle famiglie e
persone singole e prepararle all’incontro con il minore straniero, anche attraverso il
coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio”
(Raccomandazione 224.e.2), suggerimento di principio del tutto condivisibile, ma che
rimane generico. Per quanto riguarda i criteri per la scelta delle famiglie affidatarie le
Linee di indirizzo individuano tra l’altro la dinamica delle relazioni con il mondo
esterno ovvero il livello di integrazione nell’ambiente sociale ma non contengono
accenni alle capacità delle famiglie affidatarie di rapportarsi in modo rispettoso e
interessato all’individualità culturale del minore ospitato.
Va ricordato che un bambino in affido (o in adozione) è sempre uno straniero al
quale viene data ospitalità. Egli spesso produce profondi sentimenti di com-passione
e sofferenza empatica, ma nel contempo può suscitare sensi di persecutorietà ed
estraneità (come diceva la madre di un bambino italiano adottato a tre anni: “Quando
è arrivato faceva un odore strano ma io nei primi giorni l’ho lavato tanto che poi
faceva odore di famiglia”). Il bambino straniero è estraneo su parecchi fronti e può
correre il rischio di venire più o meno privato e “depurato” della sua estraneità, a
misura che la famiglia di accoglienza metta in atto manovre difensive fino ad
assumere atteggiamenti di svalutazione e discredito.
Talvolta la scelta di luoghi e persone di accoglienza effettuata dagli operatori dei
servizi cade su contesti, comunità o famiglie affidatarie, più o meno apertamente
xenofobi, confermando che la valutazione delle capacità di maneggiare il proprio
vissuto culturale forse non è ancora stata a pieno inserita nel ventaglio delle capacità
di tipo genitoriale che si devono richiedere ed esigere per un’accoglienza davvero
tutelante di un minore straniero.
2
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, 2012, scaricabile dal sito:
www.minori.it.
3
Raccomandazione 224.e.1: “Le Amministrazioni, attraverso i propri servizi sociali e sanitari, promuovono
l’affidamento, sia full time sia part time, di minori stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole
italiane o straniere, meglio se culturalmente affini (stessa lingua o religione), attivando tutte le azioni necessarie a
garantire il miglior abbinamento possibile”. Di seguito come “azione/indicazione operativa 1” si afferma che “per
l’affidamento per i minori stranieri il Centro per l’affidamento familiare coinvolge i mediatori culturali che hanno il
compito, tra gli altri, di facilitare la reciproca conoscenza e favorire i contatti e il coinvolgimento della famiglia di
origine”.
2Allorché nelle famiglie affidatarie e nelle comunità la tensione con l’altro
sconosciuto e il retaggio sottoculturale delle convinzioni sulla razza mostrano di
interferire, possono aversi conseguenze di diversa entità e gravità sulla strutturazione
della personalità e dell’identità del minore straniero accolto. Questo rischio mi pare
tanto più attivo quanto più le famiglie e gli operatori sono impegnati in complessi
movimenti di formazione reattiva – il meccanismo psichico di difesa che ci fa coprire
di attenzioni il nostro peggiore nemico –, talvolta sostenuti da scelte esistenziali e
professionali di stampo ideologico, religioso e politico.
Detto più esplicitamente, la presa in carico, le valutazioni e le conseguenti
segnalazioni, nonché le scelte relative alle famiglie affidatarie e delle comunità
sembrano, in molti casi, particolarmente influenzate da convinzioni radicate e
inconsce che richiamano fantasmi di inferiorità e di animalità, di arretratezza
culturale e psicologica dell’uomo non bianco. E questo proprio in persone che hanno
scelto per convinzione etica di dedicarsi alla cura, professionale o familiare, delle
famiglie provenienti da altri paesi.
2. La ricostruzione della storia
Il consulente tecnico di ufficio chiamato per la sua competenza a definire i livelli
di malessere di un minore straniero nella maggior parte dei casi parte dalla lettura
degli atti, che testimoniano non solo il lungo lavorio della presa in carico ma spesso
rappresentano l’unico, apparentemente arido, resoconto delle vicissitudini esistenziali
di individui e di intere famiglie. Spesso la storia narrata – in maniera talvolta
frammentaria, asettica o contraddittoria – dalle segnalazioni o dagli aggiornamenti
indirizzati al giudice è la sola traccia evidente dell’ancora breve ma spesso
complicata vita di un bambino. In certi casi il susseguirsi di educatori o di famiglie
affidatarie può rappresentare la memoria storica del bambino, costituendo una
continuità di esperienze più o meno riuscite, ma sempre significative per la
costruzione della sua identità e personalità.
Spesso però i faldoni relativi a famiglie straniere con diversi minori e con anni di
presa in carico da parte dei servizi sociali sono sorprendentemente scarni e
incompleti. Gli operatori si sono succeduti nel tempo – educatori domiciliari,
psicologi, assistenti sociali – e le notizie, assieme alle carte, si sono perse. Il
consulente tecnico avverte così che non si conoscono le famiglie che in varie riprese
– quando erano piccoli, nei periodi in cui la madre, malata psichiatrica, stava male –
hanno ospitato e aiutato Macodou e Alioun, due fratelli senegalesi, i quali ora, all’età
di nove e sette anni vorrebbero tornare a salutare delle persone cui continuavano a
sentirsi legate. Le carte non ci sono più, i servizi di riferimento sono cambiati e gli
affidatari attuali non riescono a dare risposta e senso alle domande che i due fratellini
pongono loro e che rappresentano punti ciechi nell’identità di questi bambini.
Macoudou e Alioun sembrano quasi figli di una genitorialità diffusa e imprecisata,
che comprende da un lato il padre e la madre, figure soffuse di idealizzazione e
ambivalente rancore, che faticano a ricostruire con i figli, raccontandolo, il declino
3inarrestabile del loro sogno e progetto di vita in Italia, e dall’altro i genitori affidatari,
gli assistenti sociali, i giudici, gli educatori che si sono succeduti. Non a caso
Macodou, il più grande, nel disegno della famiglia oltre a madre, padre e fratello,
disegna una pletora di altre figure, alcune nominate, altre vacue e senza connotati.
Anche nella raccolta delle biografie dei genitori si notano particolarità che rivelano
un’incompletezza legata a disagio culturale e personale dell’operatore: i resoconti si
focalizzano sul presente, sui funzionamenti attuali, sulle carenze – vedremo poi su
che metro valutate – e solo talvolta sulle potenzialità. Viceversa gli accenni al prima,
alla vita precedente alla cesura della migrazione, sono scarsi, o appena accennati,
sommari, come se gli interlocutori istituzionali, a fronte delle comprensibili reticenze
degli utenti, si tenessero a distanza di sicurezza dal nucleo identitario fatto dai ricordi,
dai sogni e dai progetti, dalla famiglia e dai nomi tradizionali che indicano il destino
di ciascuno: in definitiva come se chiudessero gli occhi sulla vita “al paese”, visto
forse ancora come un hic sulla carta dove, nell’atemporalità, sunt leones. L’Africa –
ma non solo, anche il Maghreb o l’universo Rom – è ancora quel luogo senza tempo e
senza storia, dove come in un’infanzia remota non c’è memoria: come diceva Hegel,
“una parte del mondo che non presenta evoluzione di sorta”4.
In altri casi il consulente assiste a un fenomeno di delega, foriero di scissioni e
conflitti all’interno del gruppo di lavoro che ha a carico il bambino straniero. Dopo
qualche incontro con l’assistente sociale e con la psicologa del servizio, il nucleo
familiare, spesso una madre sola con uno o più figli, viene inviato al servizio di
etnopsichiatria, che sembra essere visto come lo specialista della diversità dell’utente,
deus ex machina ambivalentemente investito. All’etnopsichiatra si affida il compito
di ricostruire la storia intima, dando ascolto al “folklore” delle spiegazioni
tradizionali della malattia e delle sue cure, della complessa rete familiare, delle parole
sconosciute, con o senza l’aiuto della mediatrice culturale.
Si dimentica così che la curiosità, l’empatia, l’apprendere dal paziente, l’utilizzo
del controtranfert e la capacità negativa di restare in attesa che il significato emerga
dall’incomprensibile e dallo sconosciuto, sono funzioni della mente indispensabili
nelle relazioni di cura e non appannaggio o privilegio di uno specialista, pure centrale
all’interno della rete di supporto. Con l’utilizzo difensivo dell’invio allo specialista
etnopsichiatra, il gruppo di operatori socio-sanitari in rete può finire per polarizzarsi e
l’etnopsichiatra corre il rischio di diventare l’alleato/difensore, impotente, del
paziente straniero.
3. Le famiglie affidatarie
Nel lavoro di consulenza mi sono trovata talvolta a vedere situazioni di affidi
ripetuti, con peregrinazioni spesso dettate dall’emergenza da una famiglia all’altra o
prolungate accoglienze, di minori stranieri collocati per anni in famiglie italiane.
Spesso ho avuto la sensazione che gli operatori nella scelta della collocazione
4
G.F. Hegel (1817), Enciclopedia delle scienze filosofiche, Laterza, Bari-Roma 2009.
4avessero poco o nulla tenuto in conto l’aspetto della diversità culturale e l’esigenza
del rispetto dell’appartenenza del minore alla sua famiglia naturale (e alla sua cultura
familiare).
Chinua e Pauline, due fratellini provenienti dall’Africa subsahariana rappresentano
un caso emblematico dei diversi esiti di due affidi profondamente differenti dal punto
di vista dell’accoglienza culturale.
I bambini erano stati messi in affido, quando Chinua aveva tre anni e Pauline aveva
qualche mese, presso due famiglie italiane, diciamo Rossi e Bianchi, facenti parte di
una rete di sostegno di matrice cattolica. I Bianchi, famiglia molto in vista nel campo
del volontariato del paese di residenza, nel corso dell’incontro con il consulente
chiamano in un’occasione Pauline “la negretta” e riferiscono amabilmente che la
minacciano di “rimandarla in Africa” quando vogliono sgridarla, oltre a parlare di
un'altra bambina da sempre in affido presso di loro come della “marocchina”.
Affermano che Pauline non ha un rapporto di attaccamento con la madre, che non ha
piacere a vederla e perciò, nonostante siano stati sollecitati più volte dai servizi ad
attenersi alla regolamentazione delle visite, accompagnano la bambina a incontrare la
madre molto saltuariamente. A sua volta Pauline, che ormai ha sei anni, è una
bambina confusa, profondamente ambivalente nei confronti della madre, sola e
autosvalutante. Pauline vorrebbe essere bianca, si sente sporca, investe poco
sull’apprendimento e sui rapporti con i pari. I servizi sembrano iniziare a permettersi
un pensiero critico sullo stile familiare di questi affidatari, ma sono sotto scacco: da
un lato gli intrecci politici e sociali di una piccola realtà dell’interland milanese,
dall’altra l’attaccamento della bambina.
La situazione critica e senza apparente via d’uscita di Pauline appare ancor più
grave per il contrasto con la realtà del fratello Chinua, accolto in una famiglia che si
mostra evidentemente fiera della diversità etnica del bambino e del suo attaccamento
alla madre, assecondandolo, tra le altre cose, nell’abbigliamento che questa gli
propone e valorizzando i racconti tradizionali che da lei ha appreso.
Chinua parla spontaneamente del suo essere “un po’ bianco e un po’ nero”, dice
che: “è ghanese, è africano, è nigeriano, è italiano e sa anche un po’ il francese… ha
due nomi e due cognomi… lui preferirebbe chiamarsi Luca Rossini e basta… con un
papà solo, una mamma sola, un nome e un cognome solo…”. Poi però rettifica: “Alla
fine non è vero, non preferisco Luca Rossini!”.
A Chinua, differentemente che a Pauline, è stato permesso di interrogarsi sulla
propria identità, anzi sul fascio di identità che lo sostanzia, l’insieme delle esperienze
culturali, dei retaggi e delle narrazioni che ci formano e danno spazio al nostro futuro.
Ciò che lo renderà, speriamo, un uomo più completo e sfaccettato, un cittadino più
consapevole e a sua volta accogliente.
4. La valutazione della genitorialità
La valutazione della genitorialità di persone provenienti da altri contesti educativi
ed esistenziali richiederebbe, tra le altre cose, un’attenta disamina delle
5problematiche legate all’immagine del bambino e delle sue capacità di crescita in
culture diverse dalla nostra. Quante volte si legge in una segnalazione che una madre
africana adultizza il figlio e si aspetta da lui condotte adeguate a un bambino di età
maggiore? Quante volte ciò è motivo di valutazione negativa delle capacità
empatiche e genitoriali? Forse noi dovremmo interrogarci sulla compulsione della
nostra civiltà a infantilizzare tutti, adulti e bambini, mantenendo i più giovani in una
sorta di scacco generazionale e costringendoli alla dipendenza e alla convivenza
forzata e ambivalente con le generazioni precedenti.
Comunque sia, spesso la valutazione della genitorialità nei soggetti stranieri
sembra suggerita da un vissuto perturbante e spaesante di estraneità che colora gli atti
più anodini di pericolosa interpretatività: come quell’educatrice che, avendo definito
trascurante una donna nigeriana nei confronti della figlia di due anni, sembrava
annaspare nei ricordi e finiva per rievocare un’unica scena nella quale la madre,
infastidita dal fatto che la bambina le mettesse le mani nel piatto, la allontanava un
po’ da sé. È come se l’altro, lo straniero, fosse portatore di uno scarto che rende
inquietante la quotidianità, la rende simile ma non uguale e pertanto angosciante e
pericolosa, come gli ultracorpi del famoso film maccartista.
Gli esempi di questa incomprensione sono tanti. I servizi sociali e gli affidatari in
un altro caso riferivano che il secondo compagno della madre era maltrattante
descrivendolo in questi termini: costringeva i minori a mangiare pepe per rinforzarli;
non voleva che venissero presi in braccio, in particolare il maschio; non voleva che la
bambina di un anno si ciucciasse il dito.
In questo modo servizi e famiglie affidatarie finiscono spesso per colludere nel
giudizio negativo nei confronti dei genitori, interpretando il disagio del minore, che
diventa un bambino diviso tra due mondi affettivi, come rifiuto della propria
famiglia. Segnalazioni inviate al tribunale e agiti della famiglia affidataria che di fatto
elude in modo più o meno cosciente la regolamentazione, finiscono per sommarsi,
stringendo il bambino in un conflitto di fedeltà che può diventare destrutturante.
Il dibattito su questi temi è ancora insufficiente e non sempre allargato e condiviso
con gli operatori di base: si fatica a scindere tra norma educativa – culturalmente e
storicamente determinata e, ritengo, non sindacabile in quanto non automaticamente e
deterministicamente produttrice di patologia – e relazione, la cui qualità e i cui
fantasmi inconsci sottesi possono rappresentare la culla del sintomo e della sofferenza
psichica, quali che siano le scelte educative.
5. Scimmia o indossatrice?
La descrizione che l’assistente sociale fa al tribunale in un aggiornamento degli atti
precedenti mi colpisce allo stomaco come un pugno. La bambina, che ha poco più di
due anni, appare un po’ maldestra nella deambulazione “forse a causa dell’arcuatura
delle gambe che le fa assumere un andamento “un po’ scimmiesco”. Dopo che l’ho
vista più volte alla fine della consulenza la bambina, nel corso di un’osservazione,
con una tazzina posta sulla sommità del capo, traverserà la stanza incedendo con
6grazia tutta africana, come se portasse un peso sulla testa, facendo sorridere di gioia
la madre e il gruppo dei consulenti.
In un altro caso le relazioni sociali avevano descritto madre e figlia in termini
fortemente svalutativi usando le categorie della sporcizia, dell’inciviltà,
dell’infantilismo, dell’imprevedibilità e dell’impulsività. La relazione tra madre e
figlia è definita simbiotica in quanto “sino all’anno di età la bambina veniva legata
alla schiena della madre, come si usa al loro Paese, e la mamma la teneva con sé in
ogni momento e in ogni attività che svolgeva in casa”. Più avanti la comunità di
accoglienza si rifiuterà di sostenere la signora economicamente per recarsi presso il
centro dove è in carico per una psicoterapia: la spiegazione che “per queste donne la
terapia è un po’ troppo… se devono lavorare, devono lavorare… se no poi non
capiscono più nulla”. Alla signora viene consigliato di non parlare nella sua madre
lingua – che è l’unica che conosce – e viene osteggiata nel suo desiderio di fare le
treccine alla figlia.
Naturalmente si dirà che siamo di fronte a casi limite. Tuttavia anche in modo più
sfumato l’alterità sembra essere spesso rifiutata a priori e tale rifiuto pare sostenuto
da una visione implicita evoluzionista nella quale gli utenti stranieri non vengono
visti come interlocutori ma come esseri vicini all’animale o al bambino, o a noi stessi
in un tempo mitico del passato, quando eravamo arretrati: “ragionano come noi negli
anni ’50”.
La tutela del minore diventa marchio di inadeguatezza del genitore e del suo
retaggio, il singolo si perde in un plurale – queste donne – che lo distrugge nella sua
umanità.
Usi e costumi vengono paternalisticamente evidenziati nei loro aspetti folkloristici
o apertamente riprovati come trascuratezza (“il bambino è costretto a dormire a
terra”) o maltrattamento (“la signora sottopone il bambino con violenza al massaggio
tradizionale con il burro di karité”; “il neonato piange perché la madre si presenta nei
suoi abiti tradizionali e indossa un turbante”).
Anche la richiesta di non parlare la propria lingua con i figli – talvolta “per aiutarli
a imparare l’italiano” talvolta in spazio neutro “per farsi capire dall’educatore” –
perturba evidentemente la relazione con i figli, che poi viene valutata “emotivamente
poco significativa”. Oppure, come nel caso di Faith, rallenta lo sviluppo del
linguaggio, problematica che, di nuovo, viene addotta per screditare le capacità
genitoriali della madre.
Tali equivoci relazionali che, estrapolati dalla situazione, possono far sorridere
seppure amaramente, creano un affastellarsi di “prove” che giungendo sul tavolo del
giudice diventano spesso il ginepraio da cui, forzosamente, scaturisce la procedura di
adottabilità e, nelle more, il collocamento extrafamiliare.
L’influenza dello sguardo dell’osservatore sull’osservato, il peso delle sue teorie e
dei suoi metodi sui risultati raccolti sono oramai quasi un luogo comune nelle scienze
esatte, e segnatamente nella fisica che per prima ha evidenziato tale feconda aporia.
Lo stesso non si può dire nel nostro campo. Le valutazioni e le diagnosi da cui
scaturiscono gli interventi raramente vengono esaminate includendo nel quadro
l’osservatore, le sue teorie, le sue convinzioni politiche e morali.
7Occorre allora che anche i consulenti comincino a darsi cornici teoriche e
pragmatiche, linee guida o buone prassi che dir si voglia, che costringano a osservare
soprattutto i loro propri comportamenti e i loro propri pregiudizi, se vogliono che
l’incontro con l’altro sia alla pari, scevro da razzismo, e non un vuoto e violento
utilizzo del potere.
8Puoi anche leggere